Storia E Futuro. Rivista Di Storia E Storiografia, N. 5
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

UNCLE SCROOGE #21 (Legacy #425), DECEMBER 2016
STORY 1 The Substitute Santa of Strathbungo from Norwegian Donald Julealbum 4, 2013 (First USA Publication) WRITER Knut Nærum and Tormod Løkling ARTIST Arild Midthun COLORIST Digikore Studios LETTERER Jesse Post DIALOGUE Byron Erickson EDITOR Sarah Gaydos STORY 2 PUBLISHER Ted Adams Scientific Sculptor from Donald Duck Sunday comic strip, 1963 ARCHIVAL EDITOR David Gerstein IFC DESIGNER Paul Hornschemeier WRITER Bob Karp COVER DESIGNER Tom B. Long ARTIST AND LETTERER Al Taliaferro COLORIST Digikore Studios REGULAR COVER Andrea Freccero REGULAR COVER colored by Mario Perrotta SUB COVER Marco Rota STORY 3 SUB COVER colored by Marco Colletti The Roundabout Rally RI COVER Marco Gervasio from Brazilian O Pato Donald 992, 1970 RI COVER colored by Marco Colletti (First USA Publication) WRITER Dick Kinney ARTIST Tony Strobl INKER Steve Steere COLORIST Digikore Studios LETTERER Jesse Post TRANSLATION David Gerstein DIALOGUE David Gerstein and Joe Torcivia Special thanks to Daniel Saeva, Julie Dorris, Manny Mederos, Roberto Santillo, Camilla Vedove, Stefano Ambrosio, Carlotta Quattrocolo, Chris Troise, Floyd Norman, and Thomas Jensen. For international rights, contact [email protected] Ted Adams, CEO & Publisher • Greg Goldstein, President & COO • Robbie Robbins, EVP/Sr. Graphic Artist • Chris Ryall, Chief Creative Officer • David Hedgecock, Editor-in-Chief • Laurie Windrow, Senior Vice President of Sales & Marketing • Matthew Ruzicka, CPA, Chief Financial Officer • Dirk Wood, VP of Marketing • Lorelei Bunjes, VP of Digital Services • Jeff Webber, VP of Licensing, Digital and Subsidiary Rights • Jerry Bennington, VP of New Product Development Facebook: facebook.com/idwpublishing • Twitter: @idwpublishing • YouTube: youtube.com/idwpublishing www.IDWPUBLISHING.com Tumblr: tumblr.idwpublishing.com • Instagram: instagram.com/idwpublishing UNCLE SCROOGE #21 (Legacy #425), DECEMBER 2016. -

Donald Duck: Timeless Tales Volume 1 Online
nLtTp (Free) Donald Duck: Timeless Tales Volume 1 Online [nLtTp.ebook] Donald Duck: Timeless Tales Volume 1 Pdf Free Romano Scarpa, Al Taliaferro, Daan Jippes audiobook | *ebooks | Download PDF | ePub | DOC #877705 in Books Scarpa Romano 2016-05-31 2016-05-31Original language:EnglishPDF # 1 10.38 x .97 x 7.63l, .0 #File Name: 1631405721256 pagesDonald Duck Timeless Tales Volume 1 | File size: 54.Mb Romano Scarpa, Al Taliaferro, Daan Jippes : Donald Duck: Timeless Tales Volume 1 before purchasing it in order to gage whether or not it would be worth my time, and all praised Donald Duck: Timeless Tales Volume 1: 7 of 7 people found the following review helpful. Nice book, great stories.By Dutch DelightWho does not like Donald Duck? Great collection of European and American artists. The book is hard cover, nicely made. needs to package it better though. You can't just stuff inside a cardboard sleeve and mail and not expect some damage. Wrap it in paper first to prevent scuffs.1 of 1 people found the following review helpful. Five StarsBy Mark NYAlways loved this type of comics.1 of 1 people found the following review helpful. Five StarsBy GrantLove it Wak! IDW's first six issues of Donald Duck are gathered in this classy collectorsrsquo; volume... including great works by Romano Scarpa, Giorgio Cavazzano, Daan Jippesmdash;and the first-ever US publication of "The Diabolical Duck Avenger," Donald's classic 1960s debut as a super-anti-hero! With special extras for true Disney Comics aficionados, this Donald compendium provides hours of history and excitement. -

Che Domandone Per Lo Zione!
Anteprima » Panini Comics L'ANGOLO DI VALENTINA CHE DOMANDONE PER LO ZIONE! � di Valentina De Poli osa capita se un gruppo di ingegneri e architetti appassionati (a dir poco!) di fumetto Disney si pongono delle domande Cfondamentali tipo: quanto denaro contiene il deposito di Zio Paperone? Quanto è grande? Quali sistemi di sicurezza lo proteggono dagli assalti della Banda Bassotti e della fattucchiera Amelia? Ma soprattutto, quanto dovrebbe essere grande un edi- ficio per contenere davvero i 9 fantasticatilioni, 4 biliongilioni, 6 centifrugalilioni, 8700 dollari e 16 cents che dice di possedere Zio Paperone? Be’, capita che per trovare le risposte nasce una mo- stra intitolata “Zio Paperone e i segreti del deposito”, che sarà inaugurata il 13 giugno presso WOW – Spazio Fumetto, museo del Fumetto, dell’Illustrazione e dell’Immagine animata di Milano Schizzi dedicati al deposito di Blasco Pisapia (info: www.museowow.it). La mostra propone un percorso ricchissimo che spazia tra fumet- to, autori, storia, progetti, spaccati, studi strutturali e modellini in 3D, difficile da riassumere in poche righe. Naturalmente il percor- so non può che cominciare con il grande Carl Barks, creatore di Paperon de’ Paperoni, che lo disegnò per la prima volta nel 1947 nella storia intitolata “Il Natale di Paperino su Monte Orso” (lettura consigliata: i primi 16 numeri di Uack! – Tutte le storie di Carl Barks). Un altro pilastro della mostra è la sezione dedicata alla famiglia dello Zione. Grazie a un’installazione multimediale si potranno scoprire tutti i legami di parentela della grande dinastia dei paperi (lettura consigliata: la raccolta Topolino Gold Edition che contiene la saga di “Zio Paperone e l’ultima avventura” di Artibani e Perina). -

The Illusion of Life: Disney Animation Interactive Edition
The Illusion of Life: Disney Animation Interactive Edition By Michelle L. Walsh Submitted to the Faculty of the Information Technology Program in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of Bachelor of Science in Information Technology University of Cincinnati College of Applied Science June 2006 The Illusion of Life: Disney Animation Interactive Edition by Michelle L. Walsh Submitted to the Faculty of the Information Technology Program in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of Bachelor of Science in Information Technology © Copyright 2006 Michelle Walsh The author grants to the Information Technology Program permission to reproduce and distribute copies of this document in whole or in part. ___________________________________________________ __________________ Michelle L. Walsh Date ___________________________________________________ __________________ Sam Geonetta, Faculty Advisor Date ___________________________________________________ __________________ Patrick C. Kumpf, Ed.D. Interim Department Head Date Acknowledgements A great many people helped me with support and guidance over the course of this project. I would like to give special thanks to Sam Geonetta and Russ McMahon for working with me to complete this project via distance learning due to an unexpected job transfer at the beginning of my final year before completing my Bachelor’s degree. Additionally, the encouragement of my family, friends and coworkers was instrumental in keeping my motivation levels high. Specific thanks to my uncle, Keith -

STORY 1 Blight Before Christmas STORY 4 High-Tech Herbert
STORY 2 Meter Your Maker from Italian Topolino 2299, 1999 (New to the USA) WRITER Alberto Savini ARTIST Corrado Mastantuono COLORIST Disney Italia with David Gerstein LETTERER Travis and Nicole Seitler TRANSLATION AND DIALOGUE David Gerstein STORY 3 Christmas Clubbing from Dutch Donald Duck 52/2002 (New to the USA) WRITER Kirsten de Graaf and Mau Heymans STORY 1 ARTIST Mau Heymans Blight Before Christmas COLORIST Sanoma with Travis and Nicole Seitler from Italian Almanacco Topolino 108, 1965 (New to the USA) LETTERER Travis and Nicole Seitler TRANSLATION AND DIALOGUE Thad Komorowski WRITER Abramo and Giampaolo Barosso ARTIST Giovan Battista Carpi COLORIST Digikore Studios with Dave Alvarez LETTERER Travis and Nicole Seitler TRANSLATION AND DIALOGUE Jonathan H. Gray STORY 4 High-Tech Herbert from Dutch Donald Duck 1/2013 (New to the USA) WRITER AND ARTIST Carlo Gentina COLORIST Sanoma LETTERER Travis and Nicole Seitler TRANSLATION AND DIALOGUE David Gerstein EDITORS STORY 5 Sarah Gaydos & The Sinister Space Santa Michael Benedetto from Italian Topolino 2730, 2008 (New to the USA) IFC DESIGNER Paul Hornschemeier WRITER Stefano Ambrosio ARCHIVAL EDITOR ARTIST Marco Mazzarello COLORIST Disney Italia with Travis and Nicole Seitler David Gerstein LETTERER Travis and Nicole Seitler COVER Giorgio Cavazzano TRANSLATION AND DIALOGUE Joe Torcivia COVER COLORS Disney Italia For international rights, Special thanks to Curt Baker, Julie Dorris, Manny Mederos, Roberto Santillo, Camilla Vedove, Stefano Ambrosio, and Carlotta Quattrocolo please contact -

Tutto Roma No Scarpa
PRESENTAZIONE TUTTO ROMA NO SCARPA Sera e Gazzetta dello Sport: la prima integrale lare in meno in una vignetta, se infastidisce mai realizzata su un autore italiano. Il segui- lo svolgimento della storia. Scarpa è la figu- to ideale di quelle intitolate ai due predeces- ra di riferimento di un movimento al quale ap- sori americani. partengono sceneggiatori e disegnatori: i con- temporanei Guido Martina e Giovan Battista I volumi che vi accompagneranno durante Carpi, Carlo Chendi e Luciano Bottaro, quin- questo 2014, ciascuno di 360 pagine, com- di Giorgio Pezzin e Bruno Concina, Sergio prendono, in ordine cronologico, tutta la pro- Asteriti e Pier Lorenzo e Massimo De Vita, duzione di Scarpa. Nella migliore edizione poi Giorgio Cavazzano con la sua rivoluzio- possibile e, dov’era il caso, restaurata. E non ne moderna, e i più giovani Francesco Artiba- solo le opere tratte da Topolino, Albi d’Oro, ni, Silvia Ziche, Corrado Mastantuono, Fabio Almanacco Topolino, Classici di Walt Disney, Celoni, Casty, e mi perdonino tutti quelli – albi e volumi speciali, Zio Paperone, Maestri anch’essi grandi – rimasti sulla tastiera del pc. Disney e riviste estere: sono state inserite an- arl Barks. Floyd Gottfredson. E Ro- Una parata dei personaggi creati da Scarpa, che le storie ancora inedite in Italia e alcune I quali forse sorrideranno ripensando a un’al- mano Scarpa. Non sembri sacrilego disegnati nel 1986 per i primi venti anni del addirittura mai pubblicate. In più, numerosi tra frase del grande Maestro: “Mi sento con- l’accostamento ai due storici autori Salone Internazionale dei Comics di Lucca. -

Paperinik, Ou Comment Les Italiens Sont Parvenus À Mettre Des Pantalons À Donald Duck
Paperinik, ou comment les Italiens sont parvenus à mettre des pantalons à Donald Duck Gianni Haver et Michaël Meyer Parmi la production des bandes dessinées Disney, un personnage peu connu dans le contexte francophone est pourtant un véritable mythe en Italie. Il est à la fois un héros apprécié pour les histoires dans lesquelles il apparaît et un ambassadeur de l’école Disney italienne. Il s’agit de Paperinik, le double super-héroïque de Donald Duck. Du point de vue de l’étude de la bande des- sinée, il constitue une figure très pertinente pour interroger la circulation des modèles visuels et narratifs de la culture de masse américaine, et leurs réap- propriations par le Vieux Continent. Pour faire apparaître les échanges et les hybridations qui sont à l’ori- gine du personnage de Paperinik, il est nécessaire d’effectuer un itinéraire qui tient compte à la fois de l’arrivée des productions Disney en Italie et de la diffusion des récits de super-héros américains. L’intégration de ces produc- tions dans le paysage culturel italien est démontrée par une appropriation rapide qui donne lieu à une production locale, aussi bien de récits Disney que d’aventures super-héroïques. Dans le cadre du personnage de Paperinik, ces influences vont se combiner avec des motifs issus de productions autochtones, en particulier les bandes dessinées mettant en scène des héros criminels. BD-US : les comics vus par Europe Disney en l’Italie Les personnages de Disney naissent aux États-Unis dans le cinéma d’anima- tion des années 1920, avant de connaître un rapide succès sous la forme de comic strips dès janvier 1930, puis de comic books. -

UNA RISTAMPA PIÙ VIVA CHE MAI! � Di Valentina De Poli
Anteprima » Panini Comics L'ANGOLO DI VALENTINA UNA RISTAMPA PIÙ VIVA CHE MAI! � di Valentina De Poli iccolo ripasso per chi non è venuto direttamente al tratti di una ristampa, ogni numero è vissuto in redazio- PalaPanini di Lucca per respirare, tra le tante altre ne con la stessa passione che mettiamo per tutte le Pattività proposte, una boccata di atmosfera uscite nuove… La carica e l’entusiasmo con cui vengo- pikappica… L’occasione da vivere era il lancio del no preparate le pagine sono gli stessi delle origini, le mensile PK GIANT - 3K EDITION, che dall’8 di questo risate idem, per non parlare dell’emozione nel riportare mese arriva anche alla luce cose in edicola e fumet- entrate nel dimenti- teria. Si tratta della catoio o addirittura ristampa della mai notate prima. E celeberrima saga di poi, diciamocela PKNA con cover tutta: mi era presa inedita su tutti i un’invidia mostruo- numeri. Nell’albo sa per il Rat-Man trova una dignito- Gigante… Così, sissima collocazione quando abbiamo anche una Pkmail constatato che tutta nuova, degna PKNA era da delle migliori pochissimo diven- tradizioni e che da tato maggiorenne ora, mese dopo Folla di Pkers: le “gabbie” sono state riaperte a Claudio Sciarrone ha lasciato la sua firma, anzi il (prima apparizione: luglio presso il WOW Spazio Fumetto di Milano. suo murales, oggi meta di pkellegrinaggi, sulle mese, si prenderà A 18 anni dall’uscita di PKNA c’erano ancora tutti! pareti del cortile del WOW Spazio Fumetto. marzo 1996) ci cura di vecchi e siamo detti: be’, è nuovi Pkers. -
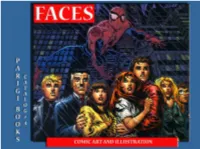
Faces Illustration Featuring, in No 1
face Parigi Books is proud to present fās/ a selection of carefully chosen noun original comic art and noun: face; plural noun: faces illustration featuring, in no 1. particular order, the front part of a person's Virgil Finlay, John Romita, John Romita, Jr, Romano Scarpa, head from the forehead to the Milo Manara, Magnus, Simone chin, or the corresponding part in Bianchi, Johnny Hart, Brant an animal. Parker, Don Rosa, Jeff MacNelly, Russell Crofoot, and many others. All items subject to prior sale. Enjoy! Parigi Books www.parigibooks.com [email protected] +1.518.391.8027 29793 Bianchi, Simone Wolverine #313 Double-Page Splash (pages 14 and 15) Original Comic Art. Marvel Comics, 2012. A spectacular double-page splash from Wolverine #313 (pages 14 and 15). Ink and acrylics on Bristol board. Features Wolverine, Sabretooth, and Romulus. Measures 22 x 17". Signed by Simone Bianchi on the bottom left corner. $2,750.00 30088 Immonen, Stuart; Smith, Cam Fantastic Four Annual #1 Page 31 Original Comic Art. Marvel Comics, 1998. Original comic art for Fantastic Four Annual #1, 1998. Measures approximately 28.5 x 44 cm (11.25 x 17.25"). Pencil and ink on art board. Signed by Stuart Immonen on the upper edge. A dazzling fight scene featuring a nice large shot of Crystal, of the Inhumans, the Wakandan princess Zawadi, Johnny Storm, Blastaar, and the Hooded Haunt. Condition is fine. $275.00 29474 Crofoot, Russel Original Cover Art for Sax Rohmer's Tales of Secret Egypt. No date. Original dustjacket art for the 1st US edition of Tales of Secret Egypt by Sax Rohmer, published by Robert McBride in 1919, and later reprinted by A. -

Walt Disneys Donald Duck: Scandal on the Epoch Express : Disney Masters Vol
WALT DISNEYS DONALD DUCK: SCANDAL ON THE EPOCH EXPRESS : DISNEY MASTERS VOL. 10 PDF, EPUB, EBOOK Mau Heymans | 192 pages | 14 Apr 2020 | FANTAGRAPHICS BOOKS | 9781683962496 | English | United States Walt Disneys Donald Duck: Scandal on the Epoch Express : Disney Masters Vol. 10 PDF Book Donald Duck Adventures Disney. Donald Duck Coloring Book Whitman Disney Comics Special Donald Duck Of course, once again all the stories have been shot from crisp originals, then re-colored and printed to match, for the first time since their original release over 60 years ago, the colorful yet soft hues of the originals-and of course the book is rounded off with essays about Barks, the Ducks, and these specific stories by Barks experts from all over the world! Anthropomorphic animals Adventure. You can help Wikipedia by expanding it. I love the Disney Masters series because we get treated to stories and illustrations from other great Duck comic creators besides the legendary Barks and Rosa. Donald Duck Beach Party Bas Heymans was born in in Veldhoven, Netherlands. Post was not sent - check your email addresses! Email required Address never made public. Published Nov by Fantagraphics. Notify me of new posts via email. Date This week Last week Past month 2 months 3 months 6 months 1 year 2 years Pre Pre Pre Pre Pre s s s s s s Search Advanced. Other books in the series. In this collection of comics stories, Donald battles master spies and his own Uncle Scrooge! There was a dinner meeting that took place in September that they both attended among some Disney comic greats from California and Italy. -

Abramo E Gian Paolo Barosso: Trecento E Più Occasioni Per Risate Intelligenti
Abramo e Gian Paolo Barosso: trecento e più occasioni per risate intelligenti Francesco Stajano http://www.cl.cam.ac.uk/~fms27/ febbraio–marzo 2008 I fratelli Abramo e Gian Paolo Barosso hanno lavorato come autori Disney per una quindicina d’anni abbondante, producen- do oltre trecento ottime storie in collaborazione con tutti i più famosi disegnatori Disney italiani; eppure sono stati fino ad ora quasi completamente ignorati sia dal pubblico che dalla critica. Anche un appassionato di fumetti con una biblioteca ben fornita avrà difficoltà a reperire su di loro molte più informazioni di quelle contenute nelle utilissime ma stringate schede biografiche compi- late dall’enciclopedico studioso disneyano Alberto Becattini per l’appendice del fondamentale volume I Disney Italiani (Granata Press, 1990). Dalle due schede, di appena undici e diciannove righe rispettivamente, apprendiamo le date di nascita, rispettivamente 1931 e 1936, l’origine torinese e il periodo di attività disneyana, 1960–1976. Apprendiamo inoltre che il fratello maggiore Abramo è laureato in ingegneria, che era scrittore per hobby e che iniziò a scrivere soggetti disneyani su incoraggiamento di Giovan Battista Carpi. Becattini inoltre indica che Abramo scriveva i soggetti men- tre Gian Paolo stendeva le sceneggiature, ma che nel 1974 Abramo passò anche a sceneggiare. Confrontando questa indicazione cro- nologica con i dati del database INDUCKS1 risulta che le storie di produzione barossiana dal 1974 in poi sono in realtà solo quat- tro (due nel 1975 e due nel 1976, tutte attribuite al solo Abramo ma ciò probabilmente proprio a seguito dell’indicazione becatti- niana e non in base a dati indipendenti) per cui appare lecito, per semplicità, attribuire l’intero corpus di storie ad entrambi i fratel- li insieme, considerandoli come un’unica entità creativa, anziché tentare di separarne e distinguerne i contributi. -

L'inferno a Fumetti Di Guido Martina E Angelo Bioletto
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO FACOLTÀ DI STUDI UMANISTICI Corso di Laurea Triennale in Lettere Una parodia della Commedia: l’Inferno a fumetti di Guido Martina e Angelo Bioletto Relatore: Chiar.ma Prof.ssa Giuliana NUVOLI Elaborato Finale di: Martina ANGELILLO Matr. n. 828315 Anno Accademico 2015/2016 Indice Introduzione………………………………………………………………….........3 I. Cronistoria di Topolino……………………………………………………….6 §1. Topolino in Italia……………………………………………………..13 §2. Le Grandi Parodie Disney…………………………………………...19 II. L’Inferno di Topolino di Guido Martina e Angelo Bioletto………………...22 §1. Topolino vian-Dante………………………………………………....25 III. Come nasce un fumetto …………………………………………………….45 §1. Le vignette e i disegni de L’Inferno di Topolino…………………........47 §2. I balloons e le didascalie de L’Inferno di Topolino…………...…......57 §3. Dal verso di Dante al verso di Martina………………………………63 Bibliografia…………………………………………………………………........68 Sitografia…………………………………………………………………………70 2 Introduzione L’inferno di Topolino è la riscrittura in chiave parodica della cantica infernale di Dante Alighieri. Il fumetto è frutto della collaborazione di due menti geniali: Guido Martina e Angelo Bioletto; i due, che operano fuori dal coro, contribuiscono alla creazione di qualcosa di assolutamente innovativo. La riscrittura parodica della Commedia è un potente motore che genera storie; si tratta di mutuare uno schema narrativo che funziona, lasciare in controluce l’originale, e infine modificare quanto basta affinché l’opera risulti adeguata al nuovo contesto. Guido Martina e Angelo Bioletto scrivono un’opera intergenerazionale: sarebbe infatti riduttivo relegare L’Inferno di Topolino ad un prodotto per l’infanzia. Scrive Faeti: «I “riscrittori” sminuzzano, triturano e soprattutto (almeno apparentemente) addolciscono, con il miele dell’ironia, i bocconi indubitabilmente salutari per lo stomaco adulto e poco appetibili per le bocche infantili»1.