Studi Veronesi IV
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Putri Sulistyowati Sasongko 28/05/15 Modern Approach of Conserving
Modern Approach of Conserving Historic Buildings ‘Castelvecchio & Palazo Chiericati’ By Putri Sulistyowati Sasongko Kingston University London The Journey to Observe and Study the Buildings from the Trip to Italy, 23 – 27 March 2015. The study trip itinerary had provided the list of from the study trip, focusing on the observation historic buildings that are mostly designed by of conservation works on both Castelvecchio Andrea Palladio, an internationally well-known (Verona) and Palazzo Chiericati (Vicenza). Italian architect from the 16th Century. With the Even though Castelvecchio was not designed influence of Greek and Roman style by Palladio, the castle was chosen along with architecture, he also produced many of Palazzo Chiericati to be part of the case study, renaissance style buildings. Palladio is focusing on their similar approaches of the considered as one of the most influential conservation works for the building. architects in the history of European architecture. Many of his works were found in all over Italy. However, the three points of areas of study are in Vicenza, Verona, and Venice. With its historic buildings that were born earlier than United Kingdom, the Italian style architecture influenced the United Kingdom and showed the resemblance in many of the Figure 1. Castelvecchio, Restored by Carlo Scarpa in 1958 – buildings as well. Therefore, it shows that 1974 (by writer) nothing is really ‘pure’ in architecture styles, design and art- they are the group and compilations of everything that were affecting the object. This trip was considered as an architectural trail for where the students were trying to find and history and character of Italian architecture. -

And Symbolism in Virgin with Child, Young St. John
The Biota of the Florentine Tondo: a biological survey and symbolism in Virgin with Child, Young St. John the Baptist and an Angel by Piero di Cosimo (1462-1522) A Biota do Tondo Florentino: levantamento biológico e simbolismo em Virgem com o Menino, São João Batista Criança e um Anjo de Piero di Cosimo (1462-1522) DOI: 10.20396/rhac.v1i1.13693 INÁCIO SCHILLER BITTENCOURT REBETEZ Programa de Pós-graduação em História da Arte, Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP) 0000-0002-5084-010X ALCIMAR DO LAGO CARVALHO Museu Nacional, Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) 0000-0002-5588-788X Abstract This paper describes and identifies the biological elements depicted in Virgin with Child, Young St. John the Baptist and an Angel by Piero di Cosimo (1462-1522) from the permanent collection of the Museu de Arte de São Paulo Assis Chateaubriand, which include a bird, an insect, a mushroom and 10 vegetables, seven of which in flowering. Starting with an analysis of the probable symbolic roles of each biological element based on individual natural and biological properties then proceeding to interpret the presence of each vis-à-vis its relation to the others, this article shows the undeniable convergence of each object’s meaning: birth, death and regeneration (or reproduction) likened to the birth, death and resurrection of Christ. Keywords: Piero di Cosimo. Biological survey. Symbolism. Resumo Neste artigo, os itens biológicos representados na Virgem com o Menino, São João Batista Criança e um Anjo de Piero di Cosimo (1462-1522), do acervo do Museu de Arte de São Paulo Assis Chateaubriand, incluindo um pássaro, um inseto, um cogumelo e dez vegetais, sete deles com flores, foram descritos e identificados. -
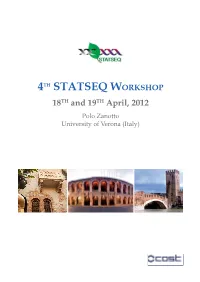
Workshop Booklet Available(Pdf)
4TH STATSEQ WORK S HOP 18TH and 19TH April, 2012 Polo Zanotto University of Verona (Italy) 3 INDEX 4TH STATSEQ WORK S HOP 18TH and 19TH April, 2012 Polo Zanotto - University of Verona (Italy) COMMITTEES & SECRETARIATS page 5 PROGRAM page 6-7 ORAL PRESENTATIONS page 9 From one for all to all for one: the NGS revolution in plant science research page 11 Assembly and temporal characterization of the V. vinifera cv. Corvina berry transcriptome page 12 TransPLANT, developing a trans-National infrastructure for Plant Genomic Science page 13 NGS data processing with Conveyor workflows page 14 MotifLab: A tools and data integration workbench for motif discovery and regulatory sequence analysis page 15 Genome-wide methods for the study of DNA-methylation inheritance page 16 A statistical approach to estimate copy number from NGS capture sequencing data page 17 Variability in RNA-seq: design and modeling page 18 A Comprehensive Evaluation of Normalization Methods for High-Throughput RNA Sequencing Data Analysis page 19 Model-based clustering for high-throughput sequencing data to determine similar expression profiles across genes page 20 Haplotype estimation and imputation using low-coverage sequence data page 21 SNP discovery from Next Generation Sequencing to study for genome variation in Arabis alpina natural populations page 22 Genotyping by sequencing tetraploid potato and attempts towards reconstruction of haplotypes page 23 Genotyping by Sequencing in Maize page 24 The effect of LD between SNPs on some statistical methods for GWAS page 25 -
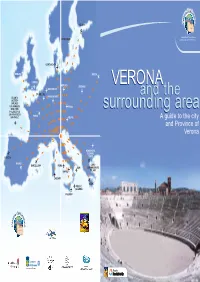
VERONA Surrounding Area VERONA Surrounding Area
Consorzio di Promozione e Commercializzazione Turistica VERONAVERONAand the surroundingsurroundingand the areaarea A guide to the city and Province of Verona TRAVEL DISTANCE BY Legend: MOTORWAY FROM VERONA TO: Trento km. 103 Fair Bolzano km. 157 Airport Vicenza km. 51 Venice km. 114 Lake Garda Brescia km. 68 Lessinia Milan km. 161 Bologna km. 142 Veronese Plain Florence km. 230 Soave Rome km. 460 Valpolicella Verona AFFI VERONA and the surrounding area A guide to the city and Province of Verona Verona Tuttintorno is proud to present the new edition of "Verona and the Surrounding Area - A Guide to the City and Province of Verona". The publication provides a general overview of the area's riches, and describes 30 fascinating itineraries to explore. The guide represents a collaborative effort between the Consortium and its members: travel agencies, hoteliers, restaurant owners, wineries, the Wine Road association, local government, transportation agencies, and tourist-sector service providers of every kind. The included itineraries offer a myriad of possibilities for enjoying the area's cultural riches, its nearby mountains, lake, and plain, getting and its world-famous enogastronomic traditions. Verona Tuttintorno, a consortium of businesses dedicated to promoting local tourism and the cultural, environmental, and enogastronomic to Verona patrimony of the City and Province of Verona, also offers up-to-date information and itinerary planning assistance for those wishing to make Verona and the surrounding area their next vacation destination. BY CAR BY TRAIN BY PLANE Enjoy Verona and the surrounding area!!! The A4 Motorway crosses the province Verona is served by the main train line The Valerio Catullo Airport, situated in of Verona from east to west. -

Bibliografia Veronese 2009 2011 Viviani Volpato UV 2014.Indd
G. F. VIVIANI ACCADEMIA DI AGRICOLTURA SCIENZE E LETTERE DI VERONA G. VOLPATO UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI VERONA BIBLIOGRAFIA VERONESE BIBLIOGRAFIA VERONESE (2009-2011) (2009-2011) di GIUSEPPE FRANCO VIVIANI e GIANCARLO VOLPATO Supplemento al vol. 185° degli Atti e Memorie dell’Accademia di Agricoltura Scienze e Lettere di Verona MMXIV VERONA · MMXIV ISBN 978-88-98513-63-5 Volumi pubblicati della “Bibliografia Veronese” Volume I: 1966-1970 (esaurito) Volume II: 1971-1973 (esaurito) Volume III: 1974-1987 (esaurito) Volume IV: 1988-1992 (esaurito) Volume V: 1993-1996 (esaurito) Volume VI: 1997-1999 (esaurito) cd: 1966-1999 (esaurito) Volume VII: 2000-2002 (esaurito) Volume VIII: 2003-2005 Volume IX: 2006-2008 Volume X: 2009-2011 ACCADEMIA DI AGRICOLTURA SCIENZE E LETTERE DI VERONA UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI VERONA BIBLIOGRAFIA VERONESE (2009-2011) di GIUSEPPE FRANCO VIVIANI e GIANCARLO VOLPATO Supplemento al vol. 185° degli Atti e Memorie dell’Accademia di Agricoltura Scienze e Lettere di Verona VERONA · MMXIV Pubblicato con il contributo del Fondo di ricerca (ex 60%) © 2014 - Dipartimento Tempo Spazio Immagine Società (TeSIS) Università degli Studi di Verona Impaginazione e stampa: Tipolitografia «La Grafica», Vago di Lavagno (Verona) ISBN 978-88-98513-63-5 INDICE Presentazione 7 Al Lettore 9 Selezione dalla critica: non per gloria né per interesse 11 Abbreviazioni 25 Avvertenza 29 Piano di classificazione 31 schede bibliografiche Generalità 41 Filosofia e discipline connesse 53 Religione 56 Scienze sociali 71 Linguistica 115 Scienze pure 120 Tecnologia (Scienze applicate) 129 Arti 135 Letteratura 206 Storia e Geografia 239 Indice degli autori 401 Indice dei soggetti 429 PRESENTAZIONE Sono trascorsi molti anni da quando i due autori della Bibliografia veronese hanno cominciato a lavorare assieme: siamo stati abituati, ormai, ad aspetta- re, a ritmi cadenzati ma sempre precisi, i loro volumi. -

C Arlo Sc Arp A
THE SHAPES OF LIGHT CARLO SCARPA CARLO CARLO SCARPA Magonza I will say right away that Carla Scarpa has always been a secret idol of mine. Secret because art and architec- ture go hand in hand, but without exchanging opinions or confidences. However, certain aspects and, in general, all his work, have established some modalities of partici- pating in space, of using and respecting materials, which have become true principles of a language that is not only architectural. Giulio Paolini Published on the occasion of Carlo Scarpa. The Shapes of Light curated by Marco Arosio and Paolo Repetto 26 September – 26 October 2018 Repetto Gallery 23 Bruton Street, W1J 6QF, London repettogallery.com CARLO SCARPA THE SHAPES OF LIGHT Magonza 6 Carlo Scarpa. The Shapes of Light Paolo Repetto 26 A Proud Venetian Charles Hind 66 Biography CARLO SCARPA. THE SHAPES OF LIGHT by PAOLO REPETTO “For an architect the most important thing in the the one able to sing. In the book Socrates is world, in life, is to be able to know the hour by looking surprised and enchanted by one of Eupalin- at the sky, to recognize the hours of the morning, of os’s precepts: “My temple must move men the day, of the evening; one must know the vibrations, the way they are moved by the object they the half tones; one must acquire the visual power nec- love”. Eupalinos was the symbol of perfection essary to dream things.” What is architecture? What of ancient Greek architecture, admired by are these solid, static shapes that separate us from Socrates and Phaedrus, and he dedicated space, from the sky, from light? What are these par- his temple to Hermes to his love, a beautiful allelepipeds, these – often ugly – elaborate cubes in girl from Corinth – a temple where one “feels which we live? Beyond its first function, which is that the presence of a person, of a woman at the of providing shelter from the cold and the heat, from moment of her blossoming, the harmony of rain, from wind and snow, a house, architecture, can be a captivating being.” The harmony of a form much more. -

Arq . Vol 8 . No 2 . 2004 Design 128 Kali Tzortzi Building and Exhibition
128 arq . vol 8 . no 2 . 2004 design 1 Castelvecchio Museum, Verona: view through 1 painting galleries Kali Tzortzi Building and exhibition layout design A comparative analysis of the Sainsbury Wing of the National Gallery, London, and the Castelvecchio in Verona demonstrates that spatial structure is a powerful variable in museum experience. Building and exhibition layout: Sainsbury Wing compared with Castelvecchio Kali Tzortzi Introduction Spatial properties of the layout It has always been thought that there are two Let us begin by exploring the patterns of spatial dimensions in museum experience: the experience organisation and the spatial qualities of the two of space which can be distinguished from that of contrasting layouts. Major axes are the recurrent exhibits, as the former is largely non-discursive while theme of both. In particular, the powerful axiality is the latter is more in the discursive domain.1 This the key structural property of the layout of the paper aims to contribute to the description and Sainsbury Wing [2]. The whole structure is created by understanding of the intricate pattern of two intersecting major axes: a cross perspective axis, interdependencies between the two parameters of which is a continuation of the central axis of the the microstructure of the gallery space, the design main building, and penetrates the whole width of of space and of the display layout. The paper uses the extension; and another, vertical axis which rigorous methods of ‘spatial data’ collection and crosses the central enfilade of rooms and runs across analysis (analytic representations of spatial the whole length of the extension. -

Castelvecchio Museum- Verona (ITALY) 1959-1973
CARLO SCARPA Castelvecchio Museum- Verona (ITALY) 1959-1973 Castelvecchio Museum (Italian: Museo Civico di Castelvecchio) is a museum in Verona, northern Italy, located in the eponymous medieval castle. Restoration by the architect Carlo Scarpa, between 1959 and 1973, has enhanced the appearance of the building and exhibits. Scarpa's unique architectural style is visible in the details for doorways, staircases, furnishings, and even fixtures designed to hold a specific piece of artwork. The museum displays a collection of sculpture, statues, paintings, ancient weapons, ceramics, goldworks, miniatures and some old bells. Sculptures, and Pictures mostly from the Romanesque period of Verona, The images of this museum are a revelation, with art being displayed in such a considered and sensitive way. It shows an approach to restoration integrating new and old that was so in advance in 1970’. Scarpa decided to place the statue of Cangrande della Scala outside of the museum, under a roof and visible to population, as a matter of fact the statue had always been on the the top of the mausoleum in the city of Verona. In this way Cangrange becomes the hinge that connects several parts of the museum, visitors percive it from the courtyard, behind the wall that separates the residential area from the militar one and even on the top of the walkway. CARLO SCARPA Castelvecchio Museum- Verona (ITALY) 1959-1973 Scarpa used modern materials to create a platform for artwor In the ground-floor sculpture galleries he created a five-room enfilade, drawing visitors through each opening with the use of large, thick, textured slabs of stone that clad the archways to create a more human scale to the dimensions of the passageway, matched to the spring line of the arches. -

Re:Reading Scarpa
Montreal Architectural Review Re:Reading Scarpa Marc J. Neveu Woodbury University Some books are to be tasted, others swallowed, and some few to be chewed and digested. — Sir Francis Bacon Abstract During the 1985-86 academic year Italo Calvino gave the Eliot Norton Lectures at Harvard University. In his third talk on “Quickness” he declared, “I do not wish to say that quickness is a value in itself. Narra- tive time can also be delaying, cyclic, or motionless. In any case, a story is an operation carried out on the length of time involved, an enchantment that acts on the passing of time, either contracting or dilating it.”1 Umberto Eco, a decade later, referenced Calvino in the third of his own lectures at Harvard entitled “Lingering in the Woods.”2 In that essay, Eco described a number of temporal strategies employed by various authors who explore the pleasures of lingering. In this short essay I will show that such temporal tactics described discussed by Eco and Calvino share uncanny similarities Carlo Scarpa’s architecture. It is my wager that a careful reader of Scarpa’s work will, inevitably, linger. I will discuss two museum projects in particular—the extension to the Cano- va Museum in Possagno and the renovation of the Castellvechio Museum, in Verona—in both of which Scarpa intentionally posits disruptions in the uniform nature of processional time through the work and location of art. Indeed, Scarpa’s work is full of delays, distractions, and redirections that, if followed, pres- MAR Volume 2, 2015 28 Marc J. -

Case Studies on the Relationship of Old and New in Architecture
CASE STUDIES ON THE RELATIONSHIP OF OLD AND NEW IN ARCHITECTURE A thesis submitted to the Kent State University Honors College in partial fulfillment of the requirements for General Honors by Jessica Stuck May, 2012 Thesis written by Jessica Stuck Approved by ________________________________________________________________, Advisor ______________________________________________, Dean, College of Architecture Accepted by _____________________________________________________, Dean, Honors College ii TABLE OF CONTENTS LIST OF FIGURES............................................................................................................iv ACKNOWLEDGEMENTS................................................................................................vi CHAPTER I. INTRODUCTION.......................................................................................1 II. ALTE PINAKOTHEK.................................................................................5 III. CASTELVECCHIO...................................................................................14 IV. EICHSTATT WAISENHAUS..................................................................31 V. CONCLUSIONS.......................................................................................44 BIBLIOGRAPHY..................................................................................................54 iii LIST OF FIGURES Figure 1. The Alte Pinakothek Southern Facade.........................................................5 Figure 2. The Present South Façade of the Alte -

Untitled, 1984
MAURO FIORESE I MUV GAM GALLERIA Treasure Rooms (2014 - 2016) I MUSEI D’ARTE MODERNA DI VERONA ACHILLE FORTI 5 aprile - 22 settembre 2019 Cultura Galleria d’Arte Moderna Achille Forti Sindaco di Verona Mostra organizzata da Galleria d’Arte Moderna Achille Forti Direzione della mostra Catalogo a cura di Foto a p. 25: New York, Metropolitan Museum Federico Sboarina Galleria d’Arte Moderna Achille Forti, Direttore Francesca Rossi Patrizia Nuzzo e Beatrice Benedetti of Art. Acquisto, dono della Horace W. Goldsmith Verona Francesca Rossi Foundation, tramite Joyce e Robert Menschel, 1992 Assessore alla Cultura e Turismo Mostra a cura di Testi di (1992.5112). © Yves Klein, by SIAE 2019; John Kender Francesca Briani Curatore Responsabile delle Collezioni d’Arte Patrizia Nuzzo e Beatrice Benedetti Elisabetta Barisoni, Beatrice Benedetti, © Roy Lichtenstein Foundation; Harry Shunk © Getty in collaborazione con Moderna e Contemporanea Clarenza Catullo, Anna Coliva, Michele Coppola, Research Institute. © 2019. Image copyright The Direzione Area Cultura Patrizia Nuzzo Segreteria organizzativa della mostra Mauro Fiorese, Tiziana Maffei, Paola Marini, Gabriele Ren Roberta Bordignoni, Giulia Petrucci (Boxart Galleria Alessandra Mottola Molfino, Patrizia Nuzzo, Metropolitan Museum of Art/Art Resource/Scala, Segreteria di Direzione d’Arte) e Beatrice Sartori Riccardo Passoni, Angela Andreina Rorro, Firenze Direttore Musei Civici di Verona Alberta Faccini Francesca Rossi, Valeria Sanpaolo, Massimo Osanna Francesca Rossi Coordinamento organizzativo Progetti -

News in IIC Los Angeles Congress Countdown
News in Conservation The e-paper from the International Institute for Conservation of Historic and Artistic Works …………………………………………………………………… ……. Issue 54, June 2016 IIC Los Angeles IIC 2016 Los Angeles Congress - Congress countdown - See details of excursion programme and other excursions and highlights on page 1-3 IIC Membership programme highlights renewal - © Chris Chris Burden © 2016-17 memberships now available. See how to renew or join on page 19 From the Monuments Man to IIC – the need for change Read a message from IIC President Sarah Staniforth on pages 8-9 Improving preservation parameters at the Chris Burden Urban Light, 2008 (Two-hundred and two) restored cast iron antique street lamps 320 1/2 x 686 1/2 x 704 1/2 in. (814.07 x 1743.71 x 1789.43 cm) Los Angeles County Museum of Art, The Napier Museum – Gordon Family Foundation's gift to "Transformation: The LACMA Campaign" (M.2007.147.1-.202) Read the full article from Tanushree Gupta LOS ANGELES – No IIC Congress would be complete without a fantastic on pages 10-12 excursion programme to match the richness and variety of the formal technical programme. Four-and-a-half days of paper presentations examining the Congress theme will be complemented by a variety of tour options exploring the familiar and the exclusive in and around Los Angeles. In addition, a social calendar of events will allow participants to meet conservation colleagues and network with contacts old and new. The social calendar will include two receptions and a Grand Event at Los Angeles’s most important museum and cultural centres, the Museum of Contemporary Art Los Angeles (MOCA), the Broad, and the www.iiconservation.org Continued… News in Conservation, June 2016 2 ………………………………………………………………………….