Seconda Sezione
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

200 Modi Per Recuperare Un Hard Disk
Retrocomputer Magazine Anno 2 - Numero 9 - Maggio/Giugno 2007 In prova: Jurassic Olivetti Linea 1 News Esclusiva: I migliori PC di tutti i tempi Inoltre: Virtual Texas Instruments disk Laboratorio: 200 modi per recuperare un hard Jurassic News - Anno 2 - numero 9 - maggio/giugno 2007 Jurassic News Sommario - Maggio/Giugno 2007 Rivista aperiodica di Retro Computing Editoriale Apple Club Coordinatore editoriale Novità in vista, 3 Tutti i linguaggi di Apple Tullio Nicolussi [Tn] (parte 1), 62 Redazione Retrocomputing Sonicher [Sn] Esseri liberi, 4 Retro Linguaggi I migliori PC di tutti i tempi, 6 COBOL (parte 4), 74 Hanno collaborato a questo numero: Salvatore Macomer [Sm] Come eravamo Videoteca Lorenzo 2 [L2] Maggio 1982, 14 2010 l’anno del contatto, 72 Besdelsec [Bs] Giugno 1982, 15 Edicola Impaginazione e grafica Le prove di JN Anna [An] Pluto Journal, 66 Olivetti L1, 16 Nuova Elettronica Z80, 38 Diffusione Retro Software [email protected] Visicalc, 68 Il racconto La rivista viene diffusa in Una giornata di Ivan Ivanovich, formato PDF via Inter- Biblioteca 24 net. Il costo di un singolo Linux Bible, 80 numero è di Euro 2. 101 Reasons: To Switch to the Abbonamento annuale (6 Retro Riviste MAC, 82 numeri) Euro 6. Olivetti Research & Tecnology Arretrati Euro 2 a numero. Review , 36 L’intervista Contatti Conversazione con Gianfranco, [email protected] Laboratorio 84 200 modi per resuscitare un HD Copyright L’opinione I marchi citati sono di (parte 1), 50 Della Pirateria, 88 copyrights dei rispettivi proprietari. Emulazione La riproduzione con qual- Virtual TI 2.5, 48 BBS siasi mezzo di illustrazioni Scumm e ScummVM, 56 Posta e comunicazioni, 94 e di articoli pubblicati sulla rivista, nonché la loro tra- duzione, è riservata e non può avvenire senza espres- sa autorizzazione. -

Comunità Per Le Libere Attività Culturali Associazione Di Associazioni Senza Scopo Di Lucro – C
Comunità per le Libere Attività Culturali Associazione di Associazioni Senza Scopo di Lucro – C. F. 92000330289 Segreteria Generale, Laboratorio Culturale, Biblioteca e Centro Documentazione Via Alvise Cornaro 1 B, 35128 Padova – Tel. +393288151502 www.clacpd.org Spett.le Settore Patrimonio e Partecipazioni del Comune di Padova Ufficio Postale Padova Centro Casella Postale Aperta 35122 Padova e, p. c., Settore Edilizia Pubblica ed Impianti Sportivi del Comune di Padova c. a. Arch. Domenico Lo Bosco p. c., Assessore alla Cultura e Musei, Edilizia M onumentale e Turismo del Comune di Padova dott. Andrea Colasio p. c., Assessore all’Ambiente, Verde, Parchi e Agricoltura del Comune di Padova dott.ssa Chiara Gallani p. c., Assessore al Patrimonio, Edilizia Comunale, Valorizzazione della Cinta Muraria e del Parco delle Mura del Comune di Padova dott. Andrea Micalizzi p. c., Soprintendenza Archeologia, Belle Arti Paesaggio per l’area metropolitana di Venezia e le province di Βelluno, Padova e Treviso c. a. Arch. Andrea Alberti Via Aquileia, 7 35139 Padova p. c., Comitato Mura di Padova Via Raggio di Sole, 2 35138 Padova p. c., Associazioni Consociate alla CLAC Via Alvise Cornaro, 1 B 35128 Padova p. c., Avvocato Carlotta Traballi Riviera Tiso da Camposampiero, 29 35122 Padova RACCOMANDATA A. R. Padova, 9 maggio 2018 Oggetto: Vs. Richiesta di sgombero del materiale presso l’ex Macello di Via Cornaro del 07/05/2018 Pagina 1 di 3 Con grande rammarico constatiamo con quale intempestività ci raggiunge la Vs. in oggetto proprio nel momento in cui, da alcune settimane a questa parte, siamo tornati a discutere e fare nuove proposte sia con gli Assessori che con gli Uffici del Comune, tra cui il Vostro, proprio sulla destinazione dell’intera area in oggetto. -

Towards an Improved Theory of Disruptive Innovation: Evidence from the Personal and Mobile Computing Industries
Towards an Improved Theory of Disruptive Innovation: Evidence from the Personal and Mobile Computing Industries Juan Sebastian Montoya, Doshisha University, Japan Toshiro Kita, Doshisha University, Japan The Asian Conference on the Social Sciences 2017 Official Conference Proceedings Abstract This research studies the concept of disruptive innovation, its patterns, and the mechanisms that cause it. By using quantitative and qualitative evidence from the personal and mobile computing industries, this research serves to corroborate Clayton Christensen's disruption theory, the main theory proposed today as an explanation of this phenomenon. It identifies the strengths and weakness of the theory, and builds upon it in order to propose an improved theory of disruption. In order to measure disruption in the personal and mobile computing industries this research collected data for 58 product lines, including personal computers and smartphones developed by companies in America, Europe, and Asia from 1974 to 2015. A correlation analysis validated the foundations of Christensen's model, however it also revealed many unexpected results such as the importance of radical innovation and architectural innovation. Further qualitative historical analysis corroborated these results. The main finding of this research was identifying three different types or phases of disruption and proposing an original categorization for them: 1) disruption by creation of a new market, 2) disruption by 'mainstreamization' of the market, and 3) disruption by commoditization of the market. This represents an improvement over the current understanding of the theory from a macro perspective. Keywords: Innovation, disruption, technology, management, design, new market, commoditization, computing, mobile iafor The International Academic Forum www.iafor.org 1. -

System Support Addendum
System Support Addendum PRODUCT NAME: PATHWORKS for DOS, Version 4.0 SSA 55.07.1 G-A (Formerly DECnet PCSA Client for DOS) HARDWARE REQUIREMENTS Maximum disk space required for the installation of all PATHWORKS for DOS software is 12MB of tree disk Systems, components, and peripherals specified be space (or 23,000 blocks on a VMS server). low are supported except as noted for specific software components: Other configurations, using selected components, may require less disk space. • An Intel® 8086-, 8088-, 80286-, 80386-, 80486- based personal computer from the Supported Base Systems Chart. OPnONALHARDWARE • A minimum of 640KB system memory. Expanded Memory Specification Version 4.0 Support • One network connection, either asynchronous or via PATHWORKS for DOS software supports the use of Ex an Ethernet controller. Refer to the Supported Base panded Memory Specification (EMS) applications that Systems Chart at the end of this document for a list are EMS, Version 4.0 compliant. The PATHWORKS for of supported Ethernet controllers in the various sup DOS networking software that can be loaded into EMS ported systems. More than one communications de requires 144KB of memory. vice may be installed in a system subject to system limitations. If use of another device is required, the Digital Printers system may need to be rebooted. A device cannot typically be shared with other communications prod PATHWORKS for DOS software supports the following ucts. Digital printers which can be connected to the PC: • In a PC local area network, at least one base system LA75 LA75P must have one diskette drive capable of reading 5.25 LA50 LA210 inch (360KB) diskettes or 3.50 inch (720KB) diskettes W250 W252 to load the distribution media. -
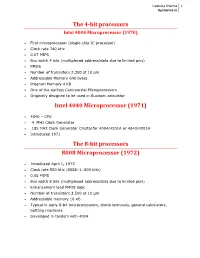
The 4-Bit Processors Intel 4040 Microprocessor
Upendra Sharma 1 Upsharma.in The 4-bit processors Intel 4004 Microprocessor (1970) First microprocessor (single-chip IC processor) Clock rate 740 kHz 0.07 MIPS Bus width 4 bits (multiplexed address/data due to limited pins) PMOS Number of transistors 2,300 at 10 μm Addressable Memory 640 bytes Program Memory 4 KB One of the earliest Commercial Microprocessors Originally designed to be used in Busicom calculator Intel 4040 Microprocessor (1971) 4040 – CPU 4 MHz Clock Generator .185 MHz Clock Generator Crystal for 4004/4201A or 4040/4201A Introduced 1971 The 8-bit processors 8008 Microprocessor (1972) Introduced April 1, 1972 Clock rate 500 kHz (8008–1: 800 kHz) 0.05 MIPS Bus width 8 bits (multiplexed address/data due to limited pins) Enhancement load PMOS logic Number of transistors 3,500 at 10 μm Addressable memory 16 KB Typical in early 8-bit microcomputers, dumb terminals, general calculators, bottling machines Developed in tandem with 4004 Upendra Sharma 2 Upsharma.in 8080 Microprocessor (1974) Introduced April 1, 1974 Clock rate 2 MHz (very rare 8080B: 3 MHz) 0.29 MIPS Bus width 8 bits data, 16 bits address Enhancement load NMOS logic Number of transistors 4,500, 6 μm Assembly language downwards compatible with 8008. Addressable memory 64 KB Up to 10X the performance of the 8008 Used in the Altair 8800, Traffic light controller, cruise missile Required six support chips versus 20 for the 8008 8085 Microprocessor (1976) Introduced March 1976 Clock rate 3 MHz 0.37 MIPS Bus width 8 bits data, 16 bits address Depletion load NMOS logic Number of transistors 6,500 at 3 μm Binary compatible downwards with the 8080. -
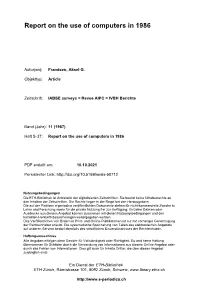
Report on the Use of Computers in 1986
Report on the use of computers in 1986 Autor(en): Frandsen, Aksel G. Objekttyp: Article Zeitschrift: IABSE surveys = Revue AIPC = IVBH Berichte Band (Jahr): 11 (1987) Heft S-37: Report on the use of computers in 1986 PDF erstellt am: 10.10.2021 Persistenter Link: http://doi.org/10.5169/seals-50712 Nutzungsbedingungen Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern. Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber. Haftungsausschluss Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind. Ein Dienst der ETH-Bibliothek ETH Zürich, Rämistrasse 101, 8092 Zürich, Schweiz, www.library.ethz.ch http://www.e-periodica.ch IABSE PERIODICA 2/1987 IABSE SURVEYS S-37/87 17 Report on the Use of Computers in 1986 Rapport sur l'utilisation des ordinateurs en 1986 Bericht über Verwendung des Computers im Jahre 1986 prepared by Working Commission VI of IABSE «Informatics in Structural Engineering» coordinated by Aksel G. -

IBM Selects Concurrent DOS-286TM for PC at Retail System
[rn~~~q~~~~~&g~j~Cq:~A A EUROPEAN MARCH 1986 ISSUE NO:18 CeBIT- 12. - 19. MARZ Stand 1023, HALLE 16 IBM selects Concurrent DOS-286TM for PC AT retail system BM's new Electronic Point of Sale (EPOS)system includes I the Personal Computer AT as Store Controller and a programmable EPOS cash register terminal likewise based on the Intel 80286 central processing unit. In both terminal and Store Controller, the IBM 4680 Store System uses the power of Digital Research's Concurrent DOS-286, the new generation real time multi-user, multitasking, operating system which operates in the full protected mode of the Intel 80286 microproc~ssor. European pilot by UK pharmacy chain At a February press conference held jointly with IBM in London, Boots plc, the leading UK retail n ha rmg~a_n~d,ornes t ic goods- chain, revealed that the first 4680 Store System site in Europe will be a pilot installation at its Peterborough store. Boots expects to introduce 4680 systems into 170 of its major stores within the next three years. IBM is a leading player in the Response ofIBM's new PC AT based Store System depends on real time capability of Concurrent DOS-286rM retail systems field, and the IBM credit authorisation, 4680 Store System is designed to classification of items and synchronous and asynchronous I provide the flexibility and returns, plus back office are supported by the 4680 versatility to address a variety of functions such as price and operating system, allowing data I Olivetti and Cornart get own vertical markets. -

Kermit User Guide
KERMIT USER GUIDE Seventh Edition Christine Gianone, Editor Columbia University Center for Computing Activities New York, New York 10027 May 26, 1988 Copyright (C) 1981,1988 Trustees of Columbia University in the City of New York Permission is granted to any individual or institution to use, copy, or redistribute this document so long as it is not sold for profit, and provided this copyright notice is retained. PREFACE Page 1 PREFACE Kermit is the name of a protocol for transferring files from one computer to another over ordinary asynchronous terminal connections. Kermit programs have been written for many different computers, and in general any two computers that have Kermit programs can exchange sequential files correctly and completely. This manual gives a brief and general overview of what Kermit is and how to use it, but consists mostly of detailed instructions for use and installation of specific Kermit programs. For a more detailed introduction to Kermit, complete with illustrations, diagrams, and tutorials, consult the book Kermit, A File Transfer Protocol, by Frank da Cruz, Digital Press, Bedford MA (1987), ISBN 0-932376-88-6, DEC order number EY-6705E-DP (phone 1-800-343-8321). The Kermit book describes Kermit in detail, from the points of view of the beginner, the user, the computer professional who must install Kermit programs or support their use, and the programmer who wishes to write new Kermit implementations. Also included are general introductions to computers, data communications, and file organization, plus a detailed troubleshooting guide, bootstrapping hints, and various appendices and tables. The latter half of the book is taken up by a complete description of the Kermit file transfer protocol, with programming examples in the C language, plus some analysis and comparisons of Kermit with other popular protocols such as Xmodem. -
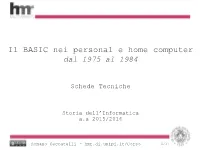
Il BASIC Nei Personal E Home Computer Dal 1975 Al 1984
Il BASIC nei personal e home computer dal 1975 al 1984 Schede Tecniche Storia dell’Informatica a.a 2015/2016 Romano Ceccatelli - hmr.di.unipi.it/Corso 1/37 MITS Altair 8800 Il MITS Altair 8800 è stato uno tra i primi microcomputer disponibili sul mercato. È stato sviluppato e commercializzato dalla Micro Instrumentation & Telemetry Systems, Inc. (MITS), azienda con sede ad Albuquerque (Nuovo Messico, USA). Era dotato di un'interfaccia basata su interruttori (24). Agendo su di essi si può programmare in codice binario, mentre il risultato delle elaborazioni viene visualizzato tramite il lampeggio dei LED (36) posti sul pannello frontale. Esso conteneva appunto 36 LED: 16 per il bus degli indirizzi, 8 per i dati, 8 per lo stato e i restanti erano usati per visualizzare lo stato della CPU. C’erano, inoltre, una serie di interruttori per inserire gli indirizzi e i dati, oltre ad un insieme di interruttori per il controllo del sistema. Bill Gates e Paul Allen decisero di scrivere un linguaggio di programmazione per far funzionare l'Altair. Il risultato fu una versione semplificata del BASIC chiamata Altair BASIC. Poiché diverse parti elettroniche non erano ancora disponibili al momento della progettazione, e per risolvere i problemi di NOME MITS Altair 8800 dimensione della scheda madre, fu necessario inventare un apposito connettore, oggi noto come bus: questa nuova struttura di AZIENDA E LUOGO MITS DI PRODUZIONE Albuquerque Nuovo trasferimento dati divenne in seguito uno standard, chiamato S- Messico USA 100. Con questo accorgimento fu possibile spostare parte della logica dalla scheda madre su altre schede, con cui comunicava ANNO 1975 tramite il bus. -
Retrocomputer Magazine
Jurassic News • hardware: Exidy Sorcerer • software: Borland Sidekick • racconto: Rimini, Rimini! • emulazione: ENIGMA • laboratorio: ENIGMA con chip ATMega 238P • linguaggi: SNOBOL • storia: il PC IBM • dal passato: M24, Toshiba T1000, P101 Retrocomputer Magazine Anno 10 - Numero 55 - Settembre 2015 Jurassic News Rivista aperiodica di Retrocomputer Jurassic News Coordinatore editoriale: Tullio Nicolussi [Tn] E’ una fanzine dedicata al retro- Redazione: computing nella più ampia accezione del [email protected] termine. Gli articoli trattano in generale dell’informatica a partire dai primi anni Hanno collaborato a questo numero: Lorenzo [L2] ‘80 e si spingono fino ...all’altro ieri. Salvatore Macomer [Sm] La pubblicazione ha carattere Sonicher [Sn] puramente amatoriale e didattico, tutte Besdelsec [Bs] Lorenzo Paolini [Lp] le informazioni sono tratte da materiale Giovanni [jb72] originale dell’epoca o raccolte su Internet. double_wrap Damiano Cavicchio La redazione e gli autori degli Riccardo Franch articoli non si assumono nessuna responsabilità in merito alla correttezza Diffusione: delle informazioni riportate o nei Lettura on-line sul sito o attraverso il servizio Issuu.com; il download è confronti di eventuali danni derivanti disponibile per gli utenti registrati. dall’applicazione di quanto appreso sulla rivista. Sito Web: www.jurassicnews.com Il contenuto degli articoli è frutto delle conoscenze, esperienze personali e opinioni dei singoli autori; possono Contatti: [email protected] pertanto essere talvolta non precise o differire da fonti “ufficiose” come Copyright: Wikipedia e siti Web specializzati. I marchi citati sono di copyrights dei rispettivi proprietari. Sono gradite segnalazioni di errori, La riproduzione con qualsiasi imprecisioni o errate informazioni che mezzo di illustrazioni e di articoli possono, a discrezione della redazione, pubblicati sulla rivista, nonché essere oggetto di errata-corrige in la loro traduzione, è riservata e non può avvenire senza espressa fascicoli successivi. -

Kermit News Issn 0899-9309
KERMIT NEWS ISSN 0899-9309 Number 4 June 1990 Contents It's Not Just Academic! . 1 MS-DOS Kermit 3.0 . 3 MS-DOS Kermit 3.0 Early Reviews . 3 MS-DOS Kermit 3.0 on Local Area Networks . 4 MS-DOS Kermit 3.0 In Print . 6 Making the Mainstream Connection with MS-DOS Kermit . 7 C-Kermit 5A . 8 IBM Mainframe Kermit 4.2 . 9 Other New Kermit Releases . 10 DEC Computers . 10 Hewlett Packard Computers . 10 PRIME Computers . 11 Other Computers . 11 How Efficient Is Kermit? . 12 World News . 16 International Character Sets . 16 Report from Western Europe . 17 Mission to Moscow . 18 Kermit Goes to Eastern Europe . 18 Business Section . 21 Kermit in the (US) Navy . 21 Fast Food! . 22 Kermit Protocol in Manufacturing . 23 MS-DOS Kermit 3.0 and Radio Communications . 24 Kermit Is Not a Toy! . 25 MS-DOS Kermit 3.0 Backers . 25 Kermit Distribution . 26 The Kermites . 26 Ordering Information . 27 Kermit Version List . 28 Donors . 30 Order Form . 31 Kermit News, ISSN 0899-9309, is published periodically free of charge by Kermit Development and Distribution, Columbia University Center for Computing Activities, 612 West 115th Street, New York, NY 10025, USA. Contributed articles are welcome. Material in Kermit News may be quoted or reproduced without permission, but with proper attribution. And be sure to send us a copy! Editor: Christine M. Gianone E-Mail: [email protected] or [email protected] The Kermit file transfer protocol is named after Kermit the Frog, star of the television series The Muppet Show, used by permission of Henson Associates, Inc. -

VCFI 2019 Brochure Lowres
2019 Roma 27 e 28 aprile Complesso Ex Cartiera Latina Via Appia Antica, 42 La più grande manifestazione sulla storia del personal computer Esposizione di PC d’epoca, raduno di collezionisti e appassionati, incontri, workshop e conferenze con i protagonisti del mondo dell’informatica. Powered by IDEA Il nostro scopo è quello di mantenere, promuovere e diffondere la storia di Personal Computer, con particolare attenzione dagli anni ’60 agli anni ’90. Quegli anni in cui tutto è cambiato e il computer è passato dall'essere un vantaggio per pochi a un beneficio per tutti. VINTAGE COMPUTER FESTIVAL ITALIA 2019 “ Focus: come il personal computer ha cambiato l’insegnamento e l’apprendimento” LOCATION Ex Cartiera Latina. La ex Cartiera Latina, tra i pochi impianti industriali sopravvissuti nella città di Roma, è una struttura unica nel suo genere ed eccezionale per la posizione strategica a ridosso delle Mura Aureliane. Oggi il complesso multifunzionale è gestito dall’Ente Parco Appia Antica, è dotato di due sale per esposizioni (Nagasawa e Appia) e una Sala Conferenze; una biblioteca; uno spazio didattico espositivo naturalistico, “Dì Natura”, dove si svolgono attività per le scuole e le famiglie e dove è presente un Punto Info con Bookshop. Uno spazio verde esterno attrezzato che ospita l’orto didattico “Hortus Urbis”, un'area didattica dedicata alle tradizioni della Campagna Romana ed una area attrezzata per la sosta. A CHI SI RIVOLGE IL VCFI Il Vintage Computer Festival Italia è per tutti coloro che amano il computer e la sua evoluzione. Dagli