Il Veneto, Le Api E L'apicoltura
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-
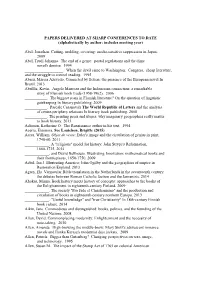
PAPERS DELIVERED at SHARP CONFERENCES to DATE (Alphabetically by Author; Includes Meeting Year)
PAPERS DELIVERED AT SHARP CONFERENCES TO DATE (alphabetically by author; includes meeting year) Abel, Jonathan. Cutting, molding, covering: media-sensitive suppression in Japan. 2009 Abel, Trudi Johanna. The end of a genre: postal regulations and the dime novel's demise. 1994 ___________________. When the devil came to Washington: Congress, cheap literature, and the struggle to control reading. 1995 Abreu, Márcia Azevedo. Connected by fiction: the presence of the European novel In Brazil. 2013 Absillis, Kevin. Angele Manteau and the Indonesian connection: a remarkable story of Flemish book trade (1958-1962). 2006 ___________. The biggest scam in Flemish literature? On the question of linguistic gatekeeping In literary publishing. 2009 ___________. Pascale Casanova's The World Republic of Letters and the analysis of centre-periphery relations In literary book publishing. 2008 ___________. The printing press and utopia: why imaginary geographies really matter to book history. 2013 Acheson, Katherine O. The Renaissance author in his text. 1994 Acerra, Eleonora. See Louichon, Brigitte (2015) Acres, William. Objet de vertu: Euler's image and the circulation of genius in print, 1740-60. 2011 ____________. A "religious" model for history: John Strype's Reformation, 1660-1735. 2014 ____________, and David Bellhouse. Illustrating Innovation: mathematical books and their frontispieces, 1650-1750. 2009 Aebel, Ian J. Illustrating America: John Ogilby and the geographies of empire in Restoration England. 2013 Agten, Els. Vernacular Bible translation in the Netherlands in the seventeenth century: the debates between Roman Catholic faction and the Jansenists. 2014 Ahokas, Minna. Book history meets history of concepts: approaches to the books of the Enlightenment in eighteenth-century Finland. -

PROGRAM INTERNATIONAL TAX AUDIT FORUM Conference Languages: English, Italian & German (Simultaneous Translation)
2018 BMW WELT MUNICH 19-20 NOVEMBER PROGRAM INTERNATIONAL TAX AUDIT FORUM Conference languages: English, Italian & German (simultaneous translation) – Draft version: November 2018 – www.taxauditforum.de 02 DRAFT VERSION OCTOBER 2018 • DAY 1 PROGRAM · DAY 1 MONDAY · 19 NOVEMBER 2018 Moderation: Dr. Nadia Altenburg OECD, Paris Johannes Becker Tax Authority Brandenburg, Potsdam 09.00 h Welcome Address Volker Freund Bavarian Ministry of Finance, for Regional Development and Regional Identity, Munich Dr. Rolf Möhlenbrock Federal Ministry of Finance, Berlin 09.30 h Tax Audits “senza frontiere” – The Italian-Bavarian cooperation: A role model for cross-border cooperation Maria Bichler Bavarian Ministry of Finance, for Regional Development and Regional Identity, Munich Chiara Putzolu Agenzia delle Entrate, Rome Michael Braun Federal Ministry of Finance, Berlin Comments Stefano Ceccacci UniCredit S.p.A., Milan Holger Engelke Munich RE, Munich 10.30 h Discussion 11.00 h Coffee break www.taxauditforum.de 03 DRAFT VERSION OCTOBER 2018 • DAY 1 PROGRAM · DAY 1 CONTINUE 11.30 h “To P.E. or not to P.E. – that is the question!” Different answers to the same question in Italy and Germany Franz Hruschka Tax Office Munich Dott. Giammarco Cottani Ludovici Piccone & Partners, Milan Prof. Dr. Gerhard Girlich University of Applied Sciences Biberach Comment Prof. Dr. Thomas Rödder Flick Gocke Schaumburg, Bonn 12.30 h Discussion 13.00 h Lunch break 14.00 h So much trouble! Tax Audit, MAP and criminal investigation on dual residence Erich Spensberger Bavarian Tax Office, Munich Michael Bär Bavarian Tax Office, Nuernberg Mag. Harald Pölzl Federal Ministry of Finance, Vienna Dr. Rolf Raum German Federal Court of Justice, Karlsruhe Comment Mag. -

Miel, Propolis, Gelée Royale : Les Abeilles Alliées De Notre Système Immunitaire
Université de Lille 2 Année Universitaire 2014/2015 Faculté des Sciences Pharmaceutiques THESE POUR LE DIPLOME D'ETAT DE DOCTEUR EN PHARMACIE Soutenue publiquement le 30 septembre 2015 Par M. CUVILLIER Alexandre _____________________________ Miel, Propolis, Gelée royale : Les abeilles alliées de notre système immunitaire. _____________________________ Membres du jury : Président : (Mr HENNEBELLE Thierry, professeur à l’université Lille II) Assesseur : (Mr GERVOIS Philippe, Maitre de conférence à l’université Lille II) Assesseur : (Mr ROUMY Vincent, Maitre de conférence à l’université Lille II) Membre extérieur : (Mr ROUSSEL Jean-Marc, Docteur en pharmacie à Lille) 1 Faculté des Sciences Pharmaceutiques et Biologiques de Lille 3, rue du Professeur Laguesse - B.P. 83 - 59006 LILLE CEDEX 03.20.96.40.40 - : 03.20.96.43.64 http://pharmacie.univ-lille2.fr Université Lille 2 – Droit et Santé Président : Professeur Xavier VANDENDRIESSCHE Vice- présidents : Professeur Alain DUROCHER Professeur Régis BORDET Professeur Eric KERCKHOVE Professeur Eric BOULANGER Professeur Frédéric LOBEZ Professeur Damien CUNY Professeur Benoit DEPREZ Professeur Murielle GARCIN Monsieur Pierre RAVAUX Monsieur Larbi AIT-HENNANI Monsieur Antoine HENRY Directeur Général des Services : Monsieur Pierre-Marie ROBERT Faculté des Sciences Pharmaceutiques et Biologiques Doyen : Professeur Damien CUNY Vice-Doyen, 1er assesseur : Professeur Bertrand DECAUDIN Assesseur en charge de la pédagogie Dr. Annie Standaert Assesseur en charge de la recherche Pr. Patricia Melnyk e ROGER Assesseur délégué à la scolarité Dr. Christophe Bochu Assesseur délégué en charge des relations internationales Ph Pr. Philippe Chavatte Assesseur délégué en charge de la vie étudiante M. Thomas Morgenroth Chef des services administratifs : Monsieur Cyrille PORTA Liste des Professeurs des Universités - Praticiens Hospitaliers Civ. -

Fr. David Kosmoski, Pastor Rev. Mr. Walter Maksimik, Deacon Mass
The Assumpon by Tian, Basilica of Santa Maria Gloriosa dei Frari, Venice Italy Fr. David Kosmoski, Pastor Rev. Mr. Walter Maksimik, Deacon Mass Schedule Saturday evening Vigil Mass: 4:00 pm Sunday: 8:00 am, 10:00 am and 11:30 am Daily Mass: Monday-Friday: 8:00am followed by the Rosary Wednesday: Devotion to Our Lady of Perpetual Help after 8:00 am Mass St. Andrew Mass Association: First Saturday of the month: 8:00 am Mass Sacrament of Reconciliation: Saturday, 3:00 pm Parish Secretary: Rosemary Horniacek Parish Office: 732-634-4355 Parish Fax: 732-750-5905 Religious Education Department: Bette Vitale 732-636-4261 Parish e-mail: [email protected] Parish website: www.standrewparish.com New parishioners are welcomed! Please register to become part of our parish family by calling or stopping by the rectory. If your child is 18 years old, or out of college, they should register on their own. Registration is one of the requirements for sponsor certificates. SCHEDULE OF EVENT BINGO SCHEDULE th Tues. 8/13 7:30PM BINGO (doors open at 6) Tuesday, August 13 , Susan Peitz RCaller, Sue BowersRTeam Leader, Wed. 8/14 7:00PM Vigil Mass Bill Kearney, Dave Kearney, Eileen Lemmon, Nancy Superak, Annee Thurs. 8/15 7:00PM The Assumption of the Conway, Kathleen Neroda, Josephine Di Marno, Cake Bakers: Ka- Blessed Virgin Mary ren Lurker, Jean Kearney, Mary Moa, JoAnn Beiter, Karen Shaffer, Lorea Dowd Sat. 8/17 3:00PM Confessions LITURGICAL MINISTER’S SCHEDULE 4:00PM Vigil Mass Lector 7:00PM N/A Men Who Care 7:30PM N/A non-Family Support Group Wed. -
Temajournal Of
Part Journal of Land Use, Mobility and TeMA Environment SMART CITY PLANNING FOR ENERGY, TRANSPORTATION AND SUSTAINABILITY OF THE URBAN SYSTEM Special Issue, June 2014 Published by Laboratory of Land Use Mobility and Environment DICEA - Department of Civil, Architectural and Environmental Engineering University of Naples "Federico II" TeMA is realised by CAB - Center for Libraries at “Federico II” University of Naples using Open Journal System Editor-in-chief: Rocco Papa print ISSN 1970-9889 | on line ISSN 1970-9870 Lycence: Cancelleria del Tribunale di Napoli, n° 6 of 29/01/2008 Editorial correspondence Laboratory of Land Use Mobility and Environment DICEA - Department of Civil, Architectural and Environmental Engineering University of Naples "Federico II" Piazzale Tecchio, 80 80125 Naples web: www.tema.unina.it e-mail: [email protected] TeMA Journal of Land Use Mobility and Environment INPUT 2014 Eighth International Conference INPUT - Naples, 4-6 June 2014 Journal of Land Use, Mobility and TeMA Environment TeMA. Journal of Land Use, Mobility and Environment offers researches, applications and contributions with a unified approach to planning and mobility and publishes original inter-disciplinary papers on the interaction of transport, land use and environment. Domains include engineering, planning, modeling, behavior, economics, geography, regional science, sociology, architecture and design, network science, and complex systems. The Italian National Agency for the Evaluation of Universities and Research Institutes (ANVUR) classified TeMA as scientific journals in the Areas 08. TeMA has also received the Sparc Europe Seal for Open Access Journals released by Scholarly Publishing and Academic Resources Coalition (SPARC Europe) and the Directory of Open Access Journals (DOAJ). -

The Cambridge Companion to HOBBES’S LEVIATHAN
P1: SBT 0521836678pre CUNY719/Springborg 0 521 83667 8 May 18, 2007 6:6 The Cambridge Companion to HOBBES’S LEVIATHAN Edited by Patricia Springborg University of Sydney Free University of Bolzano, Italy Cambridge Collections Online © Cambridge University Press, 2007 v P1: SBT 0521836678pre CUNY719/Springborg 0 521 83667 8 May 18, 2007 6:6 cambridge university press Cambridge, New York, Melbourne, Madrid, Cape Town, Singapore, Sao˜ Paulo, Delhi Cambridge University Press 32 Avenue of the Americas, New York, ny 10013-2473, usa www.cambridge.org Information on this title: www.cambridge.org/9780521836678 c Cambridge University Press 2007 This publication is in copyright. Subject to statutory exception and to the provisions of relevant collective licensing agreements, no reproduction of any part may take place without the written permission of Cambridge University Press. First published 2007 Printed in the United States of America A catalog record for this publication is available from the British Library. Library of Congress Cataloging in Publication Data Springborg, Patricia. The Cambridge companion to Hobbes’s Leviathan / Patricia Springborg. p. cm. – (Cambridge companions to philosophy) Includes bibliographical references and index. isbn-13: 978-0-521-83667-8 (hardback) isbn-13: 978-0-521-54521-1 (pbk.) 1. Hobbes, Thomas, 1588–1679. Leviathan. 2. Political science – Early works to 1800. 3. Political science – Philosophy. I. Springborg, Patricia. II. Title. III. Series. jc153.h659s67 2007 320.1 –dc22 2006029157 isbn 978-0-521-83667-8 hardback isbn 978-0-521-54521-1 paperback Cambridge University Press has no responsibility for the persistence or accuracy of urls for external or third-party Internet Web sites referred to in this publication and does not guarantee that any content on such Web sites is, or will remain, accurate or appropriate. -
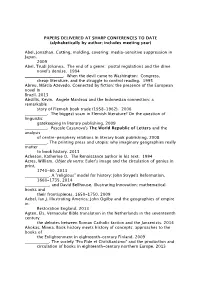
PAPERS DELIVERED at SHARP CONFERENCES to DATE (Alphabetically by Author; Includes Meeting Year)
PAPERS DELIVERED AT SHARP CONFERENCES TO DATE (alphabetically by author; includes meeting year) Abel, Jonathan. Cutting, molding, covering: media-sensitive suppression in Japan. 2009 Abel, Trudi Johanna. The end of a genre: postal regulations and the dime novel's demise. 1994 ___________________. When the devil came to Washington: Congress, cheap literature, and the struggle to control reading. 1995 Abreu, Márcia Azevedo. Connected by fiction: the presence of the European novel In Brazil. 2013 Absillis, Kevin. Angele Manteau and the Indonesian connection: a remarkable story of Flemish book trade (1958-1962). 2006 ___________. The biggest scam in Flemish literature? On the question of linguistic gatekeeping In literary publishing. 2009 ___________. Pascale Casanova's The World Republic of Letters and the analysis of centre-periphery relations In literary book publishing. 2008 ___________. The printing press and utopia: why imaginary geographies really matter to book history. 2013 Acheson, Katherine O. The Renaissance author in his text. 1994 Acres, William. Objet de vertu: Euler's image and the circulation of genius in print, 1740-60. 2011 ____________. A "religious" model for history: John Strype's Reformation, 1660-1735. 2014 ____________, and David Bellhouse. Illustrating Innovation: mathematical books and their frontispieces, 1650-1750. 2009 Aebel, Ian J. Illustrating America: John Ogilby and the geographies of empire in Restoration England. 2013 Agten, Els. Vernacular Bible translation in the Netherlands in the seventeenth century: the debates between Roman Catholic faction and the Jansenists. 2014 Ahokas, Minna. Book history meets history of concepts: approaches to the books of the Enlightenment in eighteenth-century Finland. 2009 ____________. The society "Pro Fide et Christianismo" and the production and circulation of books in eighteenth-century northern Europe. -

Deutsche Nationalbibliografie 2017 a 35
Deutsche Nationalbibliografie Reihe A Monografien und Periodika des Verlagsbuchhandels Wöchentliches Verzeichnis Jahrgang: 2017 A 35 Stand: 30. August 2017 Deutsche Nationalbibliothek (Leipzig, Frankfurt am Main) 2017 ISSN 1869-3946 urn:nbn:de:101-201612064203 2 Hinweise Die Deutsche Nationalbibliografie erfasst eingesandte Pflichtexemplare in Deutschland veröffentlichter Medienwerke, aber auch im Ausland veröffentlichte deutschsprachige Medienwerke, Übersetzungen deutschsprachiger Medienwerke in andere Sprachen und fremdsprachige Medienwerke über Deutschland im Original. Grundlage für die Anzeige ist das Gesetz über die Deutsche Nationalbibliothek (DNBG) vom 22. Juni 2006 (BGBl. I, S. 1338). Monografien und Periodika (Zeitschriften, zeitschriftenartige Reihen und Loseblattausgaben) werden in ihren unterschiedlichen Erscheinungsformen (z.B. Papierausgabe, Mikroform, Diaserie, AV-Medium, elektronische Offline-Publikationen, Arbeitstransparentsammlung oder Tonträger) angezeigt. Alle verzeichneten Titel enthalten einen Link zur Anzeige im Portalkatalog der Deutschen Nationalbibliothek und alle vorhandenen URLs z.B. von Inhaltsverzeichnissen sind als Link hinterlegt. In Reihe A werden Medienwerke, die im Verlagsbuch- chende Menüfunktion möglich. Die Bände eines mehrbän- handel erscheinen, angezeigt. Auch außerhalb des Ver- digen Werkes werden, sofern sie eine eigene Sachgrup- lagsbuchhandels erschienene Medienwerke werden an- pe haben, innerhalb der eigenen Sachgruppe aufgeführt, gezeigt, wenn sie von gewerbsmäßigen Verlagen vertrie- ansonsten -

Jahresbericht 2014 Geschäftsführung
Jahresbericht 2014 Geschäftsführung Wissenschaftlicher Beirat Aufsichtsrat Prof. Dr. Clemens Fuest Thomas Kohl Vors.: Prof. Dr. Friedrich Buttler Vors.: Ministerin Theresia Bauer MdL Kaufmännischer Direktor Stellv.: Prof. Dr. Dres. h.c. Arnold Picot Präsident Stellv.: Dr. h.c. Eggert Voscherau Stabsstelle FORSCHUNG Forschungsbereich Forschungsbereich Forschungsbereich Arbeitsmärkte, Perso nalmanagement und Soziale Sicherung Industrieökonomik und Internationale Unternehmensführung Informations- und Kommunikationstechnologien Prof. Dr. Holger Bonin Dr. Georg Licht Prof. Dr. Irene Bertschek Forschungsbereich Forschungsbereich Forschungsbereich Internationale Finan z märkte und Finanzmanagement Umwelt- und Ressourcenökonomik, Umweltmanagement Unternehmensbesteuerung und Öffentliche Finanzwirtschaft Prof. Dr. Michael Schröder Komm. Leitung: Dr. Klaus Rennings Prof. Dr. Friedrich Heinemann Forschungsgruppe Forschungsgruppe Internationale Verteilungsanalysen Wettbewerb und Regulierung Prof. Dr. Andreas Peichl Prof. Dr. Kai Hüschelrath SERVICE Information und Kommunikation Wissenstransfer & Weiterbildung Zentrale Dienstleistungen Gunter Grittmann Thomas Kohl Thomas Kohl Förderkreis Leibniz-WissenschaftsCampus Leibniz-Forschungsverbünde Förderkreis Wissenschaft • Bildungspotenziale und Praxis am ZEW e.V. Vors.: Prof. Dr. Andreas Dulger • Energiewende Stellv.: Dr. Alexander Selent • Gesundes Altern • Krisen in einer globalisierten Welt • Science 2.0 Stand: Mai 2015 Geschäftsführung Wissenschaftlicher Beirat Aufsichtsrat Prof. Dr. Clemens Fuest Thomas -

Gestione Igienico Sanitaria Degli Apiari a Salvaguardia Dell'ambiente E
> Gestione igienico sanitaria degli apiari a salvaguardia dell’ambiente e della biodiversità Gestione igienico sanitaria degli apiari a salvaguardia dell’ambiente e della biodiversità ATTI DEL I° CORSO DI PERFEZIONAMENTO a.a. 2016/2017 A cura di: Manuela Martano, Paola Maiolino, Karen Power ISBN: 978-88-97840-60-2 copyright 2019 Immagine di copertina fornita dal dr. Paolo Pariante PhD Ateneapoli srl via Pietro Colletta, 12 (80139) Napoli www.ateneapoli.it BOOKSTORE www.ateneapoli.it/libri 2 > Gestione igienico sanitaria degli apiari a salvaguardia dell’ambiente e della biodiversità INDICE • L’ape e l’uomo pag. 7 • L’ape e il mondo dell’arte pag. 18 • Sistematica ed ecologia delle api – Specie del genere APIS pag. 21 • Cenni di morfologia, anatomia e fisiologia dell’ape pag. 25 • Installazione e gestione di un apiario pag. 33 • Modalità di conduzione intensiva di un apiario pag. 42 • Sciamatura natura ed artificiale pag. 51 • Tecniche di conduzione apistica nelle diverse stagioni pag. 59 • Il lavoro dell’apicoltore durante l’anno pag. 73 • Patologie parassitarie dell'alveare pag. 80 • Patologie batteriche di interesse sanitario in apicoltura pag. 86 • L’esame anatomo-isto-patologico come strumento per lo studio delle patologie apistiche e nella diagnosi delle più comuni malattie delle api pag. 91 • I nemici delle api pag. 94 • Vespa velutina un nuovo predatore delle api italiane pag. 103 • Il miele e i prodotti dell’apiario: qualità, controllo e aspetti normativi pag. 107 • Residui di farmaci e contaminanti ambientali nel miele pag. 112 • I prodotti dell’alveare pag. 120 • Stato dell’arte e ultimi sviluppi in materia di anagrafe apistica e sanità delle api pag. -

Comparison of Apiculture and Winter Mortality of Honey Bee Colonies
Agriculture, Ecosystems and Environment 274 (2019) 24–32 Contents lists available at ScienceDirect Agriculture, Ecosystems and Environment journal homepage: www.elsevier.com/locate/agee Comparison of apiculture and winter mortality of honey bee colonies (Apis T mellifera) in Austria and Czechia ⁎ Robert Brodschneidera, , Jan Brusb, Jiří Danihlíkc,d a Institute of Biology, University of Graz, Universitätsplatz 2, 8010, Graz, Austria b Palacký University Olomouc, Department of Geoinformatics, 17. Listopadu 50, 771 46, Olomouc, Czech Republic c Palacký University Olomouc, Department of Biochemistry, Šlechtitelů 27, 783 71, Olomouc, Holice, Czech Republic d Czech Beekeepers Association, Staroměstská 2362/A, 370 04, České Budějovice, Czech Republic ARTICLE INFO ABSTRACT Keywords: Honey bees are the most important managed pollinators and provide income because of bee products. In Austria and Population dynamics Czechia, we monitored winter losses of honey bee colonies and also collected information on the apicultural sector, hive Beekeeping management, population dynamics and treatment against the mite Varroa destructor from 2013–14 to 2016–17. Varroa destructor Numbers of beekeepers and colonies, colony density and percentage of beekeepers in human population are higher in COLOSS Czechia than in Austria. Winter loss rates of honey bee colonies ranged from 8.1% to 28.4% in Austria and 6.4% to Citizen science 19.4% in Czechia, with significantly higher loss rates in all 4 investigated winters in Austria. The portion of colonieslost because of living colonies with unsolvable queen problems ranged from 3.6 to 4.4% in Austria and from 2.2 to 3.0% in Czechia. Despite of colony losses during winter, colony production in summer allows for compensation or even ex- pansion of colony populations in both countries.