Scuole Professionali Salesiane.PDF
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Dai Consiglieri Professionali Generali Alla Federazione Nazionale CNOS-FAP
Dai Consiglieri Professionali Generali alla Federazione Nazionale CNOS-FAP Felice Rizzini Il processo innovativo della Formazione Professionale s'intensificò dopo la morte dì Don Bosco per il contributo determinante dei Consiglieri Professionali Generali, per gli interventi dei Capitoli Generali e per la dedizione alla causa da par te dei Salesiani Coadiutori, in parallelo agli interventi legislativi e normativi dello Stato ed allo spazio maggiore dato ad essa dalle iniziative pubbliche e private. Dopo Don Giuseppe Lazzero, che per primo esercitò il compito di Consigliere Generale Professionale della Congregazione dal 1886 al 1898, distinguendosi nella cura particolare alla formazione dei Coadiutori Salesiani, si succedettero: Don Giu seppe Bertello (1898-1910); Don Giuseppe Vespignani (una prima volta dal 1910 al 1911 ed una seconda volta dal 1922 al 32); Don Pietro Ricaldone (1911-1922); Don Antonio Candela (1932-1958); Don Ernesto Giovannini (1959-1965). Con il Capi tolo Generale XIX venne abolita la figura del Consigliere Professionale Generale. Fra di essi si distinsero per l'impulso dato alle Scuole Salesiane Professionali e Agra rie Don Giuseppe Bertello, Don Pietro Ricaldone, Don Antonio Candela e Don Ernesto Giovannini. 1 — Don Giuseppe Bertello Don Bertello arrivò a tale incarico con una profonda preparazione umanistica (laureato in teologia, in lettere e filosofia, membro dell'Arcadia e dell'Accademia Romana di S. Tommaso) e con una ricca esperienza di governo come direttore ed 127 ispettore, ma senza una preparazione specifica. Cercò di superare questo limite con lo studio personale e con il contatto diretto con l'esperienze salesiane e con quelle più importanti maturate in quel tempo in Italia e all'estero. -

Bollettino Salesiano
2015 - Digital Collections - Biblioteca Don Bosco - Roma - http://digital.biblioteca.unisal.it IN QUESTO NUMERO : Il nuovo Rettor Maggiore Don Luigi Ricceri pag. 161 "Pietro è qui " Identificate le ossa di San Pietro pag. 165 Che fanno i ragazzi in Colonia? pag. 172 Da 50 anni i Missionari salesiani IN COPERTINA • Una delle numerose fan- lavorano nel Rio Negro fare dei collegi e oratori salesiani del Congo pag. 185 Servizio sul Congo a pag . 183 Milletrecento ragazzi francesi, belgi, svizzeri « in marcia verso Domenico » 2015 - Digital Collections - Biblioteca Don Bosco - Roma - http://digital.biblioteca.unisal.it Don Bosco ha successoreil suo sesto Alle ore 12,10 del 27 aprile scorso, una nuova mano ha impugnato il timone della Congre- gazione Salesiana. DoN LUIGI RICCERI, salutato dagli applausi cordiali dei 150 capitolari che lo avevano voluto sesto Successore di San Giovanni Bosco . In quel momento cercò inu- tilmente di dominare la sua commozione, mentre i capitolari scavalcando il protocollo si assiepavano intorno a lui per avvolgerlo in un abbraccio affettuoso e per dirgli la loro gioia «Vogliamo formare una grande famiglia » L'intensa mattinata era cominciata ai piedi del- Con questa certezza i capitolari passarono nel- l'altare . Nella nuova chiesa dell'Ateneo romano il l'aula magna per la votazione . A uno a uno giura- Rettor Maggiore uscente don Ziggiotti celebrò la rono, con la mano posata sul Vangelo, di dare il Messa per invocare l'assistenza dello Spirito Santo . voto libero e segreto a quel superiore che giudicas- Nel Vangelo lesse le parole di Gesù : « Lo Spirito sero di eleggere al cospetto di Dio . -

Newsflash - Pascua 2020 NF Pasqua 2020 SPA:Layout 1 16/04/2020 18:56 Pagina 3
NF Pasqua 2020 SPA:Layout 1 16/04/2020 18:56 Pagina 1 EEXX AALLLLIIEEVVII NNeewwssffllaasshh AÑO 9 - NÚMERO 37 - P ASCUA 2020 Sucesos actuales religiosas y periódica social de la Confederación Mundial de los Exalumnos de Don Bosco Edición española - (traducciones: Nisaury Ventura) NF Pasqua 2020 SPA:Layout 1 16/04/2020 18:56 Pagina 2 EL P. Á NGEL FERNÁNDEZ ARTIME FUE RATIFICADO COMO RECTOR MAYOR (ANS – Roma) sejo Inspectorial y Vicario Inspectorial, y del 2000 al 2006 Inspector de León. El 28º Capítulo General de la Congregación Es licenciado en Teología Pastoral, Filoso - Salesiana ratificó al P. Ángel Fernández Ar - fía y Pedagogía. time el mandato como Rector Mayor para el sexenio 2020-2026. La elección tuvo Fue miembro de la comisión técnica que lugar en la primera votación. preparó el Capítulo General 26. En 2009 fue nombrado Inspector de Argentina Sur. El P. Ángel Fernández Artime, de 59 años, En el ejercicio de su cargo como Inspector nació el 21 de agosto de 1960 en Gozón- de Argentina pudo conocer y colaborar Luanco, Oviedo; emitió la Primera Profe - personalmente con el entonces arzobispo sión Religiosa el 3 de septiembre de 1978, de Buenos Aires, Cardenal Jorge Mario realizó la Profesión Perpetua el 17 de junio Bergoglio, hoy Papa Francisco de 1984 y fue ordenado sacerdote el 4 de El 23 de Diciembre 2013 fue nombrado Su - julio de 1987. perior de la Inspectoría de España-María Auxiliadora, un encargo que nunca asumió, Originario de la Inspectoría de León, fue pues el Capítulo General 27 lo eligió como delegado de la Pastoral Juvenil, Director nuevo Rector Mayor y X Sucesor de Don del colegio de Orense, miembro del Con - Bosco. -

Don Bosco Quiz
DON BOSCO QUIZ On the 150th Anniversary of the Congregation KNOW THE SALESIAN HISTORY BETTER 1) When was the Salesian Congregation formed? 18th Dec, 1859. 2) What was, according to Don Bosco, the hallmark of the congregation? Chastity 3) When was the Salesian society approved? 19th Feb, 1869. 4) What are the things that undermine the congregation? Idleness, fastidiousness about food and a spirit of reform, undermine religious congregation. 5) When was the Constitutions of the Salesians approved? 3rd April, 1874. 6) What did Don Bosco say about the congregation during his last sickness? Our congregation is led and protected by Mary Help of Christians. 7) When did Don Bosco meet Bartholomew Garelli? 8th Dec, 1841. 8) Who is the patroness of our congregation? Mary Help of Christians. 9) What did Don Bosco say about the role of Mary in the congregation? Mary Most holy is the Foundress and will be the sustainer of our works, it is on her account that our congregation exists and prospers. We cannot make a mistake, Mary guides us. 10) Who is the patron of our congregation? St. Francis of sales. 11) In how many countries are the Salesians present? 129. 12) What is the motto of our congregation? Da mihi animas cetera tolle. 13) When was the Decretum Laudis (the decree of praise) issued for the congregation? 23rdJuly, 1864. 14) What is the website of our congregation? www. sdb. org. 15) When was the first religious profession? 14th May 1862. 16) When was Fr. Pascual Chavez elected as he Rector Major for the first time? 3rd April 2002. -

Biographical Memoirs of Saint John Bosco
The Biographical Memoirs of Saint John Bosco by GIOVANNI BATTISTA LEMOYNE, S.D.B. AN AMERICAN EDITION TRANSLATED FROM THE ORIGINAL ITALIAN DIEGO BORGATELLO, S.D.B. Editor-in-chief Volume I 1815-1840 SALESIANA PUBLISHERS, INC. NEW ROCHELLE, NEW YORK 1965 IMPRIMI POTEST: Very Rev. Augustus Bosio, S.D.B. Provincial NIHIL OBSTAT: Daniel V. Flynn, J.C.D. Censor Librorum IMPRIMATUR: * Francis Cardinal Spellman Archbishop of New York May 6, 1965 The nihil obstat and imprimatur are official declarations that a book or pamphlet is free of doctrinal or moral error. No implication is contained therein that those who have granted the nihil obstat and imprimatur agree with the contents, opinions or statements expressed. Copyright © 1965 by the Salesian Society, Inc. Library of. Congress Catalog Card No. 65-3104rev All Rights Reserved Manufactured in the United States of America FIRST EDITION Bcbttateb WITH PROFOUND GRATITUDE TO THE LATE, LAMENTED, AND HIGHLY ESTEEMED VERY REVEREND FELIX J. PENNA, S.D.B. (1904-1962) TO WHOSE WISDOM, FORESIGHT, AND NOBLE SALESIAN HEART THE ENGLISH TRANSLATION OF THE BIOGRAPHICAL MEMOIRS OF SAINT JOHN BOSCO IS A LASTING MONUMENT To The Very Reverend RENATO ZIGGIOTTI Rector Major Emeritus of the Salesian Society Editor s Preface 'AINT JOHN BOSCO, the central figure of this vastly extensiveJ &biography , was a towering person in the affairs of both Church and State during the critical 19th century in Italy. He was the founder of two very active religious congregations during a time when other orders were being suppressed; he was a trusted and key liaison between the Papacy and the emerging Italian nation of the Risorgimento; above all, in troubled times, he was the saintly Christian educator who successfully wedded modern pedagogy to Christ's law and Christ's love for the poor young, and thereby de served the proud title of Apostle of youth. -

September 2, 2018 Deacon William Vaccaro 260 Westchester Avenue Mr
Pastoral Staff/Personal Pastoral/Conselho Pastoral Rev. Patrick Angelucci, SDB, Administrator Mrs. Irma Austin, Coordinator of Religious Education Sr. Ana Maria Causa, SA, Pastoral Associate Rev. Tarcisio dos Santos, SDB, Parochial Vicar Rev. Manny Gallo, SDB, Coordinator of Youth Ministry Rev. John Grinsell, SDB, DBCC Coordinator of Salesian Mission Rev. Tomasz Grzegorzewski, SDB, Parochial Vicar Rev. Jorge Rodriguez, SDB Parochial Vicar Rev. Joseph Vien Hoang, SDB, Parochial Vicar Deacon Ivan Gemio Deacon Michael Gizzo September 2, 2018 Deacon William Vaccaro 260 Westchester Avenue Mr. Jorge Camacho, Head of Maintenance Parish Offices: 16 Washington St. Ms. Silvia Inocente, Parish Secretary Port Chester, NY 10573 Ms. Maria Massa, Parish Secretary 914-881-1400 / Fax: 914-939-2807 Mr. Michael McCarthy, Finance Office Web: Portchestercatholicchurch.org Mr. John Sullivan, Facilities Manager Trustees: Arlete C. Sasseron Pedro Villanueva Parish Office Hours Weekly Novena Horas de Oficina Escritório Aberto Every Tuesday, After all Masses Honor of Mary Help of Christians & Don Bosco Mon.-Fri./Lun.-Vie/Seg a Sexta-feira: Every Monday after 8AM Mass Miraculous Medal Novena 9:00 AM - 4:00PM Every Wednesday after the 8AM Mass Divine Mercy Chaplet Sat. / Sáb: 9:00AM - 12:00PM Baptisms / Bautismos / Batismo Register in the parish office. / Visite la rectoría. / Passe pelo escritório da igreja. Eucharistic Celebration Weddings / Bodas / Casamento Celebración / Celebraçã Contact the parish office at least six months in advance. Please come to the church before reserving your venue. Contacte la oficina de la parroquia seis meses antes. Por favor vengan a la oficina Sunday / Domingo: antes de reservar el local. English / Inglés: 7:30AM & Procure o escritório da igreja, pelo menos com 6 meses de antecedência. -

Biographical Memoirs Saint John Bosco
The Biographical Memoirs of Saint John Bosco by EUGENIO CERIA, S.D.B. AN AMERICAN EDITION Volume XI 1875 SALESIANA PUBLISHERS, INC. NEW ROCHELLE, NEW YORK 1964 IMPRIMI POTEST : Very Rev. Augustus Bosio, S.D.B. Provincial NUUL OBSTAT: Donald A. Panella, M.A., S.T.L., S.S.L. Censor Librorum IMPRIMATUR: *Francis Cardinal Spellman, Archbishop of New York September 12, 1964 The nihil obstat and imprimatur are official declarations that a book or pamphlet is free of doctrinal or moral error. No implication is contained therein that those who have granted the nihil obstat and imprimatur agree with the contents, opinions or statements expressed. Copyright 0 1964 by Salesiana Publishers, Inc. All Rights Reserved Manufactured in the United States of America FIRST EDITION ;IDetritateb WITH PROFOUND GRATITUDE TO THE LATE, LAMENTED, AND HIGHLY ESTEEMED VERY REVEREND FELIX J. PENNA, S.D.B. (1904-1962) TO WHOSE WISDOM, FORESIGHT, AND NOBLE SALESIAN HEART THE ENGLISH TRANSLATION OF THE BIOGRAPHICAL MEMOIRS OF SAINT JOHN BOSCO IS A LASTING MONUMENT Foreword ITH the Salesian Family I rejoice at the publication of this volume of the Biographical Memoirs and I want to congratulate all those who have labored so hard to make this event possible. It is in the Biographical Memoirs that Don Bosco lives once again. My fondest hope, therefore, is that through these pages describing the intimate and detailed life of Don Bosco day by day, our English-speaking Salesians—Priests, Brothers, Sisters—may come to appreciate ever more deeply Don Bosco's lively faith, firm hope, ardent love of God and souls. -

Salesian Pedagogy of Choice and Vocation: Evolution, Revision and Proposals
Salesian Pedagogy of Choice and Vocation: Evolution, Revision and Proposals Michal Vojtáš, Salesian Pontifical University (Rome, Italy) Abstract: This article approaches the theme of Salesian pedagogy of life choice and vocation on three levels of argumentation. The first level synthesizes some fundamental modifications in Salesian pedagogy of vocation that originate from the post Vatican II youth ministry model. The Salesian Congregation switched from a traditional “state of life” choice education to an approach spinning around unconditional acceptance and personalized planning of life. The consequences of these choices will be interpreted within a changed postmodern context where we point out the need of a new approach suitable for the needs of millennials and digital natives. The second level of the study outlines a set of permanent inspirational pedagogical principles. These are referring to the experience of Don Bosco that constitutes a base for every further update of salesian education theory. The third level offers strategic proposals for the actual education of life choices and vocation is linked to the challenges of the postmodern fluid societies; to the Salesian pedagogical principles of the past and to a transformational model of education, ministry and vocation. 1. Vocation: a problematic “outsider” in the post Vatican II Youth Ministry The Salesian pedagogy of vocation is the area where one can perceive in an exemplar way the Vatican II change of paradigm. From a traditional education that offered instruments for the choice of everyone’s “state of life” (secular or consecrated), the Salesian Congregation passed to a model that emphasized personal freedom, unconditional acceptance and personalized plan of life. -

THE SEPTEMBER MESSAGE of the RECTOR MAJOR from The
Volume I, Issue 9 September 2019 THE SEPTEMBER MESSAGE OF THE RECTOR MAJOR from the Salesian Bulletin DON ANGEL FERNANDEZ ARTIME, SDB “Jesus and the Crucified of This World” Dear Friends, In my office in Rome, Crucified were the teenagers Every day our Salesian con- I have a crucifix that whom I came to know in Ciu- freres visit them, but they speaks volumes to dad Don Bosco in Colombia, have little hope. Among these me. It was given to who had been forced to become young people in the prison me by the Salesians in Peru guerrillas in FARC. some are terminally ill. Little when I was visiting them. Crucified on a cross similar hope is accorded them. God It is a cross (as we well know, to the one that I have in my alone is their hope. the symbol of Christianity), but office were the teenaged and Crucified were the girls in it is not our Lord and Savior little girls who were abused various countries that I visited Jesus Christ who hangs on this sexually in Freetown, the capi- who were obliged to go to one; rather, it bears the image tal of Sierra Leone. These are work. We negotiated to get #Holiness for you, too! of a poor boy. The message is now being sheltered and cared permission for them to go to clear and very strong: our for in the Salesian house there. school, but the first to resist In this issue: Lord Jesus is being cruci- There are many others, howev- our proposal were their own fied in those who are being er, still on the streets or im- families because they would crucified in today’s world. -
Fr. Joseph Occhio, S.D.B
December 2014 1 In Memory of Fr. Joseph Occhio, S.D.B. Fr. Joseph Occhio was born to Giuseppe and Giovannina Spizzi Occhio on November 17, 1923 in Gallignano, Italy and died peacefully on December 13, 2014 in Toronto, Canada. He professed as a Salesian of Don Bosco on September 14, 1940 in Newton, New Jersey and was ordained to the priesthood on July 2, 1950 at the Basilica of Mary Help of Christians in Turin, Italy. For 34 years he contributed to the formation of young Salesians as director at Salesian Center in Columbus, Ohio and at Don Bosco College Seminary in Newton New Jersey as college president, dean of students, religious formation coordinator and, for 29 years, professor of philosophy. In 1987 he came to Canada and began a second career in Salesian community leadership and in parish ministry in Montréal, Edmonton and, for the last 15 years, in Toronto. We thank God for the witness of a life dedicated to Our Lord in the Holy Eucharist, to tireless ministry in the Sacrament of Reconciliation and to a tender devotion to Mary. 2 The search for my ancestors reaches back only to the 17th century, to a town where the previous parish registers had disappeared because of a flood. The name of the church is Sancta Maria in Campis (“Holy Mary in the Fields”). Of course, I would have liked to have been able to go further back in my genealogy, but, on the other hand, I am also delighted to see ‘Holy Mary’ at the very beginning of the known history of the Occhios: “Holy Mary in the Fields!” To me that sounds somewhat poetical, with an added aura of inspiration and mystery! There are fewer than thirty Occhio families in all Italy, not related to us by blood. -
Don Bosco Quiz 2015
DBQ 1815 with the young - For the Young 2015 SALESIAN PROVINCE OF DIMAPUR Don Bosco Quiz Compiled by Fr. Bosco, sdb Don Bosco Provincial House Dimapur - Nagaland To Salesian Cooperators, Don Bosco Alumni, Parents, Benefactors and all Bosconians INTRODUCTION “A journey of a thousand miles begins with a single step” said the Chinese philosopher Lao Tzu in 5th century BC. Don Bosco is the only saint in the Church, about whom much has been written. To understand Don Bosco one must undertake the journey of reading the 19 Biographical Memoirs of Don Bosco. It is indeed a herculean task for one to go through the exercise of reading all 19 volumes. As the Salesian Congregation celebrates the bicentenary of his birth, it is our dream to make all our students in our schools and colleges know more about Don Bosco, so that they can love and imitate him. Don Bosco Quiz (DBQ) is a realization of this dream. This simple compendium of knowledge known as DBQ is a collection of 1000 questions and answers on Don Bosco and his works. A lot of effort has been made to give accurate and correct answers to the questions on Don Bosco and Salesian Family. I wish to express my sentiments of gratitude to Fr. Nestor Guria, the provincial for his continuous encouragement and the confreres of the provincial house for their constant support. I cannot forget Fr. Kerketta Jonas, Fr. Nebu Mathew, Fr. Sebastian Jose and Fr. CD Mathai for their meticulous proof reading and corrections. Without their help this book would not become a reality. -
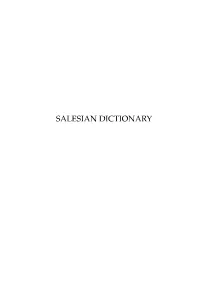
SALESIAN DICTIONARY This Book Has Been Published Under the Auspices of The
SALESIAN DICTIONARY This book has been published under the auspices of the East Asia-Oceania Region. Authors: The dictionary has been compiled over a long period of time covering two Workshops held by translators from the East Asia-Oceania Salesian region, one in 2014 the other in 2019. Publishers: Don Bosco Publishing Services - Vox Amica Press, Hong Kong, China. Cover artwork: Fr April Jerome Quinto SDB, Philippines North Province November 2019 ii Introduction The Salesian Dictionary is a comprehensive effort to compile a list of terms in current (and sometimes historical) use in Salesian dis- course in English. Many (perhaps 99%) of these terms have originated in Italian, some in the Piedmontese dialect, the vernacular of the founding Father and most of his first followers. But as Don Bosco’s charism became established outside of Italy, it was inevitable that new terms would arise with their origins in other languages. This dictionary, which has developed over many years of careful lexical observation and annotation, is chiefly interested in meanings and usage relating to Salesian discourse in English, and includes terms that have entered that discourse from English and, indeed, other languages. The dictionary (it is far more than a glossary and more like a compendium) contains a great deal of information. Not only are some terms complicated, containing several meanings, but due to their consistent use in Salesian discourse, may have developed a his- tory of their own and require some explanation. The compilation of terms has borne in mind both the translator and the seeker of know- ledge regarding the Salesian charism of St John Bosco.