Il Lauro Secco Analisi
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Gesualdo Madrigaux Livre I Solistes Des Arts Florissants Paul Agnew
AMPHITHÉÂTRE – CITÉ DE LA MUSIQUE Gesualdo Madrigaux Livre I Solistes des Arts Florissants Paul Agnew Mardi 23 octobre 2018 – 20h30 Concert enregistré par France Musique. Ce concert est diffusé en direct sur le site internet live.philharmoniedeparis.fr où il restera disponible pendant 4 mois. PROGRAMME Carlo Gesualdo (1566-1613) Ne reminiscaris Domine Luzzasco Luzzaschi (1545-1607) Dolorosi martir, fieri tormenti Claudio Monteverdi (1567-1643) Baci soavi, e cari Luca Marenzio (1553-1599) Baci soavi, e cari (Prima parte) Baci amorosi, e belli (Seconda parte) Baci affamati, e ‘ngordi (Terza parte) Baci cortesi, e grati (Quarta parte) Baci, ohimè, non mirate (Quinta & ultima parte) Carlo Gesualdo Tribulationem et dolorem Hei mihi domine Luca Marenzio Tirsi morir volea (Prima parte) Frenò Tirsi il desio (Seconda parte) Così moriro i fortunati amanti (Terza parte) 3 Benedetto Pallavicino (1551-1601) Tirsi morir volea (Prima parte) Frenò Tirsi il desio (Seconda parte) Così moriro i fortunati amanti (Terza parte) ENTRACTE Carlo Gesualdo Baci soavi e cari Quant’ha di dolce Amore (Seconda parte) Madonna, io ben vorrei Com’esser può ch’io viva se m’uccidi? Gelo ha Madonna il seno, e fiamma il volto Mentre Madonna il lasso fianco posa Ahi, troppo saggia nell’errar (Seconda parte) Se da sì nobil mano Amor, pace non chero (Seconda parte) Sì gioioso mi fanno i dolor miei O dolce mio martire Tirsi morir volea Frenò Tirsi il desio (Seconda parte) Mentre, mia stella, miri Non mirar, non mirare Questi leggiadri odorosetti fiori Felice primavera Danzan -

EUI Working Papers
DEPARTMENT OF HISTORY AND CIVILIZATION EUI Working Papers HEC 2010/02 DEPARTMENT OF HISTORY AND CIVILIZATION Moving Elites: Women and Cultural Transfers in the European Court System Proceedings of an International Workshop (Florence, 12-13 December 2008) Giulia Calvi and Isabelle Chabot (eds) EUROPEAN UNIVERSITY INSTITUTE , FLORENCE DEPARTMENT OF HISTORY AND CIVILIZATION Moving Elites: Women and Cultural Transfers in the European Court System Proceedings of an International Workshop (Florence, 12-13 December 2008) Edited by Giulia Calvi and Isabelle Chabot EUI W orking Paper HEC 2010/02 This text may be downloaded for personal research purposes only. Any additional reproduction for other purposes, whether in hard copy or electronically, requires the consent of the author(s), editor(s). If cited or quoted, reference should be made to the full name of the author(s), editor(s), the title, the working paper or other series, the year, and the publisher. ISSN 1725-6720 © 2010 Giulia Calvi and Isabelle Chabot (eds) Printed in Italy European University Institute Badia Fiesolana I – 50014 San Domenico di Fiesole (FI) Italy www.eui.eu cadmus.eui.eu Abstract The overall evaluation of the formation of political decision-making processes in the early modern period is being transformed by enriching our understanding of political language. This broader picture of court politics and diplomatic networks – which also relied on familial and kin ties – provides a way of studying the political role of women in early modern Europe. This role has to be studied taking into account the overlapping of familial and political concerns, where the intersection of women as mediators and coordinators of extended networks is a central feature of European societies. -

Gesualdo Paul Agnew Madrigali Libri Primo & Secondo FRANZ LISZT CARLO GESUALDO (1566-1613) Madrigali a Cinque Voci
Les Arts Florissants Gesualdo Paul Agnew MADRIGALI LIBRI PRIMO & SECONDO FRANZ LISZT CARLO GESUALDO (1566-1613) MADRIGALI A CINQUE VOCI CD 1 Libro primo (Ferrara, 1594) 1 | Baci soavi, e cari. Giovanni Battista Guarini. Rime amorose Prima parte 2 | Seconda parte: Quant’ha di dolce Amore 2’31 3 | Madonna, io ben vorrei. Incerto MA, MR, SC, PA, EG 3’00 4 | Com’esser può ch’io viva se m’uccidi? Incerto MA, HM, MR, PA, EG 2’12 5 | Gelo ha Madonna il seno. Torquato Tasso, Rime HM, MR, PA, SC, EG 2’07 6 | Mentre Madonna il lasso fianco posa. Torquato Tasso, Rime MA, MR, SC, PA, EG 2’14 Prima parte 7 | Seconda parte: Ahi, troppo saggia nell’errar. 2’10 8 | Se da sì nobil mano. Torquato Tasso, Rime HM, MR, PA, SC, EG 1’54 Prima parte 9 | Seconda parte: Amor, pace non chero 1’27 10 | Sì gioioso mi fanno i dolor miei. Luigi Cassola HM, MA, MR, SC, EG 2’44 11 | O dolce mio martire. Incerto MA, MR, SC, PA, EG 2’27 12 | Tirsi morir volea. Battista Guarini, Rime HM, MR, PA, SC, EG 2’19 Prima parte 13 | Seconda parte: Frenò Tirsi ’l desio 2’45 14 | Mentre, mia stella, miri. Torquato Tasso MA, MR, SC, PA, EG 2’16 15 | Non mirar, non mirare. Filippo Alberti MA, HM, MR, PA, EG 2’21 16 | Questi leggiadri odorosetti fiori. Livio Celiano (alias Angelo Grillo) HM, MR, PA, SC, EG 2’50 17 | Felice primavera. Torquato Tasso MA, MR, SC, PA, EG 1’32 Prima parte 18 | Seconda parte: Danzan le ninfe honeste, e i pastorelli 1’26 19 | Son sì belle le rose. -

Carlo GESUALDO Da Venosa Madrigals Book 1 Delitiæ Musicæ • Marco Longhini
570548 bk Gesualdo US 29/1/10 13:06 Page 12 Carlo GESUALDO da Venosa Madrigals Book 1 Delitiæ Musicæ • Marco Longhini Marco Longhini Photo: Agnes Spaak 8.570548 12 570548 bk Gesualdo US 29/1/10 13:06 Page 2 Carlo * Danzan le ninfe oneste * The honest nymphs and shepherds dance GESUALDO – Seconda parte – Part Two da Venosa (Torquato Tasso) (1566-1613) Danzan le ninfe oneste e i pastorelli The honest nymphs and shepherds dance e i susurranti augelli in fra le fronde and amid the leaves the birds softly sing THE FIRST BOOK OF MADRIGALS, 1594 al mormorar dell’onde e vaghi fiori above the murmuring water, and the Graces IL PRIMO LIBRO DE’ MADRIGALI, 1594 donan le grazie ai pargoletti amori. give pretty flowers to the little cupids. 1 Baci soavi e cari (part 1) (a, b, d, e, f) 3:36 ( Son sì belle le rose ( The roses nature gave you 2 Quanto ha di dolce amore (part 2) (a, b, d, e, f) 3:15 (Livio Celiano) 3 Madonna, io ben vorrei (a, b, c, d, f) 3:35 Son sì belle le rose The roses nature gave you 4 Come esser può ch’io viva? (a, b, c, e, f) 2:41 che in voi natura pose are as beautiful 5 Gelo ha madonna in seno (a, b, c, d, f) 2:39 come quelle che l’arte as those that art 6 Mentre madonna (part 1) (b, c, d, e, f) 2:39 nel vago seno ha sparte. has strewn on your fair breast. -

Gesualdo Da Venosa on the Ivth Centenary of His Birth
Philomusica on-line “Gesualdo 1613-2013” Gesualdo da Venosa on the IVth Centenary of his Birth Nino Pirrotta Translation by Anthony M. Cummings and Sabine Eiche ANTHONY M. CUMMINGS Department of Music, Lafayette College, Easton, Pennsylvania, 18042. [email protected] SABINE EICHE Independent scholar § Il contributo presenta la traduzione di § Translation of one of Nino Pirrotta’s uno dei più importanti articoli di Nino most important articles, Gesualdo da Pirrotta, Gesualdo da Venosa nel Venosa on the IVth Centenary of his quarto centenario della sua nascita, la Birth, which appeared in a relatively cui circolazione è stata fortemente inaccessible publication and never in limitata dal difficile reperimento del English translation, thus undeser- testo originale e dalla mancanza di una vedly limiting its circulation. The versione inglese. L’articolo fu scritto article was written to accompany the come commento all’esecuzione di performance of compositions by alcuni brani di Gesualdo e di altri Gesualdo and his contemporaries, compositori coevi, trasmessi alla radio broadcast over Italian radio in 1961, italiana nel 1961. Oltre a ripercorrere i and is a recapitulation of Gesualdo’s fatti salienti della vita di Gesualdo, life and a sensitive evaluation of his l’articolo di Pirrotta propone un’acuta compositional priorities, poetic disamina delle priorità compositive del choices, and artistic achievements. Principe, delle sue scelte in materia di testi poetici e dei suoi risultati artistici. «Philomusica on-line» – Rivista del Dipartimento di Musicologia e Beni culturali e-mail: [email protected] – Università degli Studi di Pavia <http://philomusica.unipv.it> – ISSN 1826-9001 – Copyright © 2013 Philomusica on-line – Pavia University Press Philomusica on-line “Gesualdo 1613-2013” TRANSLATORS’ NOTE Nino Pirrotta’s Gesualdo da Venosa nel IV centenario della nascita. -

Gesualdo Paul Agnew Madrigali Libri Terzo & Quarto FRANZ LISZT
Les Arts Florissants Gesualdo Paul Agnew MADRIGALI LIBRI TERZO & QUARTO FRANZ LISZT CARLO GESUALDO (1566-1613) MADRIGALI A CINQUE VOCI CD 1 48’15 Libro terzo (Ferrara, 1595) 1 | Voi volete ch’io mora. Giovanni Battista Guarini, Rime HM, LR, SC, PA, EG 1’12 15 | Se piange ohimè la donna del mio core. Incerto MA, HM, LR, PA, EG 3’12 Prima parte 16 | Ancidetemi pur, grievi martiri. Incerto HM, LR, SC, PA, EG 2’53 2 | Seconda parte: Moro, o non moro? HM, LR, SC, PA, EG 2’22 17 | Se vi miro pietosa. Incerto MA, HM, LR, SC, EG 2’18 3 | Ahi, disperata vita. Incerto MA, LR, SC, PA, EG 1’49 18 | Deh, se già fu crudele al mio martire. Incerto MA, HM, LR, PA, EG 1’51 4 | Languisco, e moro, ahi, cruda! Incerto HM, LR, SC, PA, EG 3’44 19 | Dolcissimo sospiro. Annibale Pocaterra o Ottavio Rinuccini MA, LR, SC, PA, EG 2’56 5 Del bel de’ bei vostri occhi. Incerto MA, LR, SC, PA, EG | 2’30 20 | Donna, se m’ancidete. Incerto MA, HM, LR, SC, PA, EG 2’37 6 | Ahi, dispietata e cruda. Incerto HM, LR, SC, PA, EG 3’03 7 | Dolce spirto d’amore. Giovanni Battista Guarini, Rime MA, LR, SC, PA, EG 2’36 8 | Sospirava il mio core. Incerto HM, LR, SC, PA, EG 1’42 Prima parte. Les Arts Florissants 9 | Seconda parte: O mal nati messaggi e mal intesi HM, LR, SC, PA, EG 2’38 Paul Agnew 10 | Veggio sì dal mio sole. -

Bärenreiter Verlag
CARLO GESUALDO PRINCIPE DI VENOSA NEW GESUALDO EDITION OFFERTA DI SOTTOSCRIZIONE SUBSCRIPTION OFFER EINLADUNG ZUR SUBSKRIPTION Bärenreiter L’EDIZIONE La personalità di Carlo Gesualdo (Venosa 1566 – Gesualdo 1613), uno dei più grandi aristocratici italiani del suo tempo, principe di Venosa ma anche ‘principe dei musici’, considerato con Monte - verdi il maggiore compositore a cavallo tra Cinque e Sei cento, ha da sempre attratto l’attenzione di intellettuali e artisti, per la sua tormentata esistenza ma anche per la eccezionale qualità artistica della sua produzione. Già nell’anno della sua morte uno stimato maestro di cappella genovese, Simone Molinaro, realizzò una partitura dei cinque libri di madrigali a 5 e 6 voci, elevandoli a modello per lo studio del contrappunto e della composizione. Nel secolo scorso, l’entusiasmo di Igor Stravinskij per l’audace scrittura cromatica di Gesualdo diede vita a una vera e propria ‘Gesualdo Renaissance’, e riportò con forza all’attenzione di studiosi e ascoltatori la densa polifonia vocale del Principe. Da allora molte iniziative di ricerca si sono succedute; ma le opere di Carlo Gesualdo da Venosa, rimaste fino a oggi affidate ad edizioni inadeguate sotto l’aspetto critico-testuale anche se storicamente importanti, necessitano ormai con urgenza di una vera edizione critica, condotta con metodi rigorosi e aggiornati, e funzionale sia alle moderne esigenze di studio sia a quelle della esecuzione storicamente informata. G. Balducci, Pala del Perdono (1609), Chiesa di Santa Maria delle Grazie (Gesualdo, -
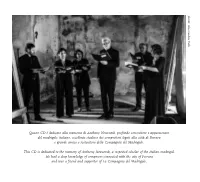
Questo CD È Dedicato Alla Memoria Di Anthony Newcomb, Profondo
p h o t o : A l e s s a n d r o V i o l i Questo CD è dedicato alla memoria di Anthony Newcomb, profondo conoscitore e appassionato del madrigale italiano, eccellente studioso dei compositori legati alla città di Ferrara e grande amico e sostenitore della Compagnia del Madrigale. This CD is dedicated to the memory of Anthony Newcomb, a respected scholar of the Italian madrigal. He had a deep knowledge of composers connected with the city of Ferrara and was a friend and supporter of La Compagnia del Madrigale. La Compagnia del Madrigale Rossana Bertini, soprano [rb] Francesca Cassinari, soprano [fc] Elena Carzaniga, alto [ec] Giuseppe Maletto, tenor [gm] Raffaele Giordani, tenor [rg] Daniele Carnovich, bass [dc] 7ef7 Recorded in Cumiana (Confraternita dei Santi Rocco e Sebastiano), Italy, on 24-28 April 2018 (Gesualdo: Secondo libro ), 24-26 June 2018 (Nenna, De Macque, Palazzotto, D’India), and 20 September 2018 (Gesualdo: O dolorosa gioia ) Engineered by Giuseppe Maletto Produced by La Compagnia del Madrigale Music transcriptions by Giuseppe Maletto Executive producer & editorial director: Carlos Céster Design: Rosa Tendero Photos on pages 11, 17, 28, 37: Giorgio Vergnano Translations: Mark Wiggins (essay, eng ), Andrea Friggi (poetry, eng ), Pierre Élie Mamou ( fra ), Susanne Lowien ( deu ) © 2019 note 1 music gmbh Ringraziamo Davide Ficco e Giorgio Taramasso per il supporto tecnico. Un grazie agli amici «Scipioni» per il loro contributo alla riscoperta di questi tesori madrigalistici. Carlo Gesualdo (1566-1613) Secondo Libro di Madrigali a cinque voci – Ferrara, 1594 7ef7 01 Se per lieve ferita [no. 3] fc, ec, gm, rg, dc 4:15 02 Non mi toglia il ben mio [no. -

New Music Announcement New Gesualdo Edition
New Music Announcement New Gesualdo Edition (HARRASSOWITZ Series ID: GES 1320) Italian composer and lutenist Carlo Gesualdo da Venosa (1566-1613), Prince of Venosa and Count of Conza, is best known for his highly expressive and richly chromatic madrigals and, together with Monteverdi, was considered the greatest composer at the turn of the 16th to 17th century. Published by Bärenreiter-Verlag Kassel, the new critical edition reviews all of Gesualdo’s existing printed and manuscript sources and evaluates their degree of authoritativeness for the very first time. The edition will comprise 12 volumes that can be purchased individually or in its entirety at a reduced subscription price. Each volume contains a Preface (in both Italian and English), a facsimile section, a critical edition of the texts set to music, and a Critical Commentary (also in both Italian and English). Order Information Please order via Fokus, HARRASSOWITZ's online system for managing subscriptions and standing orders, or through your normal library channels. Feel free to contact [email protected] for more information. Further details are also available on the HARRASSOWITZ News website under Special Announcements. Detailed citation information for the first published volume (Harr ID 185000788) may be found in OttoEditions, HARRASSOWITZ's online system for managing book and music score acquisitions. To obtain an OttoEditions or Fokus account for your library, please contact [email protected]. We hope you will find our selection to be of interest for your music -

Gesualdo US 25/8/10 12:35 Page 12
570549 bk Gesualdo US 25/8/10 12:35 Page 12 Carlo GESUALDO da Venosa Madrigals Book 2 Delitiæ Musicæ • Marco Longhini 8.570549 12 570549 bk Gesualdo US 25/8/10 12:35 Page 2 Carlo ^ Dalle odorate spoglie – Prima parte ^ From your perfumed clothes – Part One GESUALDO (Anonymous) (Anonymous) da Venosa Dalle odorate spoglie From your perfumed clothes sciogliete omai la mano free now your hands (1566-1613) che il mio voler e disvoler mi toglie. for they take my will and lack of will from me. THE SECOND BOOK OF MADRIGALS, 1594 & E quell’arpa felice – Seconda parte & And take that happy harp – Part Two IL SECONDO LIBRO DE’ MADRIGALI, 1594 (Anonymous) (Anonymous) 1 Caro amoroso neo (part 1) a, b, c, e, f 2:11 E quell’arpa felice, And take that happy harp 2 Ma se tale ha costei (part 2) a, b, c, e, f 1:57 a cui non si disdice which may without shame 3 Hai rotto e sciolto a, b, c, d, f 3:18 stringersi col bel petto, be held close to your fine breast, 4 Se per lieve ferita (part 1) a, b, c, d, f 2:10 d’Amor fido ricetto, Love’s faithful refuge, 5 Che sentir deve il petto (part 2) a, b, c, d, f 2:43 togliete e, con l’usata leggiadria, and, with your wonted grace, 6 In più leggiadro velo a, b, c, d, f 2:06 fateci udir, cara la vita mia. sing for us, Cara la vita mia. 7 Se così dolce è il duolo (part 1) a, b, c, e, f 1:27 8 Ma se avverrà ch’io moia (part 2) a, b, c, e, f 2:38 * Non mai cangerò stato * Never shall I change 9 Se taccio, il duol s’avanza a, b, c, e, f 2:28 (Anonymous) (Anonymous) 0 O come è gran martire (part 1) a, b, c, e, f, g 2:05 Non -

Hermaphroditic Mirroring in Mirtilla and Giovan Battista Andreini’S Amor Nello Specchio
Reflections of Isabella: Hermaphroditic Mirroring in Mirtilla and Giovan Battista Andreini’s Amor nello specchio Alexia Ferracuti mentre il mondo durerà, mentre staranno i secoli, mentre havran vita gli ordini e i tempi, ogni lingua, ogni grido risuonerà il celebre nome d’Isabella, specchio in vero d’onestà e tempio di dottrina —Antonio Maria Spelta, 16021 In 1601, Isabella Canali Andreini (1562-1604) became the only female member of Pavia’s Accademia degli Intenti and published her collection of Petrarchan verse, entitled Rime d’Isabella Andreini Padovana, comica gelosa.2 In the opening sonnet of her Rime, Andreini conflates her roles as poet and performer, warning her reader of the duplicitous naturalism permeating her theatrical and rhetorical talents: S’Alcun fia mai, che i versi miei negletti Legga, non creda à questi finti ardori, Che ne le Scene imaginati amori Usa à trattar con non leali affetti If ever there is anyone who reads These my neglected poems, don’t believe In their feigned ardors; loves imagined in Their scenes I’ve handled with emotions false3 Isabella likens the pretense of her pronouncements as a love poet to the artificiality of her celebrated dramatic role as a romantic heroine or innamorata.4 As if in the mode of a prologue to a play, Isabella introduces the performance about to ensue in the impending verses, which are voiced from both male and female perspectives. The fraudulence she claims to enact with her “finti ardori” is echoed in the next stanza, where she professes her deployment of “finti detti” to give life to her myriad of metamorphoses, going on to further underscore the artificiality of her 1 Antonio Maria Spelta, La curiosa et dilettevola aggionta del Sig. -

Robinson, S.E 2017 Vol.1.Pdf
‘In her right hand she bore a trumpet, in her left an olive branch...’ Performance Space and the Early Modern Female Wind Player In 2 volumes Sarah Emily Robinson Volume 1 Submitted in fulfilment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy Newcastle University, The International Centre for Music Studies (ICMuS) May 2017 Abstract References to early modern female wind players are scattered across a wide range of organological, iconographical and musicological scholarship. Normally highlighted as being unusual and in stark opposition to conventional ideals of female behaviour and musical practice of this time, such examples are often reduced to footnotes or side-lined as interesting, but unique instances. To date, no scholar has systematically brought these sources together to examine the continuities, tensions and changes to representations of, attitudes to, and detailed evidence for early modern women playing wind instruments. Among the questions I ask in this thesis are: How did early modern female wind players have access to musical educations, tutors, instruments and repertoire? What were the types of performance spaces in which they could play? Were there any constraints or rulings that stipulated how they were to present their music to private or public audiences? And where possible, I will also ask how female wind players were received by audiences and how the presentation of such unusual skills might have been used to contribute to institutional reputations. Importantly, these examples enable moments of change and stasis in the use of wind instruments to be traced to certain times and places during the early modern period which, in turn, reflect wider social patterns relating to musical developments, as well as changing instrument use and accessibility.