D'annunzio Sulla Scena Lirica
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

CHAN 3000 FRONT.Qxd
CHAN 3000 FRONT.qxd 22/8/07 1:07 pm Page 1 CHAN 3000(2) CHANDOS O PERA IN ENGLISH David Parry PETE MOOES FOUNDATION Puccini TOSCA CHAN 3000(2) BOOK.qxd 22/8/07 1:14 pm Page 2 Giacomo Puccini (1858–1924) Tosca AKG An opera in three acts Libretto by Giuseppe Giacosa and Luigi Illica after the play La Tosca by Victorien Sardou English version by Edmund Tracey Floria Tosca, celebrated opera singer ..............................................................Jane Eaglen soprano Mario Cavaradossi, painter ..........................................................................Dennis O’Neill tenor Baron Scarpia, Chief of Police................................................................Gregory Yurisich baritone Cesare Angelotti, resistance fighter ........................................................................Peter Rose bass Sacristan ....................................................................................................Andrew Shore baritone Spoletta, police agent ........................................................................................John Daszak tenor Sciarrone, Baron Scarpia’s orderly ..............................................Christopher Booth-Jones baritone Jailor ........................................................................................................Ashley Holland baritone A Shepherd Boy ............................................................................................Charbel Michael alto Geoffrey Mitchell Choir The Peter Kay Children’s Choir Giacomo Puccini, c. 1900 -

Ceriani Rowan University Email: [email protected]
Nineteenth-Century Music Review, 14 (2017), pp 211–242. © Cambridge University Press, 2016 doi:10.1017/S1479409816000082 First published online 8 September 2016 Romantic Nostalgia and Wagnerismo During the Age of Verismo: The Case of Alberto Franchetti* Davide Ceriani Rowan University Email: [email protected] The world premiere of Pietro Mascagni’s Cavalleria rusticana on 17 May 1890 immediately became a central event in Italy’s recent operatic history. As contemporary music critic and composer, Francesco D’Arcais, wrote: Maybe for the first time, at least in quite a while, learned people, the audience and the press shared the same opinion on an opera. [Composers] called upon to choose the works to be staged, among those presented for the Sonzogno [opera] competition, immediately picked Mascagni’s Cavalleria rusticana as one of the best; the audience awarded this composer triumphal honours, and the press 1 unanimously praised it to the heavens. D’Arcais acknowledged Mascagni’smeritsbut,inthesamearticle,alsourgedcaution in too enthusiastically festooning the work with critical laurels: the dangers of excessive adulation had already become alarmingly apparent in numerous ill-starred precedents. In the two decades prior to its premiere, several other Italian composers similarly attained outstanding critical and popular success with a single work, but were later unable to emulate their earlier achievements. Among these composers were Filippo Marchetti (Ruy Blas, 1869), Stefano Gobatti (IGoti, 1873), Arrigo Boito (with the revised version of Mefistofele, 1875), Amilcare Ponchielli (La Gioconda, 1876) and Giovanni Bottesini (Ero e Leandro, 1879). Once again, and more than a decade after Bottesini’s one-hit wonder, D’Arcais found himself wondering whether in Mascagni ‘We [Italians] have finally [found] … the legitimate successor to [our] great composers, the person 2 who will perpetuate our musical glory?’ This hoary nationalist interrogative returned in 1890 like an old-fashioned curse. -

Franchetti Prog Di Sala FIRENZE
Presentazione del volume ALBERTO FRANCHETTI: L’UOMO, IL COMPOSITORE, L’ARTISTA a cura di Paolo Giorgi e Richard Erkens - Lucca, Libreria Musicale Italiana, 2015 Firenze, Sala del Buonumore - Conservatorio “Luigi Cherubini” Sabato 18 giugno 2016, ore 17 Davide Ceriani, Cesare Orselli, Richard Erkens relatori Il compositore Alberto Franchetti (1860-1942), eminente personalità del cosiddetto 'lungo Ottocento' musicale, fu uno dei più conosciuti compositori della Giovane Scuola italiana, insieme a Giacomo Puccini, Pietro Mascagni e Ruggero Leoncavallo; grazie ai successi operistici internazionali delle sue opere liriche Asrael (1888), Cristoforo Colombo (1892) e Germania (1902), Franchetti ebbe una notevole fama fino agli anni Venti del XX secolo, per poi cadere nell'oblio fino agli anni più recenti. Nel settembre 2010 è stato organizzato, a cura dell' Associazione per il musicista Alberto Franchetti di Reggio Emilia, un convegno internazionale sulla sua figura, volto a dare l'avvio ad una nuova valorizzazione a lui e alla sua opera. Gli atti del convegno, ampliati nei contenuti e curati da Paolo Giorgi e Richard Erkens, costituiscono il volume Alberto Franchetti: l'uomo, il compositore, l'artista (LIM, 2015) a cura di, nel quale si affronta la figura del compositore sotto vari aspetti: l'analisi delle composizioni sinfoniche, gli aspetti drammatico- musicali delle sue numerose e articolate opere liriche, e la ricezione in Europa e in America della sua produzione; completa il volume una ricca sezione di documenti, riguardanti nuove fonti biografiche, lettere manoscritte inedite che riguardano la collaborazione tra Franchetti e Gabriele D’Annunzio per realizzazione de La figlia di Iorio del1906, nonché il catalogo del Fondo Alberto Franchetti depositato dal 2013 presso la Biblioteca Panizzi di Reggio Emilia. -

Tomo Ii Corretto
«GIÀ TROPPE VOLTE ESULI» LETTERATURA DI FRONTIERA E DI ESILIO a cura di Novella di Nunzio e Francesco Ragni Tomo II Università degli studi di Perugia Culture Territori Linguaggi – 3 2014 «GIÀ TROPPE VOLTE ESULI» LETTERATURA DI FRONTIERA E DI ESILIO a cura di Novella di Nunzio e Francesco Ragni Tomo II Università degli Studi di Perugia Indice del tomo II TESTIMONIANZE D’AUTORE DIEGO ZANDEL La mia frontiera…………………………………………………………………...p. 7 IN FUGA DA… ESILIO VOLONTARIO ELISABETH KERTESZ-VIAL Luigi Pirandello dal 1929 al 1935: un improbabile esiliato volontario…...….p. 15 ILARIA DE SETA Autoesilio americano e World Republic nei diari inediti di Giuseppe Antonio Borgese……………………………………………………………………..……..p. 23 ANDREA PAGANINI La letteratura italiana in Svizzera durante la seconda guerra mondia- le………………………………………………………………………...................p. 39 CRISTINA TERRILE Il «dispatrio» di Luigi Meneghello: la polarità come fondamento di poeti- ca……………………………………………………………...……………….…..p. 53 ERRANTI NOVELLA DI NUNZIO La funzione letteraria dell’ebreo errante e l’ebraismo come dispositivo narra- tivo e critico………………………………………………………...…………….p. 65 VALENTINA SARDELLI «La vera patria è la lingua». Gli intellettuali ebreo-tedeschi da minoranza pra- ghese a comunità esule…………….……………………………………………p. 89 MARTA MĘDRZAK-CONWAY New York Exiles, Triestine Exiles: Affinities Between American-Jewish and Svevian Protagonists.……………………………….……………….……….….p. 97 FORME DI ESILIO, MIGRAZIONE, FRONTIERA: TEATRO PAOLO PUPPA La grazia/disgrazia di essere straniero a teatro……………………………...p. 107 MARTINA DAMIANI – FABRIZIO FIORETTI L’esilio degli intellettuali italiani dai territori asburgici: il percorso di Nanni Mocenigo……………………………………………………………………...…p. 123 ANNE-MARIE LIEVENS L’arcangelo dall’ala spezzata: l’esilio di Alberti in Noche de guerra en el Museo del Prado ……………………………………………………………………….….p. 131 MARIA ESTER BADIN Migrazione e teatro……………………………………………………………..p. -
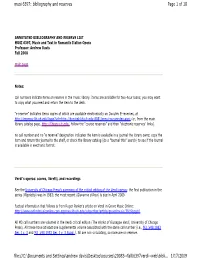
Page 1 of 18 Musi 6397: Bibliography and Reserves 1/17/2009 File
musi 6397: bibliography and reserves Page 1 of 18 ANNOTATED BIBLIOGRAPHY AND RESERVE LIST MUSI 6397, Music and Text in Romantic Italian Opera Professor: Andrew Davis Fall 2008 main page Notes: call numbers indicate items on reserve in the music library. Items are available for two-hour loans; you may want to copy what you need and return the item to the desk. “e reserve” indicates items copies of which are available electronically on Docutek E-reserves, at http://ezproxy.lib.uh.edu/login?url=http://docutek.lib.uh.edu:8081/eres/courseindex.aspx (or, from the main library catalog page, http://library.uh.edu/, follow the “course reserves” and then “electronic reserves" links). no call number and no “e reserve” designation indicates the item is available in a journal the library owns; copy the item and return the journal to the shelf, or check the library catalog (do a "journal title" search) to see if the journal is available in electronic format. Verdi's operas: scores, libretti, and recordings See the University of Chicago Press's summary of the critical edition of the Verdi operas: the first publication in the series (Rigoletto) was in 1983; the most recent (Giovanna d'Arco) is due in April 2009. Factual information that follows is from Roger Parker's article on Verdi in Grove Music Online: http://www.oxfordmusiconline.com.ezproxy.lib.uh.edu/subscriber/article/grove/music/29191pg10. All M3 call numbers are volumes in the Verdi critical edition (The Works of Giuseppe Verdi, University of Chicago Press). All these have at least one supplemental volume associated with the same call number (i.e., M3 .V48 1983 Ser. -

FINAL Tosca 2018
Stories Told Through Singing TOSCA Giacomo Puccini OPERA: Stories Told Through Singing At Palm Beach Opera, we believe that opera tells stories to which we can all relate, and that is why the operatic art form has thrived for centuries. The education programs at Palm Beach Opera plug the community directly into those stories, revealing timeless tales of love, passion, and joy. We challenge each person to find their own connection to opera’s stories, inspiring learners of all ages to explore the world of opera. At Palm Beach Opera there is something for everyone! #PBOperaForAll 1 PBOPERA.ORG // 561.833.7888 TOSCA Giacomo Puccini The Masterminds pg 3 Who's Who pg 7 Understanding the Action pg 9 Engage Your Mind pg 13 PBOPERA.ORG // 561.833.7888 2 The Masterminds 3 PBOPERA.ORG // 561.833.7888 Giacomo Puccini Composer Giacomo Puccini (December 22, 1858 – November 29, 1924) was born into a musical family. He studied composition at the Milan Conservatory, writing his first opera in 1884 at the age of 26. A prolific composer, Puccini wrote many operas including several that are still in performance today: Manon Lescaut, Tosca, Madama Butterfly, La fanciulla del West, La rondine, Suor Angelica, Gianni Schicchi, Turandot, and La bohème. Although the designation of Puccini as a verismo composer is debated, many of his works can fit in this category. Verismo is derived from the Italian word ‘vero’ meaning'true;' the style is distinguished by realistic lines and genuine characters. Fun Factoid: Puccini's full name was Giacomo Antonio Domenico Michele Secondo Maria Puccini. -

Archivio D'annunzio
[online] ISSN 2421-292X Archivio [print] ISSN 2421-4213 d’Annunzio Vol. 3 Edizioni Ottobre 2016 Ca’Foscari [online] ISSN 2421-292X Archivio d’Annunzio [print] ISSN 2421-4213 Direttori Ilaria Crotti, Pietro Gibellini, Paolo Puppa Edizioni Ca’ Foscari - Digital Publishing Università Ca’ Foscari Venezia Dorsoduro 3859/A 30123 Venezia http://edizionicafoscari.unive.it/it/edizioni/riviste/archivio-dannunzio/ Archivio d’Annunzio Rivista annuale Direttori Ilaria Crotti (Università Ca’ Foscari Venezia, Italia) Pietro Gibellini (Università Ca’ Foscari Venezia, Italia) Paolo Puppa (Università Ca’ Foscari Venezia, Italia) Comitato scientifico Giuseppina Dal Canton (Università degli Studi di Padova, Italia) Adriana Guarnieri (Università Ca’ Foscari Venezia, Italia) Mario Isnenghi (Università Ca’ Foscari Venezia, Italia) Tiziana Piras (Università degli Studi di Trieste, Italia) Ricciarda Ricorda (Università Ca’ Foscari Venezia, Italia) Comitato di lettura Raffaella Bertazzoli (Università degli Studi di Verona, Italia) Maria Ida Biggi (Università Ca’ Fo- scari Venezia, Italia) Milva Maria Cappellini (Centro Nazionale di Studi dannunziani, Pescara, Italia) Raffaella Castagnola (Universität Zürich, Schweiz) Simona Costa (Università degli Studi Roma Tre, Italia) Luciano Curreri (Université de Liège, Belgique) Željko Đuric´ (Univerzitet u Beogradu, Srbija) Silvia Fabrizio-Costa (Université de Caen-Basse Normandie, Fran- ce) Monica Giachino (Università Ca’ Foscari Venezia, Italia) Maria Rosa Giacon (Centro Nazionale di Studi dannunziani, Pescara, Italia) -

Leggi Qualche Pagina
saggi 1 © 2017 Ronzani Editore Vicenza | Elabora S.r.l. Viale del Progresso, 10 | 36010 Monticello Conte Otto (Vi) www.ronzanieditore.it | [email protected] ISBN 978-88-94911-06-0 Alessandro Duranti IL MELOMANE DOMESTICO Maria Callas e altri scritti sull’opera RE Ronzani Editore INDICE 7 Prefazione 13 Maria Callas, ovvero Tutte le torture 53 Verdi e l’arte del mutare la maniera 63 Note veriste. Mascagni e gli altri « nemici della musica» 109 Maremoto a Massaciuccoli. Il Novecento di Puccini 125 Toscanini, la vecchiaia, l’opera e il disco 141 Montale ‘en travesti ’ 161 Indice dei nomi Prefazione « Chi scrive non sa di musica»: inizia così la Filosofia della Musica (1836) di Giuseppe Mazzini e allo stesso modo ini- zio io, colpito da un attacco di megalomania fulminante, ma del resto, se ci sono i pazzi che si credono Napoleone o Garibaldi, mi sento perfino in buona compagnia. Quanto alle mie competenze musicali, non so neanche cantare a orecchio, come si dice abbiano fatto e facciano cantanti celeberrimi. Credo di essere la creatura più stonata dell’u- niverso e quando ascolto certe masterclass di grandi can- tanti e grandi didatti (ne sono state pubblicate varie, per esempio di Alfredo Kraus, di Beniamino Gigli o della stes- sa Callas) rimango sempre stupito e ammirato che qualcu- no possa aprire bocca e cantare davvero, bene o male non importa, dopo aver saputo quanti e quali ingranaggi del suo corpo – diaframmi, tonsille, laringi, polmoni, coratelle varie, cavità facciali, alluci, lobi degli orecchi (il baritono Giuseppe Valdengo, quello di Toscanini, ci aggiungeva an- che una parte del corpo meno nobile) – devono accordarsi per poterlo fare. -

Norbeck, Peters & Ford
Norbeck, Peters & Ford 59 Congress Street Saint Albans, VT 05478-1611 USA 1-802-524-7673; 1-800-654-5302 Fax: 1 888 819 4831 email: [email protected] website: www.norpete.com Auction Number 146 •- AUCTION Closing Date: Friday, 29 May, 2015 1001. AINO ACKTÉ: FAUST – Air des bijoux / LOHENGRIN – Einsam in trüben Tagen (in French). 10½” brown Parl. Odeon PO 93 (XPr 1-2/4-2), (w.Ackté’s signature embossed in shellac). M-A, superlative copy. MB 35 “It is difficult to realise that Ackté's sensational début at Covent Garden was as Salome in Richard Strauss' opera. Here she sings…with grace and excellent coloratura technique, and although she was Finnish, the style is typically French, and with immaculate diction. - John Freestone 1002. AGUSTARELLO AFFRE (The French Tamagno): ARMIDE – Plus j’observe ces lieux (Gluck) / MARCELLE DEMOUGEOT, AGUSTARELLO AFFRE, JUSTE NIVETTE: FAUST - Anges purs, anges radieux. 10½” brown & white French Odéon 97011/60895 (XP 4250/4267). A or better, choice copy has few faintest rubs, positively inaud. MB 15 1003. AGUSTARELLO AFFRE (The French Tamagno): SIGURD – Esprits, gardiens (Reyer) / L’ATTAQUE DU MOULIN – Adieux à la forêt (Bruneau). 10½” brown & gold / brown & white French Odéon 36682/36741 (XP 2460/2565). A to M-A, choice copy. MB 15 1004. AGUSTARELLO AFFRE (The French Tamagno): L’AFRICAINE – Pays merveilleux, 2s. 10½” brown & gold French Odéon 36695/72 (XP 2463/75). A to M-A, choice copy has, Sd.2 only, very few superficial pap.scuffs, barely visible & inaud. MB 15 1005. AGUSTARELLO AFFRE (The French Tamagno): GUILLAUME TELL – Asile héréditaire / LOHENGRIN – In fernem Land (in French). -

Ceriani the Reception of Alberto Franchetti’S Works in the United States 271 Marialuisa Pepi Franchetti Attraverso I Documenti Del Gabinetto G.P
Alberto Franchetti. l’uomo, il compositore, l’artista Atti del convegno internazionale Reggio Emilia, 18-19 settembre 2010 a cura di Paolo Giorgi e Richard Erkens Alberto Franchetti. L’uomo, il compositore, l’artista il compositore, L’uomo, Franchetti. Alberto associazione per il musicista ALBERTO FRANCHETTI Alberto Franchetti l’uomo, il compositore, l’artista associazione per il musicista FRANCHETTI ALBERTO a cura di Paolo Giorgi e Richard Erkens € 30,00 LIM Libreria Musicale Italiana Questa pubblicazione è stata realizzata dall’Associazione per il musicista Alberto Franchetti, in collaborazione con il Comune di Regio Emilia / Biblioteca Panizzi, e con il sostegno di Stefano e Ileana Franchetti. Soci benemeriti dell’Associazione per il musicista Alberto Franchetti Famiglia Ponsi Stefano e Ileana Franchetti Fondazione I Teatri – Reggio Emilia Fondazione Pietro Manodori – Reggio Emilia Hotel Posta – Reggio Emilia Redazione, grafica e layout: Ugo Giani © 2015 Libreria Musicale Italiana srl, via di Arsina 296/f, 55100 Lucca [email protected] www.lim.it Tutti i diritti sono riservati. Nessuna parte di questa pubblicazione potrà essere riprodot- ta, archiviata in sistemi di ricerca e trasmessa in qualunque forma elettronica, meccani- ca, fotocopiata, registrata o altro senza il permesso dell’editore, dell’autore e del curatore. ISBN 978-88-7096-817-0 associazione per il musicista ALBERTO FRANCHETTI Alberto Franchetti l’uomo, il compositore, l’artista Atti del convegno internazionale Reggio Emilia, 18-19 settembre 2010 a cura di Paolo Giorgi e Richard Erkens Libreria Musicale Italiana Alla memoria di Elena Franchetti (1922-2009) Sommario Presentazione, Luca Vecchi xi Premessa, Stefano Maccarini Foscolo xiii Paolo Giorgi – Richard Erkens Introduzione xv Alberto Franchetti (1860-1942) l’uomo, il compositore, l’artista Parte I Dal sinfonista all’operista internazionale Antonio Rostagno Alberto Franchetti nel contesto del sinfonismo italiano di fine Ottocento 5 Emanuele d’Angelo Alla scuola di Boito. -

Fondo Alberto Franchetti Inventario
Biblioteca Panizzi Fondo Alberto Franchetti Inventario A cura di Roberto Marcuccio Reggio Emilia Febbraio 2014 Fondo Alberto Franchetti – Inventario Sommario Introduzione ..................................................................................................................................... p. 3 Inventario ......................................................................................................................................... p. 7 Appendice – Documenti relativi ad Alberto Franchetti in altri fondi della Biblioteca Panizzi...................................................................................................... p. 18 1. Manoscritti e carteggi..................................................................................................... p. 18 2. Musica a stampa ............................................................................................................ p. 20 3. Libretti............................................................................................................................ p. 22 4. Altri documenti a stampa .............................................................................................. p. 24 5. Incisioni ......................................................................................................................... p. 26 6. Fotografie ....................................................................................................................... p. 26 Bibliografia ................................................................................................................................... -

C a R L N I E L S E N S T U D I
CARL NIELSEN STUDIES V O L U M E V I • 2 0 2 0 CARL NIELSEN STUDIES V O L U M E V I • 2 0 2 0 Edited by Michelle Assay, David Fanning (editor-in-chief), Daniel Grimley, Niels Krabbe (consultant), and Christopher Tarrant Copenhagen 2020 The Royal Library Honorary board John Bergsagel, prof.emer., Copenhagen Jean Christensen, prof., University of Louisville, Kentucky Ludwig Finscher, prof.emer., Wolfenbüttel Jim Samson, prof., Royal Holloway, London Arnold Whittall, prof.emer., King’s College, London Editorial board Michelle Assay David Fanning (editor-in-chief) Daniel Grimley Niels Krabbe (consultant) Christopher Tarrant Translation or linguistic amendment of texts by Eskildsen, Røllum-Larsen, and Caron has been carried out by David Fanning, Marie-Louise Zervides, and Michelle Assay. Graphic design Kontrapunkt A/S, Copenhagen Layout and formatting Hans Mathiasen Text set in Swift ISSN 1603-3663 Sponsored by The Carl Nielsen and Anne Marie Carl-Nielsen Foundation © 2020 The authors and Carl Nielsen Studies, The Royal Library All rights reserved 2020 Permission for the use of quotations from the Carl Nielsen Edition has been kindly given by The Royal Library. N I E L S E N ’ S SAUL AND DAVID A N D ITALIAN OPERA 1 By Paolo Muntoni The popular image of Carl Nielsen is more strongly associated with his symphonies and songs than with the theatre, even though he wrote two operas that are among the finest Danish examples of their kind. If Maskarade has always been regarded as a success, and has recently begun to attract international reappraisal, Saul and David by contrast has remained in the shadow of its younger sister.