Leggi Qualche Pagina
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

CHAN 3000 FRONT.Qxd
CHAN 3000 FRONT.qxd 22/8/07 1:07 pm Page 1 CHAN 3000(2) CHANDOS O PERA IN ENGLISH David Parry PETE MOOES FOUNDATION Puccini TOSCA CHAN 3000(2) BOOK.qxd 22/8/07 1:14 pm Page 2 Giacomo Puccini (1858–1924) Tosca AKG An opera in three acts Libretto by Giuseppe Giacosa and Luigi Illica after the play La Tosca by Victorien Sardou English version by Edmund Tracey Floria Tosca, celebrated opera singer ..............................................................Jane Eaglen soprano Mario Cavaradossi, painter ..........................................................................Dennis O’Neill tenor Baron Scarpia, Chief of Police................................................................Gregory Yurisich baritone Cesare Angelotti, resistance fighter ........................................................................Peter Rose bass Sacristan ....................................................................................................Andrew Shore baritone Spoletta, police agent ........................................................................................John Daszak tenor Sciarrone, Baron Scarpia’s orderly ..............................................Christopher Booth-Jones baritone Jailor ........................................................................................................Ashley Holland baritone A Shepherd Boy ............................................................................................Charbel Michael alto Geoffrey Mitchell Choir The Peter Kay Children’s Choir Giacomo Puccini, c. 1900 -

28Apr2004p2.Pdf
144 NAXOS CATALOGUE 2004 | ALPHORN – BAROQUE ○○○○ ■ COLLECTIONS INVITATION TO THE DANCE Adam: Giselle (Acts I & II) • Delibes: Lakmé (Airs de ✦ ✦ danse) • Gounod: Faust • Ponchielli: La Gioconda ALPHORN (Dance of the Hours) • Weber: Invitation to the Dance ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ Slovak RSO / Ondrej Lenárd . 8.550081 ■ ALPHORN CONCERTOS Daetwyler: Concerto for Alphorn and Orchestra • ■ RUSSIAN BALLET FAVOURITES Dialogue avec la nature for Alphorn, Piccolo and Glazunov: Raymonda (Grande valse–Pizzicato–Reprise Orchestra • Farkas: Concertino Rustico • L. Mozart: de la valse / Prélude et La Romanesca / Scène mimique / Sinfonia Pastorella Grand adagio / Grand pas espagnol) • Glière: The Red Jozsef Molnar, Alphorn / Capella Istropolitana / Slovak PO / Poppy (Coolies’ Dance / Phoenix–Adagio / Dance of the Urs Schneider . 8.555978 Chinese Women / Russian Sailors’ Dance) Khachaturian: Gayne (Sabre Dance) • Masquerade ✦ AMERICAN CLASSICS ✦ (Waltz) • Spartacus (Adagio of Spartacus and Phrygia) Prokofiev: Romeo and Juliet (Morning Dance / Masks / # DREAMER Dance of the Knights / Gavotte / Balcony Scene / A Portrait of Langston Hughes Romeo’s Variation / Love Dance / Act II Finale) Berger: Four Songs of Langston Hughes: Carolina Cabin Shostakovich: Age of Gold (Polka) •␣ Bonds: The Negro Speaks of Rivers • Three Dream Various artists . 8.554063 Portraits: Minstrel Man •␣ Burleigh: Lovely, Dark and Lonely One •␣ Davison: Fields of Wonder: In Time of ✦ ✦ Silver Rain •␣ Gordon: Genius Child: My People • BAROQUE Hughes: Evil • Madam and the Census Taker • My ■ BAROQUE FAVOURITES People • Negro • Sunday Morning Prophecy • Still Here J.S. Bach: ‘In dulci jubilo’, BWV 729 • ‘Nun komm, der •␣ Sylvester's Dying Bed • The Weary Blues •␣ Musto: Heiden Heiland’, BWV 659 • ‘O Haupt voll Blut und Shadow of the Blues: Island & Litany •␣ Owens: Heart on Wunden’ • Pastorale, BWV 590 • ‘Wachet auf’ (Cantata, the Wall: Heart •␣ Price: Song to the Dark Virgin BWV 140, No. -

Ceriani Rowan University Email: [email protected]
Nineteenth-Century Music Review, 14 (2017), pp 211–242. © Cambridge University Press, 2016 doi:10.1017/S1479409816000082 First published online 8 September 2016 Romantic Nostalgia and Wagnerismo During the Age of Verismo: The Case of Alberto Franchetti* Davide Ceriani Rowan University Email: [email protected] The world premiere of Pietro Mascagni’s Cavalleria rusticana on 17 May 1890 immediately became a central event in Italy’s recent operatic history. As contemporary music critic and composer, Francesco D’Arcais, wrote: Maybe for the first time, at least in quite a while, learned people, the audience and the press shared the same opinion on an opera. [Composers] called upon to choose the works to be staged, among those presented for the Sonzogno [opera] competition, immediately picked Mascagni’s Cavalleria rusticana as one of the best; the audience awarded this composer triumphal honours, and the press 1 unanimously praised it to the heavens. D’Arcais acknowledged Mascagni’smeritsbut,inthesamearticle,alsourgedcaution in too enthusiastically festooning the work with critical laurels: the dangers of excessive adulation had already become alarmingly apparent in numerous ill-starred precedents. In the two decades prior to its premiere, several other Italian composers similarly attained outstanding critical and popular success with a single work, but were later unable to emulate their earlier achievements. Among these composers were Filippo Marchetti (Ruy Blas, 1869), Stefano Gobatti (IGoti, 1873), Arrigo Boito (with the revised version of Mefistofele, 1875), Amilcare Ponchielli (La Gioconda, 1876) and Giovanni Bottesini (Ero e Leandro, 1879). Once again, and more than a decade after Bottesini’s one-hit wonder, D’Arcais found himself wondering whether in Mascagni ‘We [Italians] have finally [found] … the legitimate successor to [our] great composers, the person 2 who will perpetuate our musical glory?’ This hoary nationalist interrogative returned in 1890 like an old-fashioned curse. -

Franchetti Prog Di Sala FIRENZE
Presentazione del volume ALBERTO FRANCHETTI: L’UOMO, IL COMPOSITORE, L’ARTISTA a cura di Paolo Giorgi e Richard Erkens - Lucca, Libreria Musicale Italiana, 2015 Firenze, Sala del Buonumore - Conservatorio “Luigi Cherubini” Sabato 18 giugno 2016, ore 17 Davide Ceriani, Cesare Orselli, Richard Erkens relatori Il compositore Alberto Franchetti (1860-1942), eminente personalità del cosiddetto 'lungo Ottocento' musicale, fu uno dei più conosciuti compositori della Giovane Scuola italiana, insieme a Giacomo Puccini, Pietro Mascagni e Ruggero Leoncavallo; grazie ai successi operistici internazionali delle sue opere liriche Asrael (1888), Cristoforo Colombo (1892) e Germania (1902), Franchetti ebbe una notevole fama fino agli anni Venti del XX secolo, per poi cadere nell'oblio fino agli anni più recenti. Nel settembre 2010 è stato organizzato, a cura dell' Associazione per il musicista Alberto Franchetti di Reggio Emilia, un convegno internazionale sulla sua figura, volto a dare l'avvio ad una nuova valorizzazione a lui e alla sua opera. Gli atti del convegno, ampliati nei contenuti e curati da Paolo Giorgi e Richard Erkens, costituiscono il volume Alberto Franchetti: l'uomo, il compositore, l'artista (LIM, 2015) a cura di, nel quale si affronta la figura del compositore sotto vari aspetti: l'analisi delle composizioni sinfoniche, gli aspetti drammatico- musicali delle sue numerose e articolate opere liriche, e la ricezione in Europa e in America della sua produzione; completa il volume una ricca sezione di documenti, riguardanti nuove fonti biografiche, lettere manoscritte inedite che riguardano la collaborazione tra Franchetti e Gabriele D’Annunzio per realizzazione de La figlia di Iorio del1906, nonché il catalogo del Fondo Alberto Franchetti depositato dal 2013 presso la Biblioteca Panizzi di Reggio Emilia. -

RCA Victor LCT 1 10 Inch “Collector's Series”
RCA Discography Part 28 - By David Edwards, Mike Callahan, and Patrice Eyries. © 2018 by Mike Callahan RCA Victor LCT 1 10 Inch “Collector’s Series” The LCT series was releases in the Long Play format of material that was previously released only on 78 RPM records. The series was billed as the Collector’s Treasury Series. LCT 1 – Composers’ Favorite Intepretations - Vienna Philharmonic Orchestra [195?] Rosca: Recondita Amonia – Enrico Caruso/Madama Butterfly, Entrance of Butterfly – G. Farrar/Louise: Depuis Le Jour – M. Garden/Louise: Depuis Longtemps j’Habitais – E Johnson/Tosca: Vissi D’Arte – M. Jeritza/Der Rosenkavailier Da Geht ER Hin and Ich Werd Jetzt in Die Kirchen Geh’n – L Lehmann/Otello: Morte d’Otello – F. Tamagno LCT 2 – Caruso Sings Light Music – Enrico Caruso and Mischa Elman [195?] O Sole Mio/The Lost Chord/For You Alone/Ave Maria (Largo From "Xerxes")/Because/Élégie/Sei Morta Nella Vita Mia LCT 3 – Boris Goudnoff (Moussorgsky) – Feodor Chalipin, Albert Coates and Orchestra [1950] Coronation Scene/Ah, I Am Suffocating (Clock Scene)/I Have Attained The Highest Power/Prayer Of Boris/Death Of Boris LCT 4 LCT 5- Hamlet (Shakespeare) – Laurence Olivier with Philharmonia Orchestra [1950] O That This Too, Too Solid Flesh/Funeral March/To Be Or Not To Be/How Long Hast Thou Been Gravemaker/Speak The Speech/The Play Scene LCT 6 – Concerto for Violin and Orchestra No. 2 in G Minor Op. 63 (Prokofieff) – Jascha Heifetz and Serge Koussevitzky and the Boston Symphony Orchestra [1950] LCT 7 – Haydn Symphony in G Major – Arturo Toscanini and the NBC Symphony Orchestra [195?] LCT 8 LCT 9 LCT 10 –Rosa Ponselle in Opera and Song – Rosa Ponselle [195?] La Vestale: Tu Che Invoco; O Nume Tutelar, By Spontini/Otello: Salce! Salce! (Willow Song); Ave Maria, By Verdi/Ave Maria, By Schubert/Home, Sweet Home, By Bishop LCT 11 – Sir Harry Lauder Favorites – Harry Lauder [195?] Romin' In The Gloamin'/Soosie Maclean/A Wee Deoch An' Doris/Breakfast In Bed On Sunday Morning/When I Met Mackay/Scotch Memories LCT 12 – Concerto for Piano and Orchestra No. -

FINAL Tosca 2018
Stories Told Through Singing TOSCA Giacomo Puccini OPERA: Stories Told Through Singing At Palm Beach Opera, we believe that opera tells stories to which we can all relate, and that is why the operatic art form has thrived for centuries. The education programs at Palm Beach Opera plug the community directly into those stories, revealing timeless tales of love, passion, and joy. We challenge each person to find their own connection to opera’s stories, inspiring learners of all ages to explore the world of opera. At Palm Beach Opera there is something for everyone! #PBOperaForAll 1 PBOPERA.ORG // 561.833.7888 TOSCA Giacomo Puccini The Masterminds pg 3 Who's Who pg 7 Understanding the Action pg 9 Engage Your Mind pg 13 PBOPERA.ORG // 561.833.7888 2 The Masterminds 3 PBOPERA.ORG // 561.833.7888 Giacomo Puccini Composer Giacomo Puccini (December 22, 1858 – November 29, 1924) was born into a musical family. He studied composition at the Milan Conservatory, writing his first opera in 1884 at the age of 26. A prolific composer, Puccini wrote many operas including several that are still in performance today: Manon Lescaut, Tosca, Madama Butterfly, La fanciulla del West, La rondine, Suor Angelica, Gianni Schicchi, Turandot, and La bohème. Although the designation of Puccini as a verismo composer is debated, many of his works can fit in this category. Verismo is derived from the Italian word ‘vero’ meaning'true;' the style is distinguished by realistic lines and genuine characters. Fun Factoid: Puccini's full name was Giacomo Antonio Domenico Michele Secondo Maria Puccini. -
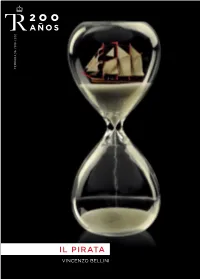
IL PIRATA VINCENZO BELLINI Hublot.Com BIG BANG UNICO
TEMPORADA 2019-2020 IL PIRATA VINCENZO BELLINI hublot.com BIG BANG UNICO Hublot_BallTeaReal_BBUnicoGC_150x210.indd 1 06.11.19 09:47 Hay energías que nos mueven por dentro. Hay energías que conectan con nuestras emociones. Como las que nos transmiten la danza, la música y el teatro. Para mantenerlas vivas y activas, patrocinamos desde hace más de una década el Teatro Real. Porque cuando transmitimos nuestra energía, el progreso es posible para todos. endesa.com Contraportada_150x210+3_S&S_Endesa2018_CULTURA_TR_P_ES_v2.indd 1 31/1/18 9:52 Regalos INOLVIDABLES Esta Navidad, regala grandes experiencias con Teatro Real. Pack Especial Navidad Sorprende regalando la aclamada producción de Willy Decker de La traviata, una ópera por descubrir como La pasajera y un recital único de Jonas Kaufmann. PACK EXCLUSIVO CON 10% DTO. EN VENTA ANTICIPADA. Desde 56,70 € (10% dto. incluido*) My Opera Player Una forma diferente de regalar ópera. Elige un plan anual o semestral para disfrutar de la nueva plataforma de vídeo del Teatro Real: grandes títulos y artistas, y lanzamientos mensuales de nuevas producciones. 45,99 € plan 6 meses o 79,99 € plan 1 año Libros del Teatro Real Imágenes, historia y anécdotas con los libros conmemorativos, disponibles en la Tienda del Real y en taquillas desde 10 €. 10 € 32 € - 48 € 19,50 € *Pack Especial Navidad: descuento aplicable a la compra conjunta de los tres títulos, disponible hasta el 5 de enero de 2020. Programa_NAVIDAD_TR2019_150x210+3.inddImágenes, 2 historia y anécdotas del Teatro Real con los libros conmemorativos 21/11/2019 11:08:49 de nuestro Bicentenario, disponibles en la Tienda del Real desde 10 €. -

Norbeck, Peters & Ford
Norbeck, Peters & Ford 59 Congress Street Saint Albans, VT 05478-1611 USA 1-802-524-7673; 1-800-654-5302 Fax: 1 888 819 4831 email: [email protected] website: www.norpete.com Auction Number 146 •- AUCTION Closing Date: Friday, 29 May, 2015 1001. AINO ACKTÉ: FAUST – Air des bijoux / LOHENGRIN – Einsam in trüben Tagen (in French). 10½” brown Parl. Odeon PO 93 (XPr 1-2/4-2), (w.Ackté’s signature embossed in shellac). M-A, superlative copy. MB 35 “It is difficult to realise that Ackté's sensational début at Covent Garden was as Salome in Richard Strauss' opera. Here she sings…with grace and excellent coloratura technique, and although she was Finnish, the style is typically French, and with immaculate diction. - John Freestone 1002. AGUSTARELLO AFFRE (The French Tamagno): ARMIDE – Plus j’observe ces lieux (Gluck) / MARCELLE DEMOUGEOT, AGUSTARELLO AFFRE, JUSTE NIVETTE: FAUST - Anges purs, anges radieux. 10½” brown & white French Odéon 97011/60895 (XP 4250/4267). A or better, choice copy has few faintest rubs, positively inaud. MB 15 1003. AGUSTARELLO AFFRE (The French Tamagno): SIGURD – Esprits, gardiens (Reyer) / L’ATTAQUE DU MOULIN – Adieux à la forêt (Bruneau). 10½” brown & gold / brown & white French Odéon 36682/36741 (XP 2460/2565). A to M-A, choice copy. MB 15 1004. AGUSTARELLO AFFRE (The French Tamagno): L’AFRICAINE – Pays merveilleux, 2s. 10½” brown & gold French Odéon 36695/72 (XP 2463/75). A to M-A, choice copy has, Sd.2 only, very few superficial pap.scuffs, barely visible & inaud. MB 15 1005. AGUSTARELLO AFFRE (The French Tamagno): GUILLAUME TELL – Asile héréditaire / LOHENGRIN – In fernem Land (in French). -

Ceriani the Reception of Alberto Franchetti’S Works in the United States 271 Marialuisa Pepi Franchetti Attraverso I Documenti Del Gabinetto G.P
Alberto Franchetti. l’uomo, il compositore, l’artista Atti del convegno internazionale Reggio Emilia, 18-19 settembre 2010 a cura di Paolo Giorgi e Richard Erkens Alberto Franchetti. L’uomo, il compositore, l’artista il compositore, L’uomo, Franchetti. Alberto associazione per il musicista ALBERTO FRANCHETTI Alberto Franchetti l’uomo, il compositore, l’artista associazione per il musicista FRANCHETTI ALBERTO a cura di Paolo Giorgi e Richard Erkens € 30,00 LIM Libreria Musicale Italiana Questa pubblicazione è stata realizzata dall’Associazione per il musicista Alberto Franchetti, in collaborazione con il Comune di Regio Emilia / Biblioteca Panizzi, e con il sostegno di Stefano e Ileana Franchetti. Soci benemeriti dell’Associazione per il musicista Alberto Franchetti Famiglia Ponsi Stefano e Ileana Franchetti Fondazione I Teatri – Reggio Emilia Fondazione Pietro Manodori – Reggio Emilia Hotel Posta – Reggio Emilia Redazione, grafica e layout: Ugo Giani © 2015 Libreria Musicale Italiana srl, via di Arsina 296/f, 55100 Lucca [email protected] www.lim.it Tutti i diritti sono riservati. Nessuna parte di questa pubblicazione potrà essere riprodot- ta, archiviata in sistemi di ricerca e trasmessa in qualunque forma elettronica, meccani- ca, fotocopiata, registrata o altro senza il permesso dell’editore, dell’autore e del curatore. ISBN 978-88-7096-817-0 associazione per il musicista ALBERTO FRANCHETTI Alberto Franchetti l’uomo, il compositore, l’artista Atti del convegno internazionale Reggio Emilia, 18-19 settembre 2010 a cura di Paolo Giorgi e Richard Erkens Libreria Musicale Italiana Alla memoria di Elena Franchetti (1922-2009) Sommario Presentazione, Luca Vecchi xi Premessa, Stefano Maccarini Foscolo xiii Paolo Giorgi – Richard Erkens Introduzione xv Alberto Franchetti (1860-1942) l’uomo, il compositore, l’artista Parte I Dal sinfonista all’operista internazionale Antonio Rostagno Alberto Franchetti nel contesto del sinfonismo italiano di fine Ottocento 5 Emanuele d’Angelo Alla scuola di Boito. -

15A Edizione PRATO, IVA PACETTI
PRATOLIRICA ODV in collaborazione Con la provincia di Prato ha istituito il Premio “PRATO—IVA PACETTI” TEATRO POLITEAMA PRATESE da assegnare ad un cantante lirico emergente, uomo o donna, “RIDOTTO” che nell’anno precedente, esibendosi in SABATO 26 OTTOBRE 2019 Concerti organizzati da Pratolirica, abbia dimostrato capacità vocali e recitative tali da ORE 16,00 riscuotere da parte del pubblico ampi Vincitori passate edizioni: a consensi. 15 edizione PRATO, Premio Il Premio viene conferito dal Consiglio Edizione 2005: Chiara Panacci, soprano (Italia) Edizione 2006: Cristiana Fogli, mezzosoprano (Italia) direttivo di Pratolirica . Edizione 2007: David Righeschi, tenore (Italia) IVA PACETTI Edizione 2008: Devid Cecconi, baritono (Italia) Edizione 2009: Myungho Kim, Tenore (Corea del Sud) Edizione 2010: Aldo Dongchul Son, baritone (Corea del Sud) Edizione 2011: Veronica Senserini, soprano (Italia) Edizione 2012: Erika Beretti, mezzosoprano (Italia) Edizione 2013: Adriano Gramigni, basso (Italia) Edizione 2014: Claire Briant Nesti, soprano (Costa Rica) Edizione 2015: Margherita Tani, mezzosoprano (Italia) Edizione 2016: Rachel Jane Birthisel, soprano (Australia) Edizione 2017: Nicolò Donini, basso (Italia) Edizione 2018: Mariangela Marini, mezzosoprano (Italia) Pratolirica ODV Via Santa Trinita, 2 –59100 Prato Tel.& Fax: 0574 611484 Cell. 3939897044 PAOLO ANTONIO NEVI, tenore Nato a Narni nel 1997, si diploma al Liceo Musicale “F. Angelo- “ALTA, FASCINOSA, BELLISSIMA” ni” di Terni e nel 2019 consegue il Diploma accademico in Can- to con il massimo dei voti, la lode e menzione d’onore, presso il conservatorio “Arrigo Boito” di Parma con i Maestri Nemi Ber- Così il Maestro Roberto Fioravanti descrive IVA PACETTI tagni (Prassi esecutiva e repertorio), Nicola Mottaran (Pratica all’uscita del Teatro Metastasio dopo la memorabile recita di del repertorio vocale) e Massimo Guidetti (Lettura dello sparti- Fedora nel 1945. -

Fondo Alberto Franchetti Inventario
Biblioteca Panizzi Fondo Alberto Franchetti Inventario A cura di Roberto Marcuccio Reggio Emilia Febbraio 2014 Fondo Alberto Franchetti – Inventario Sommario Introduzione ..................................................................................................................................... p. 3 Inventario ......................................................................................................................................... p. 7 Appendice – Documenti relativi ad Alberto Franchetti in altri fondi della Biblioteca Panizzi...................................................................................................... p. 18 1. Manoscritti e carteggi..................................................................................................... p. 18 2. Musica a stampa ............................................................................................................ p. 20 3. Libretti............................................................................................................................ p. 22 4. Altri documenti a stampa .............................................................................................. p. 24 5. Incisioni ......................................................................................................................... p. 26 6. Fotografie ....................................................................................................................... p. 26 Bibliografia ................................................................................................................................... -
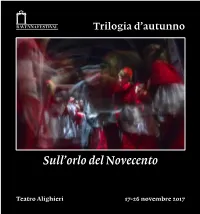
Programma Di Sala
Trilogia d’autunno Sull’orlo del Novecento Teatro Alighieri 17-26 novembre 2017 1 Sull’orlo del Novecento On the Verge of the 20th Century RAVENNA FESTIVAL 2017 Il tramonto di un’epoca si fonde all’alba di nuovi The sunset of an epoch merges into the dawn of a new era: Italian melodrama found tempi: è sul finire dell’Ottocento che il melodramma new life at the close of the 19th century. italiano ritrova nuova linfa, in quegli anni in cui tutto Those were the years when everything conduce alla modernità, a quel grumo di senso che inevitably led towards modernity, which Trilogia d’autunno precipita fino al cuore del Novecento, irradiandosi sino would explode in the heart of the twentieth Sull’orlo del Novecento century and irradiate down to us. In 1890, a noi. Nel 1890 l’immediatezza espressiva di Cavalleria Cavalleria rusticana conquered the theatres rusticana conquista i teatri imponendo il verbo “verista” with its dazzling expressive immediacy, in musica e, due anni dopo, Leoncavallo trasfigura un imposing “verismo” in music. Two years fatto di cronaca nelle tinte fosche di una passionalità later, Leoncavallo’s Pagliacci transformed an old real-life incident into a gloomy story senza scampo: la “parola scenica” esplode caricandosi of relentless passion. It was the explosion di una tradizione lunga secoli dandogli nuova luce. of what Verdi had called “parola scenica”, 17, 21, 24 novembre ore 20.30 Quella luce che splenderà nell’eroismo tragico di Tosca, which threw new light on a century-long nella forza drammaturgica e nella raffinatezza della tradition.