I SUPPORTI SONORI Storia Ed Evoluzione
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

L--Ficjfs'------I National Criminal Justice Reference Service
If you have issues viewing or accessing this file contact us at NCJRS.gov. -----------------------------------~---------------.---.~------.--~--------------- l--fiCjfS'--------i National Criminal Justice Reference Service This microfiche was produced from documents received for inclusion in the NCJRS data base. Since NCJRS cannot exercise control over the physical condition of the documents submitted, the individual frame quality will vary. The resolution chart on this frame may be used to evaluate the document quality. 1.0 1.1 U.S. ~t or Jultlcl 111111.8 NlilonallMtftut. or .Julltlee 7111,. oo."'Umt>nt hall bElon reproduC$d exactly all recolved flom tho per$Oo Of organizalloo originating It. Points of view oroplnions stated " 10 thls dccumont IIro those of tho authors and do not necessarily 111111.25 111111.4- 111111.6 1, , f!prrlSOOI Itlo Q't'Iiclal posltlon orpollcllHl of tht! Natlonallnstltulo of JulStiCO. Pormills/on to reproduce this Cepilifjhl.d malarial hall boon \)f8nled~ II, FBI Law Enforcement Bulletin MICROCOPY RESOLUTION TEST CHART NATIONAL BUREAU OF SlANDARDS·1963 A 10 the Nntional Criminal JuilUce Rtlfttrooco Servlco (NCJRS). r:urlhor loproducHon OYtslde of the NCJRS syst.m requlros permls· Glen 01 the ~ ~er. Microfilming procedures used to create this fiche comply with the standards set forth in 41CFR 101-11.504. Points of view or opinions stated in this document are those of the author(s) and do not represent the official position or policies of the U. S. Department of Justice. National Institute of Justice United States Department of Justice Washington, D. C. 20531 6/B/ B4 . l:1 f f',;( S-S3 ~ORCEMENT rr@~@~i© ~©~@m©@ rBI BULLETIN NOVEMBER 1983. -
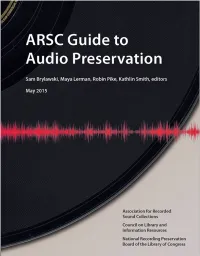
ARSC Guide to Audio Preservation
ARSC Guide to Audio Preservation Sam Brylawski, Maya Lerman, Robin Pike, Kathlin Smith, editors from last round: National Recording Preservation Board OF THE LIBRARY OF CONGRESS ASSOCIATION FOR RECORDED SOUND COLLECTIONS Council on Library and Information Resources revised: National Recording Preservation Board OF THE LIBRARY OF CONGRESS National Recording Registry OF THE LIBRARY OF CONGRESS ISBN 978-1-932326-50-5 CLIR Publication No. 164 Copublished by: Association for Recorded Council on Library and The Library of Congress Sound Collections Information Resources 101 Independence Avenue, SE c/o Nathan Georgitis, Knight Library 1707 L Street NW, Suite 650 Washington, DC 20540 1299 University of Oregon Washington, DC 20036 Website at http://www.loc.gov Eugene, OR 97403 Website at http://www.clir.org Website at http://arsc-audio.org Commissioned for and sponsored by the National Recording Preservation Board of the Library of Congress. Publication inquiries should be directed to Kathlin Smith at the Council on Library and Information Resources (CLIR). Additional copies are available for $30 each. Orders may be placed through CLIR’s website at http://www.clir.org/pubs/reports/pub164. The paper in this publication meets the minimum requirements of the American National Standard 8 for Information Sciences—Permanence of Paper for Printed Library Materials ANSI Z39.48-1984. The ARSC Guide to Audio Preservation is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License. Photos with credits are excluded from -

A Primer on Preserving Audio and Video Recordings
A Primer on Preserving Audio and Video Recordings National, Provincial and Territorial Archivists Conference Audiovisual Preservation Working Group In partnership with the National Heritage Digitization Strategy Steering Committee May 2018 Contents Preface ....................................................................................................................................................... i Version Control ......................................................................................................................................... ii Introduction .............................................................................................................................................. 1 Terminology .............................................................................................................................................. 1 Obstacles to Preservation ......................................................................................................................... 1 Format Obsolescence ............................................................................................................................ 1 Format Deterioration ............................................................................................................................ 1 Preservation Solutions .............................................................................................................................. 2 Migration.............................................................................................................................................. -

Pbcore Handbook Section 7
Controlled Vocabularies PBCore Controlled Vocabularies are sets of predefined, community-standardized terms for concepts related to audiovisual and broadcast collections. These terms can be used as drop-down value lists in a database or spreadsheet to ensure consistency in terminology, formatting and spelling, both internally and when exchanging information with outside organizations. PBCore Controlled Vocabularies include the agreed-upon spelling and formatting for each term, a definition, and a Unique Resource Identifier (or URI). The vocabularies provide only the terms that the community has determined are most widely used and shared, and are not 100% comprehensive. PBCore does not maintain controlled vocabularies for elements that have strong vocabulary options maintained by other authorities. Element definitions contain references to relevant external vocabularies, where applicable. pbcoreAssetTypeVocabulary Usage: for pbcoreAssetType Album Definition: A collection of recordings issued as a single item on CD, record, or another medium. URI: http://pbcore.org/pbcore-controlled-vocabularies/pbcoreassettype-vocabulary/#Album Animation Definition: A moving image production element created from static drawings or objects. URI: http://pbcore.org/pbcore-controlled-vocabularies/pbcoreassettype-vocabulary/#Animation Clip Definition: A short excerpt taken from a moving image or audio resource. A clip may not convey a complete intellectual concept. URI: http://pbcore.org/pbcore-controlled-vocabularies/pbcoreassettype-vocabulary/#Clip Collection Definition: A group of materials with some unifying characteristic. – 2. Materials assembled by a person, organization, or repository from a variety of sources; an artificial collection. URI: http://pbcore.org/pbcore-controlled-vocabularies/pbcoreassettype-vocabulary/#Collection Compilation Definition: A single asset containing multiple different sub-assets; for example, a reel with programs, clips, and raw footage. -

Synchronization of the Acoustic Evidence in the Assassination of President Kennedy
Scientific and technical Synchronization of the acoustic evidence in the assassination of President Kennedy R Linsker∗ and RL Garwin1 IBM T. J. Watson Research Center, P. O. Box 218 (1101 Kitchawan Road & Route 134), Yorktown Heights, NY 10598, USA e-mail: [email protected] H Chernoff1 Statistics Department, Harvard University, Cambridge, MA 02138, USA P Horowitz1 and NF Ramsey1 Physics Department, Harvard University, Cambridge, MA 02138, USA Science & Justice 2005 45 207 – 226 Received 17 November 2004 accepted 23 May 2005 We have revisited the acoustic evidence in the Kennedy assassi- de 60 Hz y metodos´ de correlacion´ para obtener calibraciones nation – recordings of the two Dallas police radio channels upon de velocidad para grabaciones hechas en los dos canales, analisis´ which our original NRC report (Ramsey NF et al., Report of espectrales para buscar instancias de segmentos repetidos du- the Committee on Ballistic Acoustics. National Research Coun- rante el play-back del canal 2( que pudiera resultar del salto de cil (US). Washington: National Academy Press, 1982. Posted surco)y metodos´ de correlacion´ y espectrograficos´ para analizar at http://www.nap.edu/catalog/10264.html) was based – in re- instancias de posibles conversaciones cruzadas usadas para sin- sponse to the assertion by DB Thomas (Echo correlation analysis cronizar ambos canales. Esta publicacion´ identifica graves errores and the acoustic evidence in the Kennedy assassination revis- en la publicacion´ de Thomas y corrige errores del informe NCR. ited. Science and Justice 2001; 41: 21–32) that alleged gunshot Reafirmamos la primitiva conclusion´ del informe NCR de que sounds (on Channel 1), apparently recorded from a motorcycle los pretendidos disparos de arma fueron registrados un minuto officer’s stuck-open microphone, occur at the exact time of the aproximadamente despues´ del asesinato. -

ED287487.Pdf
DOCUMENT RESUME ED 287 487 IR 052 164 AUTHOR Almquist, Sharon G. TITLE Sound Recordings and the Library. Occasional Papers Number 179. INSTITUTION Illinois Univ., Urbana. Graduate School of Library and Information Science. PUB DATE Aug 87 NOTE 41p. AVAILABLE FROMGraduate School of Library and Information Science, Publications Office, University of Illinois at Urbana-Champaign, 249 Armory Building, 505 E. Armory Street, Champaign, IL 61820 ($3.50 per copy; subscriptions are available). PUB TYPE Historical Materials (060) -- Information Analyses (070) EDRS PRICE MF01 Plus Postage. PC Not hvailable from EDRS. DESCRIPTORS *Aw2iodisks; Audio Equipment; *Audiotape Recordings; Library Circulation; *Library Collection Development; *Library Collections; Library Facilities; Optical Disks; *Technological Advancement; Users (Information) ABSTRACT The basic concept that sound waves could be t:aced or recorded on a solid object was developed separately by Leon Scott, Charles Cros, and Thomas Alva Edison between 1857 and 1877 and, by 1890, the foundation of the present-day commercial record industry was established. Although cylinders were the first sound recordings to be sold commercially, discs were introduced in 1894 and ultimately became more popular. The library collection of sound recordings began with the founding of the Sadie Knowland Coe Music Collection at the Evanston Public Library in 1907 during the acoustic, or pre-electric era (1877-1925) when recordings were still made and reproduced by mechanical means. Following the introduction of electrical recordings, more libraries inaugurated record collections, albeit with some caution, and by the 1940s, the idea that collections of records belonged in libraries had won acceptance. The convenience of the long-playing (LP) record, introduced in 1948, appealed to the public and librarians alike; and stereo, introduced publicly 10 years later, provided the final great improvement for pre-1980s audio recordings. -
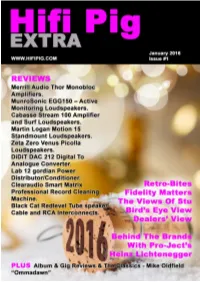
JANUARY2016.Pdf
1 C:\Users\Stuart\Desktop\DOCUMENTS THIS ONE\Hifi Pig\DESKTOP BACKUP\HIFI PIG\ADVERTISEMENTS\TQ\Grand Slam Large 2 (1).png 2 Hifi Pig www.hifipig.com CONTENTS REVIEWS 5. Merrill Audio Thor Monobloc Amplifiers 12. Cabasse Stream 100 Amplifier and Surf Loudspeakers 18. MunroSonic EGG150 – Active Monitoring Loudspeakers www.hifipig.com 23. Martin Logan Motion 15 Standmount Telephone: +33 (0)2 97 23 70 78 E mail: [email protected] Loudspeakers 28. Zeta Zero Venus Picolla Loudspeakers 34. DiDiT DAC 212 Digital To Analogue Converter MUSIC 43. Lab 12 gordian Power Distributor/Conditioner 78-85. Music and Live Gig 48. Clearaudio Smart Matrix Professional Reviews with John Scott and Record Cleaning Machine Stuart Smith 52. Black Cat Redlevel Tube speaker Cable 86. John Scott throws a log on and RCA Interconnects the fire, pours himself a wee dram and puts on his copy of INTERVIEWS Mike Oldfield’s Ommadawn as part of his Behind The Brands with Heinz Classic Albums series. Lichtenegger of Pro-Ject COLUMNS 59. Retro Bites - Janine Elliot takes another look at retro audio kit, this time focusing on the rare Tefifon 62. Voice Of Dom - Dominic Marsh gets puzzled over the differences people hear with identical products and explains how he goes about evaluating and listening to new kit. 66. Fidelity Matters - In the last of his Fidelity Matters articles for 2015, Ian Ringstead celebrates innovation wherever it comes from and applauds all the people in the hifi industry who make this wonderful kit possible. 69. The Views Of Stu - Stuart Smith looks at the year that was 2015 and hints at a few things you can expect to see in the coming year from Hifi Pig. -

Sound Evidence: an Archaeology of Audio Recording and Surveillance in Popular Film and Media
Sound Evidence: An Archaeology of Audio Recording and Surveillance in Popular Film and Media by Dimitrios Pavlounis A dissertation submitted in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy (Screen Arts and Cultures) in the University of Michigan 2016 Doctoral Committee: Associate Professor Sheila C. Murphy, Chair Emeritus Professor Richard Abel Professor Lisa Ann Nakamura Associate Professor Aswin Punathambekar Professor Gerald Patrick Scannell © Dimitrios Pavlounis 2016 For My Parents ii ACKNOWLEDGMENTS My introduction to media studies took place over ten years ago at McGill University where Ned Schantz, Derek Nystrom, and Alanna Thain taught me to see the world differently. Their passionate teaching drew me to the discipline, and their continued generosity and support made me want to pursue graduate studies. I am also grateful to Kavi Abraham, Asif Yusuf, Chris Martin, Mike Shortt, Karishma Lall, Amanda Tripp, Islay Campbell, and Lees Nickerson for all of the good times we had then and have had since. Thanks also to my cousins Tasi and Joe for keeping me fed and laughing in Montreal. At the University of Toronto, my entire M.A. cohort created a sense of community that I have tried to bring with me to Michigan. Learning to be a graduate student shouldn’t have been so much fun. I am especially thankful to Rob King, Nic Sammond, and Corinn Columpar for being exemplary scholars and teachers. Never have I learned so much in a year. To give everyone at the University of Michigan who contributed in a meaningful way to the production of this dissertation proper acknowledgment would mean to write another dissertation-length document. -

Smithsonian Pan-Institutional Audiovisual Collections Survey
Smithsonian Institution Pan-Institutional Audiovisual Collections Survey Final Project Report 2016-2017 SMITHSONIAN INSTITUTION Pan-Institutional Audiovisual Collections Survey – Final Project Report | 1 ________________________________________________________________________________________________________________ Smithsonian Institution Pan-Institutional Audiovisual Collections Survey Project Support and Funding: The National Collections Program Data Collection, Analysis, and Report Narrative: Kelli Hix Project Supervision: Alison Reppert Gerber Survey Planning and Design: Audiovisual Archivists Interest Lunch [AVAIL] Group Final Report Design and Editorial Contributions: Alison Reppert Gerber, Kira Sobers Special Thanks: Riccardo Ferrante, Jennifer Wright, Jennifer Morris, Megan McShea, Stephanie Smith, Dave Walker, Greg Adams, Jeff Place, Pam Wintle, Mark Taylor, Walter Forsberg, Jasmyn Castro, Blake McDowell, Wendy Shay, Sarah Stauderman, Taylor McBride, and Crystal Sanchez Report Completed: 28 March 2017 2 | SMITHSONIAN INSTITUTION Pan-Institutional Audiovisual Collections Survey – Final Project Report ________________________________________________________________________________________________________________ Table of Contents 1 Executive Summary ......................................................................................................................... 4 2 Introduction ..................................................................................................................................... 5 2.1 Overview -

Forming the Text, Performing the Work - Aspects of Media, Navigation, and Linking1 by Anna Gunder
ITH - Centrum för studier av IT ur ett humanvetenskapligt perspektiv vid Högskolan i Borås 2-3/2001 Forming the Text, Performing the Work - Aspects of Media, Navigation, and Linking1 by Anna Gunder This article proposes a theoretical framework intended to facilitate descriptions and discussions of texts of works in different media. The main theoretical traditions which have inspired this endeavor are, on the one hand, textual criticism (with scholars such as Fredson Bowers, D. C. Greetham, Jerome J. McGann, D. F. McKenzie, Peter L. Shillingsburg, and G. Thomas Tanselle), and, on the other hand, hypertext theory (represented by theorists like Espen Aarseth, Jay David Bolter, Jane Yellowlees Douglas, Michael Joyce, George P. Landow, and Janet H. Murray). The study aims to combine and develop the perspectives of such theoretical traditions in order to suggest a more consistent and extensive set of concepts for the analysis of how narratives are stored and disseminated. The study examines the structural aspects of texts and works, and deals with storage, presentation and reproduction of works. Moreover, the structure of works and texts, as well as the navigation related to these structures, are discussed. The study also includes an in- depth discussion on links and linking, and a new terminology is suggested for the subject. The most important concepts discussed are work, text, version, variant, storage medium, storage sign, presentation medium, presentation sign, storage capacity, life expectancy, direct text access, indirect text access, copy, edition, impression, issue, monosequential, multisequential, content space and axial structure. Furthermore, the concepts of network structure and lateral structure as well as hypertext, ergodicity, link and linking are examined. -

Spoken-Word Audio Collections
EU-US WORKING GROUP ON SPOKEN-WORD AUDIO COLLECTIONS 0.0 EXECUTIVE SUMMARY Our diverse cultures rely increasingly on audio and video resources. We need to chart a steady course to assure the utility of this record. Such a course calls for a plan to preserve these resources and to determine the most effective ways to access their rich content. For example, though our nations possess enormous collections of spoken-word materials, much of these collections will remain inaccessible to the public for lack of adequate search technologies or from decay unless we act to chart an access and preservation path. Our aim is to forge agreement on these vital topics so that as technology changes, we will be able to rely on our collections to understand and preserve these essential components of our cultural heritage. We also need to focus research support on areas of access and preservation that we believe will yield the greatest benefits across many intersecting disciplines. This document presents an agenda for collaborative research in this field. Spoken-word collections cover many different domains. These include radio and television broadcasts, governmental proceedings, lectures, oral narratives, meetings and telephone conversations. Needs vary in collecting, accessing and preserving such data: >> Political and economic: providing access for citizens to governmental proceedings, corporate shareholder meetings, public meetings of political parties and NGOs >> Cultural: building and providing access to large, multilingual archives of broadcast material, public performance, oral narrative >> Educational: acquisition, preservation, search and access of lectures; use of digital audio and video resources as primary sources for inquiry and explication. -

National Audit of UK Sound Collections Final Report, October 2015
National Audit of UK Sound Collections Final Report, October 2015 Adam Tovell and James Knight The British Library Contents National Audit of UK Sound Collections ........................................................................................................................ 1 Executive summary ........................................................................................................................................................ 3 Overview of results ........................................................................................................................................................ 4 Summary of observations .............................................................................................................................................. 4 Key recommendations ................................................................................................................................................... 5 Background .................................................................................................................................................................... 6 Scope .............................................................................................................................................................................. 7 Approach ........................................................................................................................................................................ 8 Phase one: project setup ...............................................................................................................................................