L'iconografia Del Paesaggio Agrario
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

2 Documento Preliminare Alla Progettazione.Pdf
NOVECENTOPIÙCENTO CONCORSO INTERNAZIONALE DI PROGETTAZIONE 9O O PIÙCENTO I NOVECENTOPIÙCENTO CONCORSO INTERNAZIONALE DI PROGETTAZIONE DOCUMENTO PRELIMINARE ALLA PROGETTAZIONE NOVECENTOPIÙCENTO CONCORSO INTERNAZIONALE DI PROGETTAZIONE DOCUMENTO PRELIMINARE ALLA PROGETTAZIONE INDICE PREFAZIONE 4 1. OBIETTIVI GENERALI 5 2. INQUADRAMENTO 6 2.1 Contesto urbano 6 2.2 Piazza del Duomo 8 2.3 Vicende storiche 10 2.4 L’Arengario 14 2.4.1 Il Primo Arengario - Museo del Novecento 15 2.4.2 Il Secondo Arengario 21 2.5 Ritrovamenti archeologici 22 2.6 Accessibilità 24 3. OGGETTO DEL CONCORSO 25 3.1 Ambito di intervento 25 3.1.1 Perimetro 1 - Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica 25 3.1.2 Linee Guida 27 3.2 Vincoli 27 3.2.1 Vincolo monumentale 27 3.2.2 Vincoli sull’Arengario 28 3.2.3 Vincoli sullo spazio pubblico 29 4. INDICAZIONI PROGETTUALI 30 4.1 Identità e relazioni con il contesto 30 4.2 Concept museologico 31 4.3 Programma funzionale 33 4.3 Collegamento e relazione con il Primo Arengario 34 4.4 Percorso museografico 35 4.6 Spazi espositivi 38 4.7 Materiali e finiture 39 4.8 Impianti 39 4.9 Sostenibilità ambientale 42 5. LIMITI FINANZIARI E STIMA DEI COSTI DI INTERVENTO 44 6. NORMATIVA DI RIFERIMENTO 45 7. INDICAZIONI BIBLIOGRAFICHE 50 3 PREFAZIONE A distanza di dieci anni dall’inaugurazione del Museo del Novecento, il Comune di Milano lancia “Novecentopiùcento”, concorso internazionale di progettazione per l’ampliamento del Museo, attualmente ospitato all’interno dell’Arengario in Piazza del Duomo – specificatamente nella torre a est e nella manica lunga – e negli spazi al secondo piano di Palazzo Reale. -

Vincenzo Agnetti
VINCENZO AGNETTI Born 1926 Milan, Italy Died 1981 Milan, Italy EDUCATION Brera Academy, Milan Piccolo Teatro School, Milan SELECTED SOLO EXHIBITIONS 2017 Vincenzo Agnetti: Territories, Lévy Gorvy, New York Vincenzo Agnetti, Palazzo Reale, Milan Vincenzo Agnetti: Territories, Lévy Gorvy, London Vincenzo Agnetti. Oltre Il Linguaggio, Osart Gallery, Milan Unfinished Culture #2, Vincenzo Agnetti 1979 – 1981, Fondazione Brodbeck, Catania 2016 Vincenzo Agnetti - La Lettera Perduta, Archivio Agnetti, Milan Archivio 01, Sotheby’s, Milan Vincenzo Agnetti, Palazzo Serbelloni, Milan 2015 Testimonianza, Galleria Il Ponte, Florence; also traveled to: Studio Giangaleazzo Visconti, Milan 2014 Vincenzo Agnetti, Opere da Collezioni Private, Matteo Lampertico Arte Antica e Moderna, Milan 2013 A proposito di Vincenzo Agnetti, Museo D’Arte Contemporanea Villa Croce, Genoa 2012 Vincenzo Agnetti - L’operazione Concettuale, Centro Italiano Arte Contemporanea, Foligno 2009 Vincenzo Agnetti, White Project, Pescara 2008 Vincenzo Agnetti, Studio Giangaleazzo Visconti, Milan Vincenzo Agnetti. Retrospettiva 1967-1980, Museo di Arte Moderna e Contemporanea di Trento e Rovereto, Rovereto 2006 Lavoro – Agnetti quasi dimenticato a memoria, Galleria Milano, Milan 1999 Vincenzo Agnetti, La Crocetta Arte, Gallarate 1997 Vincenzo Agnetti, Galleria Peccolo, Livorno 1991 Vincenzo Agnetti. Casualmente un percorso, Galleria Vivita, Florence Vincenzo Agnetti, Galleria Salvatore Ala, New York Vincenzo Agnetti – Adesso l’acqua sa di secchio, Galleria Giuliana De Crescenzo, Rome -

Programmazione Attività Sistema Museale Cittadino Misure E Procedure Operative
Commissione Consiliare Cultura 12 febbraio 2021 PROGRAMMAZIONE ATTIVITÀ SISTEMA MUSEALE CITTADINO MISURE E PROCEDURE OPERATIVE LE MISURE SONO PREVISTE SULLA BASE DEL DPCM DEL 14.01.2021 E DELLA SUCCESSIVA ORDINANZA DEL MINISTERO DELLA SALUTE DEL 29.01.2021 CHE COLLOCA LA LOMBARDIA IN FASCIA GIALLA Ingressi con prenotazione consigliata Contingentamento del pubblico in base alle dimensioni degli istituti Ingressi scaglionati Aperture degli istituti dal martedì al venerdì All’ingresso degli istituti: dotazione di gel igienizzante per le mani. Obbligo del corretto utilizzo della mascherina Utilizzo di termoscanner all’ingresso 2 DAL 9 FEBBRAIO APERTURA MOSTRE NELLE SEDI CIVICHE RIAPERTURE ► Palazzo Reale (ore 10-19.30) “Divine e Avanguardie. Le donne nell’arte russa” e “Prima, donna. Margaret Bourke-White” ► Museo del Novecento (ore 10-19.30) “Carla Accardi. Contesti” ► Museo Archeologico (ore 10-17.30) “Sotto il Cielo di Nut. Egitto divino” NUOVE MOSTRE ► Castello Sforzesco (ore 10-17.30) “Giuseppe Bossi e Raffaello” ► Studio Museo Francesco Messina (ore 10-17.30) “Orticanoodles. Inside” ► Casa Boschi di Stefano / piano terra (ore 10-17.30) “La prima stagione di Gianni Dova” ► Mudec (ore 10-19.30 - Sala Khaled Assad) “La grande strada Inca”. ► Dal 16 febbraio: PAC “Autoritratto” di Luisa Lambri LE MOSTRE SONO APERTE DAL MARTEDI AL VENERDI Palazzo Reale e Museo del Novecento chiudono il giovedì alle 20.30 3 DAL 16 FEBBRAIO RIAPERTURA DELLE COLLEZIONI PERMANENTI DEI MUSEI • Musei del Castello • Casa Boschi Di Stefano • GAM • Acquario • Museo Risorgimento • Museo Archeologico • Palazzo Morando GIORNI E ORARI: da martedì a venerdì dalle 10 alle 17.30 4 DAL 02 MARZO RIAPERTURA DEI MUSEI CON NUOVI ALLESTIMENTI APERTURA: • Museo del Novecento • Museo di Storia Naturale | sezione Mineralogia GIORNI E ORARI: da martedì a venerdì dalle 10 alle 17.30 APERTURA NUOVA MOSTRA: • Palazzo Reale: “Le signore dell’arte. -

Le Grandi Chiese
guida cittàdella Comune di Milano Realizzazione editoriale a cura di Settore Politiche del Turismo Iniziative Speciali e Marketing Territoriale di De Agostini Libri S.p.A. Via Dogana, 2 20121 Milano Direttore Andrea Pasquino Direttore Massimiliano Taveggia Product Manager Licia Triberti, Davide Gallotti Servizio sviluppo e monitoraggio del turismo Progetto editoriale Sergio Daneluzzi Federica Savino Servizio portale di promozione Redazione e ricerca iconografica del territorio Marco Torriani Patrizia Bertocchi con Alessandra Allemandi Supervisione dei contenuti Progetto grafico e impaginazione Mauro Raimondi Sandra Luzzani con Vando Pagliardini Testi a cura di Monica Berno Servizi Tecnici Prepress Andrea Campo Coordinamento tecnico Guido Leonardi Scarica l’App “Milano. Guida della Città” per: All’interno della Guida, attiva i QR code sul tuo smartphone: presenti in ogni itinerario, ti consentiranno di accedere ai contenuti speciali della Guida. Crediti fotografici DeAgostini Picture Library, Archivio Alinari, Alessandro Casiello, Marco Clarizia, Contrasto, Corbis, Gianni Congiu, Marka, Mauro Ranzani, Andrea Scuratti, Vando Pagliardini, Michela Veicsteinas Aggiornamento dicembre 2015 sommario Introduzione 2 Mappa della città/Centro della città 4 Milano e la sua Storia 8 1 A spasso per il Centro 10 2 Antica Roma e Medioevo 12 3 Il Rinascimento e il Barocco 14 4 Il Neoclassico e l’Ottocento 16 5 Le Grandi Chiese di Milano 18 6 I Palazzi di Milano 22 7 I Musei di Milano 26 8 Arte Contemporanea a Milano 30 9 La Milano delle Scienze 36 10 Parchi e Navigli 38 11 Shopping a Milano 42 12 Spettacoli, Sport e Divertimento 44 13 Oltre Milano 46 Informazioni Utili 48 Benvenuti Una grande città ha bisogno di uno sguardo d’insieme: ecco una guida maneggevole e completa, una porta di accesso ai tesori di bellezza di Milano e del suo territorio. -

È Un Piacere E Un Onore Poter Rappresentare E Presentare Milano Al Mondo
È un piacere e un onore poter rappresentare e presentare Milano al mondo. Milano e la sua storia millenaria; Milano e la sua cultura, le sue eccellenze scientifiche; Milano e la sua vocazione al nuovo, i sui progetti, il suo spirito internazionale. Milano è una città che unisce le sue antiche tradizioni con una sensibilità contemporanea. Il Museo del Novecento che sta nascendo dalla trasformazione del Palazzo dell’Arengario, nel cuore di Milano, rappresenta questo spirito milanese: sarà la sede dei capolavori italiani che sono patrimonio di Milano, di opere d’arte del Futurismo che il mondo ci ammira e che troveranno un luogo magico dove essere esposti e ammirati. Milano fu capitale dell’Impero Romano d’Occidente: le testimonianze di queste antiche radici sono conservate nel Museo Archeologico del Castello Sforzesco e nel Parco Archeologico. Milano è l’antica Mediolanum: un luogo di mezzo, un ponte tra culture, un centro di scambi commerciali, sociali, culturali. Tale è rimasta per sempre: nel Medioevoe poi soprattutto nel Rinascimento,quando Ludovico il Moro chiamò alla corte milaneseLeonardo Da Vinci ed egli fece di Milano il suo laboratorio di idee, producendo capolavori d’arte come il Cenacolo 1 Vinciano e opere di ingegneria idraulica come i Navigli. Milano è una capitale mondiale della cultura. Il Castello Sforzesco è con il Duomo il monumento simbolo di Milano. Vi è custodito un tesoro inestimabile:la Pietà Rondanini, l'ultima opera scolpita da Michelangelo, un capolavoro incompiuto, dove proprio il "non finito" rappresentail culmine dell'espressione drammatica del genio michelangiolesco. Tutto questo si integra con la Milano di oggi, centro culturale internazionale. -

LE MOSTRE DI DICEMBRE 2010 N° 38 Del 3.12.2010
PALAZZO MARINO LE MOSTRE DI Palazzo Marino | Sala Alessi Piazza Scala 2 | Milano NEW! n°38 DICEMBRE 2010 tutti i giorni 9.30_19.30 3|12|2010 promosse dal Comune di Milano | Cultura giovedì e sabato 9.30_22.30 ultimo ingresso 30 minuti prima della chiusura ORARI DELLE MOSTRE NELLE FESTIVITA’ www.comune.milano.it | www.cultura.eni.com DI DICEMBRE 2009 | GENNAIO 2010 ▀ TIZIANO A MILANO | Donna allo specchio/Femme au miroir | Esposizione straordinaria dal Museo del Palazzo Marino Louvre a Palazzo Marino lunedì | 6 dicembre | 9.30_19.30 ►3 dicembre 2010_6 gennaio 2011 martedì| 7 dicembre | 9.30_14.00 mercoledì | 8 dicembre | 9.30_19.30 Torna l’appuntamento annuale con un capolavoro della storia venerdì | 24 dicembre | 9.30_18.00 dell’arte. Durante tutte le festività natalizie 2010 il pubblico potrà ammirare la “Donna allo specchio” di Tiziano, proveniente dal sabato | 25 dicembre | 9.30_22.30 Musée du Louvre, dipinto straordinario del maestro veneto. domenica | 26 dicembre | 9.30_19.30 Completano l’esposizione gli incontri a tema con ospiti d’eccezione venerdì | 31 dicembre | 9.30_18.00 nella sala conferenze di Palazzo Reale, previsti per giovedì sabato | 1° gennaio | 9.30_22.30 9,16,23 dicembre e 6 gennaio alle ore 18.00. giovedì | 6 gennaio | 9.30_22.30 INGRESSO LIBERO Palazzo Reale lunedì | 6 dicembre | 9.30_19.30 PALAZZO REALE mar e mer | 7 e 8 dicembre | normale orario d’apertura venerdì | 24 dicembre | 9.30_14.00 Palazzo Reale sabato | 25 dicembre | 14.30_22.30 Piazza Duomo 12 | Milano domenica | 26 dicembre | normale orario d’apertura -

EVENTI EVENTS FEBBRAIO \ FEBRUARY 2010 La Triennale Di Milano ROY LICHTENSTEIN Meditaɵons On
FEBBRAIO \ FEBRUARY 2010 EVENTI 350 EVENTS La Triennale di Milano ROY LICHTENSTEIN MeditaƟ ons on Art © Estate of Roy Lichtenstein of Roy © Estate 30° 201018-21 febbraio BORSA INTERNAZIONALE DEL TURISMO Travel instinct. 1+1 1 PRE-REGISTRATO + scopri come su 1 INGRESSO GRATUITO www.bit.fieramilano.it O INDICE/INDEX BENVENUTI 4 WELCOME SPECIALE BIT 2010 7 BIT 2010 ARTE 16 ART FOTOGRAFIA 23 PHOTOGRAPHY VISITE GUIDATE 26 GUIDED TOURS TEATRO ALLA SCALA 29 SCALA OPERA HOUSE MUSICA CLASSICA 32 CLASSICAL MUSIC MUSICA NELLE CHIESE 40 MUSIC IN THE CHURCHES MUSICA JAZZ 41 JAZZ MUSIC MUSICA LIVE 43 LIVE MUSIC TEATRO 47 THEATRE BALLETTO 58 BALLET CINEMA 59 CINEMAS FIERA MILANO 60 TRADE FAIRS IN MILAN FIERE & MERCATI 62 FAIRS & MARKETS SPORT & TEMPO LIBERO 67 SPORTS & LEISURE SAGRE E FOLCLORE 69 FOLK EVENTS = orari/hours = chiusura/closed = prezzo/price = informazioni/informa on = inaugurato questo mese/new 3 BENVENUTI Proge ed inizia ve per un futuro migliore. Plans and ini a ves for a be er future. gni giorno che spunta, desidera il nuovo” (Fr. Bodenstedt) e di sicuro, con l’inizio del 2010, ognuno di noi ha fa o proposi , proge ed ha delle “Oaspe a ve per il nuovo anno. Per quanto riguarda la Provincia di Milano, anche in questo numero di MilanoMese, vi presen amo occasioni di ritrovo, di intrat- tenimento culturale, sociale ed inizia ve di valorizzazione del nostro territorio. Tra gli interven concre che abbiamo in ques mesi a uato ci sono nuove piste ciclabili nel territorio della Provincia e proge per migliorare la viabilità, inoltre ripar rà a maggio anche un servizio di trasporto sui Navigli e sono al vaglio tu a una serie di proge per la riqualifi cazione del patrimonio edilizio della Provincia. -

National and International Modernism in Italian Sculpture from 1935-1959
National and International Modernism in Italian Sculpture from 1935-1959 by Antje K. Gamble A dissertation submitted in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy (History of Art) in the University of Michigan 2015 Doctoral Committee: Professor Alexander D. Potts, Chair Associate Professor Giorgio Bertellini Professor Matthew N. Biro Sharon Hecker Associate Professor Claire A. Zimmerman Associate Professor Rebecca Zurier Copyright: Antje K. Gamble, 2015 © Acknowledgements As with any large project, this dissertation could not have been completed without the support and guidance of a large number of individuals and institutions. I am glad that I have the opportunity to acknowledge them here. There were a large number of funding sources that allowed me to study, travel, and conduct primary research that I want to thank: without them, I would not have been able to do the rich archival study that has, I think, made this dissertation an important contribution to the field. For travel funding to Italy, I thank the Horace R. Rackham Graduate School at the University of Michigan for its support with the Rackham International International Research Award and the Rackham Rackham Humanities Research Fellowship. For writing support and U.S.-based research funding, I thank the Department of History of Art at the University of Michigan, the Rackham Graduate School, the Andrew W. Mellon Foundation and the University of Michigan Museum of Art. For conference travel support, I thank the Horace R. Rackham Graduate School, the Department of History of Art, and the American Association of Italian Studies. While in Italy, I was fortunate enough to work with a great number of amazing scholars, archivists, librarians and museum staff who aided in my research efforts. -

Itinerari Di Architettura Milanese
ORDINE DEGLI ARCHITETTI, FONDAZIONE DELL’ORDINE DEGLI ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI DELLA PROVINCIA DI MILANO DELLA PROVINCIA DI MILANO /figure Ritratti dal professionismo milanese Lo studio BBPR e Milano Stefano Guidarini Luca Molinari Paolo Brambilla Itinerari di architettura milanese L’architettura moderna come descrizione della città “Itinerari di architettura milanese: l’architettura moderna come descrizione della città” è un progetto dell’Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Milano a cura della sua Fondazione. Coordinamento scientifico: Maurizio Carones Consigliere delegato: Paolo Brambilla Responsabili della redazione: Alessandro Sartori, Stefano Suriano Coordinamento attività: Giulia Pellegrino Ufficio Stampa: Ferdinando Crespi “Lo studio BBPR e Milano” Paolo Brambilla, Stefano Guidarini, Luca Molinari, a cura di: Alessandro Sartori, Stefano Suriano, Barbara Palazzi La Fondazione dell’Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Milano rimane a disposizione per eventuali diritti sui materiali iconografici non identificati www.ordinearchitetti.mi.it www.fondazione.ordinearchitetti.mi.it BBPR e Milano 1931-1976 Stefano Guidarini Luca Molinari Lo studio BBPR, fondato nel 1931 da Gian Luigi Banfi, Lodovico Barbiano di Belgiojoso, Enrico Peressutti ed Ernesto Nathan Rogers, costituisce uno dei primi e più interessanti casi di sodalizio artistico e culturale fondato sul lavoro di gruppo anziché sulla personalità del singolo. Questa forma d’intesa operativa si è rivelata un’intuizione culturale fondamentale, che ha permesso di superare la dimensione artigianale dello studio professionale per orientarsi verso una concezione dell’attività dell’architetto basata sull’apporto collegiale come principio metodologico. Per i BBPR la collaborazione avveniva nel rispetto di una serie di propositi e di sinergie destinati a garantire la qualità del progetto nel segno della compattezza del gruppo. -
Visualizza/Apri
2019 conferenza 1 Cos’è la comunicazione senza tecnologia? BASE / via Bergognone, 34 / 17.03.2019 2 Digital arts festival: esperienze di curatela a confronto BASE / via Bergognone, 34 / 16.03.2019 3 Il bianco e nero. Dall’analogico al digitale museo Martinitt e Stelline / corso Magenta, 57 / 15.03.2019 4 Il museo e la trasformazione digitale RAD / corso Buenos Aires, 47 / 14.03.2019 5 Low Form la Triennale di Milano / viale E. Alemagna, 6 / 17.03.2019 6 Making Free Pay: Dal vinile al cloud F.I.M.I. / via Leone XIII, 14 / 14.03.2019 7 DATAWE palazzo dei Giureconsulti / piazza dei Mercanti, 2 / 14.03.2019 8 Top Technologies for Cultural Heritage polihub / via G. Durando, 39 / 15.03.2019 evento multimediale 9 Brera Cloud pinacoteca di Brera / via Brera, 28 / 15-17.03.2019 10 Milan Machinima Festival IULM / via Carlo Bo, 7 / 15.03.2019 11 Percorsi nella Milano Letteraria la fabbrica del Vapore / via Procaccini, 4 / 15-17.03.2019 12 Percorsi nella Milano Letteraria fondazione Stelline / corso Magenta, 59 / 14-15.03.2019 13 Radiation Grooves palazzo dei Giureconsulti / piazza dei Mercanti, 2 / 14.03.2019 14 Recuperare la memoria audio-visiva della città università degli studi di Milano / via G. Celoria, 18 / 14-16.03.2019 mostra 15 @fiveartgallery instagram / via L. Cagnola / 14-17.03.2019 16 Adoperabili. Fotografie di Gabriele Corni showroom Fausto Puglisi / via B. Zenale, 3 / 14-16.03.2019 17 Art spazio espositivo temporary space / via Lanzone, 23 / 16-17.03.2019 18 Broken Nature la Triennale di Milano / viale E. -

Fascism, Middle-Class Ideals, and Holiday Villas at the 5 Th Milan Triennale
FASCISM, MIDDLE-CLASS IDEALS, AND HOLIDAY VILLAS AT THE 5TH MILAN TRIENNALE Flavia Marcello With the diffusion of architectural modernism in the first couple decades of the twentieth-century, exposition pavilions presented new and daring forms, and tested structural possibilities and innovative materials. In some cases, the form and function of these pavilions reflected idealised versions of society, which could combine entertainment, tourism and propaganda. In this context, pavilions became integral to a constructed discourse of national identity and culture. This function was crucial for fascist Italy, where the aestheticisation of politics was integral to the consent-building process and where architects played a central role in Fascism’s mission to transform Italian society. Through an analysis of prototype holiday homes from the Milan Triennale of 1933, it is argued that these pavilions manifested a nexus between four inter- related elements: 1) the technology, forms, materials and ideals of modernity; 2) the Mediterranean architectural tradition; 3) the socio-economic reforms of the fascist regime; and 4) the central role of the emergent middle classes in fascist political life. As examples of Italian Rationalist architecture, they combined the ‘international’ aspects of modernism with Italian regionalism and tradition. They applied modern technology to construction systems and materials, and incarnated the belief that architecture could act as an engine for social change. As physical manifestations of an idealised lifestyle, they cemented the position of the new ruling middle class, reflected the aspirations of the lower middle classes and offered a sense of opportunity to workers wanting to improve their lives. Keywords: pavilion, fascism, Milan Triennale, exposition, housing prototype, middle classes. -
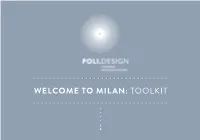
Welcome to Milan: Toolkit
WELCOME TO MILAN: TOOLKIT INDEX 01. 03. BEFORE LEAVING DURING YOUR STAY Living Costs In Milan ....................5 Transportation - Arriving at Poli.Design .... 19 Accomodation .........................7 Transportation - Public Transit ...........20 Visa Procedures ........................8 Transportation - Shared and Private .......22 Health Insurance for Non-Eu Students ......9 Design Showrooms and Museums .........23 02. Leisure ..............................24 AFTER YOUR ARRIVAL Useful Phone Numbers .................25 Residence Permit - EU Citizens ...........11 Residence Permit - Non-EU Citizens ...... 12 Tax Code ............................. 15 Health Insurance ...................... 16 Bank Account ......................... 17 Welcome to Milan: Toolkit | 3 BEFORE LEAVING Welcome to Milan: Toolkit | 4 01. BEFORE LEAVING LIVING COSTS IN MILAN Living costs and spending habits will differ considerably depending on your individual expectations and needs and, of course, on where you live, so it’s not easy to give advice that Accommodation: €300 to €800 per month is suitable to everyone. Before your arrival, plan your budget as Costs vary depending on the area, the kind of room (single or carefully as possible and try to figure out if you can meet all the double) and any programme be nefits you may have access to. expenses, even considering unexpected and emergency costs. More info on Accomodation (SEE PAGE 7). • Double room (shared): € 300 to € 450. There are some user contributed websites that allow you to • Single Room: € 500 to € 800. compare the cost of life between Milan and your city, such as www.expatistan.com. The website gives an estimated cost for various items and services for a daily life. Travel costs €22 to €39 per month • Public transport: (SEE PAGE 20).