Rapporto 100 2009 Cap 1 11.Pdf
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

New Insights Into the Microbiota of Moth Pests
International Journal of Molecular Sciences Review New Insights into the Microbiota of Moth Pests Valeria Mereghetti, Bessem Chouaia and Matteo Montagna * ID Dipartimento di Scienze Agrarie e Ambientali, Università degli Studi di Milano, 20122 Milan, Italy; [email protected] (V.M.); [email protected] (B.C.) * Correspondence: [email protected]; Tel.: +39-02-5031-6782 Received: 31 August 2017; Accepted: 14 November 2017; Published: 18 November 2017 Abstract: In recent years, next generation sequencing (NGS) technologies have helped to improve our understanding of the bacterial communities associated with insects, shedding light on their wide taxonomic and functional diversity. To date, little is known about the microbiota of lepidopterans, which includes some of the most damaging agricultural and forest pests worldwide. Studying their microbiota could help us better understand their ecology and offer insights into developing new pest control strategies. In this paper, we review the literature pertaining to the microbiota of lepidopterans with a focus on pests, and highlight potential recurrent patterns regarding microbiota structure and composition. Keywords: symbiosis; bacterial communities; crop pests; forest pests; Lepidoptera; next generation sequencing (NGS) technologies; diet; developmental stages 1. Introduction Insects represent the most successful taxa of eukaryotic life, being able to colonize almost all environments, including Antarctica, which is populated by some species of chironomids (e.g., Belgica antarctica, Eretmoptera murphyi, and Parochlus steinenii)[1,2]. Many insects are beneficial to plants, playing important roles in seed dispersal, pollination, and plant defense (by feeding upon herbivores, for example) [3]. On the other hand, there are also damaging insects that feed on crops, forest and ornamental plants, or stored products, and, for these reasons, are they considered pests. -

Pests and Diseases
Clivia assassins – pests and diseases Clivia is really quite a resistant little genus, with only a few serious pests and diseases that can be life threatening . Others, though not lethal, can seriously affect a plant’s appearance and growth . General hygienic culture conditions like good drainage, removal of infected plants and material and a spray programme can successfully prevent these pests and diseases from becoming a serious problem . Just a note of caution when working with toxic chemicals: Read the instructions of all chemicals before use! Make sure that chemicals can be mixed without detrimental effects to treated plants – if not stated as mixable, test it first on a few plants before you treat your whole collection . Plant pests Lily borer (Brithys crini, Brithys pancratii) Brithys species, also known as Amaryllis caterpillars, are serious pests amongst members of the Amaryllidaceae. They target Crinum, Cyrthanthus, Haemanthus, Nerine, Amaryllis and Clivia, to name a few. This destructive pest has three to four generations in nature annually and if a severe infestation occurs it can destroy plants within a few days. The caterpillar Breakfast! The yellow and brown-black banding is easily distinguishable with its yellow and black or brown pattern of the Brithys caterpillar makes it easy to recognise . Only a mushy pseudo stem remains banding pattern. Young larvae emerge from a cluster of after Mr Caterpillar’s visit . Growing clivias eggs, usually on the underside (abaxial side) of leaves, and then start to tunnel into the leaf. Once inside, the larvae eat the soft tissue between the outer two epidermal cell layers, tunnelling their way towards the base of the leaf. -

Gut Bacterial Communities of Two Insect Species Feeding on Toxic Plants Are Dominated by Enterococcus Sp
fmicb-07-01005 June 24, 2016 Time: 16:20 # 1 ORIGINAL RESEARCH published: 28 June 2016 doi: 10.3389/fmicb.2016.01005 The Generalist Inside the Specialist: Gut Bacterial Communities of Two Insect Species Feeding on Toxic Plants Are Dominated by Enterococcus sp. Cristina Vilanova1,2, Joaquín Baixeras1, Amparo Latorre1,2,3* and Manuel Porcar1,2* 1 Cavanilles Institute of Biodiversity and Evolutionary Biology, Universitat de València, Valencia, Spain, 2 Institute for Integrative Systems Biology (I2SysBio), University of Valencia-CSIC, Valencia, Spain, 3 Unidad Mixta de Investigación en Genómica y Salud, Centro Superior de Investigación en Salud Pública, Valencia, Spain Some specialist insects feed on plants rich in secondary compounds, which pose a major selective pressure on both the phytophagous and the gut microbiota. However, microbial communities of toxic plant feeders are still poorly characterized. Here, we Edited by: Mark Alexander Lever, show the bacterial communities of the gut of two specialized Lepidoptera, Hyles ETH Zürich, Switzerland euphorbiae and Brithys crini, which exclusively feed on latex-rich Euphorbia sp. and Reviewed by: alkaloid-rich Pancratium maritimum, respectively. A metagenomic analysis based on Virginia Helena Albarracín, CONICET, Argentina high-throughput sequencing of the 16S rRNA gene revealed that the gut microbiota Jeremy Dodsworth, of both insects is dominated by the phylum Firmicutes, and especially by the common California State University, gut inhabitant Enterococcus sp. Staphylococcus sp. are also found in H. euphorbiae San Bernardino, USA though to a lesser extent. By scanning electron microscopy, we found a dense ring- *Correspondence: Manuel Porcar shaped bacterial biofilm in the hindgut of H. euphorbiae, and identified the most [email protected]; prominent bacterium in the biofilm as Enterococcus casseliflavus through molecular Amparo Latorre [email protected] techniques. -

Page 1 Concessionaria Per La Progettazione, Realizzazione E
Concessionaria per la progettazione, realizzazione e gestione del collegamento stabile tra la Sicilia e il Continente Organismo di Diritto Pubblico (Legge n° 1158 del 17 dicembre 1971, modificata dal D.Lgs. n°114 del 24 aprile 2003) P O N T E S U L L O S T R E T T O D I M E S S I N A PROGETTO DEFINITIVO ALTERNATIVE AI SITI DI DEPOSITO (Richieste CTVA del 22/12/2011 Prot. CTVA/2011/4534 e del 16/03/2012 Prot. CTVA/2012/1012) EUROLINK S.C.p.A. IMPREGILO S.p.A. SOCIETÀ ITALIANA PER CONDOTTE D’ACQUA S.p.A. COOPERATIVA MURATORI E CEMENTISTI - C.M.C. DI RAVENNA SOC. COOP. A.R.L. SACYR S.A.U. ISHIKAWAJIMA - HARIMA HEAVY INDUSTRIES CO. LTD A.C.I. S.C.P.A. - CONSORZIO STABILE IL CONTRAENTE GENERALE STRETTO DI MESSINA STRETTO DI MESSINA IL PROGETTISTA PROJECT MANAGER Direttore Generale Amministratore Delegato Dott. Ing. D. Spoglianti (Ing. P.P. Marcheselli) Ing. G. Fiammenghi Dott. P.Ciucci Ordine Ing. Milano n° A 20953 Dott. Ing. E. Pagani Ordine Ing. Milano n° 15408 Firmato digitalmente ai sensi dell’ ”Art.21 del D.Lgs. 82/2005” Unità Funzionale GENERALE AMV0258_F0 Tipo di sistema AMBIENTE Raggruppamento di opere/attività STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE Opera - tratto d’opera - parte d’opera QUADRO DI RIFERIMENTO AMBIENTALE - FAUNA Titolo del documento RELAZIONE GENERALE – AMBIENTE TERRESTRE C G 0 7 0 0 P R G V G A M I A Q 3 0 0 0 0 0 0 0 8 F0 CODICE REV DATA DESCRIZIONE REDATTO VERIFICATO APPROVATO F0 31/05/2012 Emissione finale P.MICHELI M.SALOMONE D.SPOGLIANTI NOME DEL FILE: AMV0258_F0.doc revisione interna:F0 Ponte sullo Stretto di Messina PROGETTO DEFINITIVO RELAZIONE GENERALE – AMBIENTE Codice documento Rev Data TERRESTRE AMV0258_F0.doc F0 31/05/2012 INDICE INDICE .......................................................................................................................................... -

Biodiversity and Ecology of Critically Endangered, Rûens Silcrete Renosterveld in the Buffeljagsrivier Area, Swellendam
Biodiversity and Ecology of Critically Endangered, Rûens Silcrete Renosterveld in the Buffeljagsrivier area, Swellendam by Johannes Philippus Groenewald Thesis presented in fulfilment of the requirements for the degree of Masters in Science in Conservation Ecology in the Faculty of AgriSciences at Stellenbosch University Supervisor: Prof. Michael J. Samways Co-supervisor: Dr. Ruan Veldtman December 2014 Stellenbosch University http://scholar.sun.ac.za Declaration I hereby declare that the work contained in this thesis, for the degree of Master of Science in Conservation Ecology, is my own work that have not been previously published in full or in part at any other University. All work that are not my own, are acknowledge in the thesis. ___________________ Date: ____________ Groenewald J.P. Copyright © 2014 Stellenbosch University All rights reserved ii Stellenbosch University http://scholar.sun.ac.za Acknowledgements Firstly I want to thank my supervisor Prof. M. J. Samways for his guidance and patience through the years and my co-supervisor Dr. R. Veldtman for his help the past few years. This project would not have been possible without the help of Prof. H. Geertsema, who helped me with the identification of the Lepidoptera and other insect caught in the study area. Also want to thank Dr. K. Oberlander for the help with the identification of the Oxalis species found in the study area and Flora Cameron from CREW with the identification of some of the special plants growing in the area. I further express my gratitude to Dr. Odette Curtis from the Overberg Renosterveld Project, who helped with the identification of the rare species found in the study area as well as information about grazing and burning of Renosterveld. -

Martial Epigrams
LIBRARY UNIVERSITY OF SAN DIEGO THE LOEB CLASSICAL LIBRARY EDITED BY E.CAPPS, PH.D., LL.D. T. E. PAGE, LiTT.D. W. H. D. ROUSE, Lrrr.U. MARTIAL EPIGRAMS II MARTIAL EPIGRAMS WITH AN ENGLISH TRANSLATION BY WALTER C. A. KER, M.A. SOMETIME SCHOLAR OF TRINITY COLLEGE, CAMBRIDGE OF THE INNER TEMI'LK, BARR1STER-AT-LAW IN TWO VOLUMES II LONDON : WILLIAM HEINEMANN NEW YORK : G. P. PUTNAM'S SONS MCMXX CONTENTS PAGE BOOK VIII I BOOK IX 67 BOOK X 151 BOOK xi 235 BOOK XII 315 BOOK xin 389 BOOK xiv 439 EPIGRAMS ASCRIBED TO MARTIAL 519 INDEX OF PROPER NAMES 535 INDEX OF FIRST LINES . 545 THE EPIGRAMS OF MARTIAL VOL. II. M. VALERI MARTIALIS EPIGRAMMATON LIBER OCTAVUS IMPERATORI DOMITIANO CAESARI AUGUSTO GERMANICO DACICO VALERIUS MARTIALIS S. OMNES quidem libelli mei, domine, quibus tu famam, id est vitam, dedisti, tibi supplicant; et, puto propter hoc legentur. hie tamen, qui operis nostri octavus in- fruitur minus scribitur, occasione pietatis frequentius ; itaque ingenio laborandum fuit, in cuius locum mate- ria successerat: quam quidem subinde aliqua iocorum mixtura variare temptavimus, ne caelesti verecundiae tuae laudes suas, quae facilius te fatigare possint quam nos satiare, omnis versus ingereret. quamvis autem epigrammata a severissimis quoque et summae fortunae viris ita scripta sint ut mimicam verborum licentiam adfectasse videantur, ego tamen illis non permisi tam lascive loqui quam solent. cum pars libri et maior et melior ad maiestatem sacri nominis tui alligata sit, meminerit non nisi religiosa purifica- tione lustratos accedere ad templa debere. quod 1 This book appears by internal evidence to have been published towards the end of A.D. -
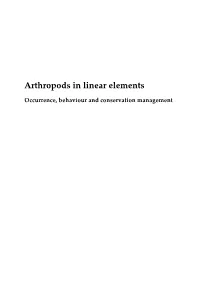
Arthropods in Linear Elements
Arthropods in linear elements Occurrence, behaviour and conservation management Thesis committee Thesis supervisor: Prof. dr. Karlè V. Sýkora Professor of Ecological Construction and Management of Infrastructure Nature Conservation and Plant Ecology Group Wageningen University Thesis co‐supervisor: Dr. ir. André P. Schaffers Scientific researcher Nature Conservation and Plant Ecology Group Wageningen University Other members: Prof. dr. Dries Bonte Ghent University, Belgium Prof. dr. Hans Van Dyck Université catholique de Louvain, Belgium Prof. dr. Paul F.M. Opdam Wageningen University Prof. dr. Menno Schilthuizen University of Groningen This research was conducted under the auspices of SENSE (School for the Socio‐Economic and Natural Sciences of the Environment) Arthropods in linear elements Occurrence, behaviour and conservation management Jinze Noordijk Thesis submitted in partial fulfilment of the requirements for the degree of doctor at Wageningen University by the authority of the Rector Magnificus Prof. dr. M.J. Kropff, in the presence of the Thesis Committee appointed by the Doctorate Board to be defended in public on Tuesday 3 November 2009 at 1.30 PM in the Aula Noordijk J (2009) Arthropods in linear elements – occurrence, behaviour and conservation management Thesis, Wageningen University, Wageningen NL with references, with summaries in English and Dutch ISBN 978‐90‐8585‐492‐0 C’est une prairie au petit jour, quelque part sur la Terre. Caché sous cette prairie s’étend un monde démesuré, grand comme une planète. Les herbes folles s’y transforment en jungles impénétrables, les cailloux deviennent montagnes et le plus modeste trou d’eau prend les dimensions d’un océan. Nuridsany C & Pérennou M 1996. -

Towards a Molecular Understanding of the Biosynthesis of Amaryllidaceae Alkaloids in Support of Their Expanding Medical Use
Int. J. Mol. Sci. 2013, 14, 11713-11741; doi:10.3390/ijms140611713 OPEN ACCESS International Journal of Molecular Sciences ISSN 1422-0067 www.mdpi.com/journal/ijms Review Towards a Molecular Understanding of the Biosynthesis of Amaryllidaceae Alkaloids in Support of Their Expanding Medical Use Adam M. Takos and Fred Rook * Plant Biochemistry Laboratory, Department of Plant and Environmental Sciences, University of Copenhagen, Thorvaldsensvej 40, 1871 Frederiksberg, Denmark; E-Mail: [email protected] * Author to whom correspondence should be addressed; E-Mail: [email protected]; Tel.: +45-3533-3343; Fax: +45-3533-3300. Received: 28 April 2013; in revised form: 26 May 2013 / Accepted: 27 May 2013 / Published: 31 May 2013 Abstract: The alkaloids characteristically produced by the subfamily Amaryllidoideae of the Amaryllidaceae, bulbous plant species that include well know genera such as Narcissus (daffodils) and Galanthus (snowdrops), are a source of new pharmaceutical compounds. Presently, only the Amaryllidaceae alkaloid galanthamine, an acetylcholinesterase inhibitor used to treat symptoms of Alzheimer’s disease, is produced commercially as a drug from cultivated plants. However, several Amaryllidaceae alkaloids have shown great promise as anti-cancer drugs, but their further clinical development is restricted by their limited commercial availability. Amaryllidaceae species have a long history of cultivation and breeding as ornamental bulbs, and phytochemical research has focussed on the diversity in alkaloid content and composition. In contrast to the available pharmacological and phytochemical data, ecological, physiological and molecular aspects of the Amaryllidaceae and their alkaloids are much less explored and the identity of the alkaloid biosynthetic genes is presently unknown. An improved molecular understanding of Amaryllidaceae alkaloid biosynthesis would greatly benefit the rational design of breeding programs to produce cultivars optimised for the production of pharmaceutical compounds and enable biotechnology based approaches. -

BRUNSVIGIA ORIENTALIS Candelabra flower, Koningskandelaar, Perdespookbossie Amaryllidaceae
SNR FACT SHEET BRUNSVIGIA ORIENTALIS Candelabra flower, Koningskandelaar, Perdespookbossie Amaryllidaceae Late summer in Steenbok Park sees the emergence of the spectacular crimson Candelabra flower or Brunsvigia orientalis which grows in scattered colonies in coastal sand. The bud of this large bulb pushes up through the sand on its sturdy stem before a leaf can be seen, and produces up to 40 flowers in a head shaped like a rounded candelabra. As the flowers fade the ovaries enlarge and become papery and eventually the flower stem breaks away and the flower head is blown about, tumbling over the ground and scattering its seeds. These ‘balls’ blowing in the wind no doubt give rise to the Afrikaans name Perdespookbossie. The plant was initially called Amaryllis orientalis, but in 1753 Lorenz Heister, a botanist and professor of medicine at the University of Helmstädt, renamed it Brunsvigia in honour of his patron the Duke of Brunswick. Karl Wilhelm Ferdinand (1735-1806), a cultured and benevolent despot, promoted the study of plants. The bulb had been sent to Germany in 1748 by Cape Governor, Ryk Tulbagh, who was very interested in the flora and fauna of the Cape and regularly sent plants and stuffed animals to Europe. Brunsvigias are deciduous and have adapted to the dry period of the year by resting underground. The large flower heads appear shortly before the rainy season. Sunbirds searching for nectar in the tubular flowers are their chief pollinators. Once the seeds have been scattered they germinate very quickly, giving the seedling a full rainy season to develop sufficiently to withstand its first dry season underground. -

The Effect of Landscape on the Diversity in Urban Green Areas
DOI: 10.1515/eces-2017-0040 ECOL CHEM ENG S. 2017;24(4):613-625 Marina KIRICHENKO-BABKO 1*, Grzegorz ŁAGÓD 2, Dariusz MAJEREK 3 Małgorzata FRANUS 4 and Roman BABKO 1 THE EFFECT OF LANDSCAPE ON THE DIVERSITY IN URBAN GREEN AREAS ODDZIAŁYWANIE KRAJOBRAZU NA RÓ ŻNORODNO ŚĆ W OBSZARACH ZIELENI MIEJSKIEJ Abstract: This article presented the results of a comparative analysis of carabid species compositions (Coleoptera: Carabidae) in urban green areas of the City of Lublin, Eastern Poland. In this study, the occurrence and abundance of ground beetles were analysed according to habitat preference and dispersal ability. A total of 65 carabid species were found in the three green areas. Obviously, the high species richness of ground beetles in the greenery of the Lublin is determined by the mostly undeveloped floodplain of the river Bystrzyca. The species richness of carabids and their relative abundance decrease in the assemblage of green areas under the effect of isolation of green patches and fragmentation of the semi-natural landscape elements in the urban environment. Generalists and open-habitat species significantly prevailed in all green areas. The prevailing of riparian and forest species at floodplain sites of the river Bystrzyca demonstrated the existence of a connection of the carabid assemblage with landscape of river valley. The Saski Park and gully “Rury” are more influenced by urbanization (fragmentation, isolation of green patches) and recreation that is consistent with the significant prevalence of open-habitats species in the carabid beetle assemblage. Keywords: green areas, Carabidae, species diversity, urban ecology, Poland Introduction The growth of populated areas and the transformation of landscapes have been important factors from the second half of the 20 th century to the present. -

T-Ïfrsükt UNIVERSITEIT GENT
t-ïfrsüKT UNIVERSITEIT GENT Fa c u l t y o f Sc ie n c e s * \o lo 9/0 ■».■'•Si Vakgroep Biologie Krijgslaan 281-S8. B-9000 Gent. BELGIUM E c o l o g y o f macrobenthos a s A BASELINE FOR AN ECOLOGICAL ADJUSTMENT OF BEACH NOURISHMENT E c o l o g ie v a n macrobenthos a l s e e n b a s is v o o r e e n ecologische b ij s t u r in g v a n strandsuppleties J e r o e n Sp e y b r o e c k Thesis submitted in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor in Sciences: Biology Promotor: Prof. dr. Magda Vincx Co-promotor: dr. Steven Degraer Academic year 2006-2007 M e m b e r s o f t h e r e a d in g c o m m it t e e : Prof. dr. Magda Vincx, promotor (UGent, B) dr. Steven Degraer, co-promotor (UGent, B) dr. Gerard Janssen (RIKZ, NL) dr. ir. Jan van de Graaft (TU-Delft, NL) M e m b e r s o f t h e examination c o m m it t e e : Prof. dr. Wim Vyverman, chair (UGent, B) Prof. dr. Magda Vincx, promotor (UGent, B) dr. Steven Degraer, co-promotor (UGent, B) dr. Gerard Janssen (RIKZ, NL) dr. ir. Jan van de Graaff (TU-Delft, NL) Prof. dr. Jean-Pierre Maelfait (UGent and IN BO, B) dr. -

Final Policy Review: Alternative Risk Management Measures to Import Lilium Spp
International plant protection convention 14_EWGCutFlowers_2014_June Final policy review Lilium spp. Agenda Item: 4.1 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------------------------------- Final policy review: Alternative risk management measures to import Lilium spp. cut flowers from Taiwan December 2013 International plant protection convention 14_EWGCutFlowers_2014_June Final policy review Lilium spp. Agenda Item: 4.1 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------------------------------- © Commonwealth of Australia Ownership of intellectual property rights Unless otherwise noted, copyright (and any other intellectual property rights, if any) in this publication is owned by the Commonwealth of Australia (referred to as the Commonwealth). Creative Commons licence All material in this publication is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Australia Licence, except for content supplied by third parties, photographic images, logos, and the Commonwealth Coat of Arms. Creative Commons Attribution 3.0 Australia Licence is a standard form licence agreement that allows you to copy, distribute, transmit and adapt this publication provided that you attribute the work. A summary of the licence terms is available from creativecommons.org/licenses/by/3.0/au/deed.en.