Studio Di Impatto Ambientale
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
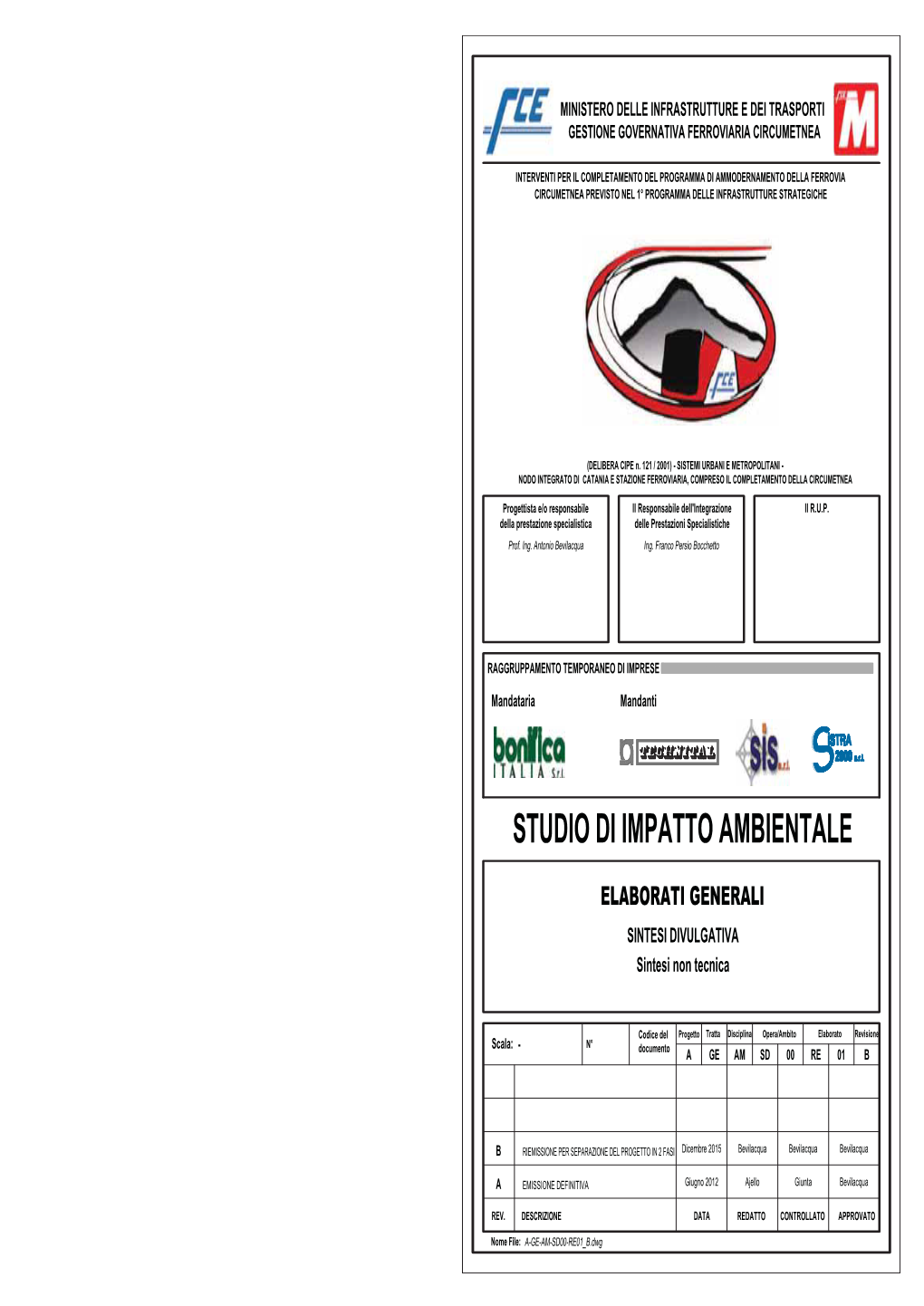
Load more
Recommended publications
-
Orario-Estivo-2020.Pdf
FERROVIA CIRCUMETNEA - CATANIA ORARIO TRENI E AUTOBUS (TRAIN AND BUS TIMETABLE) In vigore dal 29 giugno 2020 ( Timetable valid from June, 29, 2020 ) Il servizio è sospeso nelle giornate di Domenica e Festive ( The service is suspended Sunday and Holidays ) INFORMAZIONI - Informations : 095.541250 • • ♦ • ∇ ∇ ∇ •♦ ∇ ∇ ∇ ∇ ∇ ∇ ♦ ∇ ∇ • • •♦ • STAZIONI STAZIONI BUS* BUS BUS BUS* BUS BUS TR BUS TR BUS TR BUS TR BUS TR BUS BUS BUS BUS BUS TR BUS BUS BUS BUS BUS TR BUS BUS TR BUS BUS TR BUS BUS BUS BUS BUS BUS BUS BUS BUS TR. BUS BUS BUS BUS TR. TR. BUS BUS BUS TR. BUS* BUS TR. BUS TR. BUS BUS BUS TR. TR. BUS BUS BUS TR. BUS BUS BUS BUS BUS* 703 203 s1202 705 207 601 1 603 3 22 5 605 7 607 9 211 1202 36 44 48 11 213 858 609 70 72 13 611 709 15 862 613 17 84 615 88 90 92 602 17 9 851 2 604 21 43 1205 4 6 606 s702 608 8 702 204 10 81 12 861 610 208 14 16 s95 95 863 18 612 614 212 214 708 CATANIA Parcheggio S.Sofia 5.40 6.50 8.30 9.30 11.00 12.15 12.15 13.00 13.00 13.30 14.00 14.00 14.50 16.00 17.25 18.30 19.00 19.00 20.00 CATANIA Parcheggio S.Sofia 12.10 14.10 17.25 18.40 CATANIA MILO Staz. Metro 5.50 7.00 8.40 9.40 11.10 12.25 12.25 13.10 13.10 13.40 14.10 14.10 15.00 16.10 17.35 18.40 19.10 19.10 20.10 CATANIA MILO Staz. -
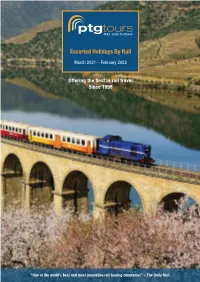
Escorted Holidays by Rail
Escorted Holidays By Rail March 2021 – February 2022 Offering the best in rail travel Since 1998 “One of the world’s best and most innovative rail touring companies” – The Daily Mail Enjoy the freedom of travel with THE PTG TOURS TRAVEL EXPERIENCE GROUP TRAVEL Let us guide you through unfamiliar territory in the most In today’s world the group tour has become an opportunity comfortable and relaxing way possible. We journey on some to travel with other likeminded people who share common of the most scenic routes in the world. Simply enjoy the world interests. At PTG Tours our itineraries further enhance the passing you by as you travel in comfort to your destination. experience by visiting places not on the itineraries of other tour Your trusted guide will be traveling with you to make sure you groups. However, our itineraries are designed to give you the get the best and most unique experiences. We make sure your choice of having your independence from the group by giving trip is relaxed and problem free. you the option to take time out to enjoy your own Our guides have a passion for travel and extensive tour day or evening experience. experience over many years but from time to time we join up HOTELS with local guides, in addition to our tour guide, who have local We aim to provide stays at good hotels and these will vary insights and take your experience to another level that might depending on the type of tour. Generally the hotels we will use be missed if travelling without a guide. -

Annex 4.3 – Case Study Report: Catania (IT)
ENSURE – European Sustainable Urbanisation through port city Regeneration Targeted Analysis Annex 4.3 – Case Study Report: Catania (IT) Case-Study Report This Case-Study Report is conducted within the framework of the ESPON 2020 Cooperation Programme, partly financed by the European Regional Development Fund. The ESPON EGTC is the Single Beneficiary of the ESPON 2020 Cooperation Programme. The Single Operation within the programme is implemented by the ESPON EGTC and co-financed by the European Regional Development Fund, the EU Member States and the Partner States, Iceland, Liechtenstein, Norway and Switzerland. This delivery does not necessarily reflect the opinion of the members of the ESPON 2020 Monitoring Committee. Authors Daniele Ronsivalle, Maurizio Carta (UNIPA) Project Support Team Davide Crimi (Comune Catania) ESPON EGTC Michaela Gensheimer (Senior Project Expert), Caroline Clause (Senior Financial Expert), Nikos Lampropoulos (Project Expert – European Outreach/Press and Media) Information on ESPON and its projects can be found on www.espon.eu. The web site provides the possibility to download and examine the most recent documents produced by finalised and ongoing ESPON projects. © ESPON, 2019 Printing, reproduction or quotation is authorised provided the source is acknowledged and a copy is forwarded to the ESPON EGTC in Luxembourg. Contact: [email protected] Annex 4.3 – Case Study Report – Catania (IT) ENSURE – European Sustainable Urbanisation through port city Regeneration Version 29/04/2020 Disclaimer: This document is a case-study report. The information contained herein is subject to change and does not commit the ESPON EGTC and the countries participating in the ESPON 2020 Cooperation Programme. The final version of the report will be published as soon as approved Table of contents List of Maps ............................................................................................................................... -

The Bulletin
ERA BULLETIN — MARCH, 2019 The Bulletin Electric Railroaders’ Association, Incorporated Vol. 62, No. 3 March, 2019 The Bulletin NYCT’S ENHANCED STATION INITIATIVE (ESI) Published by the Electric Railroaders’ PROGRAM COMPLETED Association, Inc. P. O. Box 3323 by Jeffrey Erlitz Grand Central Station New York, NY 10163 (Photographs by Sunny Zheng) For general inquiries, Station Closed Reopened or Bulletin submissions, As of January 28, 2019, MTA New York City contact us at Transit has completed the rehabilitation of all 53 St NR 3/27/2017 9/8/2017 bulletin@erausa. org 19 stations under the Enhanced Station Initi- or on our website at Bay Ridge Av R 5/1/2017 10/13/2017 erausa. org/contact ative project. This $936 million project was originally supposed to renovate 32 stations, Prospect Av R 6/5/2017 11/2/2017 Editorial Staff: but the other 13 stations were deferred to the 30 Av NW 10/23/2017 6/22/2018 Jeffrey Erlitz 2020-4 Capital Program due to budget con- 36 Av NW 10/23/2017 6/22/2018 Editor-in-Chief cerns. 163 St- 3/12/2018 9/27/2018 Ronald Yee ESI work included cellular service, Wi-Fi, Amsterdam Av C Tri-State News and charging stations, interactive service adviso- Cathedral Pkwy 4/9/2018 9/2/2018 Commuter Rail Editor ries and maps, improved signage, strip maps (110 St) BC Alexander Ivanoff for the subway routes, subway countdown 72 St BC 5/7/2018 10/4/2018 North American and clocks, service alerts, On-The-Go Informa- 86 St BC 6/4/2018 10/25/2018 World News Editor tional Dashboards, neighborhood maps, new 39 Av 7/2/2018 1/28/2019 David Ross art, and improved station lighting. -

Ferrovia Circumetnea - Catania
FERROVIA CIRCUMETNEA - CATANIA ORARIO TRENI - In vigore dal 15 settembre 2014 (Il servizio è sospeso tutte le domeniche e i giorni festivi) RAILWAYS - WINTER TIMETABLE VALID FROM SEPT, 15, 2014. THE SERVICE IS SUSPENDED SUNDAY AND HOLIDAYS INFORMAZIONI - INFORMATION: 095-541250 CATANIA - PATERNO' - ADRANO - RANDAZZO - RIPOSTO RIPOSTO - RANDAZZO - ADRANO - PATERNO' - CATANIA ^ ^ ^ TRENO TRENO TRENO TRENO TRENO TRENO TRENO TRENO TRENO TRENO TRENO TRENO FAC TRENO TRENO TRENO TRENO TRENO TRENO TRENO TRENO TRENO FAC TRENO TRENO TRENO TRENO TRENO TRENO TRENO TRENO TRENO TRENO TRENO FAC TRENO TRENO TRENO TRENO TRENO TRENO TRENO STAZIONI 5 1 3 7 9 15 11 13 17 19 21 23 203 25 27 29 31 33 35 37 STAZIONI 2 10 202 4 8 6 12 14 18 16 20 24 26 22 204 28 32 30 34 36 38 40 CATANIA BORGO 5.43 5.58 6.40 7.45 9.31 10.30 11.08 12.20 13.20 13.38 13.59 14.16 15.12 16.26 17.20 18.34 19.24 20.10 RIPOSTO 6.26 9.10 12.28 13.55 14.56 CIBALI 5.47 6.02 6.44 7.49 9.35 10.34 11.12 12.24 13.24 13.42 14.03 14.20 15.16 16.30. 17.24 18.38 19.28 20.14 GIARRE 6.31 9.15 12.33 14.00 15.01 NESIMA 5.51 6.06 6.48 7.53 9.38 10.37 11.16 12.28 13.29 13.46 14.24 15.20 16.37 17.28 18.42 19.33 20.18 VILLA DI GIARRE 6.33 9.17 12.35 14.02 15.03 LINERI 5.53 6.08 6.50 7.55 9.40 10.39 11.18 12.30 13.31 13.48 14.26 15.22 16.39 17.30 18.44 19.35 20.20 CUTULA 6.36 9.21 12.39 14.05 15.06 MISTERBIANCO 5.58 6.13 6.57 8.02 9.45 10.44 11.23 12.35 13.36 13.53 14.33 15.27 16.44 17.35 18.49 19.40 20.25 MASCALI NUNZIATA 6.40 9.25 12.42 14.12 15.10 PIANO TAVOLA 6.03 6.18 7.02 8.07 9.50 10.49 11.28 12.40 13.41 13.58 14.16 14.37 15.33 16.49 17.40 18.53 19.45 20.31 S. -

Piedimonte Etneo Piano D’Azione Per L’Energia Sostenibile
COMUNE DI PIEDIMONTE ETNEO PIANO D’AZIONE PER L’ENERGIA SOSTENIBILE Comune di PIEDIMONTE ETNEO Provincia Catania – Regione Sicilia ITALIA PIANO D’AZIONE PER L’ENERGIA SOSTENIBILE BASELINE EMISSION INVENTORY (BEI) Data Redazione Approvazione EDS: Nome e cognome Approvazione Comune: data Redazione a cura di: RTP Ing. Matteo Francesco Longo Ing. Corradini Roberto Ing. Martina Nicolosi Con finanziamento della Regione Sicilia Bando DDG n. 413 del 4 – 10 – 2013 1 COMUNE DI PIEDIMONTE ETNEO PIANO D’AZIONE PER L’ENERGIA SOSTENIBILE Indice delle figure Figura 1-1 Schermata del sito europeo dedicato all’iniziativa del Patto dei Sindaci che evidenzia la diffusione dell’iniziativa nei Comuni Europei (http://www.pattodeisindaci.eu) ........................... 10 Figura 1-2 Particolare dei Comuni Italiani che hanno aderito al PAES ........................................ 10 Figura 1-3 Comuni Siciliani che hanno aderito al PAES .............................................................. 11 Figura 1-4 Il Comune di Piedimonte Etneo nelle Signatories ....................................................... 11 Figura 1-1 Portale Istat (Reperimento dati Censimento popolazione 14° censimento 2001 e 15° censimento 2011, relativamente alle informazioni sul numero di abitazioni, di edifici per epoca costruttiva e sulle dotazioni in termini impiantistici) ......................................................................... 15 Figura 1-2 Portale siciliano dell’energia ....................................................................................... -

Social Program
Web‐site: http://conf.nsc.ru/CRS3 E‐mail: [email protected] SOCIAL PROGRAM The Organizing Committee will suggest an entertaining program and the excursions to the participants and accompanying persons. The city‐tour (Guide Excursion around Catania) is included in the package of the registration fee. Other excursions are offered to the participants optionally. We offer a wide range of excursions, on your choice. September 6, Sunday, 3.00 p.m. Excursion to Etna (42 Euro) – half day excursion September 7, Monday, 7.00 p.m. Welcome reception September 8, Tuesday, 4.30 p.m. Guide Excursion around Catania September 9, Wednesday, 7.00 p.m. Banquet (75 Euro) September 10, Thursday, 2.00 p.m. Excursion to Taormino (42 Euro) – half day excursion September 11, Friday, 9.00 a.m. Visiting Biomass Power Plant, Excursion to Enna (70 Euro) – full day excursion September 12, Saturday, 9.00 a.m. Excursion to Syracuse (65 Euro ) – full day excursion WALKING TOUR AROUND CATANIA Catania is Sicily’s second largest city, with a population of around 300,000. It lies on the Ionian Sea, at the south‐east of Sicily, under the shadow of Mount Etna, or “A Muntagna” as the locals refers to it. Mount Etna is Europe's highest and most active volcano. Etna is ever‐present and in a large extent shapes both the history, and the actual existence of Catania. On several occasions volcanic eruptions destroyed the city, the most devastating of which happened in the 17th Century. In 1669 Catania was covered in lava and then, just 24 years later in 1693 an earthquake has shaken the town to its foundations. -

Prefettura Di Catania Serie I Affari Generali Dei Comuni Elenco 26 1886
26 Prefettura di Catania serie I Affari generali dei Comuni Elenco 26 1886 – 1896 schedatura e inventariazione a cura di Donatella Psaila, secondo i nuovi criteri descrittivi e con l'ausilio del software Arianna.2, (realizzato nel 1999-2000 da Cecilia Poggetti e Luca Pieraccini, presso il Centro di ricerche informatiche per i beni culturali della Scuola Normale Superiore di Pisa). st. 17, p. t., scaf. I, cass. 41 - 50; scaf. II cass. 51 - 69 Stampa 2016 Elenco: 26 1 244 unità archivistiche 1 26 1 [3535, 1ex] 1889 - 1892 2 Collocazione: 1, El. 26 Pratiche individuali Fascicolo cartaceo contenuto in busta di carta da pacchi di fascicolo 1; numerazione successiva per fascicoli. Varia "Pratiche individuali in ordine alfabetico"; indennità varie. Luoghi rilevati: Provincia Catania Leggibilità buona. 2 [3536, 2ex] 1884 - 1893 3 Collocazione: 2, El. 26 Indennità varie Fascicoli cartacei contenuti in busta di carta da pacchi di fascicoli 9; numerazione successiva per fascicoli. Varia Indennità (incaricato del servizio di leva, trasferta, residenza, missione, trasloco, retribuzione). Luoghi rilevati: Catania Leggibilità Buona. 3 [3537, 3ex] 1888 - 1892 4 Collocazione: 3, El. 26 Pensioni, indennità Fascicolo cartaceo contenuto in busta di carta da pacchi di fascicolo 1; numerazione successiva per fascicoli. Varia "Liquidazione di pensioni", indennità di trasferte, di trasloco. Luoghi rilevati: Catania Leggibilità Buona. 4 [3538, 4ex] 1881 - 1894 5 Collocazione: 4, El. 26 Leggi, decreti, bollettini Fascicoli cartacei contenuti in busta di carta da pacchi di fascicoli 2; numerazione successiva per fascicoli. 2 26 Varia "Raccolta di leggi e decreti". "Materiale del Bollettino di Prefettura". Annotazioni: la busta contiene manifesti. -

FERROVIA CIRCUMETNEA Carta Dei Servizi 2019 2
FERROVIA CIRCUMETNEA Carta dei Servizi 2019 2 INDICE Introduzione 3 I valori guida e gli impegni 4 L’offerta 5 Rete ferroviaria e metropolitana 6 L’offerta in cifre 8 Indicatori e obiettivi 9 Come viaggiare con i mezzi di Ferrovia Circumetnea 11 Titoli di viaggi e tariffe 14 Stazioni ferroviarie: biglietterie 17 Convenzione studenti universitari 18 Servizio Metro Shuttle 19 Metropolitana: indagine di Customer Satisfaction 20 I punti vendita 22 Servizi turistici: come raggiungere l’Etna con Ferrovia Circumetnea 28 Per comunicare con Ferrovia Circumetnea 29 Ferrovia Circumetnea - Carta dei servizi 2019 3 INTRODUZIONE La Carta dei Servizi, che nell’ambito dei servizi di trasporto pubblico prende il nome di Carta della Mobilità, è il documento che regola i rapporti tra le Aziende che offrono servizi di pubblica utilità e i fruitori di tali servizi. La presente Carta consente ai viaggiatori di informarsi, in modo semplice e rapido, sugli impegni programmatici di Ferrovia Circumetnea, sui principi fondamentali che la guidano nello svolgimento della propria attività, sui servizi offerti e sugli obiettivi che si è prefissata di raggiungere. Ferrovia Circumetnea, anche attraverso la Carta dei Servizi, si prefigge il raggiungimento di due obiettivi primari: • migliorare la qualità dei servizi forniti; • migliorare il rapporto tra cliente e Azienda. Ferrovia Circumetnea - Carta dei servizi 2019 4 I VALORI GUIDA E GLI IMPEGNI Ferrovia Circumetnea svolge le proprie attività ed eroga i propri servizi nel rispetto dei principi fondamentali qui di seguito riportati. Sicurezza del viaggio e dei passeggeri - Ferrovia Circumetnea considera irrinunciabile la sicurezza e per tale motivo si impegna a fornire a tutti i suoi clienti un servizio che rispetti i più rigidi standard di sicurezza del viaggio. -

Provincia Regionale Di Catania PIANO TERRITORIALE PROVINCIALE
Provincia Regionale di Catania PIANO TERRITORIALE PROVINCIALE SCHEDA INTERVENTO Ente (1) Ambito Comuni Trasporti Enti diversi Enti territoriali Settore di intervento (2) Titolo intervento Quadro conoscitivo Obiettivi e Allegato n. valenza strategica (3) Soggetto attuatore (se diverso dall'ente) Allegato n. Breve descrizione dell'intervento Documenti di riferimento (4) Allegato n. Fattibilità tecnica Livello di definizione esigenza Costo presunto (tutto compreso) euro idea studio di fattibilità/prefattibilità Elaborati progettuali allegati? no sì, allegato n. progetto preliminare/definitivo progetto esecutivo Localizzazione Allegato n. Inserimento in strumenti di pianificazione/concertazione Piani Allegato n. Patti/accordi Allegato n. Vincoli ambientali, Allegato n. paesistici, naturalistici Stato di avanzamento iter amministrativo Tempi di realizzazione previsti Autonomia/dipendenza (5) Sostenibilità economico - finanziaria Copertura finanziaria (6) suscettibile al Project Financing fondi propri: euro (pari al %) Soggetto Programma finanz. euro (pari al %) Soggetto Programma finanz. euro (pari al %) Soggetto Programma finanz. euro (pari al %) Costi gestione annui euro Eventuali ricavi annui euro Scheda compilata da Rif. Telefonici Ruolo/Ufficio Data / / Firma ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE 1 Inserire il codice dell'Ente e la relativa denominazione, secondo la codifica riportata di seguito (a cura del ricercatore): 101 Comune di Aci Bonaccorsi 129 Comune di Misterbianco 157 Comune di Maniace 102 Comune di Aci Castello 130 Comune di Motta -

Ferrovia Circumetnea Previsto Nel 1° Programma Delle Infrastrutture Strategiche
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI GESTIONE GOVERNATIVA FERROVIARIA CIRCUMETNEA INTERVENTI PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGRAMMA DI AMMODERNAMENTO DELLA FERROVIA CIRCUMETNEA PREVISTO NEL 1° PROGRAMMA DELLE INFRASTRUTTURE STRATEGICHE (DELIBERA CIPE n. 121 / 2001) - SISTEMI URBANI E METROPOLITANI - NODO INTEGRATO DI CATANIA E STAZIONE FERROVIARIA, COMPRESO IL COMPLETAMENTO DELLA CIRCUMETNEA Progettista e/o responsabile Il Responsabile dell'Integrazione Il R.U.P. della prestazione specialistica delle Prestazioni Specialistiche RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESE Mandataria Mandanti STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE ELABORATI GENERALI QUADRO DI RIFERIMENTO PROGETTUALE PARTE GENERALE Relazione Codice del Progetto Tratta Disciplina Opera/Ambito Elaborato Revisione Scala: - N° documento A GE AMQT 00 RE 01 B B Dicembre 2015 Bevilacqua Bevilacqua Bevilacqua A EMISSIONE DEFINITIVA Giugno 2012 Ajello Giunta Bevilacqua REV. DESCRIZIONE DATA REDATTO CONTROLLATO APPROVATO Nome File: INTERVENTI PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGRAMMA DI AMMODERNAMENTO DELLA FERROVIA CIRCUMETNEA Studio d’Impatto Ambientale 3.3.4 Opere d’arte maggi ori ........................................................................................................................................................ 17 3.3.5 Variante 3 (verde) .............................................................................................................................................................. 17 FERROVIA CIRCUMETNEA 3.3.5.a Descrizione generale del tracciato ............................................................................................................................ -

TRENI STORICI DEL GUSTO SICILIA 2018 Locomotiva Gr
Con la collaborazione di Regione Siciliana Azione 6.8.03 Assessorato del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo TRENI STORICI DEL GUSTO SICILIA 2018 Locomotiva Gr. 740.049 in uscita dallo scalo merci del porto di Catania, 1969. Foto Archivio Fondazione FS Nello Musumeci, Presidente della Regione Siciliana Come una ragnatela tessuta con dedizione e sacrificio, le linee ferrate isolane sono un fiore all'occhiello della mobilità sostenibile perchè consentono di addentrarsi nei meandri della Sicilia più autentica e di scoprirne le bellezze. E' con questo spirito che la Regione Siciliana offre il suo contributo per un progetto che diventa valore aggiunto di un'offerta turistica globale. Essa non guarda solo all'incoming, ma anche alla fruizione del territorio durante una permanenza finalizzata, tra l'altro, alla destagionalizzazione. Il treno ci riporta a un ritmo di viaggio da assaporare lentamente, un'occasione in più non solo per i turisti, ma anche per i tanti siciliani che, grazie a questa iniziativa, possono riscoprire le peculiarità della nostra terra e apprezzarne da vicino le tante sfaccettature. Viaggiare sulle rotaie diventa dunque il sistema perfetto per vivere appieno l'armonia fra cultura, gusto e paesaggio che solo quest'Isola sa offrire. Nello Musumeci Sandro Pappalardo, Assessore del Turismo,dello Sport e dello Spettacolo E' possibile vivere un'esperienza di viaggio coinvolgente attraverso i territori della Sicilia che sveli attraverso il cibo la storia della sua cultura materiale. Un viaggio che superi i tradizionali clichè e non si limiti alla visita del suo straordinario patrimonio monumentale, storico artistico, naturale. E' la scommessa culturale del progetto i Treni storici del gusto che offre un programma di ventitre itinerari e cinquanta appuntamenti per attraversare e conoscere la Sicilia dalla fine di luglio all'inizio di dicembre, in una visione di turismo relazionale integrato che rimanda ai principi ispiratori delle azioni condotte sui Borghi d’Italia, l’Anno del Cibo Italiano, il Turismo di ritorno.