Rivista Storia Dello Sport N. 2
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
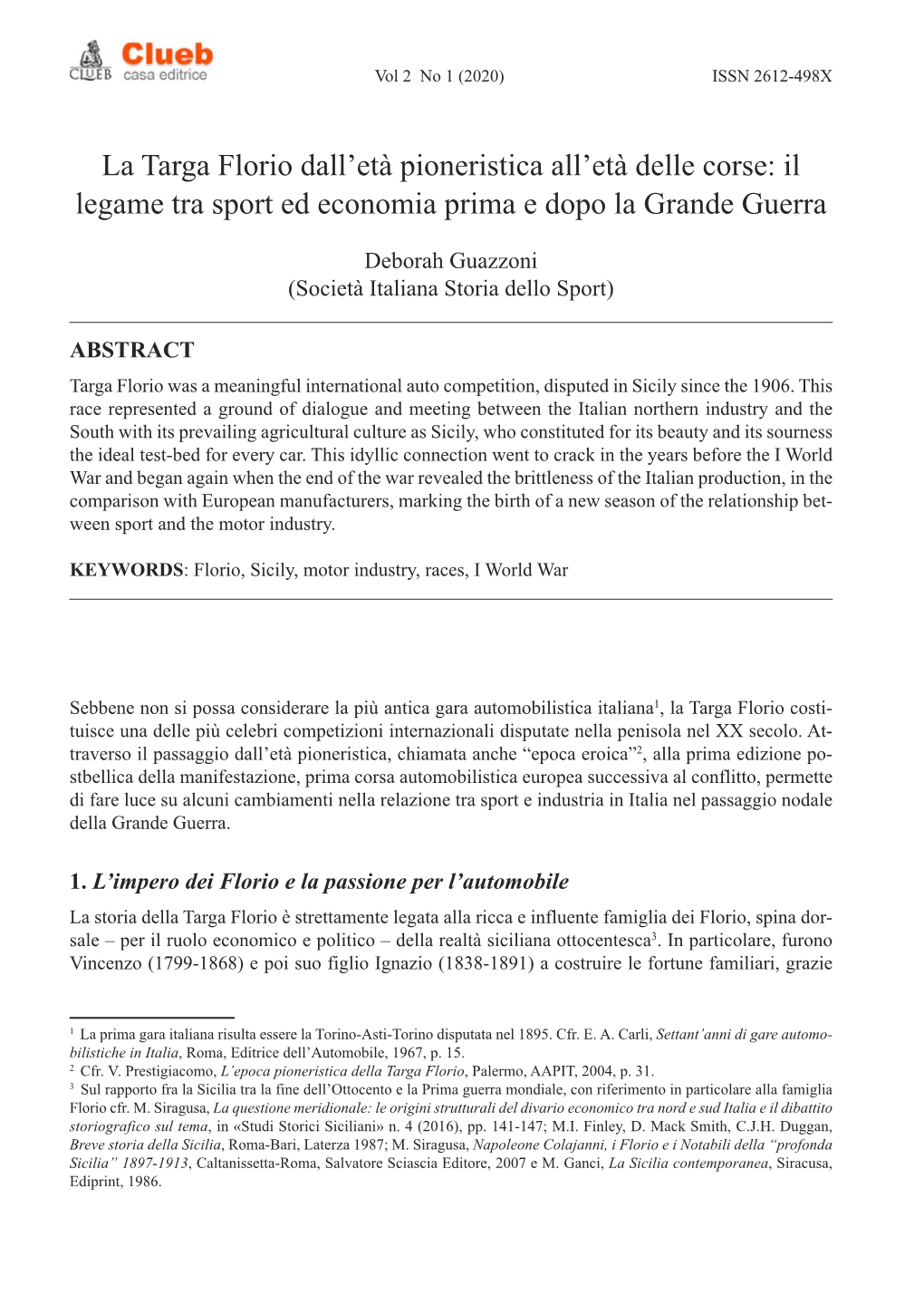
Load more
Recommended publications
-

Cento Volte Targa Florio
a cura di Giuseppe Valerio CENTO VOLTE con la collaborazione di www.targapedia.com - www.amicidellatargaflorio.com Cento Volte Targa Florio Non siamo ammattiti e i conti, più o meno, sappiamo ancora farli. La gara più antica del mondo raggiungerà il traguardo delle 100 edizioni solo nel 2016. Noi iniziamo qui un lungo conto alla rovescia per celebrare degna- mente l’evento. Il 2016 sembra piuttosto lontano, alme- no se visto dalle pagine di un giornale che por- La Targa Florio assegnata nella prima edizione del 1906. ta la data del maggio 2014. Però noi, qui e og- gi, abbiamo deciso di intraprendere un cam- mino che vuole anche essere la giusta cele- Sopra, la brazione del patrimonio forse più grande custodito nello scrigno dell’au- Coppa Florio, tomobilismo sportivo italiano: la Targa Florio. primo trofeo La gara più vecchia del mondo quest’anno celebra la sua edizione nu- 1906-1907: ideato da mero 98; nel 2016 saranno 100. Sembrano solo numeri a caso, invece, Vincenzo Florio nel nel 2016 la Targa sarà anche la prima gara automobilistica a raggiungere 1905. le 100 edizioni. A voler sottilizzare, nello stesso periodo anche un’altra garetta amatoriale raggiungerà lo stesso traguardo, la 500 Miglia di In- dianapolis. Ma chi solleverà per la centesima volta il trofeo Borg & War- La Targa Florio ner avrà comunque la certezza di essere arrivato secondo perché la Tar- ga è nata nel 1906, la 500 Miglia nel 1911. E’ solo la diversa durata delle sospensioni belliche tra Europa e America a determinare la differenza, ma la Targa resta dunque la più anziana e sarà quindi la prima a raggiun- nasce adulta gere il prestigioso traguardo. -

Das Schnauferl Offizielles Magazin Des Allgemeiner Schnauferl-Club Deutschland E.V
/2020 10 DAS SCHNAUFERL OFFIZIELLES MAGAZIN DES ALLGEMEINER SCHNAUFERL-CLUB DEUTSCHLAND E.V. (ASC-D). GEGRÜNDET 1900. AUSGABE Bella Italia Historisches von Opel Termine 2021 PininFarina & Messe Padua Rennbahn und Altwerk International, ASC, Messing AUSTRIA HISTORIC 2021 Mehr als die Ennstal Classic www.ennstal-classic.at In der Mitte von Österreich ABER eine Woche mit Genuss auf ca 1100 km mit maximal 13% Steigung KEINE WERTUNGEN KEINE ANSPRACHEN KEINE SPONSORVERPFLICHTUNGEN und keine "Promis" und Werkteams PURE FREUDE AM FAHREN MIT FREUNDEN mit Fahrzeugen bis Bj 1945 Neue Freunde gewinnen und alte Freunde treffen. 1.- 8.8.2021 im Schlosshotel Pichlarn www.pichlarn.at Lang, schwer, anspruchsvoll, machbar. Die Strecke ist die Prüfung. Für max 40 Teams. So wird die Fahrt zu einem Erlebnis: Fahren - Kultur - Genuss Salzkammergut, Planai, Stoderzinken, Nockberge, Sölkpass, Eisenwurzen, Gesäuse, Erzberg, Red Bull Ring, befahren und genießen, maximal ca 250 wunderbare km pro Tag! Aber ohne Stress, sondern entspannt und mit Genuss durch diese herrlichen Landschaften ! Zu gewinnen gibt es die erlebnisreichste Woche des Sommers - ganz ohne Pokale. Darum bemühen wir uns mit 35qm Zimmern u Suiten im Schlosshotel Pichlarn Welcome Drinks,Dinner,Spa,Sauna,Frühstück, Parkplatz,Mautgebühren,Führungen,Roadbooks Nummern,Kappen,Polos,Plakette,Servicefahrzeug Mechaniker,alles und vieles mehr… …womit wir Euch noch überraschen können. Nenngeld pro Person im DZ € 1893,- (EZ + 485,- ) Nennung mit Foto und € 600,- sofort. Rest bis 31.3.2021 Raiffeisenkasse Biedermannsdorf BLZ 32250 Konto-Nr.:504399 Austria Historic 2021 RLNWATWWGTD AT43 3225 0000 0050 4399 Nicht AUTOMOBIL VETERANEN CLUB AUSTRIA Gleich zu lange AVCA A-1011 Wien Postfach 332 TEL 0043 699 171 177 12 Start sichern warten Fax 0043 1 812 24 01 [email protected] www.avca.at = nennen All die Jahre war die Austria Historic schon sehr früh gut gebucht Die Fahrt ist nicht gewinnorientiert kalkuliert, 2 wir sind ein Club für historische Fahrzeuge, kein Reisebüro. -

Coppaflorio Cullenthomas.Pdf
Vincenzo Florio's first race A Subject of some Confusion by Cullen Thomas l:ey were shrouded in a confusion so resolute as to be almost admirable. They produced some of the wildest and most unlikely sporting contests irn aginable. Depending upon point of view or perspective, there were eight of them, or nine, or elevenspanning a quarter of a century or so. They were the Coppa Florio races, though for some the name "Florio" wasn't attached, and for others the "Coppa" wasn't offered. Few people remember them today, Vincenzo Florio himself had probably forgotten about them long before the last one. Stili they deserve to be recalled, for they provided a fascinating if dis jointed saga, and have left to history one of the most beautiful victory trophies in the history of motor sport. It was around November of 1904 that the trophy itself made its appearance, Vincenzo Florio having offered the Automobile Club of ltaly for its purchase the sum of 100,000 lirewhich the British A utocar considered qui te excessive even for "onc of the wealthiest men in Italy" and hoped that much wouldn't be spent on anything so frivolous. What Florio hoped for was an objet d'art worthy of an event which in turn he hoped would rivai in importance the much vaunted raccs for the Gordon Bennett cup. IL was noi lo be. The Florio Cup would previde more tribulation than tributeand soon its donor's attention 3·13 would be diverted to another sporting contesi lo which he would lend his name "tailgate" racing, the less than adequate telegraph arrangement for keeping und mosr of his energythe Targa (meaning "shield" or "plate"): scoreali fairly typical of cornpetition in those daysmeant that no one in the But that's getting ahead of the story. -

1 75° ANNIVERSARIO 1° GRAN PREMIO D'italia Tavola Rotonda
75° ANNIVERSARIO 1° GRAN PREMIO D’ITALIA Tavola rotonda con Adolfo Orsi, Mauro Mori Griffith Borgeson Brescia, 5 settembre 1996 ADOLFO ORSI PERCHE’ BRESCIA La prima corsa che toccò la città di Brescia fu la “Verona-Brescia-Mantova- Verona” nel marzo del 1899: l’entusiasmo fu tale che i bresciani organizzarono nel settembre di quello stesso anno le “Feste automobilistiche”, la prima manifestazione autenticamente bresciana, il cui programma prevedeva la corsa “Brescia-Cremona-Mantova-Verona-Brescia” (vinta da Luigi Storero su De Dion Bouton), il “Criterium delle motociclette” (vinto da Carlo Maserati su Carcano), e la “Corsa Brescia” disputatasi sulla circonvallazione cittadina. Nel 1900 fu organizzato il “Convegno automobilistico” che prevedeva la gara “Record di velocità” sui cinque chilometri, e la corsa “Brescia- Cremona-Mantova-Verona-Brescia”, vinta da Soncino su un triciclo di sua costruzione alla media di 57 chilometri all’ora. Si passò poi al 1904 con la “Settimana automobilistica”, che vide la vittoria di Vincenzo Lancia su Fiat nella corsa “Brescia-Cremona-Mantova-Brescia”, e la partecipazione del magnate siciliano Vincenzo Florio che, entusiasta, decise di istituire per l’edizione dell’anno successivo la ricchissima “Coppa Florio”. Nel 1905, la “Settimana automobilistica” comprendeva un’esposizione di tutta la produzione automobilistica e degli accessori nella Crociera di S.Luca, la gara mononautica sul Lago di Garda e il “Circuito di Brescia” sul tradizionale percorso a triangolo Brescia-Cremona-Mantova-Brescia, che fu vinta da Raggio su Itala. Fu grazie alla presenza alle “settimane” bresciane del 1904 e del 1905 che il Vincenzo Florio maturò l’idea di una manifestazione automobilistica in Sicilia e nel 1906 organizzò la prima “Targa Florio” che divenne da allora una delle classiche più importanti del calendario internazionale. -

Regesto Articoli Su FTA - Florentia Apparsi Ne La Stampa Sportiva (22 Giugno 1902 - 27 Giugno 1909)
Regesto articoli su FTA - Florentia apparsi ne La Stampa Sportiva (22 giugno 1902 - 27 giugno 1909) “La Stampa Sportiva”, 22 giugno 1902, Torino [00023] Automobilismo: La Coppa della Consuma La corsa automobilistica internazionale in salita sul percorso Pontassieve-Consuma, km. 15, sortì esito splendido. La corsa ha per premio una coppa di argento challenge, che verrà disputata annualmente sullo stesso percorso Pontassieve-Consuma; viene dichiarata vincitrice la macchina che impiega minor tempo; il proprietario della macchina vincitrice assumerà il titolo di detentore della coppa; per diventare proprietario della coppa stessa dovrà vincerla tre volte consecutive. Durante i tre anni la coppa sarà tenuta in custodia, sotto la sua responsabilità, dalla Società Automobilistica italiana, cui il concorrente appartiene, ed in difetto dal Club Automobilistico d'Italia. Alla corsa presero parte: Pollazzi, Bolide 30 HP; Malenchini, Bernhard 16 HP; Cappellini, Panhard 12 HP; Adami, Rondine 10 HP; Tonietti, Banhard 20 HP; Nagliati, De Dion 10 HP; Calosi, Florentia 3 HP; Noury, triciclo De Dion 6 HP. Categoria Touristes: Lawley De Dion, 4 posti 8 HP; Miccinesi, 3 posti Fiorentia 8 HP; Alberti, Sposti Fiat 12 HP; Duca Strozzi, 3 posti Fiorentia 8 HP; Della Stufa, 4 posti Fiat 12 HP. Il Noury col triciclo impiegò 21 minuti e 30 secondi, il Tonietti 25,18, il Nagliati e il Cappellini 31, il Malenchini 33,17, il Calosi 33,40, il Pollazzi 51. Nella categoria Touristes il Miccinesi impiegò 54 minuti, l'Alberti 57, lo Strozzi 60, il Lawley 1 ora e 35 minuti. Conseguentemente, le vetture Banhard di Tonietti e Cappellini, De Dion di Nagliati, Fiorentia della fabbrica Toscana e Fiat dell'Alberti vinsero il l° premio della loro rispettiva categoria. -

F.Lli CEIRANO – Pionieri Dell' Auto a Torino
F.lli CEIRANO – Pionieri dell’ auto a Torino Parte terza : Automobili ed Autocarri SPA Automobili ITALA MONOGRAFIA del Dott. Ing. GIORGIO BENVENUTO S O C I E T A’ P I E M O N T E S E A U T O M O B I L I Testo desunto da : www.targaflorio.info Nella pagina successiva la PRODUZIONE della SPA Una SPA 50 HP del 1914 La SPA partecipò alla 3A targa FLORIO , nel 1908 con Ernesto CEIRANO ed alla 4A , nel 1909 , col Barone Francesco CIUPPA che risultò vincitore. Barone Francesco CIUPPA Motore aereonautico SPA 6A : 6 cilindri in linea – 14780 cm3 – 200 HP – raffreddato ad acqua Lo SPA 6A equipaggiava i vari modelli degli aerei SVA www.it.wikipedia.org 41 tipo AUTOCARRO 41 tipo TRATTORE Testo desunto da : www.it.wikipedia.org SPA 38R allestimento OFFICINA SPA 38R allestimento STAZIONE RADIO con radio MARELLI R5 Fronte ALBANESE Fronte RUSSO Da : www.it.wikipedia.org Uno SPA TM40 nella campagna di RUSSIA Uno SPA TM40 , preda di guerra , traina una V2 in GERMANIA I T A L A F A B B R I C A A U T O M O B I L I ITALA 1908 (Vincitrice della prima Targa Florio nel 1906) “Questa piccola Casa torinese realizzò alcune tra le più grosse e più veloci automobili da corsa dei suoi tempi, dotate di enormi motori, tecnicamente d’avanguardia” Come un tenia ricorrente, il nome Ceirano si ripete per tutto il primo periodo della storia dell’industria automobilistica torinese: è quello di alcuni vulcanici fratelli che sembra abbiano dato vita praticamente a ogni marca di prestigio nata a Torino prima della Grande Guerra. -

1 La Tela Del Ragno La Parola Crisi
LA TELA DEL RAGNO LA PAROLA CRISI Serve lo studio della Storia? Generazioni di storici hanno lasciato saggi preziosi e profondi, insostituibili per capire il passato; e la molla che spinge uno studioso a capire il passato è dotarsi degli strumenti per interpretare correttamente il presente, e magari presagire qualche accadimento futuro. Di fronte però al ripetersi ciclico di eventi simili, troppo simili, con conseguenze devastanti, ugualmente devastanti, viene da chiedersi se l’aver studiato quegli avvenimenti sia davvero servito. O se l’uomo, in definitiva, non sia costretto, ogni volta, a ricominciare da capo, come una tabula rasa, come uno scolaretto di sei anni al suo primo giorno di scuola, senza poter contare sulla esperienza dei padri. Altro che nani sulle spalle dei giganti. Crisi, è la parola di oggi. Crisi del matrimonio, crisi dei valori, crisi industriale, finanziaria, immobiliare, crisi del consumo, crisi della quarta settimana, magari anche della terza. C’è la crisi, è colpa della crisi: questa è la frase chiamata a descrivere e giustificare le situazioni più diverse, l’arrembaggio ai voli low cost, la denatalità, l’aumento degli immigrati clandestini, la disoccupazione, la lievitazione dei prezzi, le ronde anticriminalità. Magari anche gli stupri, la violenza sulle donne… La Crisi è una palude in cui l’intera nostra società sta sprofondando più o meno lentamente, vischiosa, appicicaticcia: si attacca a tutto, e tutto confonde. Per capirla, o illudersi di, vale la pena immergersi nelle crisi che il Novecento ha profuso a piene mani. La crisi del ’29 per esempio, richiamata instancabilmente alla memoria, fino a farla diventare un semplice esercizio linguistico anziché un mezzo di investigazione. -

Nata Nel 1906, È Considerata La Gara Automobilistica Più Antica Del Mondo
SPORT /TARGA FLORIO di Stefano Cossetti Mito e storia NATA NEL 1906, È CONSIDERATA LA GARA AUTOMOBILISTICA PIÙ ANTICA DEL MONDO. VOLUTA DA VINCENZO FLORIO PER PROMUOVERE E VALORIZZARE La “suA” sicilia, nel CORSO DEGLI ANNI VIDE SFILARE LUNGO IL PERCORSO VETTURE ENTRATE NELLA LEGGENDA. OGGI È DIVENTATA UN RALLY. MA IL SOGNO CONTINUA 24 AUTOMOBILE LUGLIO-AGOSTO 2012 hissà cosa direbbe alle montagne madonite; Coggi Alessandro Ca- ma non fu possibile per gno, il primo vincitore la presenza della ferrovia della Targa Florio, sco- che tagliò fuori Cefalù. prendo che la corsa si- La gara si spostò su un ciliana è ancora in vita e Ferrari GT Berlinetta. percorso lungo paesi che si fregia del titolo di “gara poi sarebbero diventati più antica del mondo”. famosi proprio grazie alla La prima edizione in Si- Targa Florio: Cerda, Cal- cilia si disputò il 6 maggio tavuturo, Petralia, Gera- del 1906 (anche se in re- ci, Castelbuono… fino al altà una Coppa Florio si lungo rettilineo di Buon- era già svolta in provincia fornello, uno dei tratti più di Brescia nel 1905). Dei celebri della Targa Florio, 13 piloti iscritti, partiro- Ferrari 250 GT Berlinetta. assieme ai box di Cerda, no in dieci e arrivarono tuttora esistenti e che a in sette. In programma volte vengono utilizzati c’erano tre giri del grande da qualche casa automo- circuito delle Madonie, bilistica per la presenta- lungo 148 chilometri e zione di nuovi modelli. 823 metri, per un totale In occasione della prima di 446 chilometri e 469 edizione, Vincenzo Florio La Testa Rossa di Phil Hill lungo metri.