Francesco Cusani Confalonieri, Traduttore, Storico
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
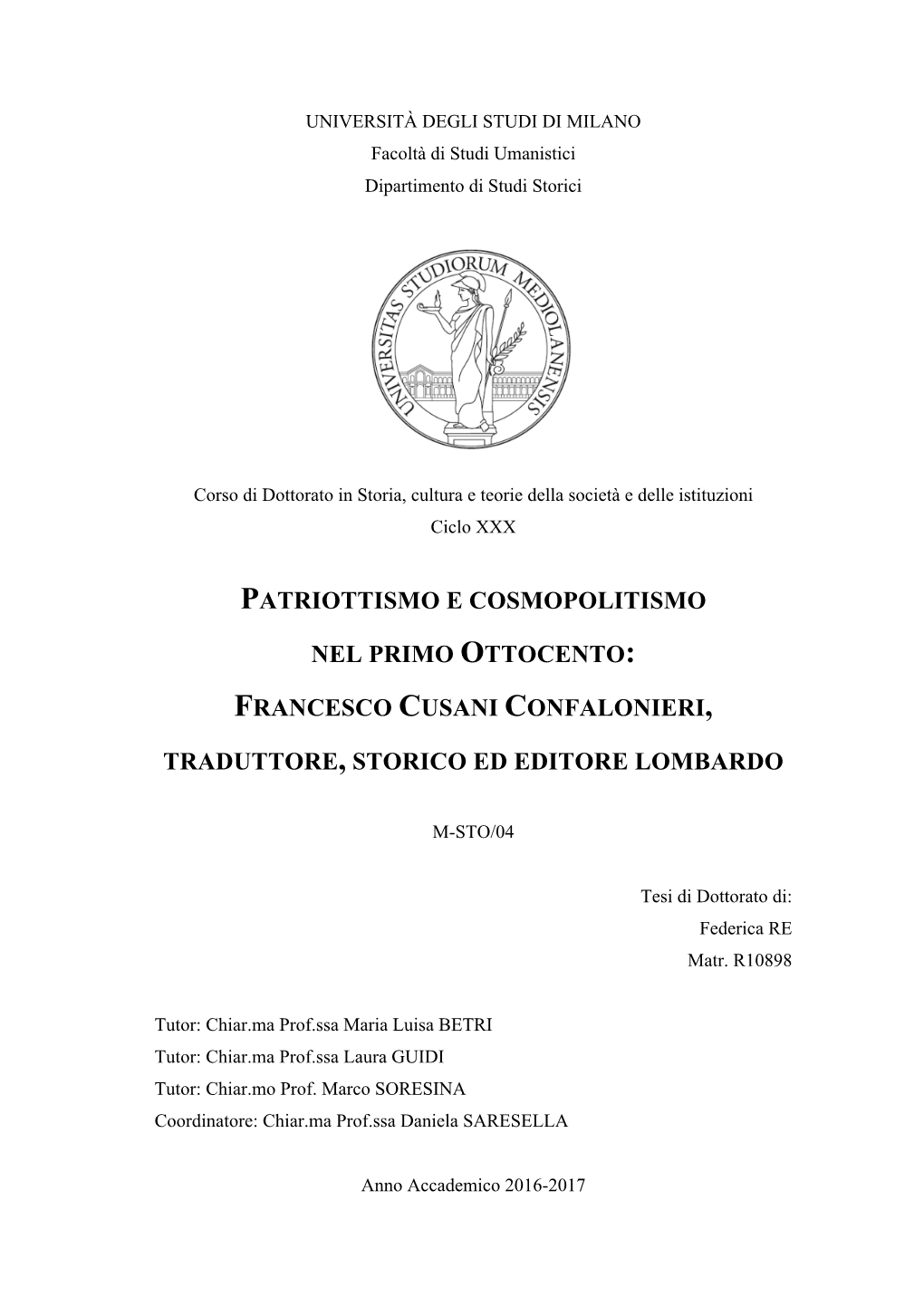
Load more
Recommended publications
-

II. Ingegnere O Architetto?
II. IngegnereGiacomo o Architetto? Tazzini, archit etto di tre Corti II.II. Ingegnere o Architetto? La questione della firma nel primato del disegno UL piano estetico e didattico il periodo di maggior tensione lavorativa di S Giacomo Tazzini vide fra i teorici delle discipline architettoniche, dalla metà degli anni Trenta dell’Ottocento, l’estremizzazione di una querelle già avviata da tempo, ma mai vissuta in modo così ‘passionale’ da parte degli attori coinvolti, e in primis dai conservatori dell’architettura pura. La questione coinvolgeva e contrapponeva ingegneri e architetti, e nella fattispecie gli architetti formati nelle Università da quelli formati nelle Accademie d’arte. Ciò che era inviso ai conservatori più agguerriti, come agli accademici del calibro di Carlo Amati, era che nelle Università andava via via crescendo il numero di corsi di disegno architettonico a corredo del piano formativo per i futuri ingegneri e architetti civili, i quali, ottenuto il grado accademico, e dopo aver compiuto il praticantato obbligatorio e l’esame di stato, potevano svolgere la professione di architetto senza mai aver messo piede in un’accademia d’arte, luogo deputato alla formazione del vero architetto1. Per comprendere meglio la situazione dobbiamo fare un passo indietro, fino al novembre del 1786. A Milano il Regio Imperiale Consiglio di Governo (gli austriaci) pubblicava il 6 novembre 1786 un Avviso che regolamentava il percorso di studi delle suddette professioni, esso diceva Essendo la Regia Università di Pavia il centro della Istruzione -

Conservation of the Courthouse of Milan
POLITECNICO DI MILANO Laurea Magistrale (MSc) in Building and Architectural Engineering CONSERVATION OF THE COURTHOUSE OF MILAN Supervisor: PROF. ARCH. Elisabetta ROSINA Thesis by : Baris Demirel - 840553 Liu Yuheng - 840629 Lu Shan - 832833 INDEX ABSTRACT 1 ABSTRACT (Italian Version) 2 1. INTRODUCTION 3 1.1 - Information on Milan 3 1.1.1 - Geographical context 3 1.1.1.1 - Climate 4 1.1.1.2 - Population 5 1.1.1.3 - Education 7 1.1.1.4 - Art & culture 9 1.1.1.5 - Economy 10 1.1.1.6 - Transportation 11 1.1.2 - The events leading to Courthouse of Milan 12 1.2 - Information on the Courthouse 16 1.2.1 - Historical synopsis 16 1.2.2 - Architectural information 29 1.2.2.1 - Design 29 1.2.2.2 - Distribution of the spaces 31 1.2.2.3 - Circulation in the environment 34 1.2.2.4 - Metric data 35 1.2.2.5 - Architectural drawings 36 1.2.2.5.1 - Plans 36 1.2.2.5.2 - Elevations 44 1.2.2.5.3 - Partial sections and elevations 45 1.2.3 - Technical information 47 1.2.3.1 - Construction 47 1.2.3.2 - Structure data and conditions 51 1.2.3.3 - Materials 53 1.2.3.4 - Technical equipments 54 1.2.3.4.1 - Doors and windows 54 1.2.3.4.2 - Lighting equipments 57 1.2.3.4.3 - Water and health services 58 1.2.3.4.4 - Heating and air-conditioning system 60 1.2.3.4.5 - Electrical system 62 1.2.4 - Courthouse of Milan as an art gallery 66 1.2.4.1 - Information 66 1.2.4.2 - Artworks on the ground floor 70 1.2.4.3 - Artworks on the first floor 71 1.2.4.4 - Artworks on the third floor 79 1.3 - SWOT analyses 89 1.3.1 - Analysis on Milan 89 1.3.2 - Analysis on the Courthouse 90 2. -
La Chiesa Di Sant'anna in San Damiano
LA CHIESA DI SANT’ANNA I N S A N D A M I A N O Quella che i sandamianesi conoscono come la “geseta de Sant’Anna” sorge su un suolo di antica tradizione. In un atto di donazione dell’853 d.C. si rileva che nella “baragia” esisteva già una cappella, una chiesetta dedicata ai SS. Cosma e Damiano; nucleo attorno a cui sorgeva un piccolo convento e alcune abitazioni dipendenti dal monastero di Sant’Ambrogio in Milano. Oggi la chiesa porta ancora la testimonianza dell’antica titolazione del territorio nella scritta che compare dipinta sullo scudo scolpito nella cimasa sagomata del portone centrale. L’antica cappella e l’annesso monastero furono demoliti nel 1578, forse perché fatiscenti, per volere di San Carlo Borromeo, vescovo della diocesi di Milano che in quell’anno era in visita pastorale in queste terre. I materiali di riporto della chiesetta di San Damiano servirono per ampliare la chiesa di San Bartolomeo in Brugherio e per arricchire la zona absidale del Duomo di Monza. L’attuale chiesetta è di costruzione settecentesca, risulta menzionata per la prima volta nel 1767 dallo storico monzese Anton Francesco Frisi che la considera «di fabbrica recente». Si trattava probabilmente della cappella privata appartenente alla villa rurale, oggi scomparsa, denominata “Villa Viganoni-Benaglia” dal nome dei proprietari. Tra la !ne del XVIII e l’inizio del XIX secolo la villa è stata residenza estiva dell’illustre famiglia Parravicini, tra i quali Alessandro è indicato come prefetto di Milano nel 1755. Verso il 1800 Antonio Parravicini vi soggiornò con la moglie, la nobildonna Isabella Blasi, ed è a loro che, secondo la tradizione, si deve l’attuale titolazione della chiesa a Sant’Anna. -

Monza E Della Brianza
dal 26 settembre al 4 ottobre 2020 dal 26 settembre al 4 ottobre 2020 al 4 ottobre dal 26 settembre L’iniziativa è promossa dalla Provincia di Monza e della Brianza Presidente: Luca Santambrogio Direttore del Settore Risorse e Servizi ai Comuni: Erminia Vittoria Zoppè Responsabile Servizio Attività di marketing territoriale, servizi di rete, cultura e turismo, pari opportunità e Comunicazione istituzionale: Renzo Arienti Hanno collaborato: Alessandro Cavara, Barbara Maiocchi, Ilaria Pirovano, Silvia Temporali, Alex Tonello, Monica Vigilante, Simonetta Zago Progetto Grafico: Tipografia Vigrafica S.R.L. Ufficio Stampa: Spaini & Partners Partecipano i Comuni di: Abbadia Lariana, Agrate Brianza, Alserio, Anzano del Parco, Arcore, Barlassina, Bellano, Bellusco, Bernareggio, Besana Brianza, Biassono, Bollate, Bosisio Parini, Bovisio Masciago, Briosco, Brugherio, Cabiate, Carate Brianza, Caponago, Carnate, Casatenovo, Cassago, Castellanza, Cavenago Brianza, Cernobbio, Cesano Maderno, Cinisello Balsamo, Civate, Cogliate, Concorezzo, Cornate d’Adda, Cremella, Cuggiono, Desio, Erba, Galbiate, Garlate, Giussano, Inverigo, Lainate, La Valletta Brianza, Lecco (fz. Chiuso), Lentate sul Seveso, Limbiate, Lissone, Macherio, Mariano Comense, Meda, Merate, Merone, Missaglia, Montevecchia, Monticello Brianza, Monza, Muggiò, Nova Milanese, Oggiono, Olgiate Molgora, Paderno d’Adda, Ponte Lambro, Pusiano, Robbiate, San Fermo della Battaglia, Seregno, Sirtori, Solaro, Sovico, Sulbiate, Trezzo sull’Adda, Triuggio, Usmate Velate, Valmadrera, Varedo, Varenna, -

Edifici Storici E Destinazione Museale
GAM_Preprint:Villa Reale_25.03.2010 25/03/10 14:12 Pagina 1 Edifici storici e destinazione museale Conservazione degli edifici e delle opere d’arte Progetti per il restauro e l’integrazione di impianti esistenti a cura di Davide Del Curto e Maria Fratelli GAM_Preprint:Villa Reale_25.03.2010 25/03/10 14:12 Pagina 2 Sindaco Letizia Moratti Assessore Massimiliano Finazzer Flory Direttore centrale Massimo Accarisi Direttore di Settore Claudio Salsi Direttore Galleria d’Arte Moderna Sandrino Schiffini Conservatore Maria Fratelli Segreteria Giuseppina Ornaghi, Elisabetta Ciccarelli, Graziella Furuli Stagiste Sara Minotti, Federica Berti Volontari del servizio Civile Nazionale Fabrizio Calletti, Alessio Zipoli, Antonella Pagliarulo, Elena De Cristofaro, Giorgio Calegari, Marco Cavenago POLITECNICO DI MILANO DIPARTIMENTO DI ARCHITETTURA E PIANIFICAZIONE Rettore Giulio Ballio Direttore del dipartimento Patrizia Gabellini Responsabile della ricerca Alberto Grimoldi Laboratorio di analisi e diagnostica del costruito Davide Del Curto, Carlo Manfredi Andrea Luciani, Luca Valisi Copyright: Politecnico di Milano Galleria d’Arte Moderna, Milano Con il patrocinio di Con il contributo di MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI Direzione Generale per i Beni Culturali Culture Identità e Paesaggistici della Lombardia e Autonomie della Lombardia GAM_Preprint:Villa Reale_25.03.2010 25/03/10 14:12 Pagina 3 Indice p. 5 Presentazione Sandrino Schiffini p. 6 Il clima degli edifici e la tutela del patrimonio culturale. Premesse ed itinerari di ricerca Alberto Grimoldi Parte prima p. 11 Villa Reale: da dimora Belgiojoso a Museo d’Arte Moderna Maria Fratelli p. 23 Le manutenzioni agli impianti di riscaldamento della Villa Belgiojoso attraverso la documentazione archivistica Emanuela Villa p. -

Studium Památkové Ochrany Historické Architektury a Příkladů Zapojení Moderní Architektury Do Historických Částí Města
Studium památkové ochrany historické architektury a příkladů zapojení moderní architektury do historických částí města Účastníci: ing. arch. Karel Bíba, ing. arch. Břetislav Cír Termín: 26. – 30.června 2006 Cíl: Lugano, Locarno, Bellinzona - Švýcarsko Účel: Studium památkové ochrany historické architektury a příkladů zapojení moderní architektury do historických částí města Komunikace: němčina, angličtina (bez tlumočníka) Úhrada: MHMP Časový průběh cesty: 25. 6. 06 neděle 18.00 odjezd vlakem z Prahy přes Rakousko do Švýcarska 26. 6. 06 pondělí 17.00 příjezd na hotel v Luganu, ubytování (po sedmihodinovém zpoždění vlaku způsobeném poškozenou trolejí na českém území vlivem bouřky) 27. 6. 06 úterý 9.00 – 19.00 informační centrum radnice Lugano – prohlídka staveb architekta M. Botty 5 Continenti, logements, commerces housing, shops Administrative building Ransila I-Edificio amministrativo Gottardo Bank (Banca del Gottardo) Edificio amministrativo Ransila II Ristrutturazione in Piazza Manzoni Caimato Administrative Building Canopy of the TPL, Bus Terminal Lugano – prohlídka rekonstrukcí městské architektury Civic Palace Congress Palace 28. 6. 06 středa 9.00 – 20.00 Locarno – prohlídka staveb architekta M. Botty Nuovo impianto funivia a Cardada Locarno – prohlídka rekonstrukcí historické architektury Historické centrum města Bellinzona - prohlídka staveb architekta M. Botty Swisscom Building Casa a Daro Bellinzona - prohlídka rekonstrukcí historické architektury Historické centrum města Castello di Montebello Castello di Sasso Corbaro 29. 6. 06 čtvrtek 9.00 – 15.00 Lugano – prohlídka staveb architekta M. Botty Palazzo Botta (Apartments Building) Lugano – prohlídka rekonstrukcí historické architektury Santa Maria Di Loreto Church San Lorenzo Cathedral Santa Maria Degli Angioli Church San Rocco Church 18.45 odjez vlakem z Lugana Strana 1 z 5 30. 6. -

Herons Round Milan '
cover_INGL 20-02-2008 10:24 Pagina 1 MILAN AND ITS PROVINCE MILAN AND ITS PROVINCE MILAN AND ITS PROVINCE HERONS ROUND MILAN ‘ This guide is part HERONS of a project that the Province of Milan is carrying out with all the main local ‘ actors in order ROUND to boost tourism in the Abbiategrasso- MILAN Magenta area. A TOURIST GUIDEBOOK A TOURIST GUIDEBOOK Abbiategrasso, Magenta, Canals and Parks cover_INGL 20-02-2008 10:24 Pagina 2 ABBIATEGRASSO MAGENTA AREA Highways Main roads Important roads Parco Lombardo della Valle del Ticino Parco Agricolo Sud Milano Places mentioned in the guidebook MILAN AND ITS PROVINCE HERONS‘ ROUND MILAN A TOURIST GUIDEBOOK Abbiategrasso, Magenta, Canals and Parks DIREZIONE CENTRALE TURISMO E AGRICOLTURA Viale Piceno 60 20129 Milano [email protected] Director of the Tourism Text by and Agricolture Department Roberto Peretta Pia Benci Art Director Tourism Department Barbara Vitale Monica Giudici Andrea Vitale Anna Zetti Editing and Layout Digital Art sas Thanks to Via Rimini, 24 - 20144 Milano Paolo Ambrosoni, Rossana Arioli, e-mail: [email protected] Maurizio Bianchi, Tiziano Binfarè, Franco Del Grandi, Raffaele Forni, Photo credits Maurizio Bianchi Piero Gabelli, Giovanna Gualeni, Toni Nicolini Vittorio Malvezzi, Alberto Marini, Massimo Pizzigoni Silva Martinis, Alessandro Mola, Romano Vitale Simone Moroni, Roberta Nencini, Archivio Digital Art Gianni Oggioni, Dario Oliverio, Daniela Paci, Giovanni Pioltini, Maps Elisabetta Porro, Fabrizio Scelsi, LS International Margherita Scirpa, Danilo Taglietti, Illustrations Giuseppe Zanoni … Adelchi Galloni Our thanks also go to all those who have been collaborating English Version with us for months Studio Associato ScriptoriA to reach this goal. -

Dall'ideale Classico Al Novecento Scritti Per Fernando Mazzocca
Dall’ideale classico al Novecento Dall’ideale classico Dall’ideale classico al Novecento Scritti per al Novecento Fernando Mazzocca Scritti per Fernando Mazzocca Il volume raccoglie, in occasione dei settant’anni di Fernando Mazzocca, Fernando Mazzocca Scritti per 35 studi che amici e allievi hanno voluto dedicargli. I saggi, diversi per cronologia e ambiti, si rivelano in sintonia con le quarantennali ricerche del grande studioso, dedicate alle arti, alla critica e al collezionismo tra Settecento e Novecento. I contributi restituiscono importanti novità fi lologiche e decisive revisioni di storia della critica d’arte. Toccano, tra gli altri, protagonisti come Batoni, Canova, Appiani, Sommariva, Hayez, Leopardi, Pellizza da Volpedo, Sartorio. Il libro è completato dall’elenco ragionato degli scritti di Mazzocca. € 25,00 9 788836 641901 www.silvanaeditorale.it mazzocca cop 18 mm.indd 1 12/10/18 14:29 Scritti per Fernando Mazzocca 001-192 Mazzocca BN CIANO.indd 1 11/10/18 09:33 Con il contributo di Marco Fabio Apolloni Federico Bano Ezio e Nadia Benappi Gianfranco Brunelli Fabbio Copercini e Andreino Giuseppin Alessandra Di Castro Gallerie d’Italia, Intesa Sanpaolo Diego Gomiero Maurizio Nobile Carlo Orsi Filippo Orsini Duccio Pallesi Carlo Virgilio Marco Voena 001-192 Mazzocca BN CIANO.indd 2 11/10/18 17:50 Dall’ideale classico al Novecento Scritti per Fernando Mazzocca a cura di Stefano Grandesso e Francesco Leone 001-192 Mazzocca BN CIANO.indd 3 11/10/18 17:51 Premessa In nome della riconoscenza per il nostro maestro e dell’aff etto che ci lega a lui da più di vent’anni, abbiamo pensato, insieme ad alcuni amici, di rendere omaggio alla vita di studioso di Fernando Mazzocca con una raccolta di studi, pubblicata per l’occasione del suo settantesimo compleanno. -

Le Chiese Di Milano
Edizioni presenti nella Biblioteca Centrale/ www.comune.milano.it/sbm CONTRIBUTO A UNA BIBLIOGRAFIA DELLE CHIESE DI MILANO Il grande patrimonio storico e artistico costituito dalle chiese di Milano racchiude gran parte della memoria di una città che forse come nessun’altra in Italia si è esposta alle trasformazioni della modernità. Per questo ci è parso importante che nell’elenco di chiese, oggetto della ricerca, comparissero anche i numerosi edifici scomparsi, al fine di realizzare uno strumento bibliografico che aiuti a mantenere vivo un passato che ha formato e in parte ancora forma l’identità cittadina. Sulle chiese di Milano esiste una bibliografia ragguardevole, ma spesso difficile da individuare, dispersa com’è fra opere di carattere più generale oppure in riviste e bollettini storici dove la trattazione assume un taglio specialistico, spesso meglio rispondente tuttavia, rispetto a opere monografiche o divulgative, alle ricerche. La bibliografia è costituita essenzialmente dalla collazione dei dati raccolti soprattutto a partire dal contributo di: M. POGLIANI, Contributo per una bibliografia delle Fondazioni religiose di Milano , “Ricerche storiche sulla Chiesa ambrosiana”, XV (1985), 157-281, del quale abbiamo mantenuto la struttura; Le chiese di Milano , a cura di Maria Teresa Fiorio, Milano, Electa, Credito artigiano, 1985, Dizionario della Chiesa ambrosiana , direzione dell'opera Angelo Majo, Milano, 1987-1993 6 v; V. FORCELLA, Iscrizioni delle chiese e degli altri edifici di Milano dal secolo 8. ai giorni nostri raccolte da Vincenzo Forcella per cura della Società storica lombarda ,. Milano, Tip. Bortolotti, 1889-1893 12 v.;.; Storia di Milano , Milano, Fondazione Treccani degli Alfieri per la storia di Milano, Istituto della Enciclopedia italiana, 1953-1966, 17 v.; con aggiornamento di notizie tratte prevalentemente da riviste storiche e repertori bibliografici (es. -

A Province to Be Explored a Province
Monza Coperta Ita.qxp:Layout 1 20-05-2009 17:07 Pagina 1 MONZA AND ITS PROVINCE MONZA AND ITS PROVINCE MONZA AND ITS PROVINCE A PROVINCE TO BE EXPLORED A PROVINCE Four itineraries explore architecture, nature, stately homes and gardens scattered across TO BE EXPLORED the 55 towns and cities in the new Province of Monza & Brianza. A journey through The art, nature and culture the history and traditions that have marked the roots and identity of an area at the centre of one of of Brianza Europe’s most highly industrialised zones. Monza Coperta Ita.qxp:Layout 1 20-05-2009 17:07 Pagina 2 Monza 001-035:Layout 1 20-05-2009 17:34 Pagina 1 MONZA AND ITS PROVINCE A PROVINCE TO BE EXPLORED The art, nature and culture of Brianza Andrea Spiriti – Laura Facchin Monza 001-035:Layout 1 25/05/09 14:26 Pagina 2 F DIREZIONE CENTRALE HEAD OFFICE TURISMO E AGRICOLTURA MONZA AND BRIANZA PROJECT Viale Piceno 60 Piazza Diaz 1 20052 Monza P 20129 Milano ot www.visitamilano.it www.provincia.milano.it/monzabrianza [email protected] Ita General Director - Monza and Brianza Pr oject in General Director Giuseppe Valtorta pr Tourism and Agriculture Pia Benci Project director – society and culture a Monza and Brianza pe Tourism Erminia Zoppè Monica Giudici pl Roberto Barelli Cultural and visitor events promotion tin Colette Perna for Monza and Brianza vi Anna Zetti Gianpiero Bocca Elena Gomiero is Carmen La Malfa ve Press Office Giulia Prada Giuseppe Baselice Alex Tonello za Communication and Press Office tio Marta Caratti co za Texts Andrea Spiriti ve Laura -

Contributo a Una Bibliografia Dei Palazzi Privati Di Milano Dal Xiv Secolo All’Età Neoclassica
Edizioni presenti nella Biblioteca Centrale/ www.comune.milano.it/sbm CONTRIBUTO A UNA BIBLIOGRAFIA DEI PALAZZI PRIVATI DI MILANO DAL XIV SECOLO ALL’ETÀ NEOCLASSICA Il contributo consta di due sezioni: una bibliografia generale e una bibliografia relativa ai singoli palazzi. Si è preferito disporre la bibliografia generale in ordine alfabetico, invece che secondo il più usuale ordinamento cronologico, per facilitare la ricerca delle fonti per autore. L'ordinamento cronologico è stato invece mantenuto all'interno delle schede bibliografiche concernenti i singoli palazzi. Il riferimento geografico della ricerca è all’intera area dell’attuale comune di Milano. Per quel che concerne gli edifici all’interno della cerchia delle mura spagnole si è rispettata l’antica suddivisione amministrativa in sestieri, corrispondenti alle sei porte munite. All’interno di ognuno dei sestieri, i singoli palazzi sono riportati secondo un ordine “di prossimità”, seguendo un itinerario ideale. Per quel che riguarda invece l’area extra muraria è stata ripresa la suddivisione, dove possibile, secondo gli antichi borghi ordinati alfabeticamente. I contributi che, per l'ampiezza della trattazione o per l'importanza delle notizie riportate, costituiscono la base di riferimento per le ricerche sono riportati in extenso nelle singole schede bibliografiche dei palazzi. Le opere che invece non hanno come argomento monografico l’edificio stesso, sono citate sommariamente col cognome dell’autore principale e la data di edizione, rimandando alla bibliografia generale, dove è stata anche contrassegnata da una lettera s in grassetto la presenza del titolo nelle raccolte della Biblioteca comunale centrale. L’indicazione dei fondi archivistici, riportata nelle schede bibliografiche dei singoli palazzi, deriva da altre bibliografie e non ha pertanto alcuna pretesa di completezza. -

00 Mediterr Saggi
A COLLECTION OF CULTURAL EXCELLENCE A COLLECTION OF CULTURAL EXCELLENCE The Artistic Heritage of the Fondazione Cariplo edited by Giovanna Ginex Domenico Sedini Cover First published in Italy in 2009 Angelo Morbelli, Battello by Skira Editore S.p.A. sul Lago Maggiore, 1915, detail Palazzo Casati Stampa via Torino 61 Art Director 20123 Milano Marcello Francone Italy www.skira.net Design Luigi Fiore © 2014 Fondazione Cariplo © 2014 Skira editore, Milano Editing © Filippo De Pisis, Mario Sironi by SIAE Maria Conconi 2014 Elisabet Lovagnini All rights reserved under international Layout copyright conventions. Paola Pellegatta No part of this book may be reproduced Translations or utilized in any form or by any means, Emily Ligniti electronic or mechanical, including Alta Price photocopying, recording, or any information storage and retrieval system, Photographs without permission in writing from the Fondazione Cariplo Archives, Milan publisher. Mauro Ranzani Sandro Roberto Scarioni Printed and bound in Italy. Second edition In order to enhance its own art collection—which is educational activities aimed at schools (ArtL@b composed of 767 paintings, 116 sculptures, 51 objects learning project). and furnishings, in addition to the historical palazzos The communicative means adopted are diverse and Melzi d’Eril and Confalonieri—the Fondazione Cariplo complementary, with the goal of helping to bring a has elaborated an entire program of cultural proposals, vaster audience closer to the world of art, to raise better known as the Artgate project. sensibility and awareness on our shared cultural This publication, in its revised edition, is part of a heritage, to activate secondary initiatives such as program aimed at spreading culture.