Università Di Pisa Facoltà Di Scienze Politiche
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
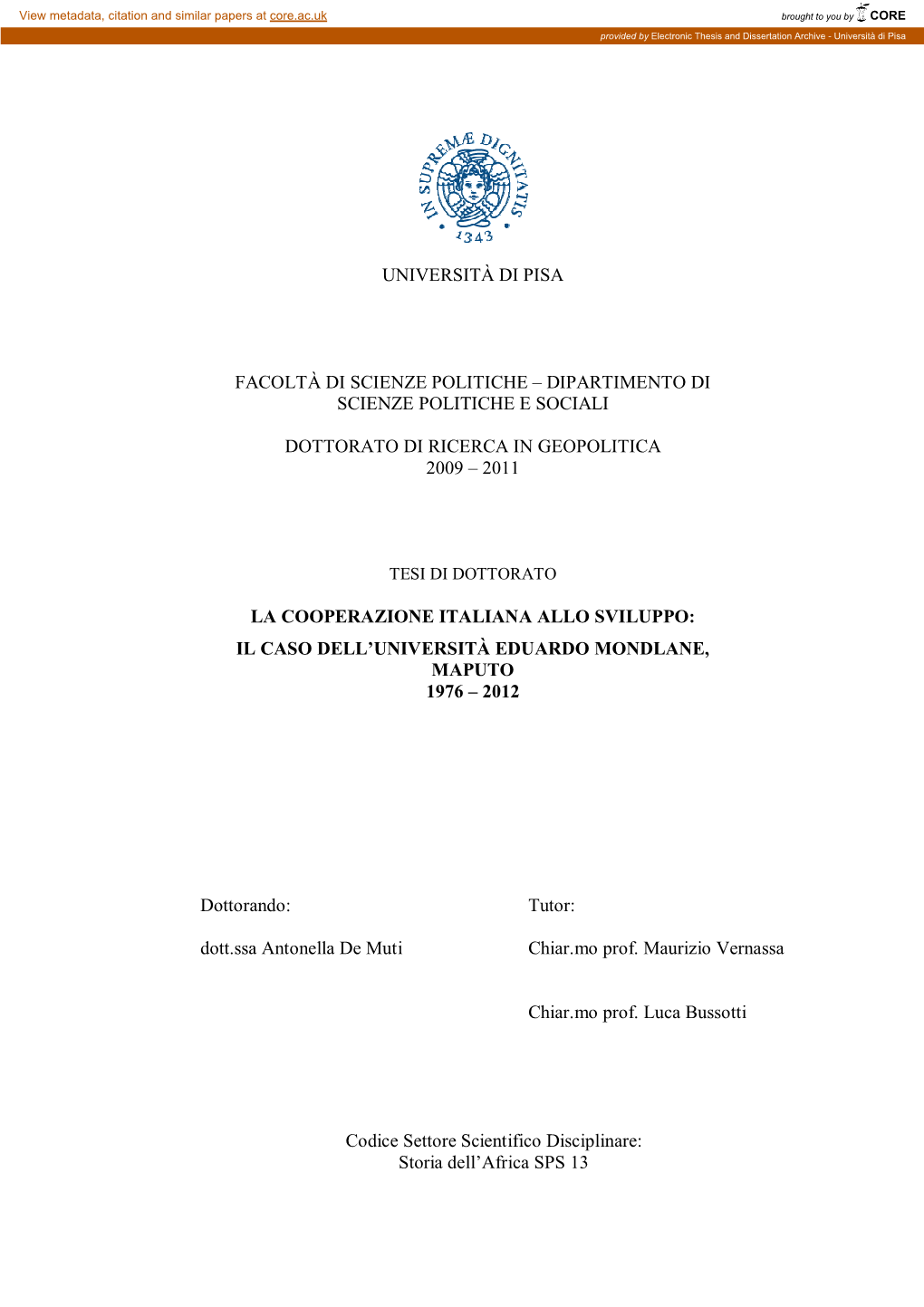
Load more
Recommended publications
-

LA FIGURA DI GIUSEPPE SONCINI TRA AZIONI ANTICOLONIALI E AIUTI SANITARI Tracce Attuali Della ‘Stagione Della Solidarietà’ Per Una Rielaborazione Memoriale
View metadata, citation and similar papers at core.ac.uk brought to you by CORE provided by AIR Universita degli studi di Milano Lingue e Linguaggi Lingue Linguaggi 32 (2019), 361-385 ISSN 2239-0367, e-ISSN 2239-0359 DOI 10.1285/i22390359v32p361 http://siba-ese.unisalento.it, © 2019 Università del Salento This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 LA FIGURA DI GIUSEPPE SONCINI TRA AZIONI ANTICOLONIALI E AIUTI SANITARI Tracce attuali della ‘stagione della solidarietà’ per una rielaborazione memoriale ELISA ALBERANI UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO Abstract – The Soncini-Ganapini archive’s analysis, gives the opportunity to understand the link between the city of Reggio Emilia and the African national liberation movements, in particular Mozambicans. The analysis proposed focuses on the figure of Giuseppe Soncini, who was able to create a network of contacts and friendships, which led to the birth of health, social and political projects. The archival study is centered on the numerous letters and personal communications between Giuseppe Soncini and the representatives of FRELIMO, in particular Marcelino dos Santos, Samora Machel and Oscar Monteiro, to try to understand how the city of Reggio Emilia becomes a point of reference and support for FRELIMO. The period taken into consideration goes from the beginning of the first exchanges of letters in the 1960s, to the period just after the National Solidarity Conference (held in Reggio Emilia in 1973), in particular until the independence of Mozambique. Furthermore, it was decided to question the presence of traces of that story dating back to almost fifty years ago, therefore set in our contemporaneity, in order to try and understand what remains today of that historical period called “the great season of international solidarity”. -

Italy and Mozambique: Science, Economy & Society Within a History
Advances in Historical Studies 2013. Vol.2, No.4, 185-193 Published Online December 2013 in SciRes (http://www.scirp.org/journal/ahs) http://dx.doi.org/10.4236/ahs.2013.24023 Italy and Mozambique: Science, Economy & Society within a History of an Anomalous Cooperation Luca Bussotti1, Antonella De Muti2 1Centro de Estudos Internacionais ISCTE-IUL, Lisbon, Portugal 2Federal University of Minas Gerais, Belo Horizonte, Brazil Email: [email protected], [email protected] Received November 18th, 2013; revised December 19th, 2013; accepted December 26th, 2013 Copyright © 2013 Luca Bussotti, Antonella De Muti. This is an open access article distributed under the Crea- tive Commons Attribution License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any me- dium, provided the original work is properly cited. In accordance of the Creative Commons Attribution License all Copyrights © 2013 are reserved for SCIRP and the owner of the intellectual property Luca Bussotti, An- tonella De Muti. All Copyright © 2013 are guarded by law and by SCIRP as a guardian. In this article the authors aim at showing how an “anomalous” international and very intense cooperation between Italy and Mozambique was born. In fact, Italy has not a strong colonial tradition, especially in Mozambique, so it seems interesting to try to understand the reason why this former Portuguese colony has become the Italian most important partner in its cooperation activity. This analysis is based on the main hypothesis related to the birth of international bilateral cooperation: they have been seriously considered in order to explain the origin of this strange relationship, but they cannot completely clarify this particular case. -

Mozambique Revolution, No. 52
Mozambique Revolution, No. 52 http://www.aluka.org/action/showMetadata?doi=10.5555/AL.SFF.DOCUMENT.numr197207 Use of the Aluka digital library is subject to Aluka’s Terms and Conditions, available at http://www.aluka.org/page/about/termsConditions.jsp. By using Aluka, you agree that you have read and will abide by the Terms and Conditions. Among other things, the Terms and Conditions provide that the content in the Aluka digital library is only for personal, non-commercial use by authorized users of Aluka in connection with research, scholarship, and education. The content in the Aluka digital library is subject to copyright, with the exception of certain governmental works and very old materials that may be in the public domain under applicable law. Permission must be sought from Aluka and/or the applicable copyright holder in connection with any duplication or distribution of these materials where required by applicable law. Aluka is a not-for-profit initiative dedicated to creating and preserving a digital archive of materials about and from the developing world. For more information about Aluka, please see http://www.aluka.org Mozambique Revolution, No. 52 Alternative title Mozambique RevolutionMozambican Revolution Author/Creator Mozambique Liberation Front - FRELIMO Contributor Department of Information [FRELIMO] Publisher Mozambique Liberation Front - FRELIMO Date 1972-09 Resource type Magazines (Periodicals) Language English Subject Coverage (spatial) Mozambique Coverage (temporal) 1972 Source Northwestern University Library, L967.905 M939 Rights By kind permission of the Mozambique Liberation Front (FRELIMO). Description New front in Manica e Sofala. FRELIMO at the conference of east and central African states. -

Scomparsa Di Marcelino Dos Santos
Ufficio Stampa Piazza Prampolini, 1 – 42121 Reggio Emilia tel. (+39) 0522 456390-456840 fax. (+39) 0522 456677 [email protected] Reggio Emilia, mercoledì 12 febbraio 2020 Cordoglio del sindaco Luca Vecchi per la scomparsa di Marcelino Dos Santos, leader dell’indipendenza del Mozambico e dei popoli dell’Africa australe A Reggio in varie occasioni, fu amico di Renzo Bonazzi e Giuseppe Soncini E' scomparso ieri, 11 febbraio, all’età di 92 anni, Marcelino Dos Santos, uno dei più importanti leader della lotta per l'indipendenza dei popoli africani e leader - insieme a Amilcar Cabral, Eduardo Mondlane, Agostinho Neto, Kenneth Kaunda, Oliver Tambo, Samora Machel e Nelson Mandela - della liberazione dei popoli dell'Africa Autrale. Figura chiave per le relazioni di Reggio Emilia con il Mozambico, insieme a Oscar Monteiro, Dos Santos fu, esattamente 50 anni fa, il primo rappresentante del Mozambico a entrare in Sala del Tricolore e iniziare la storia di cooperazione che continua anche oggi. “Marceliono Dos Santos – afferma il sindaco di Reggio Emilia, Luca vecchi - è stato una personalità fondamentale, insieme a Renzo Bonazzi e Giuseppe Soncini, nel gettare le basi di un'amicizia che continua e che oggi vede Reggio Emilia protagonista riconosciuta a livello europeo e nazionale della cooperazione con il Mozambico. Nelle prossime settimane avvieremo uno dei più grandi progetti finanziati dall’Europa con la città di Pemba. Ci lascia uno dei grandi protagonisti della storia africana del Novecento, che la nostra città ha potuto accogliere in diverse e importanti occasioni di incontro, dialogo e cooperazione”. Il rapporto tra Marcelino Dos Santos e Reggio Emilia avviene nel 1963, a Varsavia, dove l’allora sindaco di Reggio Emilia, Renzo Bonazzi, incontra il leader africano, con il quale intrattiene, nel corso degli anni Sessanta una corrispondenza. -
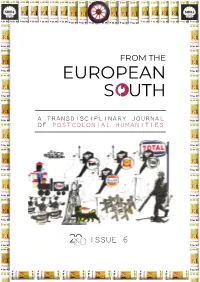
European S Uth
FROM THE EUROPEAN S UTH A TRANSDISCIPLINARY JOURNAL OF POSTCOLONIAL HUMANITIES 2020 ISSUE 6 europeansouth.postcolonialitalia.it a scientific publication of the postcolonialitalia project DiSLL University of Padua, Italy ISSN 2531-4130 2020 | issue 6 Editor-in-Chief: Annalisa Oboe Deputy Editor: Anna Scacchi Editorial board: Shaul Bassi, Roberto Beneduce, Elisa Bordin, Adone Brandalise, Gianpaolo Chiriacò, Roberto Derobertis, Gaia Giuliani, Françoise Kral, Marilena Parlati, Tatiana Petrovich Njegosh, Farah Polato, Tania Rossetto, Davide Zoletto International advisory board: Iain Chambers, Carli Coetzee, Jean Comaroff, Ashley Dawson, Federico Faloppa, Nigel Gibson, Achille Mbembe, Sandro Mezzadra, Claudio Minca, Boaventura de Sousa Santos, Neelam Srivastava, Joseph Tonda, Janet Wilson From the European South DiSLL Università degli Studi di Padova Via E. Vendramini, 13 35137 Padova Italy [email protected] From the European South provides open access to all of its contents to make research and current intellectual and scientific debate freely available. No publication/submission/waiver policy charges are applied. This journal is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License. Citations of the author’s work must be accompanied by reference to the author and to the journal as source (year, issue, and page). Marco Rinaldi Francesca Gallo Francesca De Rosa Marta Nezzo Paola Valenti Simona Morrone Aurora Roscini Vitali Mauro Folci Maria Thereza Alves Alessandra Ferrini Antonio Perticara Sapienza Università di Roma In ambito internazionale l’approccio postcoloniale nelle arti visive è in agenda fin dagli anni Novanta, grazie soprattutto ad artiste/i di origine africana e afroamericana che hanno ottenuto riconoscimenti e visibilità sulla scena globale, mentre artiste/i di origine (o con base) italiana nel medesimo frangente hanno privilegiato una delle ricadute storiche più evidenti del colonia- lismo, ovvero il fenomeno migratorio. -
Padre Michael Lapsley, Vittima Dell'apartheid in Sudafrica E Amico
Ufficio Stampa Piazza Prampolini, 1 – 42121 Reggio Emilia tel. (+39) 0522 456390-456840 fax. (+39) 0522 456677 [email protected] Lunedì 23 gennaio 2012 Padre Michael Lapsley, vittima dell’apartheid in Sudafrica e amico di Nelson Mandela, sarà a Reggio Emilia domani e mercoledì In programma anche un incontro con gli studenti su ‘Memoria, guarigione, riconciliazione, perdono’ Nelson Mandela, premio Nobel per la pace e primo presidente del Sudafrica dopo l’apartheid, ha detto di padre Michael Lapsley: La sua vita rappresenta una metafora convincente su come un cittadino straniero che è venuto nel nostro paese ha contribuito a trasformarlo. La sua vita è parte integrante della vita e delle lotte del nostro popolo. E proprio padre Lapsley sarà ospite per la prima volta del nostro Paese, in un viaggio che inizierà a Reggio Emilia domani, martedì 24, e mercoledì 25 gennaio, e che proseguirà a Firenze e a Roma. L’iniziativa, condotta dal Tavolo di coordinamento Reggio Africa, è promossa dal Comune capoluogo in collaborazione con l’Ambasciata del Sudafrica in Italia e vedrà padre Michael Lapsley partecipare ad un nutrito programma di appuntamenti: domani, alle ore 16, nella sala dell’Archivio Reggio Africa (presso la sede di Istoreco in via Dante Alighieri 11), incontrerà i componenti del Tavolo di coordinamento per condividere, attraverso la ricca raccolta di documentazione, la storia delle relazioni tra la nostra città e il Sudafrica e per valutare nuove opportunità di cooperazione. Mercoledì, alle ore 9.30, al cinema AlCorso (corso Garibaldi 14), terrà una conferenza per gli studenti delle scuole superiori sul tema Memoria, guarigione, riconciliazione, perdono, e nel pomeriggio visiterà il Centro internazionale per l’infanzia ‘Loris Malaguzzi’. -

The Presidency Annual Report 2013/2014
THE PRESIDENCY ANNUAL REPORT 2013 / 2014 THE PRESIDENCY ANNUAL REPORT 2013/2014 SUBMISSION OF THE ANNUAL REPORT TO THE EXECUTIVE AUTHORITY To the President of the Republic of South Africa, Mr Jacob Zuma, I have the honour of submitting to you, in term of Section 40 of the Public Finance Management Act (PFMA), (Act 1 of 1999), the annual report of The Presidency for the period 1 April 2013 to 31 March 2014. R Cassius Lubisi, PhD Director-General and Secretary to Cabinet i THE PRESIDENCY ANNUAL REPORT 2013/2014 2 THE PRESIDENCY ANNUAL REPORT 2013/2014 TABLE OF CONTENTS PART A: GENERAL INFORMATION 6 Foreword by The Minister 6 Report of The Accounting Officer 10 Statement of responsibility and confirmation of accuracy for the annual report. 12 Strategic overview 13 Legislative and other mandates 13 Organisational structure 16 Entities and departments reporting to the former ministers in The Presidency: 18 PART B: GOVERNMENT PROGRAMME OF ACTION: THE 12 OUTCOMES 21 PART C: PERFORMANCE INFORMATION 27 Auditor-General’s report: pre-determined objectives 27 Strategic outcome-orientated goals 28 Overview of The Presidency’s performance: 28 Performance information by programme 47 Programme 1: Administration 47 1. PROGRAMME 1: ADMINISTRATION 47 1.1. Branch: Private Office of the President 47 1.2. Branch: Office of the Deputy President 57 1.3. Ministry of Performance Monitoring and Evaluation 67 1.4. Branch: Cabinet Office 73 1.5. Branch: Strategy and Operations 81 Programme 2: National Planning 89 1.6. Branch: NPC Secretariat 89 Transfer payments to -

Il Comune Di Reggio Emilia E L'africa, 40 Anni Di Storia
Il Comune di Reggio Emilia e l’Africa, 40 anni di storia Il rapporto tra Reggio Emilia e l’Africa ha origini lontane: il confronto tra la comunità reggiana e quella africana nasce negli anni ’60, prima come solidarietà sanitaria e in seguito come rapporto di cooperazione decentrata che coinvolge gli enti locali e la società civile del territorio in una serie di azioni rivolte ai paesi africani. Negli anni ’70 Reggio ha avuto un ruolo di primo piano a livello internazionale nella promozione dei movimenti di lotta al colonialismo e alla segregazione razziale. Il 24 e 25 marzo del 1973 al teatro Valli si tenne la “Conferenza di solidarietà contro il colonialismo, l’imperialismo e per la libertà e l’indipendenza dell’Angola, della Guinea Bissau e del Mozambico” alla presenza dei maggiori leader africani, compreso il futuro presidente del Mozambico Samora Machel. Grazie all’impegno di Giuseppe Soncini e di tanti cittadini che hanno voluto impegnarsi per i popoli africani, il Comune costituì il “Comitato unitario per l’amicizia, la cooperazione e la solidarietà con i popoli”. Il 2 luglio 1975 l’allora sindaco Renzo Bonazzi firmò il patto di amicizia e di cooperazione culturale con la città di Pemba (Mozambico). Il presidente mozambicano Samora Machel venne in visita ufficiale nella nostra città nel 19891 per ringraziare Reggio per l’impegno profuso nei confronti della comunità mozambicana. La nostra città il 26 giugno 1977 siglò un “patto di solidarietà” con il movimento antiapartheid dell’African National Congress, il movimento di liberazione per la creazione di un Sudafrica unito e democratico fondato da Nelson Mandela, Oliver Tambo e Walter Sisulu. -

Università Di Napoli L'orientale Questo Articolo È Il Tentativo Di
Università di Napoli L’Orientale The following essay aims to be an examination of the dyna- mics of the struggles of liberation from the Portuguese empire, the processes of decolonization and the end of the Estado Novo, through the analysis of the film and visual heritage produced in the international context, specifically the Italian one, more than forty years from the liberation of the Portuguese colonies. In the 1960s and 1970s, unlike many other European and Western countries, Italy showed a growing attention to what was happening in the Portuguese colonies in Africa, developing an intense activity of solidarity with the liberation movements (PAIGC, FRELIMO and MPLA). In an attempt to undertake a more systematic analysis of that experience before it is totally lost, the following work aims to study the audiovisual and photographic productions produced in those years: documentaries, films, photojour- nalism projects realized in Angola, Guinea Bissau, Mozambique. Nelli, Conchiglia, de Stefani, Lucas, Alfredo, Cigarini, Massobrio and Bedei are the most famous in this rich panorama of reporters and filmmakers who supported the liberation movements. postcolonial visual studies, international solidarity movements; anticolonial struggle, cinema ‘guerrilla’, Lusophone Africa Questo articolo è il tentativo di scavare nell’archivio di relazioni che negli anni Sessanta e Settanta ha visto coinvolte le esperienze di lotta per la liberazione delle ex colonie portoghesi in Africa e diverse figure italiane in un proficuo rapporto di sostegno, collaborazione e solida- rietà. Un dialogo che si è articolato negli anni in cui l’internazionalismo metteva in campo la costituzione di fronti comuni con i movimenti anticoloniali non solo politicamente, ma che si declinava anche attraverso relazioni intellettuali, produzioni culturali, audio-visive e fotogra- fiche. -

Oliver Tambo
OLIVER TAMBO 1917 –1993 S E V I H C R A E Y U B I Y A M M U E S U M D N A L S I N E B B O R - C W U : T H G I R Y P O C ABOVE LEFT : Oliver Tambo and Nelson Mandela in their law oDce in the early 1950s. ABOVE RIGHT : Reunited in Sweden in 1990 after 28 years. Oliver Tambo was teacher, political leader, diplomat S and revolutionary. As Deputy President and later M L I F Y T I R Presiden t, he led the African National Congress in A L C F O Y exile for 30 years, while Nelson Mandela and many S E T R U O C others were gaoled in South Africa. / E V I H C R A Under Tambo’s leadership, the ANC’s external mission C C W : T H G grew from a few exiles into an movement with oDces I R Y P O in all the world‘s major capitals. From the mid-1970s C it inspired, and built links with, the mass movement against apartheid inside South Africa. Tambo held the ANC together, seeking consensus, but never afraid to take diDcult decisions. He was a strategic thinker, who endorsed the decision to pursue armed N A M struggle in 1961, and in the 1980s seized the S Å S T A M chance for negotiations with the apartheid regime. : T H G I R Y P O Tambo was respected by world leaders and inspired C hundreds of thousands of people to join the anti- apartheid struggle. -

Sechaba, May 1982
Sechaba, May 1982 Use of the Aluka digital library is subject to Aluka’s Terms and Conditions, available at http://www.aluka.org/page/about/termsConditions.jsp. By using Aluka, you agree that you have read and will abide by the Terms and Conditions. Among other things, the Terms and Conditions provide that the content in the Aluka digital library is only for personal, non-commercial use by authorized users of Aluka in connection with research, scholarship, and education. The content in the Aluka digital library is subject to copyright, with the exception of certain governmental works and very old materials that may be in the public domain under applicable law. Permission must be sought from Aluka and/or the applicable copyright holder in connection with any duplication or distribution of these materials where required by applicable law. Aluka is a not-for-profit initiative dedicated to creating and preserving a digital archive of materials about and from the developing world. For more information about Aluka, please see http://www.aluka.org/. Page 1 of 38 Alternative title Sechaba Author/Creator African National Congress (Lusaka, Zambia) Publisher African National Congress (Lusaka, Zambia) Date 1982-05 Resource type Journals (Periodicals) Language English Subject Coverage (spatial) South Africa Coverage (temporal) 1982 Source Digital Imaging South Africa (DISA) Rights By kind permission of the African National Congress (ANC). Format extent 36 page(s) (length/size) Page 2 of 38 SECHABAMAY 1982official organ of the african national congress south africaFront Line States Presidents with the leaders of ANC and SWAPOat the recent Maputo summitFrom L to R: Nujoma (SWAPO), Dos Santos (ANGOLA), Masire (BOTSWANA),Nyerere (TANZANIA), Mugabe (ZIMBABWE), Kuanda (ZAMBIA), and TAMBO (ANC). -

Download National Orders Booklet 2013.Pdf
Order of Proceedings PRESENTATION OF NATIONAL ORDERS SEFAKO MAKGATHO PRESIDENTIAL GUESTHOUSE PRETORIA 27 APRIL 2013 14:00 – 16:00 1. Nominees for the National Orders and guests take their seats 2. Arrival of the President and Mrs Zuma 3. The National Anthem 4. Word of welcome by the Programme Director 5. Ceremonial oration by the Grand Patron of National Orders 6. Investiture of the National Orders • THE ORDER OF MENDI FOR BRAVERY • THE ORDER OF IKHAMANGA • THE ORDER OF THE BAOBAB • THE ORDER OF LUTHULI • THE ORDER OF MAPUNGUBWE • THE ORDER OF THE COMPANIONS OF OR TAMBO 7. The President, the Chancellor and the recipients of National Orders proceed to the credentials room for a photo opportunity 8. Guests proceed to the marquee on the eastern side of the Presidential Guesthouse Grand Patron of National Orders President Jacob Zuma Chancellor of National Orders Dr Cassius Lubisi The Advisory Council on National Orders Ms M Burton, Mr FG Brownell, Ms S Williams-De Bruyn, Prof B Figaji, Dr J Kani, Mr AM Kathrada, Prof C Landman, Ms R Mompati, Bishop M Mpumlwana, Mr MMTB Msimang, Dr Y Muthien (Chairperson), Lt-Gen G Ramano 2 Preface It is a cause of immense pleasure on this auspicious day to present to you the latest recipients of our National Orders. They will be receiving the following National Orders: the Order of Mendi for Bravery, the Order of the Baobab, the Order of Ikhamanga, the Order of Luthuli, the Order of Mapungubwe and Order of the Companions of OR Tambo. These are extraordinary men and women, from inside and outside our country, some of whom are no longer with us.