Impaginato RM Avignone EXP:Arte
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
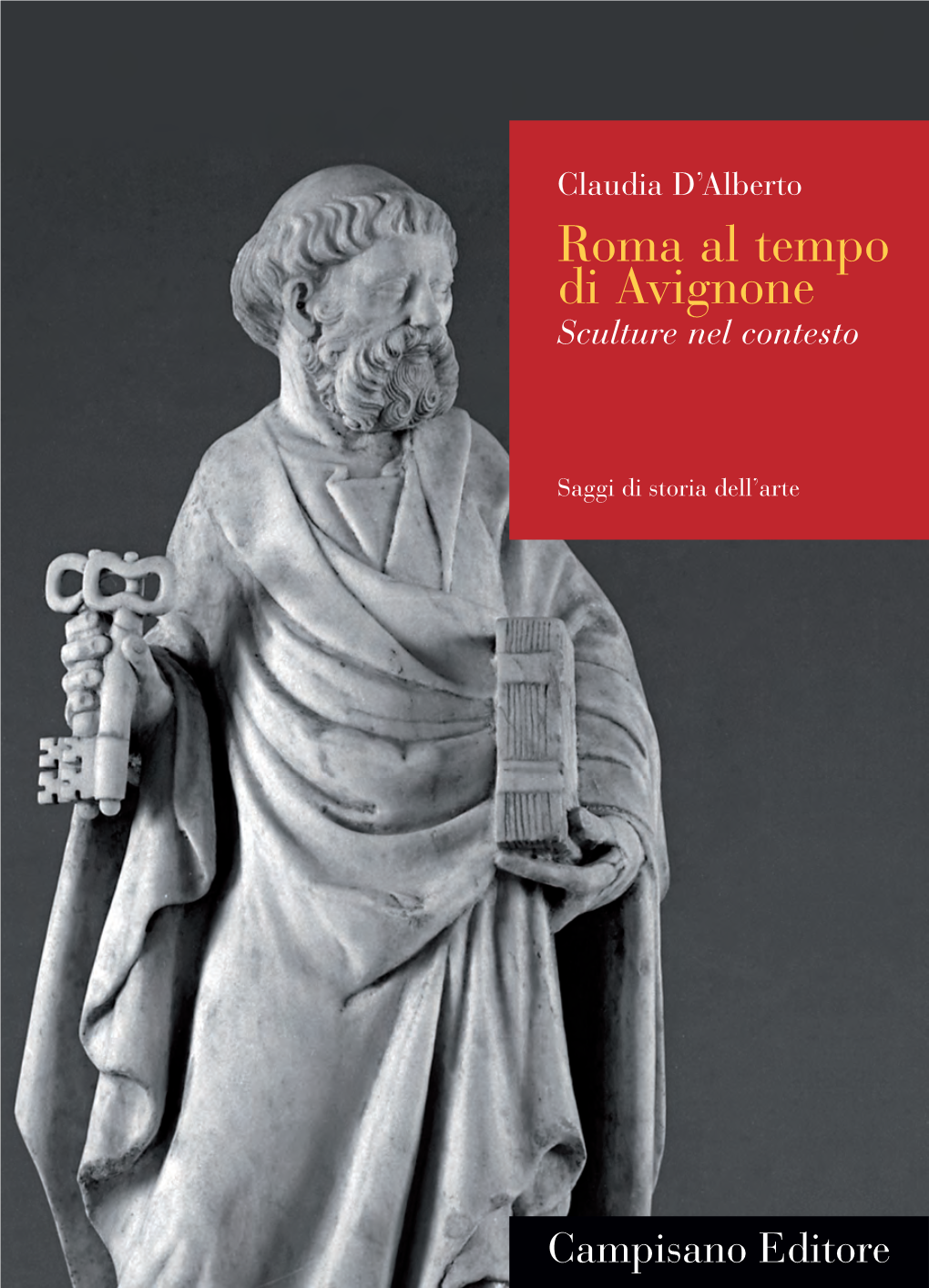
Load more
Recommended publications
-

History of the Franciscan Movement
HISTORY OF THE FRANCISCAN MOVEMENT Volume 2 FROM THE YEAR 1517 TO THE SECOND VATICAN COUNCIL On-line course in Franciscan History at Washington Theological Union Washington DC By Noel Muscat OFM Jerusalem 2008 History of the Franciscan Movement. Volume 2: From 1517 to the Second Vatican Council Chapter 10 NEW REFORMS AND NEW DIVISIONS: THE BIRTH OF THE CAPUCHINS AND REFORMS WITHIN THE OBSERVANCE The friars “of the Holy Gospel” The Order of Friars Minor of the Regular Observance, after the union of all the reformed families in 1517, became a powerful religious family dedicated mainly to apostolic missions. A minority of friars, however, continued to insist upon living a simpler Franciscan life in the hermitages. Besides the Amadeiti and Coletani, there were other congregations which preferred eremitical life, like the Clareni and the friars “of the Holy Gospel” or Capuciati. This last religious family was one which the Bulla Ite vos of Leo X (1517) had not managed to integrate within the Order of the Friars Minor of the Regular Observance. They were born, as we have already seen, with the initiative of Juan de la Puebla, who had made an experience of Franciscan life in the Umbrian hermitages of central Italy, and then had returned to Spain, founding a congregation of friars who lived the literal observance of the Rule in the hermitages. Among his followers there was Juan de Guadalupe, who in 1508 obtained the approval of the Province “of the Holy Gospel”.1 The negative reaction of the Spanish Observants, who persecuted the new religious family, compelled the brothers of the Custody of Estremadura to place themselves under the obedience of the Conventuals in 1515, and thus became to be known by the name of “Reformed Conventuals”.2 They wore a short tunic with a pyramidal hood, and hence also the name Capuciati. -

Edward J. Olszewski Dynamics of Architecture in Late Baroque Rome
Edward J. Olszewski Dynamics of Architecture in Late Baroque Rome. Cardinal Pietro Ottoboni at the Cancelleria Edward J. Olszewski Dynamics of Architecture in Late Baroque Rome. Cardinal Pietro Ottoboni at the Cancelleria Managing Editor: Monika Michałowicz Published by De Gruyter Open Ltd, Warsaw/Berlin Part of Walter de Gruyter GmbH, Berlin/Munich/Boston This work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 license, which means that the text may be used for non-commercial purposes, provided credit is given to the author. For details go to http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/. Copyright © 2015 Edward J. Olszewski ISBN 978-3-11-045245-7 e- ISBN 978-3-11-045246-4 Bibliographic information published by the Deutsche Nationalbibliothek The Deutsche Nationalbibliothek lists this publication in the Deutsche Nationalbibliografie; detailed bibliographic data are available in the Internet at http://dnb.dnb.de. Managing Editor: Monika Michałowicz www.degruyteropen.com Cover illustration: © Gabinetto Nazionale delle Stampe, Rome Contents Preface VIII Abbreviation X 1 Introduction 1 1.1 Origins 1 1.2 Papal Patronage 5 2 Architectural Beginnings 17 2.1 The First Architects 17 2.2 Early Theaters 21 2.3 Ottoboni Holdings 25 2.4 G.F. Pellegrini 31 2.5 Nicola Michetti 33 3 Theater Architecture 36 3.1 Ottoboni Theater & Filippo Juvarra 36 3.2 Juvarra’s Theater Drawings 39 3.3 The Lost Theater 40 3.4 Studies of Juvarra’s Theater Drawings 45 3.5 The Fate of Ottoboni’s Theater 53 3.6 Appearance of the Theater 53 4 Other Cancelleria Spaces 73 4.1 The Sala Riaria 73 4.2 Ludovico Rusconi Sassi 73 4.3 The Arcadian Academy 76 4.4 The Bosco Parrasio 78 4.5 San Lorenzo in Damaso 81 5 Architectural Collaboration 87 5.1 The Lateran Façade Competition 87 6 Fugitive Architecture 92 6.1 The Final Decade 92 6.2 Domenico Gregorini 96 6.3 Ottoboni’s Ephemeral Constructions 101 6.4 Alessandro Mauri 111 6.5 G.B. -
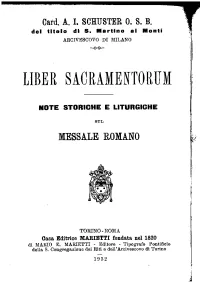
L I B E R S a C R a M E I T O R I
Card. A. I. SCHUSTER 0. S. B. del titolo di S. Martino ai Monti ARCIVESCOVO DI MILANO LIBER SACRAM EITORIIM NOTE STORICHE E LITURGICHE SUL MESSALE ROMANO TORINO-ROMA Gasa Editrice MARIETTI fondata nel 1820 di MARIO E. MARIETTI - Editore - Tipografo Pontificio della S. Congregazione dei Riti e dell’Arcivescovo di Torino 1 9 3 2 Card. A. I. SCHUSTER 0. S. B. del titolo di S. Martino al Monti ARCIVESCOVO DI MILANO LIBER SACBAMESTORUM NOTE STORICHE E LITURGICHE SUL MESSALE ROMANO V ol . V ili. I Santi nBl Mistero della Redenzione (Le Feste dei Santi dall’Ottava dei Principi degli Apostoli alla Dedicazione di S. Michele) (Seconda edizione) TORINO -ROMA Casa Editrice MARIETTI fondata nel 1820 di MARIO E. MARIETTI - Editore - Tipografo della S. Congregazione dei Riti e dell’Arcivescovo di Tori 1932 Imprimi potest. f GREGOEIUS 0. S. B. Abbas Ord. Montìs Casini et Congreg. Cassili. Praeses. Visto: Nulla osta alla stampa. Torino, li 21 Dicembre 1931. Can. A g o s t in o P a s s e e a , Bev. Deleg. Imprimatur. C. FRANCESCO PALE ARI, Provìe. tìen. PROPRIETÀ LETTERARIA (2 5 - 1 1 1 -2 9 ---- 1 0 -1 1 1 -3 2 ). Nel Bai,fisterò dì san Lorenzo. Adsp]ICE • QVI ■ TRANSIS - QVAM -.SIT • BREYIS . AC[oipe vita AtquJE . TVAE . JfAVIS • ITEK . AD ■ LITVS • PARADpsi RellJEGE • QVO ■ VVLTVM . DNI . FAOIAS ■ TIBI • PO[rtmm Percipias graJTIAM ■ QTIS • QVIS • HAEC ■ SACRA • PERH[anris GtlorjlA • SVMMA • DS • LVMEN ■ SAPIENTI A ■ VIR[tn9 Ver]VS ■ IN ■ ALTARI ■ C3VOE • EST - VINYM • QVE ■ [videtirr la] Q ■ TVI - LATERIS . PER - OPVS - MIRAE ■ [pietatia Unde] POTENTER . -

Dottorato Di Ricerca in Storia, Territorio E Patrimonio Culturale Curriculum in Studi Storico-Artistici, Archeologici E Sulla Conservazione
Dottorato di ricerca in Storia, territorio e patrimonio culturale Curriculum in Studi storico-artistici, archeologici e sulla conservazione XXIX ciclo I duchi Caetani tra Sette e Ottocento: cultura artistica, committenze e collezioni (1710-1882) Dottoranda: Ilaria Sferrazza Docente guida: prof.ssa Giovanna Sapori 1 I duchi Caetani tra Sette e Ottocento: cultura artistica, committenze e collezioni (1710-1882) Indice Introduzione………………………………………………………………………………………... 4 1. Michelangelo I (1685-1759), le attività edilizie e i cantieri decorativi nella prima metà del Settecento. …………………………………………………………………………………………………….11 1.1 Cenni biografici. ..…………………………………………………………………………… 11 1.2 La vendita ai Ruspoli del palazzo Caetani (già Rucellai) al Corso. ..……………………….. 13 1.3 I cantieri di Cisterna: il restauro del palazzo baronale e la costruzione della villa. ..………...18 1.4 Il feudo di Fogliano e le sue trasformazioni. ..………………………………………………..31 1.5 L’inventario dei beni di Michelangelo I (1760). Aggiunte e novità. …..…………………….36 2. Francesco V (1738-1810). Vicende storiche e aperture culturali tra due secoli………….... 44 2.1 Cenni biografici e nuove valutazioni. ………………………………………………………..44 2.2 Francesco V e gli artisti al suo servizio. …………………………………………………..…52 2.3 Gli eredi. Le vicende della successione e due figure meno note. ……………………………67 3. La Villa Caetani all’Esquilino. Un’importante impresa Caetani a Roma (1725-1855). …...82 3.1 Fonti iconografiche: la villa nelle piante di Roma. …………………………………………..88 3.2 Dalla vigna Cesi alla villa Nerli. ……………………………………………………………..93 3.3 La villa nei documenti Caetani: restauri, ampliamenti e decorazioni. ……………………….98 3.4 La villa come luogo di svago e di cultura. ………………………………………………….112 3.5 La villa nell’Ottocento. La vendita e la distruzione. ………………………………………..119 4. I Caetani per l’arte e per la cultura nell’Ottocento. -

ROMA Y ESPAÑA Un Crisol De La Cultura Europea En La Edad Moderna
ROMA Y ESPAÑA un crisol de la cultura europea en la edad moderna (Actas del Congreso Internacional celebrado en la Real Academia de España en Roma del 8 al 12 de mayo de 2007) VOLUMEN II Coordinador: Carlos José Hernando Sánchez SOCIEDAD ESTATAL PARA LA ACCIÓN CULTURAL EXTERIOR Madrid, 2007 ÍNDICE VOLUMEN I Presentaciones ........................................................................................................................................................................................... 15 Introducción ............................................................................................................................................................................................... 19 Carlos José Hernando Sánchez PERSPECTIVAS GENERALES ................................................................................................................................................... 43 Roma papale e Monarchia Cattolica nei secoli XVI-XVII ............................................................................... 45 Giuseppe Galasso Roma e la Monarchia Cattolica nell’età dell’egemonia spagnola in Italia: un bilancio storiografico .................................................................................................................................................................. 49 Mª Antonietta Visceglia Italianismo español e Hispanismo italiano ..................................................................................................................... 79 Luis Ribot L’asse Roma-Napoli -

The Catholic Church in the Philippines in One Hundred Years: from the Spanish Colonial Period to the End of the Marcos Dictatorship 1886-1986
THE CATHOLIC CHURCH IN THE PHILIPPINES IN ONE HUNDRED YEARS: FROM THE SPANISH COLONIAL PERIOD TO THE END OF THE MARCOS DICTATORSHIP 1886-1986 ii iii THE CATHOLIC CHURCH IN THE PHILIPPINES IN ONE HUNDRED YEARS: FROM THE SPANISH COLONIAL PERIOD TO THE END OF THE MARCOS DICTATORSHIP 1886-1986 LA IGLESIA CATÓLICA DE FILIPINAS DENTRO DE CIEN AÑOS: DE LA ÉPOCA COLONIAL ESPAÑOLA DE LA DICTADURA DE MARCOS A thesis presented to the Department of Social Science of the College of Arts and Sciences in partial fulfilment of the requirements for the degree of Bachelor of Arts in Political Science Aaron James Ricardo de VELOSO 2008-47231 University of the Philippines, Manila March, 2012 LA IGLESIA CATÓLICA DE FILIPINAS DENTRO DE CIEN AÑOS- DE LA ÉPOCA COLONIAL ESPAÑOLA DE LA DICTADURA DE MARCOS, 1521-1986 (The Catholic Church in the Philippines in One Hundred Years: from the Spanish Colonial Period to the end of the Marcos Dictatorship, 1886-1986) © 2012 by Aaron James R. Veloso. All rights reserved. No part of this undergraduate thesis may be reproduced in any form or by electronic or mechanical means including information storage or retrieval systems without permission in writing from the copyright owner. Nihil Obstat: Imprimatur: R. P. Reginaldus R. Malicdem, Sec. E.mi ac R.mi D. Aloisio Antonio G. Tagle, D.D. Secretarius Archiepiscopus Manilensis Archiepiscopum Metropolitam Manilensem Die XXII mensis FEBRUARII A. D. MMXII Die XIX mensis MARTII A.D. MMXII In Festo Cathedrae Sancti Petri In Solemnitatis Sancti Iosephi, Spons. B.V.M Printed in the Philippines by: Don Bosco Press, Inc.