Bassa Friulana
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Unione Territoriale Intercomunale
UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE RIVIERA BASSA FRIULANA – RIVIERE BASSE FURLANE Determinazione nr. 56 Del 16/07/2019 CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA OGGETTO: COMUNE DI LIGNANO SABBIADORO - PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DEGLI ARTT. 63 E 36, COMMA 2, LETTERA C-BIS) SOTTO SOGLIA DEL D.LGS 50/2016 E S.M.I. PER L'APPALTO DEI LAVORI "ASTER RIVIERA TURISTICA FRIULANA RETE DELLE CICLOVIE DI INTERESSE REGIONALE IV STRALCIO IN COMUNI DI LATISANA E RONCHIS" – APPROVAZIONE ATTI DI GARA E AVVIO DEL PROCEDIMENTO – CUP: H41B09000630002 – CIG: 79710541DA IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO VISTI: - la L.R. 28/12/2018 n. 31 “Modifiche alla L.R. 12/12/2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione - Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni Territoriali Intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative), alla L.R. 17/07/2015, n.18 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle Leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali), e alla L.R. 31/03/2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale)”; - lo Statuto dell’U.T.I., approvato con deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci n. 4 del 5/03/2018; - la deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci n. 8 dd 19 marzo 2018 con la quale è stato eletto il Presidente dell’Unione; - il decreto del Presidente n. 1 dd 11 gennaio 2019 recante nomina del Dott. Nicola Gambino a Direttore generale ad interim dell’U.T.I. Riviera Bassa Friulana; RICHIAMATI: - la deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci n. -

Carta Dei Servizi
Questo documento è scritto in versione facile da leggere e da capire CARTA DEI SERVIZI dell’Azienda per l’Assistenza Sanitaria 2 Bassa Friulana, Isontina GUIDA AI SERVIZI PER LA SALUTE Azienda per l’Assistenza Sanitaria 2 Bassa Friulana, Isontina INDICE CAPITOLI PAGINE Presentazione 3 L'organizzazione aziendale 10 Dipartimento Assistenza Ospedaliera 12 (Gli ospedali) Dipartimento Assistenza Primaria 36 (Tutti i vari tipi di assistenza) Medici di Medicina Generale e Pediatri di Libera Scelta 55 (I medici di famiglia ed i pediatri) Servizio di continuità assistenziale 56 (La Guardia Medica) Dipartimento di Salute Mentale 60 (La cura delle malattie della mente) Dipartimento Prevenzione 63 (Vaccinazioni, medicina del lavoro, cura degli animali) Impegni, programmi e indicatori di qualità 66 (Per migliorare la qualità dei servizi) Meccanismi di tutela e partecipazione dei cittadini 68 (La protezione dei diritti dei cittadini) L'emergenza-urgenza 82 (Il Soccorso Sanitario – 112) Accesso alle prestazioni 85 (Come prendere appuntamenti per le visite mediche) Glossario 88 (La raccolta di parole difficili e la loro spiegazione) 1 Attenzione: Quando una parola è colorata d’azzurro vuol dire che il suo significato è spiegato nel Glossario. Il Glossario è una raccolta di parole difficili con la loro spiegazione e si trova alla fine di questo libretto. 2 Presentazione L’ Azienda per l’Assistenza Sanitaria 2 Bassa Friulana – Isontina (AAS2) si occupa dei servizi per la salute. Questa azienda è nata il 1° gennaio 2015. Nell’Azienda per l’Assistenza Sanitaria 2 Bassa Friulana – Isontina c’è una persona importante che la dirige: il Direttore Generale. Lui ha altre tre persone importanti che lo aiutano: · Il Direttore Sanitario · Il Direttore Amministrativo · Il Direttore dei Servizi Sociosanitari 3 Contatti: Dove si trova la sede legale, cioè la sede centrale con gli uffici? Indirizzo: Gorizia, via Vittorio Veneto n. -

Carta Intestata
ALLEGATO ALLA DELIBERA N. 1109 DEL 17 GIUGNO 2016 Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia Azienda per l’Assistenza Sanitaria n. 2 "Bassa Friulana-Isontina" Via Vittorio Veneto, 174 – 34170 Gorizia PEC: [email protected] Cod. Fisc.: 01162270316 - Part. I.V.A.: 01162270316 AREA WELFARE ASS2 BASSA FRIULANA- ISONTINA Prot. XX del XX.XX.XX CONVENZIONE concernente il supporto di Area Welfare di Comunità dell’Azienda per i Servizi Sanitari n° 2 “Bassa Friulana” nelle attività di programmazione, progettazione e gestione degli interventi in ambito culturale, dello sport e della solidarietà In Trieste, l’anno duemilasedici (2016), il giorno xx (____)del mese di xxxx (_____), presso la sede della Direzione centrale cultura, sport e solidarietà della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, in via Milano, n. 19 INTERVENGONO 1) REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA con sede legale in Trieste, Piazza dell’Unità d’Italia n. 1, codice fiscale 80014930327, di seguito denominata per brevità “Regione”, rappresentata dalla dott.ssa Anna Del Bianco, nata a Gorizia (GO) il 12.10.1968, domiciliata per la carica in Trieste in via Milano, n. 19, nella sua qualità di Direttore centrale della Direzione centrale cultura, sport e solidarietà della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia; 2) AZIENDA PER L’ASSISTENZA SANITARIA BASSA FRIULANA ISONTINA – AREA WELFARE DI COMUNITA’ con sede legale in Gorizia (GO) via Vittorio Veneto 174, codice fiscale 01162270316, rappresentata dal dott. Giovanni Pilati, nato a Bologna il 18.0.1954, domiciliato per la carica in Gorizia (GO) , via Vittorio Veneto 174 nella sua qualità di Direttore Generale dell’Azienda per l’Assistenza sanitaria n. -

La Rete Bibliotecaria Del Friuli Venezia Giulia
La rete bibliotecaria del Friuli Venezia Giulia Al fine di garantire a tutti i cittadini un adeguato servizio bibliotecario, La Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, in attuazione dei principi stabiliti dagli articoli 9 e 117 della Costituzione e dallo Statuto speciale di autonomia, valorizza i patrimoni delle biblioteche appartenenti a enti pubblici o a soggetti privati aperte al pubblico e promuove lo sviluppo di una rete bibliotecaria regionale aperta alla cooperazione nazionale e internazionale. La rete bibliotecaria del Friuli Venezia Giulia è formata, ai sensi della L. R. 23/2015, da sistemi e dalle biblioteche di interesse regionale. I sistemi bibliotecari realizzano servizi coordinati basati sull’ottimizzazione delle risorse economiche, su politiche di acquisto comuni o coordinate, sulla condivisione di strumenti e di risorse umane, sull’armonizzazione e sulla promozione delle attività di valorizzazione del patrimonio librario e documentale. La Regione riconosce e sostiene le biblioteche d’interesse regionale, quali quelle di conservazione, quelle specializzate e quelle che svolgono un servizio di particolare interesse regionale. In applicazione della normativa vigente prima della citata L. R 23/2015 (ossia in applicazione della L. R. 25/2006 e del Regolamento emanato con DPReg. 30 settembre 2008, n.262/Pres.) erano stati riconosciuti i 14 sistemi bibliotecari e le 12 biblioteche di interesse regionale di cui al seguente elenco.. Attualmente il processo avviato in base alla nuova normativa prevede la creazione di nuovi sistemi bibliotecari e la revisione di tutte le biblioteche di interesse regionale, comprese quelle che erano già state riconosciute in passato, e che hanno perduto tale qualifica a seguito della abrogazione della L. -
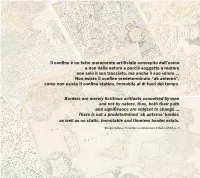
Il Confine È Un Fatto Meramente Artificiale Concepito Dall'uomo E Non Dalla Natura E Perciò Soggetto a Mutare Non Solo Il Su
Il confine è un fatto meramente artificiale concepito dall’uomo e non dalla natura e perciò soggetto a mutare non solo il suo tracciato, ma anche il suo valore … Non esiste il confine predeterminato “ab aeterno”, come non esiste il confine statico, immobile al di fuori del tempo. Borders are merely fictitious artifacts conceived by man and not by nature, thus, both their path and significance are subject to change ... There is not a predetermined ‘ab aeterno’ border, as well as no static, immutable and timeless border exists. Giorgio Valussi, Il confine nordorientale d’Italia, 1972, p. 7 Confini nel tempo Un viaggio nella storia dell’Alto Adriatico attraverso le carte geografiche (secoli XVI-XX) Borders through Time A Journey through the History of the Upper Adriatic with Geographical Maps (XVI-XX Century) Orietta Selva Dragan Umek con testi di / with essays by: Franco Cecotti, Sergio Zilli Il volume è stato ideato per la mostra di cartografia antica “Confini nel UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE tempo” tenutasi a Trieste presso Palazzo Costanzi, sala “Umberto Veruda” nel giugno-luglio 2012 a cura di Orietta Selva, Dragan Umek e Sergio Dipartimento di Studi Umanistici (DiSU) Zilli. L’evento espositivo è stato realizzato in occasione del Convegno Internazionale “Borderscape III” diretto da Elena dell’Agnese e Sergio Zilli e promosso dalle Università di Milano Bicocca (Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale) e di Trieste (Dipartimento di Studi Umanistici). Con la collaborazione di: Si ringraziano: Gian Carlo Bertuzzi, IRSML Friuli -

ASU FC Serivizio Normale P Pomeriggio Servizio Normale (Chiusura Al Mattino)
ASU FC serivizio normale P Pomeriggio servizio normale (chiusura al mattino) zona BASSA FRIULANA # servizio normale + turno diurno M Mattino servizio normale (chiusura al pomeriggio) Calendario di apertura e chiusura delle farmacie servizio normale + turno settimanale di guardia Ű X chiusura giornaliera completa Maggio 2020 farmaceutica 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Ve Sa Do Lu Ma Me Gi Ve Sa Do Lu Ma Me Gi Ve Sa Do Lu Ma Me Gi Ve Sa Do Lu Ma Me Gi Ve Sa Do 1 AIELLO DEL FRIULI [Beltrame] via XXIV Maggio, 1 - Tel. 0431 99011 X X X X Ű Ű Ű Ű Ű Ű Ű X 2 AQUILEIA [Corradini D'Elia] via Gramsci, 18 - Tel. 0431 91001 X M X M X M X M X M X 3 BAGNARIA ARSA - fraz. SEVEGLIANO [Gergolet] fraz. SEVEGLIANO, via Vittorio Veneto 4 - Tel. 0432 920747 X X X X X X X X X X X 4 BICINICCO [Qualizza] Via Palmanova 5/A - Tel. 0432 990558 X M X M X M X M X M X 5 CAMPOLONGO TAPOGLIANO [Rutter] corso Marconi, 10 - Tel. 0431 999347 X M X M M X M M X M M X M M X 6 CARLINO [Charalambopoulos] piazza San Rocco, 11 - Tel. 0431 68039 Ű Ű Ű Ű Ű Ű Ű M X M X M X M X 7 CERVIGNANO DEL FRIULI [Comunale città di Cervignano] via Monfalcone, 7 - Tel. -

L'accorpamento Tra I Consorzi Di Bonifica Ledra Tagliamento E Bassa
CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA FRIULANA L’ACCORPAMENTO TRA I CONSORZI DI BONIFICA LEDRA TAGLIAMENTO E BASSA FRIULANA INDICE 1. PREMESSA 2. ORDINAMENTO GIURIDICO DEI CONSORZI DI BONIFICA 3. IL CONSORZIO DI BONIFICA LEDRA TAGLIAMENTO Cenni storici Comprensorio 3.2.1 Pedologia 3.2.2 L’idrografia Attività del Consorzio Di Bonifica Ledra-Tagliamento 3.3.1 Il Sistema Ledra Tagliamento 3.3.2 Sistema delle Rogge 3.3.3 Bonifica idraulica e risanamento idraulico-agrario 3.3.4 Impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili 3.4 Infrastrutture 3.5 Prestazioni di servizi a favore di altri Enti 4. IL CONSORZIO DI BONIFICA BASSA FRIULANA 4.1 Cenni Storici 4.2 Comprensorio 4.2.1 Orografia 4.2.2 Pedologia 4.2.3 Rete idrografica 4.3 Le opere di bonifica 4.3.1 Sistema di scolo delle acque 4.3.2 Rete idraulica di bonifica 4.3.3 Impianti idrovori 4.3.4 Attività di manutenzione ordinaria 4.3.5 Irrigazione 4.4 Infrastrutture 5. PROGETTO DI ACCORPAMENTO 6. CONSORZIATI, ENTI LOCALI, PORTATORI DI INTERESSE, SERVIZI E POPOLAZIONE 7. RETI, IMPIANTI ED INFRASTRUTTURE 2 7.1 Dotazione mezzi 8. ENERGIA ED AMBIENTE 9. OBIETTIVI DELL'INTEGRAZIONE 10. L'AGGREGAZIONE 10.1 Le economie di scala 10.2 Le sinergie 11. RILANCIO DEL RUOLO DI GESTORE DEL TERRITORIO 12. NUOVE COMPETENZE 12.1 Gestione unica dei corsi d'acqua - PER UNIFORMITA' E CHIAREZZA 12.2 Strade interpoderali e vicinali - AFFINCHE' QUALCUNO FACCIA MANUTENZIONE 12.3 Sfalcio lungo le strade comunali, provinciali e regionali - PER L'OTTIMIZZAZIONE DEI COSTI 12.4 Dragaggi di laguna e fiumi - PER GARANTIRE LA NAVIGABILITA’ E LA DIFESA DEL TERRITORIO 12.5 Servizi di piena - PER FRONTEGGIARE LE AVVERSITA' 12.6 Irrigazione - PER UN'AGRICOLTURA CERTA E DI QUALITA' 12.7 Regime autorizzativo - PER SEMPLIFICARE 13. -

Report on the Protection of the Friulian-Speaking Minority
REPORT ON THE PROTECTION OF THE FRIULIAN-SPEAKING MINORITY (Council of Europe. Fifth Italian Report on the Implementation of the Framework Convention for the Protection of National Minorities) 1. SPEAKERS ARLeF – Agenzia regionale per la lingua friulana (Regional Friulian Language Agency), with the collaboration of Udine University and coordinated by its chief scientist Claudio Melchior, presented in 2015 the full data gathered by the sociolinguistic survey on the Friulian language carried out in 2014. Among the most interesting results are the data concerning the distribution and understanding of the Friulian language in the area involved in the research: at present, 600,000 people resident in the former provinces of Gorizia, Pordenone and Udine speak Friulian. Of these, 420,000 speak it regularly, 180,000 occasionally. This amounts to over 60% of the population of the three former provinces. If the inhabitants of the former province of Trieste are added, the total number of Friulian-speakers comes to almost half of all the inhabitants of the Autonomous Region of Friuli Venezia Giulia. Almost the entire population actually understands Friulian, even though they might not speak it: over 83% of the population of the former provinces of Gorizia and Pordenone understand Friulian. This percentage rises to 96% in the former province of Udine. This means that overall over 90% of the inhabitants of the three provinces in the survey claim to at least understand the Friulian language. It is worth mentioning that these figures do not take into account Friulian-speakers living in the municipalities of the eastern part of the Veneto Region (Mandamento di Portogruaro), in the rest of Italy and people from the region who now live abroad. -

LAVORO FINITO SOFIA Ultima Edizione
IL PROFILO DI COMUNITA’ DI MARANO LAGUNARE 1 Premessa Il Profilo di Comunità “La comunità locale è un -sistema complesso- inteso come insieme di parti quali unità territoriale, sociale, politica, economica, culturale, correlate ed interagenti tra di loro e funzionanti come un tutto”. Secondo la teoria dei sistemi quando una qualsiasi unità cambia tutto il sistema ne viene coinvolto. La comunità funziona quando tutte le sue parti funzionano. “La comunità può essere considerata anche come un campo all’interno del quale correnti di energia si incontrano e si scontrano, si influenzano e si potenziano, si limitano, si distruggono dando origine ad un processo basato su equilibri costantemente dinamici”. La conoscenza della comunità è una condizione indispensabile per imprimere intenzionalità e direzione alle energie professionali ed economiche ben sapendo quali sono le motivazioni sottese alle azioni proposte. Tutti noi viviamo in una comunità ma questo non significa che sappiamo cosa essa sia, quali siano le sue origini, i suoi confini, qual è l’organizzazione politica, economica, qual è il sistema dei valori comuni, quali sono i suoi problemi emergenti, come i vari servizi socio-educativi e di tutela della salute rispondono ai bisogni della popolazione. Pertanto potendo dare una definizione di comunità così come la si intende per questo lavoro essa può essere così delineata. “La comunità locale è un sottosistema socio-territoriale a confini amministrativi definiti (città, comune, quartiere, distretto socio-sanitario…) dove si dispongono, in un mutuo scambio di influenze, individui, gruppi, ambiente fisico, ambiente costruito dall’uomo, bisogni, risorse, attività di interpretazione e/o di trasformazione della vita”. -

Zone Ad Alto Rischio Di Introduzione E Di Diffusione (Zone A)
Zone ad alto rischio di introduzione e di diffusione (Zone A) COMUNE AAS/ASUI PROVINCIA AREE AD ELEVATO RISCHIO AIELLO DEL FRIULI BASSA FRIULANA-ISONTINA UDINE TERRITORIO COMUNALE A SUD DELL'AUTOSTRADA A4 AQUILEIA BASSA FRIULANA-ISONTINA UDINE INTERO TERRITORIO COMUNALE BAGNARIA ARSA BASSA FRIULANA-ISONTINA UDINE TERRITORIO COMUNALE A SUD DELL'AUTOSTRADA A4 CAMPOLONGO TAPOGLIANO BASSA FRIULANA-ISONTINA UDINE TERRITORIO COMUNALE A SUD DELL'AUTOSTRADA A4 CARLINO BASSA FRIULANA-ISONTINA UDINE INTERO TERRITORIO COMUNALE CASTIONS DI STRADA ALTO FRIULI-COLLINARE-MEDIO FRIULI UDINE TERRITORIO COMUNALE A SUD DELL'AUTOSTRADA A4 CERVIGNANO DEL FRIULI BASSA FRIULANA-ISONTINA UDINE INTERO TERRITORIO COMUNALE DUINO-AURISINA A.S.S.TRIESTINA TRIESTE TERRITORIO COMUNALE A SUD DELL'AUTOSTRADA A4 FIUMICELLO BASSA FRIULANA-ISONTINA UDINE INTERO TERRITORIO COMUNALE GONARS BASSA FRIULANA-ISONTINA UDINE TERRITORIO COMUNALE A SUD DELL'AUTOSTRADA A4 GRADO BASSA FRIULANA-ISONTINA GORIZIA INTERO TERRITORIO COMUNALE LATISANA BASSA FRIULANA-ISONTINA UDINE INTERO TERRITORIO COMUNALE LIGNANO SABBIADORO BASSA FRIULANA-ISONTINA UDINE INTERO TERRITORIO COMUNALE MARANO LAGUNARE BASSA FRIULANA-ISONTINA UDINE INTERO TERRITORIO COMUNALE MONFALCONE BASSA FRIULANA-ISONTINA GORIZIA TERRITORIO COMUNALE A SUD DELL'AUTOSTRADA A4 MUGGIA A.S.S.TRIESTINA TRIESTE INTERO TERRITORIO COMUNALE MUZZANA DEL TURGNANO BASSA FRIULANA-ISONTINA UDINE TERRITORIO COMUNALE A SUD DELL'AUTOSTRADA A4 PALAZZOLO DELLO STELLA BASSA FRIULANA-ISONTINA UDINE TERRITORIO COMUNALE A SUD DELL'AUTOSTRADA A4 -

Episodio Di Ronchi, Terzo Di Aquileia, 09.04.1945 I.Storia
EPISODIO DI RONCHI, TERZO DI AQUILEIA, 09.04.1945 Nome del compilatore: IRENE BOLZON I.STORIA Località Comune Provincia Regione Ronchi Terzo di Aquileia Udine Friuli Venezia Giulia Data iniziale: 9 aprile 1945 Data finale: 9 aprile 1945 Vittime decedute: Totale U Bam Ragaz Adult Anzia s.i. D. Bambi Ragazze Adult Anzian S. Ig bini zi (12- i (17- ni (più ne (0- (12-16) e (17- e (più i n (0- 16) 55) 55) 11) 55) 55) 11) 7 7 7 Di cui Civili Partigiani Renitenti Disertori Carabinieri Militari Sbandati 7 Prigionieri Antifascisti Sacerdoti e Ebrei Legati a Indefinito di guerra religiosi partigiani Elenco delle vittime decedute: 1. Fulvio Innocente, di Giuseppe e Durigutto Marcellina, nato a Giussago di Portogruaro il 6.7.1924, residente a Ronchi dei Legionari, partigiano. 2. Archildo Taverna “Fernando”, di Attilio e Fornezza Pasqua, nato a San Giorgio di Nogaro, il 10.4.1915, partigiano. 3. Ego Maran “Guido”, di Giacomo e Pitta Lucia, nato a San Giorgio di Nogaro il 14.11.1926, ivi residente, partigiano. 4. Giuseppe Amato “Dik”, di Corrado e Pinzan Argentina, nato a San Giorgio di Nogaro il 21.7.1924, partigiano. 5. Corrado Bean “Learco”, di Luciano e Iustolin Maria, nato a San Canzian d’Isonzo il 28.9.1913, ivi residente, partigiano. 6. Giovanni Gastone Bonito, di Luigi e Tubaro Argentina, nato a Trieste il 29.2.1924, ivi residente, partigiano. 7. Ottone Bonettig, nato a Fiumicello il 24.02.1918, ivi residente, partigiano. Altre note sulle vittime: Partigiani uccisi in combattimento contestualmente all’episodio: Descrizione sintetica La mattina del 9 aprile 1945 in località Ronchi Di Terzo d’Aquileia un plotone proveniente dalla Caserma “Piave” di Palmanova fucilò sei prigionieri provenienti dalla celle della struttura con l’obiettivo di vendicare la morte di un ufficiale tedesco avvenuta qualche giorno prima per iniziativa di una squadra GAP locale. -

Utopia and Fascist Foundation Cities the Case of Torviscosa
Utopia and Fascist foundation cities The case of Torviscosa Maurizio Scaini1 University of Trieste Abstract The foundation cities were the principal expression of Fascist urban planning that was linked to the industrial urban utopias of the 19th century. This construction pursued a new social model that envisioned harmonious co-habitation among the residents, the relative end of class conflict, the promotion of autarchy, the organisation of the new anthropological model of a radiant society in which the dichotomy between city and countryside would be superseded. In this article, we analyse the case of the town of Torviscosa, founded in the lower Friulian plain in 1937, amidst swampland subject to reclamation whose economic activity, the production of viscose, was a response to international sanctions that were applied to Italy after the invasion of Ethiopia the preceding year. 1. Utopias and ideal cities The word Utopia should be understood in its most authentic meaning. If we limit ourselves to the etymology of the term, we find two meanings: the first, u-topia, negates itself, being a non-place. The second, eu-topia, emphasises instead the possibility of a happy place. The numerous texts that summarise these reflections may be grouped into two principal schools. On one hand, those regarding tales of utopia, referred to by writers such as Thomas More, Campanella, Paruta, Francis Bacon, Cyrano de Bergeraq, Fontanelle, Tissot de Patov, Swift, Morelly, Voltaire etc., and the industrialist utopia of Socialist and collectivist inspiration that appeared in Europe during the 19th century. Although it was a milestone in its literary genre, Thomas More’s Utopia of 1516 represents in reality a chapter of a much longer literary tradition that began with Plato.