Ambrosia Spp. (A
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Perennial Ragweed: State Prohibited Weed LC0286
February 1998 Perennial ragweed: LC0286 State Prohibited Weed ISSN 1329-833X Keith Turnbull Research Institute, Frankston Common Name robust, creeping, lateral roots develop buds that form new plants. Perennial ragweed Botanical Name Life Cycle Root buds and seeds both shoot and produce new plants in Ambrosia psilostachya DC. autumn. During winter and spring masses of creeping Status perennial roots are produced. Flowering stems are formed in spring, prior to flowering from mid summer through to Perennial ragweed is one of only fourteen weeds autumn. Top growth normally would die off in late summer proclaimed as State prohibited weeds in Victoria. This is to early autumn. the highest category to which a noxious weed can be allocated. Known infestations have been eradicated from the State. Origin Perennial ragweed is native to western North America from Mexico to Canada and is considered a weed in North and South America, Europe, western Asia, Japan and Mauritius. In Australia it was first recorded as naturalised in 1922. Description An upright perennial herb growing to a height of 30 to 150 cm. Plants branch near the base and have a number of main stems . Stems - hairy, branched in the upper half, becoming Figure 1. Perennial ragweed. woody at the base. Many branches are terminated with long, spike-like male flowerheads. Leaves - grey-green, hairy, deeply lobed, 5 to 12 cm long, Dispersal shortly stalked, with aromatic glands. Lower leaves grow An infestation of perennial ragweed will increase in size directly opposite each other while upper leaves are spaced and density as new plants develop from lateral roots. -

Ambrosia Artemisiifolia As a Potential Resource for Management of Golden
Research Article Received: 28 June 2017 Revised: 22 October 2017 Accepted article published: 17 November 2017 Published online in Wiley Online Library: 16 January 2018 (wileyonlinelibrary.com) DOI 10.1002/ps.4792 Ambrosia artemisiifolia as a potential resource for management of golden apple snails, Pomacea canaliculata (Lamarck) Wenbing Ding,a,b Rui Huang,a,c Zhongshi Zhou,d Hualiang Hea and Youzhi Lia,b* Abstract BACKGROUND: Ambrosia artemisiifolia, an invasive weed in Europe and Asia, is highly toxic to the golden apple snail (GAS; Pomacea canaliculata) in laboratory tests. However, little is known about the chemical components of A. artemisiifolia associated with the molluscicidal activity or about its potential application for GAS control in rice fields. This study evaluated the molluscicidal activities of powders, methanol extracts, and individual compounds from A. artemisiifolia against GAS in rice fields and under laboratory conditions. RESULTS: Ambrosia artemisiifolia powders did not negatively affect the growth and development of rice but they reduced damage to rice caused by GAS. Extracts had moderate acute toxicity but potent chronic toxicity. The 24-h 50% lethal –1 concentration (LC50) of the extracts against GAS was 194.0 mg L , while the weights, lengths and widths of GAS were significantly affected by exposure to a sublethal concentration (100 mg/mL). Psilostachyin, psilostachyin B, and axillaxin were identified as the most active molluscicide components in the aerial parts of A. artemisiifolia,andthe24-hLC50 values of these purified compounds were 15.9, 27.0, and 97.0 mg/L, respectively. CONCLUSION: The results indicate that chemical compounds produced by A. artemisiifolia may be useful for population management of GAS in rice fields. -

The First International Ragweed Review
Couv 2009 1.qxp 13/11/2009 14:33 Page 1 AMBROISIEAMBROISIE the first international ragweed review N° 26 - Novembre 2009, November 2009 Lettre d’Information Apériodique de l’Association Française d’Etude des Ambroisies (AFEDA) Association à but non lucratif, régie par la loi de 1901, Inscription en Préfecture du Rhône N° 17509-JO du 28/02/1983 couverture 2009 verso.qxp 20/11/2009 09:51 Page 1 Les noms d’ Ambrosia artemisiifolia The names of Ambrosia artemisiifolia L. en Europe et en Russie 1. Allemagne, Germany, Deutschland L. in Europe and in Russia "beifußblättriges traubenkraut" 1818 èmeème etet 1919 èmeème ColloquesColloques 2. Autriche, Austria, Österreich "beifußblättriges“ or traubenkraut" or "Ambrosia" or” dede l’AFEDAl’AFEDA or “aufrechtes traubenkraut" or "wilder hanf" MuséeMusée Gallo-RomainGallo-Romain dede St-Romain-en-St-Romain-en- GalGal (2006)(2006) or “fetzenkraut” 3. Chypre Grecque, Cyprus/Greece ParcParc dede MiribelMiribel JonageJonage (2007)(2007) "αµβροσία","amvrosia" 4. Croatie, Croatia, Hrvatska "pelinolisni limundzik", “ambrozija”, “partizanka” 5. Espagne, Spain, Spanish "ambrosia" 6. Esthonie, Estonia, Eesti "Pujulehine ambroosia" 7. Finlande, Finland, Suomi " "Marunatuoksukki", ambrosia artemisiifolia 8. France, France, France "ambroisie" 9. Grèce, Greece, Hellas "amvrosia", "αµβροσία ελλαδα" 10. Hongrie, Hungary, Magyarorszag "parlagfû" 11. Italie, Italy, Italia "ambrosia" 12. Lettonie, Latvia, Latvija "Vermerlapu ambrozija" 13. Lithuanie, Lithuania, Lietuva " Kietine ambrozija” 14. Norvège, Norway, Norge " Beskambrosia" -

Risk Analysis for Plants As Pests (Weeds) for Ambrosia Trifida
Risk analysis for plants as pests for Ambrosia trifida Risk analysis for plants as pests for Ambrosia trifida Inter-American Institute for Cooperation on Agriculture (IICA), 2018 Risk analysis for plants as pests for Ambrosia trifida by IICA is published under license Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 IGO (CC-BY-SA 3.0 IGO) (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/igo/) Based on a work at www.iica.int IICA encourages the fair use of this document. Proper citation is requested. This publication is available in electronic (PDF) format from the Institute’s Web site: http://www.iica.int Editorial coordination: Lourdes Fonalleras and Florencia Sanz Translator: Alec McClay Layout: Esteban Grille Cover design: Esteban Grille Digital printing Risk analysis for plants as pests for Ambrosia trifida / Inter-American Institute for Cooperation on Agriculture, Comité Regional de Sanidad Vegetal del Cono Sur; Alec McClay. – Uruguay : IICA, 2018. 26 p.; A4 21 cm X 29,7 cm. ISBN: 978-92-9248-811-6 Published also in Spanish and Portuguese 1. Asteraceae 2. Ambrosia 3. Phytosanitary measures 4. Pests of plants 5. Risk management 6. Pest monitoring 7. Weeds I. IICA II. COSAVE III. Title AGRIS DEWEY H10 632.5 Montevideo, Uruguay - 2018 ACKNOWLEDGMENTS The Guidelines of procedures for risk assessment of plants as pests (weeds) has been applied for the development of two case studies: Hydrocotyle batrachium and Ambrosia trífida. This products was a result of the component aimed to build technical capacity in the region to use a Pest Risk Analysis process with emphasis on the assessment of Plants as Pests (weeds) in the framework of STDF / PG / 502 Project “COSAVE: Regional Strengthening of the Implementation of Phytosanitary Measures and Market Access”. -
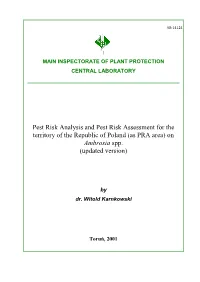
Ambrosia Spp
08-14124 MAIN INSPECTORATE OF PLANT PROTECTION CENTRAL LABORATORY ___________________________________________________ Pest Risk Analysis and Pest Risk Assessment for the territory of the Republic of Poland (as PRA area) on Ambrosia spp. (updated version) by dr. Witold Karnkowski Toruń, 2001 CONTENTS INTRODUCTION - 1 PART A. INFORMATION FOR PRA - 1 Section 1. The organism - 1 1.1. Name and taxonomic position - 1 1.2. Relationship with known quarantine pests - 1 1.3. Methods for identification for inspection purposes - 1 1.4. Methods for detection - 6 Section 2. Biological characteristics of the pests - 6 Ambrosia artemisiifolia - 6 Ambrosia psilostachya - 8 Ambrosia trifida - 9 Section 3. Geographical distribution of the pest - 11 3.1. Present distribution in PRA area - 11 3.2. World distribution of the pests - 11 3.3. Area of origin and history of spread - 12 3.4. Overlap of world distribution of the pests with that of major host crops - 12 Section 4. The crops infested with weeds - 13 4.1. Crops infested with the pests reported on areas of their present distribution - 13 4.2. Host crops occurring in the PRA area - 13 4.3. Nature of the host crops range - 13 Section 5. Potential of the pest for establishment in the PRA area - 13 5.1. Climatic conditions for the pest development - 13 5.2. Data on climatic conditions in PRA area - 14 Section 6. Control of the pests - 15 6.1. Control measures in regular use - 15 6.2. Records of eradication of the pests - 22 Section 7. Transport of the pests - 22 7.1. Methods of natural spread elsewhere in the world - 22 7.2. -

Vascular Plant Species of the Comanche National Grassland in United States Department Southeastern Colorado of Agriculture
Vascular Plant Species of the Comanche National Grassland in United States Department Southeastern Colorado of Agriculture Forest Service Donald L. Hazlett Rocky Mountain Research Station General Technical Report RMRS-GTR-130 June 2004 Hazlett, Donald L. 2004. Vascular plant species of the Comanche National Grassland in southeast- ern Colorado. Gen. Tech. Rep. RMRS-GTR-130. Fort Collins, CO: U.S. Department of Agriculture, Forest Service, Rocky Mountain Research Station. 36 p. Abstract This checklist has 785 species and 801 taxa (for taxa, the varieties and subspecies are included in the count) in 90 plant families. The most common plant families are the grasses (Poaceae) and the sunflower family (Asteraceae). Of this total, 513 taxa are definitely known to occur on the Comanche National Grassland. The remaining 288 taxa occur in nearby areas of southeastern Colorado and may be discovered on the Comanche National Grassland. The Author Dr. Donald L. Hazlett has worked as an ecologist, botanist, ethnobotanist, and teacher in Latin America and in Colorado. He has specialized in the flora of the eastern plains since 1985. His many years in Latin America prompted him to include Spanish common names in this report, names that are seldom reported in floristic pub- lications. He is also compiling plant folklore stories for Great Plains plants. Since Don is a native of Otero county, this project was of special interest. All Photos by the Author Cover: Purgatoire Canyon, Comanche National Grassland You may order additional copies of this publication by sending your mailing information in label form through one of the following media. -

Biological Activity of Acetone Extract of Pollen Of
99 Kragujevac J. Sci. 30 (2008) 99-104. UDC 575.4:582.926.16:595.77 COMPARATIVE ANALYSIS OF ACETONIC AND WATERY POLLEN EXTRACT OF AMBROSIA ARTEMISIIFOLIA L. ON DROSOPHILA MELANOGASTER Sanja Matić, Snežana Stanić, Slavica Solujić - Sukdolak & Tanja Milošević Institute of Biology and Ecology, Faculty of Science, University of Kragujevac Radoja Domanovića 12, 34000 Kragujevac, Republic of Serbia e-mail: [email protected] (Received April 15, 2008) ABSTRACT: Chemical components of the acetone and watery extract of Ambrosia artemisiifolia (LINNAEUS, 1753) plant, and the two identified lactones in the acetone extract: the ambrosin and dihydroambrosin, was tested for genotoxicity activities. The genotoxicity of the extract was tested on the eukaryotic model system Dro- sophila melanogaster using the sex-linked recessive lethal test (SLRL test). The re- sults presented here illustrate that the two identified lactones, ambrosin and dihydro- ambrosin from acetone extract and same chemical substance from watery extract indu- ce recessive lethal mutations on X-chromosome of Drosophila melanogaster in II and III broods, based on which we can conclude that spermatides and spermatocytes repre- sent a more sensitive stages of spermatogenesis. Key words: Ambrosia artemisiifolia, extract, genotoxicity. INTRODUCTION The Ambrosia (Asteraceae) genus is classified as a part of the Heliantheae tribe. The Ambrosia artemisiifolia (L.) plant is an invasive allergenic plant that produces large amounts of pollen (WANG et al., 2006). Sesquiterpene lactones ambrosin, isabelin, psilostachyn (BLOSZYK et al., 1992; RUGUTT et al., 2001), cumanin and peruvin (PARKHOMENKO et al., 2005; DAVID et al., 1999), triterpenoids of type α− and β-amyrine and derivatives of caffeic acid have all been identified in the Ambrosia artemisiifolia (L.) plant (WANG et al., 2006; TAMURA et al., 2004). -

Checklist of the Vascular Plants of San Diego County 5Th Edition
cHeckliSt of tHe vaScUlaR PlaNtS of SaN DieGo coUNty 5th edition Pinus torreyana subsp. torreyana Downingia concolor var. brevior Thermopsis californica var. semota Pogogyne abramsii Hulsea californica Cylindropuntia fosbergii Dudleya brevifolia Chorizanthe orcuttiana Astragalus deanei by Jon P. Rebman and Michael G. Simpson San Diego Natural History Museum and San Diego State University examples of checklist taxa: SPecieS SPecieS iNfRaSPecieS iNfRaSPecieS NaMe aUtHoR RaNk & NaMe aUtHoR Eriodictyon trichocalyx A. Heller var. lanatum (Brand) Jepson {SD 135251} [E. t. subsp. l. (Brand) Munz] Hairy yerba Santa SyNoNyM SyMBol foR NoN-NATIVE, NATURaliZeD PlaNt *Erodium cicutarium (L.) Aiton {SD 122398} red-Stem Filaree/StorkSbill HeRBaRiUM SPeciMeN coMMoN DocUMeNTATION NaMe SyMBol foR PlaNt Not liSteD iN THE JEPSON MANUAL †Rhus aromatica Aiton var. simplicifolia (Greene) Conquist {SD 118139} Single-leaF SkunkbruSH SyMBol foR StRict eNDeMic TO SaN DieGo coUNty §§Dudleya brevifolia (Moran) Moran {SD 130030} SHort-leaF dudleya [D. blochmaniae (Eastw.) Moran subsp. brevifolia Moran] 1B.1 S1.1 G2t1 ce SyMBol foR NeaR eNDeMic TO SaN DieGo coUNty §Nolina interrata Gentry {SD 79876} deHeSa nolina 1B.1 S2 G2 ce eNviRoNMeNTAL liStiNG SyMBol foR MiSiDeNtifieD PlaNt, Not occURRiNG iN coUNty (Note: this symbol used in appendix 1 only.) ?Cirsium brevistylum Cronq. indian tHiStle i checklist of the vascular plants of san Diego county 5th edition by Jon p. rebman and Michael g. simpson san Diego natural history Museum and san Diego state university publication of: san Diego natural history Museum san Diego, california ii Copyright © 2014 by Jon P. Rebman and Michael G. Simpson Fifth edition 2014. isBn 0-918969-08-5 Copyright © 2006 by Jon P. -

Chapter 10 Kiowa Ethnobotany
Chapter 10 Kiowa Ethnobotany ______________________________________________________ 10.1 Introduction The ethnological and ethnohistorical literature review documented approximately 124 plant resources acknowledged or used by the Kiowa. Seventy-three plants were recorded as food resources, including fodder for horses. Sixty-eight plants were listed as having medicinal value and 26 plants had explicit religious or spiritual value. Fifty-seven flora resources were used in the manufacture of material items. Of the complete plant inventory, the literature recorded six plants with no cultural use for the resource. Below are the plant resources listed by scientific name, although some plants could not be specifically identified. These plants are listed as unidentified.1 10.2 Ethnobotanical Resources Acer negundo L. Boxelder; Aceraceae Tribal Nation: Kiowa Indigenous Name: Kaw-sen-an-daw Meaning: Not given Habitat/Ecological Zone: Found in moist, sheltered locations, the foothills to montane regions. The tree is distributed from central British Columbia, Canada to New Mexico Plants Parts Harvested: Wood Season Collected: Not given 728 Spiritual/Religious Use(s): Wood burned in the altar fire of the peyote ceremony References: 2 ______________________________________________________ Aesculus glabra var. arguta (Buckl.) B.L. Robins Ohio Buckeye; Hippocastanaceae Western Buckeye Tribal Nation: Kiowa Indigenous Name: Kon-ta-la Meaning: Not given Habitat/Ecological Zone: Found from Nebraska south into Texas Plants Parts Harvested: Fruit Season Collected: Not given Medicinal Use(s): The inside of the fruit is brewed into a drink that makes a powerful emetic. References: 3 ______________________________________________________ Amaranthus blitoides S. Wats Mat Amaranth; Amaranthaceae Spreading Pigweed; Prostrate Amaranth Tribal Nation: Kiowa Indigenous Name: Not given Meaning: Not given Habitat/Ecological Zone: Occurs in dry or cultivated ground. -

ANSES Opinion and Report on Conducting a Risk
Mesures de maîtrise Riskde la analysis brucellose relating chez to the giantles bouquetins ragweed (Ambrosia du Bargy trifida L.) in order to formulateAvis de l’Anses management recommendationsRapport d’expertise collective ANSESJuillet Opinion2015 Édition scientifique Collective Expert Appraisal Report July 2017 Scientific Edition Risk analysis relating to the giant ragweed (Ambrosia trifida in order to L.) formulate management recommendations Risk analysis relating to the giant ragweed (Ambrosia trifida L.) in order to formulate management recommendations ANSES Opinion Collective Expert Appraisal Report July 2017 Scientific Edition ANSES Opinion Request No 2016-SA-0090 The Director General Maisons-Alfort, 10 July 2017 OPINION1 of the French Agency for Food, Environmental and Occupational Health & Safety on conducting a risk analysis relating to the giant ragweed (Ambrosia trifida L.) in order to formulate management recommendations ANSES undertakes independent and pluralistic scientific expert assessments. ANSES primarily ensures environmental, occupational and food safety as well as assessing the potential health risks they may entail. It also contributes to the protection of the health and welfare of animals, the protection of plant health and the evaluation of the nutritional characteristics of food. It provides the competent authorities with the necessary information concerning these risks as well as the requisite expertise and technical support for drafting legislative and statutory provisions and implementing risk management strategies (Article L.1313-1 of the French Public Health Code). Its opinions are published on its website. This opinion is a translation of the original French version. In the event of any discrepancy or ambiguity the French language text dated 10 July 2017 shall prevail. -

Iva Axillaris Pursh Ssp. Robustior (Hook.) Bassett
SPECIES Iva axillaris Pursh ssp. robustior (Hook.) Bassett NRCS CODE: Family: Asteraceae IVAXR Order: Asterales Subclass: Asteridae Tribe: Helenieae Subtribe: Ambrosiinae Class: Magnoliopsida A. Montalvo, w. Riverside Co. Subspecific taxa California plants have been treated as a subspecific taxon of I. axillaris Pursh. Synonyms I. axillaris Pursh var. pubescens Gray Common name povertyweed, deathweed, devil's-weed, poverty sumpweed, bozzleweed, salt sage, marsh elder, small-flowered marsh elder (DiTomaso & Healy 2007, Painter 2009). There are many more common names. Taxonomic relationships Species in the genus Iva are related to Ambrosia and Artemisia in southern California. Seven Iva species are currently recognized in North America (FNA), but nine species were assessed for phylogenetic relationships using cpDNA (Miao et al. 1995). Related taxa in region Iva hayesiana A. Gray (rare, native subshrub found mostly in sw San Diego County) is the closest relative in the region. The species differ in chromosome number, stature, size and habitat; I. hayesiana has n=17 chromosomes, is a coastal (Miao et al. 1995), and also differs in having flower heads with separate phyllaries (Munz 1974, DiTomaso & Healy 2007). Ragweeds are in the same section of the Asteraceae. Some (e.g., Ambrosia psilostachya ) are found in similar areas and have a similar growth habit, but unlike Iva , they have incised or lobed leaf margins (DiTomaso & Healy 2007). Outside focus area: Iva nevadensis Jones is an annual herb found in sagebrush scrub and pinyon-juniper woodlands of CA (Munz 1974); Iva acerosa (Nutt.) Jackson is a perennial found on alkali sinks and desert areas of CA (Munz 1974). -

Ecological Features of Ambrosia Artemisiifolia L
ACTA AGROBOTANICA Vol. 61 (2): 35–47 2008 ECOLOGICAL FEATURES OF AMBROSIA ARTEMISIIFOLIA L. FLOWERS AND CHARACTERISTICS OF AMBROSIA L. POLLEN SEASONS IN THE CONDITION OF LUBLIN (POLAND) IN THE YEARS 2001-2008 Elżbieta Weryszko-Chmielewska, Krystyna Piotrowska Department of Botany, University of Life Sciences, Akademicka 15, 20-095 Lublin, Poland e-mail: [email protected] Received: 19.09.2008 Summary brosia is recorded in different regions of the country: In the study, the biology of fl owering of Ambrosia ar- Ambrosia artemisiifolia L., A. psilostachya DC. and temisiifolia L. was investigated and the pattern of the Ambrosia A. trifi da L. (Tacik, 1971; Rutkowski, 1998; pollen seasons in Lublin in the years 2001-2008 was character- Zają c and Z a j ą c , 2001). A. artemisiifolia has been ised. The structure of male and female A. artemisiifolia fl owers noted, inter alia, in the Lublin region (Fijał kowski was observed in cultivated plants under controlled conditions 1994), in Wrocław (Malkiewicz and W ą sowicz, in the 2000 vegetative season. The number of pollen grains 2003), in the Upper Silesia region (C h ł opek and produced by the stamen, fl ower, infl orescence and plant was Tokarska-Guzik, 2006). Ambrosia psilostachya determined. It was shown that in A. artemisiifolia fl owers non- sites have been described, among others, in Szczecin functional pistils occurred with a reduced ovary, performing the (Ć wikliń ski, 1968; Puc, 2004) and the Lublin role of a pollen presenter. The pistils found in female fl owers region (Ś wię s and Wrzesień , 2002).