Scarica Questo File
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Biblioteca Venezia Odg Veneto.Pdf
NUMERO d'ORDINE TITOLO AUTORE GENERE OOO1 Cinquant'anni di sport a Vedelago Volpato, Zavarise SPORT OOO2 Il telefono, il lavoro, la società Sip STORIA OOO3 Sulla via di Ol Moran Bellerno VIAGGI OOO4 Il basket e i caravaggeschi Rizzardini SPORT OOO5 La posta in Verona e nella sua provincia Cataldi STORIA OOO6 Checklist e distribuzione della fauna italiana AAVV SCIENZA OOO7 Páginas de Resistência, 1946-1958 Ribero STORIA OOO8 La Necropoli dell'Età del Bronzo all'Olmo di Nogara Solzani STORIA OOO9 Luigi de Zan, scritti, disegni, dipinti Pappacena BIOGRAFIA OO1O Annuario dell'Università di Urbino 1991-92 DOCUMENTI OO11 Annuario dell'Università di Urbino 1993-94 DOCUMENTI OO12 Agenda delle autonomie Regione Veneto DOCUMENTI OO13 Quaderni di studi arabi Dorigo LETTERATURA OO14 Annuario dell'Università di Urbino 1992-93 DOCUMENTI OO15 Rivista studi alpini Alto Adige 2003-04 STORIA OO16 La guerra e la vita pulsava Menini Beltrami STORIA OO17 Codice della Regione del Veneto LEGGE OO18 48ma Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di CINEMA Venezia OO19 Sul fiume azzurro nei Sciangallah Beltrame VIAGGI OO20 La me tera la me gente Menini Beltrami STORIA OO21 International Communications Strategy Cambié, Yang-May Ooi MEDIA OO22 Don Floriano e la musica al Barbarigo Cioffredi MUSICA OO23 Carissimi di famiglia Menini Beltrami STORIA OO24 Sicutérat nun prinsìpio. Cronache di Adria e del Polesine Beltramini STORIA OO25 Con gli occhi di un bambino. La vecchia Schio Piazza STORIA OO26 Il coraggio del pettirosso Maggiani NARRATIVA OO27 Dolo 100, trent'anni -

Renaissance Monti Di Pietà in Modern Scholarship: Themes, Studies, and Historiographic Trends1
Renaissance Monti di Pietà in Modern Scholarship: Themes, Studies, and Historiographic Trends1 nicola lorenzo barile University of Bari Il existe une longue tradition d’études des Monti di Pietà, qui est presqu’entière ment publiée en italien. Cet article propose une revue historiographique de ces recherches, en se basant sur quatre thèmes centraux les ayant orientées. Le premier de ces thèmes correspond aux relations entre les banques et les premiers Monti, et à la question de savoir s’ils étaient de véritables banques ou des institutions charitables. Le deuxième thème correspond au contexte de ces pratiques formé par les débats théologiques et les opinions juridiques de la fin du Moyen Âge et de la Renaissance. Le troisième thème est centré sur l’influence des prédicateurs franciscains, incluant comment leurs discours antisémites ont été contrebalancés par les préoccupations économiques locales, pour former un compromis pratique. Le quatrième thème correspond au rôle et à la fonction qu’ont joués les Monti dans le Royaume de Naples. En conclusion, cette revue examine les recherches sur les Monti publiées en anglais depuis les années 1930. here is a long tradition of studying Italy’s charitable pawn banks, or monti Tdi pieta, ahistorically, as either a chapter in the history of local pious in- stitutions, an issue related to late medieval scholastic discussions of usury, or an argument in the debate on the medieval origins of modern banking.2 By examining a few principal themes, as these have been developed in both Italian and English language studies, we can see how the monti are now emerging as a distinct subject of research fully integrated into larger historiographical trends relating to sources, methodologies, and questions. -

A Quarterly Review SEPTEMBER
A Quarterly SEPTEMBER Review 1941 VO L.UM E 22 NEW SERIES, VOLÜME 1 N Ü M B E R 3 Economic Significance o f THE Montes Pietatis Anscar Parsons, O. F. M . Cap. E g o n o m ig Pr o b l e m o f t h e Fa m il y Gonzálve Poulin, O. P. M . C a r d in a l F is h e r a n d D u n s Sc o t u s Ladislas Siekaniec, O. F. M . T h e C u l t o f t h e M o t h e r o f G o d i n t h e B y z a n t in e L it u r g y Cuthbert Gumbinger, O. F. Aí. Cap. T h e Centiloquium Attributed to Ockham (Part III) Philotheus Boehner, O. F. M . Sgotistic Bibliography o f THE Last Decade (1929-1939) ( P a r t III) Maurice Grajewski, O. F. M. F r a n c is c a n a B o o k R e v ie w s McKeon, ed., TIbe Basic Works o f Aristotle; Sinisterra, Estadistica Gen eral de la Provincia Franciscana de Santa Fé de Bogotá; McGarry, Unto the End; Report o f the Second Biennial Meeting, The Capuchin Educa- tio n d Conference; Fitzgerald and Frank, comp., A List of 5,000 Cath- olic Authors; Narratio de Itinere Navali Peregrinorum Hierosolymam Tendentium et Silviam Capientium, A. D. 1189 B o o k s R e c e iv e d Published by The Franciscan Educational Conference St. -

M-001 Macrobius, Aurelius Theodosius in Somnium Scipionis
M r M-001 Macrobius, AureliusTheodosius h4 Macrobius, AureliusTheodosius: Saturnalia. In somnium Scipionis expositio, et al. refs. Macr. r Brescia: Boninus de Boninis, de Ragusia, 6 June 1483. Folio. [a2 ] Cicero, Marcus Tullius: Somnium Scipionis: De republica 10 8 6 8 6 8 6 8 6 8 6 8 [extract]. collation: a b c d e^g h i k l^n o q^u x y & m a A^C . Leaf a2 signed a, a3 signed aii, etc. refs. Cic. Rep. 6. 9^29; Macrobius, Commentarii in somnium v Scipionis, ed. James Willis (Leipzig, 1963),155^63. Woodcut diagrams, and, on f8 , a map of the world, for which see v Campbell. [a4 ] Macrobius, Aurelius Theodosius: In somnium Scipionis expositio. HC *10427; Go¡ M-9; BMC VII 968; Pr 6953; BSB-Ink M-2; refs. Macrobius, Commentarii in somnium Scipionis, ed. Willis, Campbell, Maps, 879(i); CIBN M-7; Sander 4072; Sheppard 1^154. 5750. Micro¢che: Unit 3: Image of the World: Geography and r Cosmography. [f5 ] Macrobius, AureliusTheodosius: Saturnalia. refs. Macr. COPY Venice: Nicolaus Jenson, 1472. Folio. Wanting the blank leaf a1. collation: [a b10 c^m8 n10 o^v8]. Leaf a10 bound after b8. Binding: Eighteenth/nineteenth-century gold-tooled diced rus- HCR 10426; Go¡ M-8; BMC V 172; Pr 4085; BSB-Ink M-1; CIBN sia; gilt-edged leaves, marbled pastedowns; the gold stamp of the M-6; Hillard 1268; Lowry, Jenson, 242, no. 27; Rhodes 1135; Bodleian Library on both covers. Size: 312 ¿ 222 ¿ 37 mm. Sizeof Sheppard 3258. leaf: 300 ¿ 203 mm. -

Caritas – Societas
Pietas – Caritas – Societas Bildprogramme karitativer Einrichtungen des Spätmittelalters in Italien Band 2 Inauguraldissertation zur Erlangung der Doktorwürde der Philosophischen Fakultät der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität zu Bonn vorgelegt von Ulrike Ritzerfeld aus Münster Bonn 2007 Katalog Anhang Abkürzungen Literaturverzeichnis 223 11 Katalog 11.1 Die Fassadenfresken der Misericordia in Bergamo 11.1.1 Der Consorzio dellaMisericordiaMaggiore Geschichte In Bergamo sind in der Zeit um 1300 acht karitative Bruderschaften belegt. 1270 Der heute noch bestehende „Consorzio Misericordiae domine sancte Marie majoris de Pergamo“ gilt als eine der ältesten Konfraternitäten und als deren mächtigste. 1271 Die Gemeinschaft wur- de in den 60er Jahren des 13. Jahrhunderts unter Mitwirkung des Bischofs von Bergamo von Prälaten der städtischen Kirchen, von Kanonikern, Franziskanern und Dominikanern gegründet. 1272 Pinamonte Brembati (gest. 1266), 1273 schriftstellerisch tätiges Mitglied des Dominikanerklosters Santo Stefano, verfaßte im Jahre 1265 die ersten Statuten. 1274 Als Versammlungsraum diente im ersten Jahrhundert nach der Gründung der Chor von S. Vin- cenzo (Abb. 28). Dort wurden in einer Truhe Dokumente und Statuten aufbewahrt. 1275 Spä- ter trafen sich die Mitglieder auch in der Dominikanerkirche Santo Stefano. 1276 An Ein- nahmen flossen der Korporation Hinterlassenschaften, Spenden und gerichtlich verhängte Bußgelder zu. 1277 Sie veranstaltete zudem öffentliche Sammlungen im ganzen Stadtgebiet, hauptsächlich jedoch während der Gottesdienste in S. Vincenzo. 1278 Die Donationen er- folgten in Form von Geld, Land- und Hausbesitz sowie von Naturalien, Wein, Salz, Mehl 1270 Zu den übrigen Bruderschaften s. Little 1988, S. 55-65. Einige standen in enger Verbindung zur Miseri- cordia, z. B. wurden mehrfach ihre Regeln übernommen. Little 1988, S. 60-64. -

Sensation 2009 Il Borro
FreeTimeFreeTimePeriodico di informazione, spettacolo, turismo, moda e cinema Anno VII - n. 1-2009 Sensation 2009 Il carnevale di Venezia cambia volto Sensation 2009 Venice Carnival changes look Il Borro Tradizione e lusso in Toscana Tradition and luxury in Tuscany &REETIMEXPDF 7èè/ "³Ç£{ÎÓ{{{{Ç 1 èè/ ° "³Ç£{ÎÎnÎÎ è "è ,è6° è 1 / ° "°³ÎäÓ°nänä{Î è " 79","-è -*è,- "","è 1 è 1-- ",, < 777° , -°/*è "6è è*" FreeTime Numero uno • gennaio 2009 • Anno VII In copertina: il carnevale di Venezia foto di Ezio Consoli Cover issue: Venice’s carnival photos by Ezio Consoli iniziato un nuovo anno, i cambiamenti sono stati ecclatanti. In as- soluto l’ elezione di Barack Obama, il primo presidente degli Stati Uniti afroamericano, nato a Honolulu Hawaii, da padre africano del Kenya e madre bianca del Kansas. Nei trasporti l’alta velocità rivoluziona il modo di viaggiare: il treno ÈFrecciarossa ETR 500 collega Roma-Milano in 3 ore e 30 senza fermate inter- mediarie. In questo numero parliamo anche del Carnevale più antico del mondo, quello di Venezia che quest’anno cambia volto a partire da Piazza San Marco che per l’occasione si vestirà a nuovo. Poi c’è un servizio dedicato al Capodanno ci- nese che da il via al nuovo anno, dello zodiaco cinese con la scoperta del pro- prio animale, ricordando che quest’anno è l’anno del “bue” e tutte le novità lega- te alla Formula Uno con il relativo calendario. Come sempre si potranno trovare le curiosità dal mondo, le fiere più importanti, le mostre d’arte, ma l’argomento preferito di Freetime e di EPICS è sicuramente la “promozione” del Made in Italy attraverso la presentazione di stilisti, artisti, ar- tigianato e prodotti di qualità del territorio italiano che attraverso il nostro gior- nale hanno la possibilità di essere conosciuti ed apprezzati in tutto il mondo. -

Le Competenze Canonistiche Di Un Civilista Usura, Questione Ebraica E Conflitti Di Giurisdizione Nei Consilia Di Paolo Da Castro
Università degli Studi di Milano – Bicocca Dottorato in Scienze Giuridiche Curriculum in Storia del diritto medievale e moderno Le competenze canonistiche di un civilista Usura, questione ebraica e conflitti di giurisdizione nei consilia di Paolo da Castro Bernardo Pieri Matr. 775150 XXVIII Ciclo – a. a. 2014/2015 INDICE INTRODUZIONE 1. «Qui fu Castro». Vita Pauli per verba magistri p. 5 2. Sui consilia . L’occhio della storiografia 21 3. Giustificazione del lavoro e modus operandi 26 CAPITOLO I Duæ potestates, duæ iurisdictiones, duo fora sunt – una aequitas 0. Agli albori dell’ utrumque ius 45 1. La sistemazione bartoliana 50 2. La posizione di Baldo: tra implicite conferme e stravaganze 53 3. Per alteram viam . I diversi interessi di due grandi politologi del Trecento: Oldrado da Ponte e Lorenzo Ridolfi 58 4. Paolo da Castro tra enunciazione di principio e mobilità della prassi 63 5. Un contenuto etico nella solutio dei responsi? 70 6. Il foro ecclesiastico come estrema risorsa a tutela delle miserabiles personae 76 7. Altri intrecci, nuovi contrasti: il caso spinoso delle legittimazioni e una prospettiva rovesciata 82 1 CAPITOLO II L’usura, oʃʃ ia economia e morale son due cognate 1. Storia di una polemica secolare 93 2. L’intervento del legislatore ecclesiastico: l’usura da peccato di cupidigia a peccatum secundum se 104 3. Prima eccezione al divieto: la liceità dell’interesse 109 4. L’idea di ‘capitale’ secondo l’ œconomia francescana 113 5. I primi, impacciati interventi della dottrina civilistica 121 6. Bartolo da Sassoferrato: tra velleità e reticenze 125 7. Intermedio I . L’usura tra gli ebrei, fra divieti ed esercizio 133 8. -

IL CAPITALE CULTURALE Studies on the Value of Cultural Heritage
2011 IL CAPITALE CULTURALE Studies on the Value of Cultural Heritage JOURNAL OF THE DEPARTMENT OF CULTURAL HERITAGE University of Macerata 2eum Il Capitale culturale Web Studies on the Value of Cultural Heritage http://www.unimc.it/riviste/cap-cult Vol. 2, 2011 e-mail [email protected] ISSN 2039-2362 (online) Editore eum edizioni università di macerata, Centro © 2011 eum edizioni università di macerata direzionale, via Carducci 63/a – 62100 Registrazione al Roc n. 735551 del 14/12/2010 Macerata tel (39) 733 258 6081 Direttore fax (39) 733 258 6086 Massimo Montella http://eum.unimc.it [email protected] Coordinatore di redazione Mara Cerquetti Layout editor Cinzia De Santis Coordinatore tecnico Pierluigi Feliciati Progetto grafi co +crocevia / studio grafi co Comitato di redazione Mara Cerquetti, Francesca Coltrinari, Pierluigi Feliciati, Mauro Saracco, Federico Valacchi Comitato scientifi co - Dipartimento beni culturali Giuseppe Capriotti, Mara Cerquetti, Francesca Coltrinari, Andrea Fantin, Pierluigi Feliciati, Patrizia Dragoni, Claudia Giontella, Susanne Adina Meyer, Massimo Montella, Umberto Moscatelli, Sabina Pavone, Francesco Pirani, Mauro Saracco, Michela Scolaro, Federico Valacchi Comitato scientifi co Michela Addis, Alberto Mario Banti, Carla Barbati, Sergio Barile, Nadia Barrella, Marisa Borraccini, Rossella Caffo, Ileana Chirassi Colombo, Rosanna Cioffi , Claudine Cohen, Lucia Corrain, Giuseppe Cruciani, Stefano Della Torre, Maurizio De Vita, Michela Di Macco, Fabio Donato, Rolando Dondarini, Andrea Emiliani, Gaetano Maria Golinelli, Xavier Greffe, Alberto Grohmann, Susan Hazan, Joel Heuillon, Lutz Klinkhammer, Emanuele Invernizzi, Federico Marazzi, Fabio Mariano, Giuliano Pinto, Marco Pizzo, Edouard Pommier, Adriano Prosperi, Mauro Renna, Orietta Rossi Pinelli, Roberto Sani, Girolamo Sciullo, Simonetta Stopponi, Frank Vermeulen, Stefano Vitali «Il capitale culturale», II (2011), pp. -

L'imago Pietatis E Gli Istituti Di Carità. Problemi Di Iconografia
L’«IMAGO PIETATIS» E GLI ISTITUTI DI CARITÀ Problemi di iconografia A partire dalla seconda metà del Quattrocento, in Italia, il tipo ico- 1 nografico dell’Imago pietatis , la raffigurazione di Cristo morto, ritto nel 1) Il tema iconografico si sviluppò nell’Oriente bizantino, passando in Occidente solo in un secondo tempo, nel corso del XIII secolo. Un primo fattore di diffusione è da collegarsi alla presa di Costantinopoli avvenuta nel 1204, in seguito alla quale una quantità notevole di icone e reliquie affluì nelle terre dei conquistatori. Ulteriore centro di diffusione per l’immagine è poi stata la città di Venezia, assieme al suo territorio, tradizionale ponte di collegamento tra le due aree, al cui ambito risalgono molti tra gli esemplari superstiti più antichi: da quest’area proviene infatti la Croce di Chiaravalle nel cui braccio destro è inserita una pasta vitrea che imita il tipo orientale dell’Akra Tapeinosis (al riguardo: C. Bertelli, La Croce di Chiaravalle, in R. Zorzi [a cura di], Il Re dei Confessori. Dalla croce dei Cloisters alle croci italiane, catalogo della mostra, Milano 1984, p. 130), mentre per quanto riguarda la pittura essa appare in una tavola del Museo di Torcello e nel Trittico di santa Chiara a Trieste. Ed è interessante notare come Venezia sia l’unica località dove talora appare un’Imago pietatis riprendente una tipologia iconografica bizantina, in cui non è inclusa la rappresentazione delle braccia. Oltre alla Croce di Chiaravalle, un secondo esempio si ha in un trittico della collezione Kleiweg de Zwaan all’Aia, pubblicato da H. Van Os (The Discovery of an Early Man of Sorrows on a Domenican Triptych, «Journal of the Warburg and Courtalds Institutes» 41 [1978], pp. -
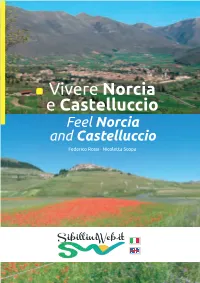
Vivere Norcia E Castelluccio
Castelluccio and Vivere Norcia Norcia e Castelluccio Feel Feel Norcia and Castelluccio Federico Rossi · Nicoletta Scopa Castelluccio e Norcia Vivere Vivere € 7,50 Partner Commerciale - Business Partner Ringraziamenti Special Thanks Trekkingmontiazzurri.com Trekkingmontiazzurri.com for the precious collaboration with per la preziosa collaborazione sulla stesura dei testi dei sentieri the draft of the chapters about the paths Federico Gallieri (Foto Castelluccio di Norcia) Federico Gallieri (Pictures of Castelluccio di Norcia) Marco Lambertucci (Sentiero nr.5 Da Serravalle a Norcia Marco Lambertucci (Path #5 - From Serravalle to Norcia along lungo il tracciato della Ex Ferrovia) the Route of the Ex- Railway) Antonio Galdi (Foto di Castelluccio di Norcia) Antonio Galdi (Pictures of Castelluccio di Norcia) Prodelta (Foto Aeree di Castelluccio di Norcia) Prodelta (Aerial Pictures of Castelluccio di Norcia) I Nursini (Informazioni storiche e territoriali) People from Norcia (Historical and Territorial Information) Amici di Facebook di Sibilliniweb Facebook friends of Sibilliniweb Vogliamo esprimere un sentito ringraziamento a tutte le A sincere thanks goes to all the Touristic Infrastructures and Sibilliniweb.it (Acquisto Online) • Portale Web Informativo dei Monti Sibillini - www.sibilliniweb.it Strutture Turistiche e Guide Escursionistiche per aver con- Hiking Guides that have contributed to the achievement of tribuito alla realizzazione di questo volume. that volume. SibilliniWeb.it dichiara di non aver percepito fondi, sovven- SibilliniWeb.it declares that no resources, subsidy or other zioni o altri finanziamenti se non quelli dei Partner, unita- funds have been collected by them except those coming from Guide e Accompagnatori mente ai mezzi propri. the listed Partners together with their own private resources. -

Rachele Scuro La Presenza Ebraica a Vicenza E Nel Suo Territorio Nel Quattrocento
View metadata, citation and similar papers at core.ac.uk brought to you by CORE provided by Reti Medievali Open Archive Rachele Scuro La presenza ebraica a Vicenza e nel suo territorio nel Quattrocento Estratto da Reti Medievali Rivista, VI-2005/1 (gennaio-giugno) <http://www.dssg.unifi .it/_RM/rivista/atti/ebrei/Scuro.htm> RetiR MedievaliM Ebrei nella Terraferma veneta del Quattrocento Atti del Convegno di studio (Verona, 14 novembre 2003) A cura di di Gian Maria Varanini e Reinhold C. Mueller Firenze University Press Reti Medievali Rivista, VI - 2005/1 (gennaio-giugno) <http://www.dssg.uni .it/_RM/rivista/atti/ebrei/Scuro.htm> RetiR MedievaliM ISSN 1593-2214 © 2005 Firenze University Press La presenza ebraica a Vicenza e nel suo territorio nel Quattrocento di Rachele Scuro 1. I tempi della presenza ebraica a Vicenza nel Quattrocento La presenza ebraica a Vicenza nel medioevo abbraccia poco più di un se- colo, dalla prime sporadiche attestazioni nel territorio nella seconda metà del Trecento sino alla de nitiva espulsione del 1486. Le prime notizie di ebrei nel territorio vicentino si hanno infatti nel 1369 per Lonigo, dove era attivo il banco dell’ebreo padovano Leone di Consiglio da Perugia1, mentre dall’ultimo decennio del Trecento erano certamente pre- senti degli ebrei anche nel capoluogo2; tale situazione è attestata anche da una sentenza dell’Avogaria di Comun veneziana datata 1395, che dimostra come almeno da due anni prima a Vicenza risiedesse ed operasse l’ebreo Abraam di Samuel da Norimberga3. Malgrado queste prime attestazioni tardotrecen- tesche, una presenza più de nita si ha solo a partire dai primi decenni del Quattrocento, quando le fonti permettono di delineare maggiormente i primi ebrei stabilitisi in città, sia in funzione di prestatori, sia come pezzaroli (ven- ditori di vesti ed oggetti usati). -

Römisches Jahrbuch Der Bibliotheca Hertziana
Römisches Jahrbuch der Bibliotheca Hertziana BAND 41 · 2013 / 14 VERÖFFENTLICHUNGEN DER BIBLIOTHECA HERTZIANA MAX-PLANCK-INSTITUT FÜR KUNSTGESCHICHTE ROM HERAUSGEGEBEN VON SYBILLE EBERT-SCHIFFERER UND TANJA MICHALSKY REDAKTION: SUSANNE KUBERSKY-PIREDDA REDAKTIONSASSISTENZ: MARA FREIBERG SIMMEN, CATERINA SCHOLL Die Beiträge des Römischen Jahrbuchs werden einem Peer-Review-Verfahren unterzogen. Bibliographische Informationen der Deutschen Nationalbibliothek: Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliographie; detaillierte bibliographische Daten sind im Internet über http: / / dnb.ddb.de abrufbar. © !"#$ Hirmer Verlag GmbH, München Gestaltung und Satz: Tanja Bokelmann, München Lithographie: ReproLine Genceller, München Druck: Kösel GmbH & Co. KG, Altusried-Krugzell Printed in Germany ISBN %&$-'-$$$(-!&'&-' Philine Helas Kunst und visuelle Präsenz zweier Hospitäler in Rom: Santo Spirito in Sassia und Santissimo Salvatore ad Sancta Sanctorum am Lateran zwischen dem 14. und frühen 16. Jahrhundert Da meine Beschäftigung mit den römischen Hospitälern bereits in die Zeit Patrizia Tosini und Erik Wegerhoff. Eine große Hilfe bei der Transkription meiner Tätigkeit am SFB )"" Fremdheit und Armut. Wandel von Inklu- waren Angelo Restaino und Tobias Daniels. Der Text lag bereits !""% in sions- und Exklusionsformen von der Antike bis zur Gegenwart der Uni- einer ersten Fassung vor, !"## konnte ich einen Teilaspekt in dem Band versität Trier zurückreicht, ist es unmöglich, allen hilfreichen Personen und