Il Progetto Roselle 2018-2020: Gli Scavi Sulla “Tempelterasse”
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Umbria from the Iron Age to the Augustan Era
UMBRIA FROM THE IRON AGE TO THE AUGUSTAN ERA PhD Guy Jolyon Bradley University College London BieC ILONOIK.] ProQuest Number: 10055445 All rights reserved INFORMATION TO ALL USERS The quality of this reproduction is dependent upon the quality of the copy submitted. In the unlikely event that the author did not send a complete manuscript and there are missing pages, these will be noted. Also, if material had to be removed, a note will indicate the deletion. uest. ProQuest 10055445 Published by ProQuest LLC(2016). Copyright of the Dissertation is held by the Author. All rights reserved. This work is protected against unauthorized copying under Title 17, United States Code. Microform Edition © ProQuest LLC. ProQuest LLC 789 East Eisenhower Parkway P.O. Box 1346 Ann Arbor, Ml 48106-1346 Abstract This thesis compares Umbria before and after the Roman conquest in order to assess the impact of the imposition of Roman control over this area of central Italy. There are four sections specifically on Umbria and two more general chapters of introduction and conclusion. The introductory chapter examines the most important issues for the history of the Italian regions in this period and the extent to which they are relevant to Umbria, given the type of evidence that survives. The chapter focuses on the concept of state formation, and the information about it provided by evidence for urbanisation, coinage, and the creation of treaties. The second chapter looks at the archaeological and other available evidence for the history of Umbria before the Roman conquest, and maps the beginnings of the formation of the state through the growth in social complexity, urbanisation and the emergence of cult places. -

Emptyscapes: Filling an 'Empty' Mediterranean Landscape At
Emptyscapes: filling an ‘empty’ Mediterranean landscape at Rusellae, Italy ∗ Stefano Campana Research The Emptyscapes project is an interdisci- plinary programme designed to stimulate new developments in Italian landscape archaeology. It achieves this through the integration of traditional approaches with multidisciplinary studies, to which are added Rusellae the relatively new techniques of large-scale geophysical survey, airborne laser scanning Rome and geo-environmental analysis. The effec- tiveness of such an approach has been borne out by results from central Italy. These show that the underlying ‘archaeological continuum’ can be detected even in an area where archaeological evidence was previously N 0 km 200 thought to be absent. Keywords: Mediterranean, Italy, empty spaces, landscape, archaeological continuum, holistic On one matter there is universal agreement: the appearance of practically every square metre in the Mediterranean today, save a few remote fastnesses, has been altered, directly or indirectly, by the past activity of people (Broodbank 2013: 71). Introduction In Italy, archaeologists have, in the past, concentrated to a large extent on architecture and urbanism, and understandably so in light of the country’s myriad surviving Classical-period monuments. There was, however, a shift in focus towards the investigation of regional multi-period change in the 1950s, not least through the initiatives of the British School at Rome in studying the landscape of south Etruria (Ward-Perkins 1961). More recent research has involved long-term studies drawing heavily on the results of field-walking survey and aerial photography to identify, date and characterise sites, and to record the results of these ∗ Ancient Topography, Landscape Archaeology & Remote Sensing Laboratory, Department of History and Cultural Heritage, University of Siena, Via Roma 56, 53100 Siena, Italy (Email: [email protected]) © Antiquity Publications Ltd, 2017 antiquity 91 359 (2017): 1223–1240 doi:10.15184/aqy.2017.139 1223 Stefano Campana on distribution maps. -

Repertorio Delle Fonti Documentarie Edite. Bibliografia, P
121 Repertorio delle Fonti documentarie edite Tavola delle abbreviazioni A.S.F. = Archivio di Stato di Firenze A.S.S. = Archivio di Stato di Siena A.S.I. = “Archivio di Stato Italiano” B.S.S.M. = “Bollettino della Società Storica Maremmana” B.S.S.M. = “Bollettino Senese di Storia Patria” M.S.S. = “Miscellanea Storica Senese” N.D.I. = “Nuovissimo Digesto Italiano” A.I.I. - Acta Imperii inedita, 1 e 2, E. WINKELMANN (a cura di) MDL IV/2 - Memorie e Documenti per servire all’Istoria del 1880-1885, Innsbruck (ristampa Innsbruck 1964). Ducato di Lucca, T. IV/2 a cura di D. BERTINI, Lucca 1836. A.I.S. - Acta Imperii selecta, J.F. BÖHMER (a cura di) 1870, Innsbruck (ristampa Innsbruck 1967). MDL IV, appendice - Memorie e Documenti per servire all’Isto - ria del Ducato di Lucca, Appendice a cura di D. BER- F. ANICHINI 1751-1752, Storia ecclesiastica della Città e Dio - TINI, Lucca 1836. cesi di Grosseto, A.V. Grosseto, ms n. 1723. M.D.L. V/2 - Memorie e Documenti per servire all’Istoria del C.D.A. - Codex diplomaticus amiatinus, Urkundenbuch der Ducato di Lucca, D. BARSOCCHINI (a cura di) Abtei S. Salvatore am Monteamiata von den Anfän - 1841, Lucca. gen bis zum Regierungsantritt Papst Innocenz III (736-1198), I e II,W. KURZE (a cura di) 1974, 1982, M.G.H. Script. - Monumenta Germaniae Historica, Scriptores, Tübingen. T.VI, PERTZ, G. H. (a cura di), Hannover 1884. C.D.L. - Codice diplomatico longobardo, 1-2, L. SCHIAPAREL- M.G.H. Auct. Ant. - Monumenta Germaniae Historica. -

Chiusi Romana Ricerche Di Prosopografia E Di Storia Socio-Economica
Chiusi romana Ricerche di prosopografia e di storia socio-economica Inaugural-Dissertation zur Erlangung des Doktorgrades der Philosophischen Fakultät der Universität zu Köln im Fach Alte Geschichte, Historisches Institut vorgelegt von Giuliano Caracciolo aus Rom, Italien Köln, den 30. Oktober 2018 Erster Referent: Prof. Dr. Werner Eck Zweiter Referent: Prof. Dr. Gian Luca Gregori A zia Dedé 2 SOMMARIO INTRODUZIONE 5 PARTE I. IL CONTESTO STORICO 1. Etruria romana. Modalità e criteri di espansione territoriale (III-I sec. a.C.) 10 2. Il nuovo ordine politico-amministrativo dopo il bellum sociale 15 2.1. Da municipio a colonia? La questione dello status giuridico di Clusium 20 PARTE II. PROSOPOGRAFIA E SOCIETÀ 1. Elementi di continuità e integrazione culturale nel corso del I sec. a.C. 26 1.1. Genealogie chiusine nella fase di transizione 27 1.2. Mutamenti nella prassi epigrafica 40 1.3. Iscrizioni digrafe e bilingui 43 1.4. Iscrizioni latine della fase di transizione 61 2. I gruppi sociali nella città romana 74 2.1. Senatori 75 2.2. Cavalieri 79 2.3. Magistrati 81 2.4. Militari 83 2.5. Altri gruppi sociali 86 2.5.1. Donne di nascita libera 86 2.5.2. Liberti e schiavi 90 2.6. Clusium e Clusini nel resto dell’Impero 94 3. Vita religiosa. Tradizioni etrusche e culti romani in territorio chiusino 95 4. Chiusi e Roma. Dediche a senatori e tracce della “praesentia Caesaris” 107 5. Chiusi tardoantica 111 5.1. Il complesso ipogeo “misto” di S. Caterina 116 5.2. La catacomba di S. Mustiola e la comunità cristiana 118 PARTE III. -

Download Etruscan Civilization: a Cultural History Free Ebook
ETRUSCAN CIVILIZATION: A CULTURAL HISTORY DOWNLOAD FREE BOOK Sybille Haynes | 432 pages | 01 Sep 2005 | J. Paul Getty Trust Publications | 9780892366002 | English | United States Etruscan cities Early modern. Main article: Etruscan society: Rise of the family. In this, they were different from the surrounding Italics, who had chiefs and tribes. Introduction: A Grammar of Oscan and Umbian. Manchester University Press. Etruscan Civilization: A Cultural History by Hartmann, Thomas Michael. In Mario Torelli ed. This led the Etruscans to ally themselves with Carthagewhose interests also collided with the Greeks. Firenze: All'Insegna del Giglio. Download as PDF Printable version. The mining and commerce of metal, especially copper and ironled to an enrichment of the Etruscans and to the expansion of their influence in the Italian peninsula and the western Mediterranean sea. Populus seems to mean the people assembled in a military body, rather than the general populace. Inscription of Tinia on the Chimera's leg. Main article: Etruscan civilization. Their own name for themselves, however, is the same as that of one of their leaders, Rasenna. Few Etruscan words entered Latinbut the names of at least two of the tribes — Ramnes and Luceres — seem to be Etruscan. BevaniaMaevania. Los Angeles: Getty Trust Publications published He finds Etruscan Etruscan Civilization: A Cultural History one hand genetically related to the Rhaetic language spoken in the Alps north of Etruria, suggesting autochthonous connections, but on the other hand the Lemnian language found on the "Lemnos stele" is closely related to Etruscan, entailing either Etruscan presence in " Tyrsenian " Lemnos, or "Tyrsenian" expansion westward to Etruria. -

Classical Myth-Rom Bklt.Qxd
CLASSICAL MYTHOLOGY : THE ROMANS COURSE GUIDE Professor Peter W. Meineck NEW YORK UNIVERSITY Classical Mythology: The Romans Professor Peter Meineck New York University Recorded Books ™ is a trademark of Recorded Books, LLC. All rights reserved. Classical Mythology: The Romans Professor Peter Meineck Executive Producer John J. Alexander Executive Editor Donna F. Carnahan RECORDING Producer - David Markowitz Director - Matthew Cavnar COURSE GUIDE Editor - James Gallagher Design - Edward White Lecture content ©2005 by Peter Meineck Course guide ©2005 by Recorded Books, LLC 72005 by Recorded Books, LLC Cover image: Statue of Jupiter, Rome © Clipart.com #UT066 ISBN: 978-1-4193-4990-4 All beliefs and opinions expressed in this audio/video program and accompanying course guide are those of the author and not of Recorded Books, LLC, or its employees. Course Syllabus Classical Mythology: The Romans About Your Professor ................................................................................................... 4 Introduction ................................................................................................................... 5 Lecture 1 Mythological Rome ................................................................................ 6 Lecture 2 The Making of Myth: How the Romans Recorded Their Mythology ................................................................................... 11 Lecture 3 Greek Myths and the Romans: Cacus, Hercules, and the Greeks in Italy ............................................................................... -

Some Considerations on the Making and Use of Colours in Etruria During the Middle Orientalising Period Francesco Napolitano
Etruscan Studies Journal of the Etruscan Foundation Volume 10 Article 2 2007 Some Considerations on the Making and Use of Colours in Etruria During the Middle Orientalising Period Francesco Napolitano Follow this and additional works at: https://scholarworks.umass.edu/etruscan_studies Recommended Citation Napolitano, Francesco (2007) "Some Considerations on the Making and Use of Colours in Etruria During the Middle Orientalising Period," Etruscan Studies: Vol. 10 , Article 2. Available at: https://scholarworks.umass.edu/etruscan_studies/vol10/iss1/2 This Article is brought to you for free and open access by ScholarWorks@UMass Amherst. It has been accepted for inclusion in Etruscan Studies by an authorized editor of ScholarWorks@UMass Amherst. For more information, please contact [email protected]. Some Considerations on the Making and Use of Colours in Etruria During the Middle Orientalising Period * by Francesco Napolitano 1. EVIDENCE FROM FUNERARY BUILDINGS n Etruria the earLiest evidence for decorating the interiors of funeraL chambers with coLour dates bacK to the middLe OrientaLising period (680-630 B.C.). This tradition con - Icerns a Limited number of tombs owned by famiLies of the dominant sociaL cLass. The decoration (in some cases found onLy in certain parts of the room ,1 in other cases adorning aLL the waLLs and ceiLings 2) distinguishes these tombs from others of the same ranK 3. 1.1. Colours and materials The coLours empLoyed for tomb waLL decoration, as shown in tabLe 1, are mostLy yeLLow and red. As chemicaL anaLyses have reveaLed, these two coLours come from hydroxide and iron oxide (yeLLow and red ochre) ,4 extracted respectiveLy from Limonite and hematite. -

Climatic and Geographic Influences On
Climatic and Geographic Influences on Ancient Mediterranean Forests and the Lumber Trade Author(s): Ellen Churchill Semple Source: Annals of the Association of American Geographers, Vol. 9 (1919), pp. 13-40 Published by: Taylor & Francis, Ltd. on behalf of the Association of American Geographers Stable URL: http://www.jstor.org/stable/2569572 Accessed: 11-05-2016 22:42 UTC Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at http://about.jstor.org/terms JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. Association of American Geographers, Taylor & Francis, Ltd. are collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Annals of the Association of American Geographers This content downloaded from 132.174.255.116 on Wed, 11 May 2016 22:42:48 UTC All use subject to http://about.jstor.org/terms ANNALS OF THE ASSOCIATION OF AMERICAN GEOGRAPHERS Volume IX, pp 13-37 CLIMATIC AND GEOGRAPHIC INFLUENCES ON ANCIENT MEDITERRANEAN FORESTS AND THE LUMBER TRADE ELLEN CHURCHILL SEMPLE The Mediterranean Basin is,.a climatic unit. It is a. region of winter rains and summer drought, of warn summers and mild winters. The summer drought increases in length and intensity from north to south. The annual precipitation throughout the region as a, whole is relatively scant, but it varies greatly from one district to another. -

Princeton/Stanford Working Papers in Classics
! ! ! ! ! Princeton/Stanford!Working!Papers!in!Classics! ! ! Corpore enormi: the rhetoric of physical appearance in Suetonius and imperial portrait statuary! ! ! Version!1.0! ! ! May!2013! ! ! Jennifer!Trimble! ! ! Stanford!University! ! ! ! Abstract:!This paper explores rhetorical constructions of what the Roman emperor looked like, focusing on the apparently irreconcilable descriptions in Suetonius’ Twelve Caesars and in imperial portrait statues of the same men. ! ! ! ! ©[email protected]! ! ! Corpore enormi: the rhetoric of physical appearance in Suetonius and imperial portrait statuary1 Jennifer Trimble Written for Jaś Elsner and Michel Meyer, eds. Rhetoric and Roman Art. Cambridge University Press (forthcoming). Lenin’s corpse, Caligula’s body Vladimir Ilyich Lenin died in 1924, but his embalmed body has been displayed in a mausoleum in Moscow’s Red Square for almost ninety years (fig. 1). This extraordinary act of preservation makes strong claims about Lenin’s appearance. In his memoir about caring for the body, Ilya Zbarsky explains that the embalmers did not try to make Lenin look younger (he was 53 when he died), more handsome, stronger or in some other way better than life. The point was to make him better than death.2 They tried to prevent signs of decomposition and produce a lifelike appearance of sleep. This mattered most for the visible parts of the body, the head and hands. Early work focused on reversing the corpse’s greenish-gray color and plumping up the shriveled ears; false eyeballs kept the eyes from appearing too sunken; the eyelids and mouth were sewn shut.3 Anything below the visible surface was fair game for transformation; not least, the entire body was regularly immersed in a mix of glycerine and potassium acetate. -
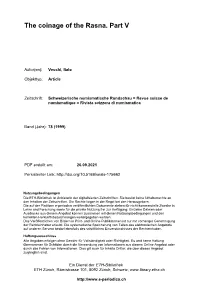
The Coinage of the Rasna. Part V
The coinage of the Rasna. Part V Autor(en): Vecchi, Italo Objekttyp: Article Zeitschrift: Schweizerische numismatische Rundschau = Revue suisse de numismatique = Rivista svizzera di numismatica Band (Jahr): 78 (1999) PDF erstellt am: 26.09.2021 Persistenter Link: http://doi.org/10.5169/seals-175662 Nutzungsbedingungen Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern. Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber. Haftungsausschluss Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind. Ein Dienst der ETH-Bibliothek ETH Zürich, Rämistrasse 101, 8092 Zürich, Schweiz, www.library.ethz.ch http://www.e-periodica.ch -

Etruscans, Migrated from Undetermined Regions and Caused the Decline of Etruscan Power
Table of Contents Legendary Etruria . 5 Etruscan City-States . 6 Etruria’s Origins . 7 Etruria’s Literature . 8 Time Capsule Tombs. 9 Masters of the Sea . 10 Religion . 11 Tombs . 12 Economy . 13 Architecture & the Lively Arts . 14 Weapons & Dress . 16 Technology . 17 Etruria’s Time Line . 18 A Collage Map of Etruria . 20 Grid Map . 22 City-State Labels . 23 Etruscan Facts Scrapbook . 24 An Etruscan Trading Ship . 25 Tomb Site Fact Cards . 27 Ship Patterns . 29 Terra-Cotta Alphabet Tablet . 30 Time Capsule Treasure Box . 31 Etruscan Alphabet . 33 Paint a Story . 34 Design Bucchero Pottery. 35 Repeating Patterns. 37 Design a Medallion Paperweight . 39 Bucchero Pottery Forms . 40 Design a Temple . 41 Oatmeal Box Chariot. 42 Temple Patterns . 43 Aluminum Foil Jewelry. 44 Jewelry Forms . 46 Architectural Designs . 47 TLC10354 Copyright © Teaching & Learning Company, Carthage, IL 62321-0010 iii Legendary Etruria Drawing by Marilynn G. Barr. ong ago, the region on the northwestern coast of Etruria grew and flourished for nearly 300 years. It the Italian peninsula, known today as Tuscany, was a confederacy made up of 12 city-states: Arretium Lwas called Etruria. Etruria was just north of Rome (Arezzo), Caere (Cerveteri), Clusium, Cortona, and included the famous cities of Florence and Pisa. Perusia (Perugia), Populonia, Rusellae, Tarquinii It’s geographical boundaries were the Arno and Tiber (Tarquinia), Veii (Veio), Vetulonia, Volaterrae Rivers, the Apennines Mountains and the Tyrrhenian (Volterra) and Vulci. Foreign invasions, war, disease Sea. Scholars believe the people of Etruria, called and the lack of political unity between the city-states Etruscans, migrated from undetermined regions and caused the decline of Etruscan power. -

The First Archaeological Season at Podere Cannicci (Civitella Paganico - GR)
The Journal of Fasti Online (ISSN 1828-3179) ● Published by the Associazione Internazionale di Archeologia Classica ● Palazzo Altemps, Via Sant'Appolinare 8 – 00186 Roma ● Tel. / Fax: ++39.06.67.98.798 ● http://www.aiac.org; http://www.fastionline.org The First Archaeological Season at Podere Cannicci (Civitella Paganico - GR) Alessandro Sebastiani - Fabiana Fabbri - Valentina Trotta and Edoardo Vanni The aim of this paper is to present the preliminary results of the first archaeological season (May-June 2017) at the ar- chaeological site of Podere Cannicci (Civitella Paganico – GR). The excavations focused on a new small portion of a Ro- man settlement, previously investigated by the Soprintendenza Archeologia Toscana in the 1990s. The research revealed the existence of other functional spaces belonging to the settlement, which was interpreted as the pars rustica of a villa. Our research brought to light a blacksmith’s workshop and some other facilities that were in use between the 3rd c. BC and the years of the Second Civil War (beginning of the 1st c. BC). The paper also offers a reassessment of the archaeological data of the earlier excavation seasons (1989-1990), as well as a preliminary overview of the territory of Civitella Paganico in the Roman period. Introduction During the last part of the month of May and the first two weeks of June 2017, the 1st archaeological sea- son at Podere Cannicci took place under the umbrella of the IMPERO (Interconnected Mobility of People and Economies along the River Ombrone) Project. The excavations were carried out by the Department of Archae- ology of the University of Sheffield (UK), in collaboration with Michigan State University (USA) and the Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Siena, Grosseto e Arezzo.