Conferenza Finale: L’Indice Di Funzionalità Fluviale Come
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Il Sile: I Mulini Nella Storia
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA FACOLTÀ DI LETTERE E FILOSOFIA. Il Sile: i mulini nella storia. Tesi di laurea triennale in storia e tutela dei beni culturali. Matteo Grespi 555914 STB INTRODUZIONE. Il Sile (…) mormora, ride, scroscia, incupisce, spumeggia, sempre caro al cuore di tutti quelli che li sono affezionati, che lo conoscono da quando, bambini, si rincorrevano sulle sue rive, o gittavano sassi appiattiti nelle sue onde per vederli rimbalzare (Zago, 1932 p. 945). Il sole radente illuminava la distesa dei canneti brillanti di verde e in mezzo l‟acqua vitrea, profonda e lenta andava fino ad una svolta lontana. Una barca a remi scendeva con la corrente e un‟altra si internò tra i canneti, da questa scesero a terra due uomini che la portarono in secca e la capovolsero sulla riva (Comisso, 1935 p. 49). L‟oggetto di questa tesi è un preciso contesto storico-geografico vicino al paese in cui vivo. Nella prima parte tratto in generale l‟aspetto storico-geografico di questo fiume di risorgiva e, di conseguenza, individuo i rapporti tra l‟uomo e il territorio nel corso della storia. Nella seconda parte, più specifica, la scala geografica si restringe a Quinto di Treviso e ai suoi mulini, che nel corso dei secoli hanno avuto un‟ importanza vitale per la storia della Serenissima. La scelta dell‟argomento specifico dei mulini di Quinto è stata motivata anche dalla mancanza di studi approfonditi riguardo questa realtà. Questa tesi è articolata in tre capitoli: il primo tratta la geografia del Sile, il secondo la storia e il terzo Quinto e i suoi mulini. -
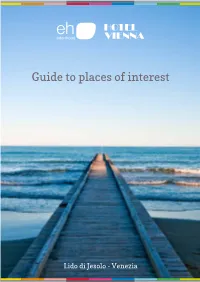
Guide to Places of Interest
Guide to places of interest Lido di Jesolo - Venezia Cortina Oderzo Portogruaro Noventa di Piave Treviso San Donà di Piave Caorle Altino Eraclea Vicenza Jesolo Eraclea Mare Burano Cortellazzo Lido di Jesolo Dolo Venezia Verona Padova Cavallino Mira Cà Savio Chioggia Jesolo and the hinterland. 3 Cathedrals and Roman Abbeys . 10 Visits to markets Concordia Sagittaria, Summaga and San Donà di Piave Venice . 4 From the sea to Venice’s Lagoon . 11 St Mark’s Square, the Palazzo Ducale (Doge’s Palace) and the Caorle, Cortellazzo, Treporti and Lio Piccolo Rialto Bridge The Marchland of Treviso The Islands of the Lagoon . 5 and the city of Treviso . 12 Murano, Burano and Torcello Oderzo, Piazza dei Signori and the Shrine of the Madonna of Motta Verona and Lake Garda. 6 Padua . 13 Sirmione and the Grottoes of Catullo Scrovegni Chapel and Piazza delle Erbe (Square of Herbs) The Arena of Verona and Opera . 7 Vicenza . 14 Operatic music The Olympic Theatre and the Ponte Vecchio (Old Bridge) of Bas- sano del Grappa Cortina and the Dolomites . 8 The three peaks of Lavaredo and Lake Misurina Riviera del Brenta . 15 Villas and gardens The Coastlines . 9 Malamocco, Pellestrina, Chioggia 2 Noventa di Piave Treviso San Donà di Piave Eraclea Caorle Jesolo Eraclea Mare Lido di Jesolo Cortellazzo Cavallino Jesolo and the hinterland The lagoon with its northern appendage wends its way into the area of Jesolo between the river and the cultivated countryside. The large fishing valleys of the northern lagoon extend over an area that is waiting to be explored. Whatever your requirements, please discuss these with our staff who will be more than happy to help. -

Casale Sul Sile V I Tesori Del I Tesori Parco
Capitello GiraSile Punto Fabbricato Antico passo Il territorio del Votivo panoramico rurale a barca non (percorso significativo più in uso ciclopedonale) Parco del Sile Nuclei GiraSile Mulino boscati Ponte Punto di storico significativi rilevante accesso (sentieri pedonali) al Parco i Tesori del Parco Viabilità ordinaria di collegamento con Ponte o i Borghi del Parco Chiesa Albero Passerella Parcheggio secolare scambiatore auto/bici Vascon Conegliano GiraSile, la greenway del Parco del Sile n Silea rbon via Ne via Roma vi cade a P via Ron aris Bo rd 200 mt one v ia St orta zia i 0 r o G via via Cen don Villa Valier Battaggia autostrada A27 uscita Treviso Sud 7 A2 Casier via Malviste via Cendon Villa Barbaro Roman 7 A2 o r iet P San ia v tiera n a P ia v via San olino t’El a M ena vi ( via l oc alità Malviste Ex Cave Ce nd di Casier e Silea on) iera via pant via P rin icip 1 a Cendon le ello aci it p orn Ca o F via icol v e 2 b Torr via Co via via Claudia Au lot ti Basse di Cendon e Lughignano gusta 3 via Po zzetto 4 sa via ie h C San o an n t’ ig Ele Lughignano vi h via Pozzetto a Nu n ro Lug a (l e ia ova Tr v o imit ca a C e l zie vi it vi ra gia à elle G n San via d a Lughig t’E lena) nan o S.Elena 7 A2 Basse di illotto S.Elena nscio Chiesa Anc o via Co in nn ia G via 5 via Ceroico i via tovan 7 V via Man A2 e c c h no i a a n T ghig r u e o L v sc i o g via B i a n a C a sal Villa Mantovani-Orsetti Ex Oasi e 6 a di S.Elena via Bigone Ex Cave di Rivalta Casale sul Sile Villa della Celestia ivalta via R 7 A2 ave via delle C e via M Casal . -

CASALE Sul Sile in FORMA GIORNALINO SEMESTRALE DEL COMUNE DI CASALE SUL SILE
N.02 Comune di dicembre Casale sul Sile 2019 CASALE sul sile IN_FORMA GIORNALINO SEMESTRALE DEL COMUNE DI CASALE SUL SILE www.comunecasale.tv.it Silent Sile dei sogni, ma semplicemente stru- dobbiamo essere consapevoli: gli menti per governare che ci permet- Amministratori passano, per quanto tano di decidere. Vogliamo essere facciano del loro meglio, ma i veri a ąanco di Imprese, Associazioni protagonisti rimangono sempre i Cit- e Cittadini e non essere per loro tadini. E secondo noi questa è la stra- un freno. Siamo pronti a elaborare da giusta per riavvicinare le persone proposte di leggi semplici e coeren- alla gestione della cosa pubblica, un ti con i punti sopra esposti. Siamo modo concreto per formare nuovi interlocutori istituzionali afądabili: Amministratori Civici che vogliano per questo chiediamo l’integrazione rendersi disponibili per un momen- della Commissione Parlamentare per taneo servizio civico nell’esclusivo le questioni regionali con i Rappre- interesse della Comunità. La strada è sentanti dei Comuni, Province, Città aperta a tutti! Metropolitane e Regioni, come sede Per dare un’ulteriore prova di questi di raccordo parlamentare fra tutte le nostri intendimenti, come Ammini- Istituzioni costitutive della Repubbli- strazione abbiamo deciso di prendere ca in attuazione dell’articolo 11 della una posizione più diretta nella gestio- legge costituzionale 3/2001”. ne dell’Ente Pubblico “Acque Risorgi- E ancora: “Il tema delle risorse ąnan- ve”, che da anni si occupa dell’assetto ziarie è essenziale per assicurare il buon -

Asparago Bianco Del Sile
Atlante dei prodotti agroalimentari tradizionali del Veneto PRODOTTI VEGETALI ALLO STATO NATURALE O TRASFORMATI ASPARAGO BIANCO DEL SILE Eventuali sinonimi e termini dialettali quisto effettuate per conto dei dogi veneziani nella Usi Asparago bianco del Sile, asparago del Sile. prima metà del ‘500. Tuttavia la coltivazione risale L’asparago è noto per le sue caratteristiche diure- a molto tempo prima, infatti alcuni documenti di tiche. È consigliabile cucinarlo a vapore in modo fi ne 1400 testimoniano che l’usanza di legare gli da ridurre al minimo il rischio di perdita dei valori asparagi in mazzetti era diffusa ancor prima della nutritivi e per conservarne intatto il sapore. scoperta dell’America. In Veneto questo ortaggio ha trovato un ambiente ideale per la sua coltiva- Reperibilità zione. Il prodotto è disponibile da fi ne marzo a giugno, re- peribile in tutti i mercati della provincia di Treviso. Descrizione del prodotto L’asparago presenta una colorazione bianco-avorio Territorio interessato alla produzione con eventuale lieve colorazione rosa sui turioni Provincia di Treviso nei comuni di: Vedelago, Mor- e punta compatta. I turioni si devono presentare gano, Quinto di Treviso, Zero Branco, Treviso, Si- interi, sani, privi di danni, puliti, di aspetto fresco, lea, Casier, Casale sul Sile, Preganziol, Mogliano esenti da parassiti, privi di ammaccature, privi di Veneto, Istrana e in parte del comune di Resana. odore e/o sapore estranei; il taglio alla base del tu- rione deve essere perfettamente perpendicolare all’asse maggiore; possono presentarsi lievemen- te incurvati. La lunghezza dei turioni è compresa tra 12 e 22 cm, il calibro è compreso tra gli 8 e i 20 mm. -

The Operating Venetian Lagoon: the Agency of Barene
The Operating Venetian Lagoon: The Agency of Barene. A resilient landscape infrastructure towards cultural, ecological and productive heritage preservation. Amina Chouairi, Student, Delft Technical University [email protected], [email protected] (+39) 339 8853874 Foulkeslaan 82 Delft, NL 2625RA Abstract This paper presents and discusses a research (by design) conducted during a Landscape Architecture Master thesis on the Venetian Lagoon, North of Italy - a territory in constant transition, presenting a landscape of delicate equilibrium, threatened by the combined effects of climate change and consequently sea level rise on one side and human actions on the other (as the extreme flooding event of November 2019 demonstrates). The research aims to seek for ways how to mitigate the above-mentioned threats by providing nature-based solutions. Therefore, it is necessary to address crucial issues as the Venetian Lagoon hydro-morphological sufferance, the over-engineered flood defence design and the state of neglect of its secondary islands. Secondary objectives the research takes in consideration are habitats restoration, creation of alternative forms of slow-tourism, enrichment of local community livelihood and economical vibrancy, and enhancement of the cultural image of the Venetian Lagoon as a stretched, unceasing water surface consisting of a diffuse sense of horizontality. From the conducted research, what emerges is the need for redefining the role of the entire Venetian Lagoon in the next future, shifting it from passive to active, from being exploited and consequently damaged, to be able to mitigate future impacts sustainably without losing the spatial characteristics of its territory. To do so, the main strategy proposed is to reinforce the barene landscape - fundamental for the hydro-morphological and ecological survival of the lagoon. -

Flybevenicecruising-1
Inspiration FOR A FAMILY BREAK WITH A DIFFERENCE, ROBIN MCKELVIE CLIMBED ABOARD A MOTORBOAT AND EXPLORED THE WATERWAYS IN AND AROUND VENICE Water world n a city that lives and breathes our Magnifique Class cruiser. We were armed Our first day saw us enjoy a short, stately water, there really is only one way with a crew of four adults, one teenager and amble down the sleepy River Sile in search of I to get around. I’ve spent many trips three very excited small girls, two of them my Casale sul Sile, an appositely-soporific village exploring the Venetian Lagoon by ferry and daughters, 10-year-old Tara and seven-year-old where we found more swans than people gondola, but this adventure was different. Emma. idling by the waterfront. This bountiful I was at the helm of our own motorboat, The Magnifique name proved an apt one wildlife was something that became nigh chugging through the Divine Republic on a as I’m used to the relative privations of a ever-present as the week unfurled in a swathe week-long voyage that brought out the best narrow yacht or longboat. This was a whole of flora and fauna. Even moored in the heart in Venice. It also revealed a surprising world different kettle of Adriatic fish, as our aquatic of the city of Venice, it wasn’t long before we of sleepy rivers, riotously-fun beach resorts chariot for exploring this corner of northern spotted one of the ubiquitous shags – or was it and a swathe of wildlife, including egrets Italy came with lashings of space. -
Carta Nautica Provincia Di VENEZIA Di Laguna in Laguna
Di laguna in laguna: le carte nautiche della provincia di Venezia Provincia di Venezia - Assessorato al turismo www.turismo.provincia.venezia.it Azienda di Promozione Turistica della Provincia di Venezia Ambito Turistico di Venezia www.turismovenezia.it Ambito Turistico di Bibione e Caorle www.bibionecaorle.it www.caorleturismo.it Ambito Turistico di Jesolo ed Eraclea www.turismojesoloeraclea.it Ambito Turistico di Chioggia www.chioggiatourism.it Le vie navigabili nella Provincia di Venezia Nel territorio tra il Delta del Po e la Laguna di Caorle si estende un’ampia area costiera, che spesso è conosciuta dai visitatori della regione soltanto per la presenza di una città famosa come Venezia. Tuttavia l’intera fascia costiera merita di essere scoperta, se si vuole conoscere il vero volto delle isole e dei paesaggi lagunari e fluviali. La costa dell’Adriatico Settentrionale assunse definitivamente la forma attuale circa seimila anni fa quando, tra il Delta del Po e il Carso friulano, si formò una catena di dune costiere che limitavava vaste lagune spesso sommerse dai fiumi. Gli etruschi furono i primi a scavare canali per creare vie di navi- gazione artificiali all’interno della linea costiera. In questo modo era possibile navigare anche in condizioni di cattivo tempo. I romani in seguito proseguirono questi lavori, amplian- do la rete dei fiumi e dei canali da Ravenna sino ad Aquileia in Friuli, e iniziarono un’opera di bonifica dei territori paludosi attorno alle lagune. Testimonianze di questi interventi si ritrovano in Romagna e ad est di Padova nel cosiddetto “Decumano”. Con la caduta dell’impero romano le vie d’acqua furono utilizzate molto poco, anche perché una parte della popolazione si era rifu- giata direttamente sule piccole isole della laguna dove ora sorge Venezia. -

02-Esterna Risorgive Morgano B
REGIONE VENETO Come arrivare Come arrivare ASSESSORATO AI PARCHI Il Parco del Sile può essere alle Risorgive: a Morgano: E AREE NATURALI PROTETTE raggiunto tramite: www.parchiveneto.it Autostrada: A27 VE-BL, uscita da Treviso SR53 (Castellana); a da Treviso SR53; a Paese Assessore Mogliano Veneto o Treviso Sud. Flavio Silvestrin Vedelago dirigersi verso la SP79; a Quinto di Treviso SP5 Milano Padova Aeroporti: Antonio Canova (TV) frazione di Casacorba; da e girare in via S. Martino Venezia Marco Polo (VE) Casacorba imboccare via Santa direzione Badoere. Parco Naturale DOV’È PARCO NATURALE Bologna Viabilità ordinaria: da Treviso Brigida seguendo le indicazioni REGIONALE DEL IL PARCO SP17 in direzione Quinto, da Padova Venezia “Sorgenti del Sile”. IL PARCO FIUME SILE Regionale del Fiume Sile Venezia SS13 in direzione E I SUOI COMUNI GIA’ CHE CI SIETE www.parks.it/parco.fiume.sile/ Treviso. Presidente DEL SILE ENTE PARCO VISITATE IL PARCO Alberto Magaton 2. The GiraSile between Resurgences and Morgano NATURALE E LE SUE OASI! 2. Il GiraSile tra le Risorgive e Morgano REGIONALE DEL per visite guidate a piedi, in bicicletta, in canoa, in PROVINCIA DI TREVISO The track winds through a territory, which is very particular in his enviroinment and his culture. The FIUME SILE Il percorso si snoda lungo un territorio che presenta diverse specificità ambientali e culturali. La Villa Letizia barca, in ‘pantana’ : www.provincia.treviso.it vegetation of the plain (fig. a), the stable field and the peat bog represent the tipical landscape of Presidente vegetazione planiziale con il grande albero patriarca noto come “la grande Quercia” (fig. -

The Roman City of Altinum, Venice Lagoon, from Remote Sensing and Geophysical Prospection
See discussions, stats, and author profiles for this publication at: https://www.researchgate.net/publication/280716715 The Roman City of Altinum, Venice Lagoon, from Remote Sensing and Geophysical Prospection Article in Archaeological Prospection · August 2015 DOI: 10.1002/arp.1520 CITATIONS READS 0 109 6 authors, including: Paolo Mozzi Alessandro Fontana University of Padova University of Padova 71 PUBLICATIONS 419 CITATIONS 64 PUBLICATIONS 384 CITATIONS SEE PROFILE SEE PROFILE Francesco Ferrarese Stefano Campana University of Padova Università degli Studi di Siena 39 PUBLICATIONS 112 CITATIONS 89 PUBLICATIONS 254 CITATIONS SEE PROFILE SEE PROFILE Some of the authors of this publication are also working on these related projects: Master di secondo livello (EQF 8) in GIScience and Unmanned System for the integrated management of the territory and the natural resources - with majors View project All in-text references underlined in blue are linked to publications on ResearchGate, Available from: Alessandro Fontana letting you access and read them immediately. Retrieved on: 10 November 2016 Archaeological Prospection Archaeol. Prospect. 23,27–44 (2016) Published online 3 August 2015 in Wiley Online Library (wileyonlinelibrary.com) DOI: 10.1002/arp.1520 The Roman City of Altinum, Venice Lagoon, from Remote Sensing and Geophysical Prospection PAOLO MOZZI1*, ALESSANDRO FONTANA1, FRANCESCO FERRARESE2, ANDREA NINFO1, STEFANO CAMPANA3 AND ROBERTO FRANCESE4,5 1 Dipartimento di Geoscienze, Università di Padova, Padova, Italy 2 Dipartimento di Scienze Storiche, Geografiche e dell’Antichità, Università di Padova, Padova, Italy 3 Faculty of Classics, University of Cambridge, United Kingdom 4 Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale, Sgonico, Italy 5 Dipartimento di Fisica e Scienze della Terra, Università di Parma, Parma, Italy ABSTRACT Geophysical prospection on 14 ha integrates the processing and interpretation of vertical multispectral and oblique aerial images for uncovering the archaeology of the Roman city of Altinum. -

SILE JAZZ X Edizione the GREEN RIVER 4 Giugno - 25 Luglio 2021
SILE JAZZ X edizione THE GREEN RIVER 4 giugno - 25 luglio 2021 Torna il Jazz sulle rive del fiume silenzioso: nei weekend di giugno e luglio si alza il sipario sul Festival Sile Jazz. 19 appuntamenti in 14 comuni e tre province, Treviso, Padova e Venezia, con la di new entry Jesolo Protagonisti di questa decima edizione sono la sostenibilità ambientale, le bellezze artistiche e naturali del territorio, insieme al grande Jazz internazionale che torna sulla scena: con FORQ, Barionda, ZZ Quartet, Thomas Siffling, Jussi Fredriksson Trio, Leonardo de Lorenzo, e molti altri (Treviso, 25 maggio 2021) La decima edizione di Sile Jazz è pronta a partire. Nei weekend dal 4 giugno al 25 luglio torna la rassegna di Jazz che porta la grande musica dal vivo lungo le sponde del fiume Sile. 19 concerti in 14 comuni tra le province di Treviso, Padova e Venezia, uniti dallo scorrere del “fiume silenzioso”: i comuni del trevigiano Quinto di Treviso, Casier, Silea, Roncade, Casale Sul Sile, Istrana, Morgano, Treviso, Mogliano Veneto, Vedelago, Zero Branco, Preganziol, fino a Padova con Piombino Dese, sfociando a Venezia, con la nuova partecipazione del Comune di Jesolo. Un festival che non si è mai fermato e che ritorna anche nel 2021, riportando in Veneto la scena musicale internazionale con artisti da tutta Europa, tra cui Barionda (Italia/Austria/Argentina) Maris Briezkalns Quintet (Lettonia) Thomas Siffling (Germania) ZZ Quartet (Italia/Croazia/Germania/Slovenia) Jussi Fredriksson Trio (Finlandia), e dagli Stati Uniti con l’attesissima data dei Forq. Insieme, come sempre, ad alcuni tra i migliori talenti italiani, come Solaris, Leonardo De Lorenzo, Luca Falomi, Max Trabucco, John de Leo, e giovani artisti (Anais Drago, EmAb Connection, Pericopes+1, Ferdinando Romano) protagonisti con progetti avventurosi e originali, che testimoniano la straordinaria stagione creativa del jazz italiano e l’attenzione costante del festival alle nuove proposte. -

Il Porto Di Altinum
Margherita Tirelli IL PORTO DI ALTINUM L'esistenza ad Altino di uno scalo portuale attivo gia alla fine del VI sec. a.C., e quindi di un porto nell'abitato veneto, e un dato da tempo acquisito grazie a rinvenimenti in particolare di ceramica attica e italiota (1). Ma la reale dimensione emporica dell' Altino veneta sta delineandosi con precisione solo in quest'ultimi anni a seguito del rinvenimento di un'area sacra di ecceziona le interesse, la cui frequentazionesembra iniziare alla fine del VI sec. a.C. (2). I materiali votivi rinvenuti all'interno della stipe, attestando il convergere nel santuario altinate di manufatti, provenienti dall'area greca, magnogreca, etru sca e celtica, evidenziano infatti il ruolo egemone, nello smistamento di traf fici e commerci tra l'entroterra veneto e l'orizzonte mediterraneo, del centro lagunare nel quale sembrerebbe individuabile il porto principale dei Veneti in eta protostorica. La successiva evoluzione dello scalo in centro portuale e commerciale di ben piu vaste proporzioni risulta strettamente conseguente all'interesse di Roma di promuovere una politica marittima nell'alto Adriatico, manifestato si a partire dal II sec. a.C. (3). Puntuali valutazioni dovettero presiedere alla scelta del centro altinate: innanzitutto la posizione strategica di Altino, porto sicuro all'interno della gronda lagunare veneta, situato a breve distanza clal mare, a meta della rotta che congiungeva Ravenna ad Aquileia, rotta che si suppone attivata con una certa regolarita a partire dagli anni immediatamen te successivi il 181 a.C., fondazione della colonia aquileiese. Tale ipotesi trova puntuale riscontro nell'avvio ad Altino di un processo di romanizzazione che si sta rivelando ben pii:1 precoce di quanto finora sup posto (4), i cui primi esiti monumentali, consistenti significativamente come vedremo proprio in impianti portuali, si inquadrano cronologicamente nella (1) Si rimanda da ultima a CAPu1s 1996, e quindi a BoNoM1 c.s.