Studi E Ricerche
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-
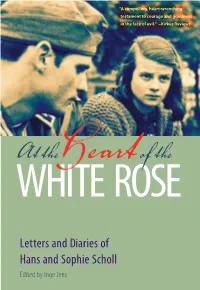
At the Heart of the White Rose: Letters and Diaries of Hans and Sophie
“A compelling, heart-wrenching testament to courage and goodness in the face of evil.” –Kirkus Reviews AtWHITE the eart ROSEof the Letters and Diaries of Hans and Sophie Scholl Edited by Inge Jens This is a preview. Get the entire book here. At the Heart of the White Rose Letters and Diaries of Hans and Sophie Scholl Edited by Inge Jens Translated from the German by J. Maxwell Brownjohn Preface by Richard Gilman Plough Publishing House This is a preview. Get the entire book here. Published by Plough Publishing House Walden, New York Robertsbridge, England Elsmore, Australia www.plough.com PRINT ISBN: 978-087486-029-0 MOBI ISBN: 978-0-87486-034-4 PDF ISBN: 978-0-87486-035-1 EPUB ISBN: 978-0-87486-030-6 This is a preview. Get the entire book here. Contents Foreword vii Preface to the American Edition ix Hans Scholl 1937–1939 1 Sophie Scholl 1937–1939 24 Hans Scholl 1939–1940 46 Sophie Scholl 1939–1940 65 Hans Scholl 1940–1941 104 Sophie Scholl 1940–1941 130 Hans Scholl Summer–Fall 1941 165 Sophie Scholl Fall 1941 185 Hans Scholl Winter 1941–1942 198 Sophie Scholl Winter–Spring 1942 206 Hans Scholl Winter–Spring 1942 213 Sophie Scholl Summer 1942 221 Hans Scholl Russia: 1942 234 Sophie Scholl Autumn 1942 268 This is a preview. Get the entire book here. Hans Scholl December 1942 285 Sophie Scholl Winter 1942–1943 291 Hans Scholl Winter 1942–1943 297 Sophie Scholl Winter 1943 301 Hans Scholl February 16 309 Sophie Scholl February 17 311 Acknowledgments 314 Index 317 Notes 325 This is a preview. -
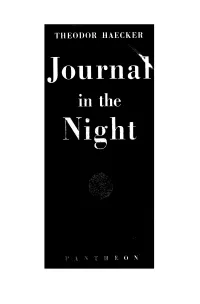
Journalinthenigh009030mbp.Pdf
3.50 JOURNAL IN THE NIGHT By THEODOR HAECKER Edited and translated^ with an introduction by AIJCK DRU Haecker, a German philosopher and re- ligious thinker, tran.slator of 'Kierkegaard and Newman, was deeply concerned with the harmony of faith and reason. This is the central theme of the Journal. Con- verted to Catholicism in 1920, Haecker was among the few who immediately recognized the character of ihe Nazi re- gime. He published his first article at- tacking it at the moment in which Hitler came to power. In consequence, he was arrested and, after his release, forbidden to lecture or to broadcast. His Journal was written at night, arid the pages hidden, as they were written, in a house in the country. This book, reminiscent in form of Pascal's Pensees, is his last testimony to the Lruth and a confession of faith that is a spon- taneous rejoinder to a particular moment in history. It is "written by a man intent, by nature, on the search for truth, and driven, by circumstance, to seek for it in anguish, in solitude, with an urgency that grips the reader. JACQUES MARATAIN on TUKODOR HAECKKK: Theodor Haecker was a man of deep in- a sight qnd rare intellectual integrity f "Knight of Faith" to use Kierkegaard s expression. The testimony of this great Christian has an outstanding value. I thank Pantheon Rooks for making so mag- nanimoits and* moving a work as his diary available to ^ American reader. DDD1 DS7t,fl 68-09952 193 H133J 193 H133J 68-09952 Haecker $3*50 Journal in the night Missouri gUpM lunsjs city, ** only Books will b2 issued of library card. -
The White Rose in Cooperation With: Bayerische Landeszentrale Für Politische Bildungsarbeit the White Rose
The White Rose In cooperation with: Bayerische Landeszentrale für Politische Bildungsarbeit The White Rose The Student Resistance against Hitler Munich 1942/43 The Name 'White Rose' The Origin of the White Rose The Activities of the White Rose The Third Reich Young People in the Third Reich A City in the Third Reich Munich – Capital of the Movement Munich – Capital of German Art The University of Munich Orientations Willi Graf Professor Kurt Huber Hans Leipelt Christoph Probst Alexander Schmorell Hans Scholl Sophie Scholl Ulm Senior Year Eugen Grimminger Saarbrücken Group Falk Harnack 'Uncle Emil' Group Service at the Front in Russia The Leaflets of the White Rose NS Justice The Trials against the White Rose Epilogue 1 The Name Weiße Rose (White Rose) "To get back to my pamphlet 'Die Weiße Rose', I would like to answer the question 'Why did I give the leaflet this title and no other?' by explaining the following: The name 'Die Weiße Rose' was cho- sen arbitrarily. I proceeded from the assumption that powerful propaganda has to contain certain phrases which do not necessarily mean anything, which sound good, but which still stand for a programme. I may have chosen the name intuitively since at that time I was directly under the influence of the Span- ish romances 'Rosa Blanca' by Brentano. There is no connection with the 'White Rose' in English history." Hans Scholl, interrogation protocol of the Gestapo, 20.2.1943 The Origin of the White Rose The White Rose originated from individual friend- ships growing into circles of friends. Christoph Probst and Alexander Schmorell had been friends since their school days. -

Journal of the Union Faculty Forum
Journal of the Union Faculty Forum A Publication of the Union University Faculty Forum Vol. 30 Fall 2010 Faculty Forum President’s Letter Greetings Union University Faculty! It is a great privilege to be able to serve as your Union University Faculty Forum President for the 2010-2011 academic year. I encourage you to actively participate in this organization that was created, “to provide a means for the faculty to express its interests and concerns to The Greater Faculty and the Provost, and to make recommendations about issues affecting Union University.” Last year, the membership made valuable inquiries and suggestions in matters involving facilities and equipment, student testing services, academic and University policies, technology, and fringe benefits. Your participation will ensure that faculty voices continue to be heard, and that we can provide input that supports our core values of being Excellence-Driven, Christ-Centered, People-Focused, and Future-Directed. The Faculty Forum is also pleased to provide a vehicle to share the scholarship and creative endeavors of our faculty via The Journal of the Union Faculty Forum (JUFF). Thanks to Melissa Moore and Jeannie Byrd, who served as co-editors of JUFF this year. We are also grateful to University Services and Provost Carla Sanderson who provided logistical and financial support, respectively, for JUFF. If you were not among the JUFF contributors this year, please plan now to contribute to this forum of ideas in next year’s publication. In addition to the JUFF editors, I would like to thank our other 2010-2011 Faculty Forum officers, Gavin Richardson, Vice President, and Terry Weaver, Secretary. -

Theodor Haeckers Christliches Menschenbild Im Kontext Des Kulturkatholizismus
Die „Desorientiertheit“ des Menschen – Theodor Haeckers christliches Menschenbild im Kontext des Kulturkatholizismus Dissertation zur Erlangung des Doktorgrads der Theologie der Katholisch-Theologischen Fakultät der Universität Augsburg vorgelegt von Daniela Kaschke 2019 Erstgutachter: Prof. DDr. Thomas Marschler Zweitgutachter: Prof. Dr. Roman Siebenrock Tag der mündlichen Prüfung: 7. Februar 2020 Vorwort Die vorliegende Arbeit wurde im Sommersemester 2019 von der Katholisch-Theologischen Fakultät der Universität Augsburg als Dissertationsschrift angenommen. Ich danke Herrn Prof. Dr. Dr. Thomas Marschler für die Erstellung des Erstgutachtens und die angenehme Zusam- menarbeit am Lehrstuhl für Dogmatik. Hier sei auch Frau Elke Griff gedankt, der guten Seele des Lehrstuhls. Für freundlichen Rat und die Erstellung des Zweitgutachtens danke ich Herrn Prof. Dr. Roman Siebenrock (Innsbruck). Die Hanns-Seidel-Stiftung unterstützte eine wichtige Phase dieses Projekts mit einem Stipendium, auch hierfür sei gedankt. Ideelle Förderung erfuhr ich zudem durch die Graduiertenschule für Geistes- und Sozialwissenschaften der Universität Augsburg. Durch die Vermittlung von Frau Prof. Dr. Kerstin Schlögl-Flierl in ihrer Funktion als Frauenbeauftragter der Fakultät kam ich in den Genuss einer durch das Büro für Chancen- gleichheit der Universität Augsburg finanzierten Hilfskraft während der Elternzeit. Frau Teresa Emanuel, die diese Aufgabe übernahm, war mir über mehrere Monate eine wertvolle Unter- stützung. Vielen Dank dafür! Ein besonderer Dank gilt den zahlreichen Unterstützer*innen aus meinem Freundes- und Kolleg*innenkreis sowie meiner Familie. Sie wissen, dass sie gemeint sind und müssen nicht namentlich genannt werden. 3 Inhaltsverzeichnis 0. Einleitung9 0.1. Forschungsstand . 10 0.2. Fragestellung und Vorgehensweise . 14 I. Die Moderne als Herausforderung für katholische Intellektuelle im be- ginnenden 20. -

The Honourable Society of Lincoln's
The Honourable Society of Lincoln’s Inn John Henry Newman was admitted to the Inn 201 years ago, on 19 November 1819. There is no date of call recorded for John Henry Newman and we know that he did not go on to train as a barrister, and indeed may never have intended to. This was not uncommon at the time; attending one of the Inns of Court was often used as a way for people to make good social contacts rather than qualify to be a barrister. John Newman's admission entry to the Inn, 19 November 1819. From the Inn Archive. Prior to his admission, John Henry Newman entered Trinity College, Oxford in 1817, winning a scholarship in May 1818. He did not achieve his predicted double first, as he failed Mathematics and attained a fourth in Classics. He ultimately decided to enter the Church and in 1825 he was ordained as a priest of the Church of England, becoming Vicar of University Church, St Mary’s, in 1828. In the summer of 1833 he became associated with John Keble, Edward Pusey and others in what became known as the Oxford Movement, an attempt within the Church of England to rediscover and promote its Catholic aspects. Newman went on to convert to Catholicism in 1845. In September 1846 he entered college in Rome and he was ordained on 30 May 1847. He founded the Birmingham Oratory in 1848 and helped to establish the Catholic University of Dublin (now University College Dublin). He died at the Birmingham Oratory on 11 August 1890 and was buried in the Oratory cemetery at Rednal. -

Sophie Scholl and the White Rose
ACCLAIM FOR SOPHIE SCHOLL AND THE WHITE ROSE “The animated narrative reads like a suspense novel.” The New York Times “This is a story that commands our attention.” Newsweek International “Inspiring – and could not be more timely.” Studs Terkel “Superbly written.” Library Journal “Unusually powerful and compelling ...Among the indispensable literature of modern political culture.” Hans-Wolf von Wietersheim, Das Parlament (Official publication, German Bundestag) “Heart-wrenching and inspiring . a story few readers will forget.” San Francisco Chronicle “Could change your life forever.” Dayton Daily News “Dumbach and Newborn have told their compelling story beautifully.” Washington Jewish Week “This is an impressive, highly readable and beautifully researched account of two brave German youths and their comrades who rejected Hitler’s demonic vision and fought to open their countrymen’s eyes to the horrors that lay ahead—at the cost of their lives . This book drives home the high cost of courage in world gone mad, and the brilliant light these brave young people shone into the dark night of Nazi Germany.” Susan Rubinowitz, Political Reporter, New York “A must for anyone, especially young people, to read.” Evelyn Rubin, author of Ghetto Shanghai “A dramatic story of courage during the darkest period of the 20th century ...Andit’sastorywithnewchapters unfolding. This book is a fundamental resource and a memorable read.” Toby Axelrod, author and reporter, Berlin & New York “This book, chapter by chapter, builds into an incontestable argument for the power and possibilities of action over passive acceptance and apathy.” Jewish Chronicle TESTIMONIALS ABOUT THE WHITE ROSE BY NOTABLE CONTEMPORARIES “Good, splendid young people! You shall not have died in vain; you shall not be forgotten. -

NACHRICHTEN V Aus Dem Kösel -Verlag V
NACHRICHTEN v aus dem Kösel -Verlag V »Der Brenner« Leben und Fortleben einer Zeitschrift http://www.uibk.ac.at/brenner-archiv/bibliothek/pdf/nachrichten-koesel.pdf Diese Sondernummer der Nachrichten aus dem Kösel-Verlag ist der Erinnerung an die »Zeit- und Denkschrift« DER BRENNER gewidmet. Zugleich ist sie als Ehrengabe für ihren Gründer und Herausgeber Ludwig von Ficker gedacht, der am 13. April 1965 das 85. Lebensjahr vollendet. Zu solcher Erinnerung hat der Ver lag um so mehr Anlaß, als ein bedeutender Teil gerade jener Autoren, die vor dreißig, vierzig und fünfzig Jahren erstmals im BRENNER auftraten, nun hier beheimatet sind, sei es mit ein zelnen Schriften, sei es in Werkausgaben: Theodor Däubler, Pe ter Altenberg, Else Lasker-Schüler, Theodor Haecker, Ferdinand Ebner, Erik Peterson, Gertrud von le Fort, Joseph Bernhart, Werner Kraft. Es ist nicht schwer, die Linien zu ziehen, die von hier aus zu den weiteren Kösel-Autoren führen: Karl Kraus, Sigismund von Ra- decki, Konrad Weiss, Martin Buber, Ludwig Strauss, Alfred Mombert, Berthold Viertel. So gedenkt dieses Heft auch dieser Namen und nennt sie in einem Atem mit jenen. Fast könnte es, angesichts dieser Fülle, so scheinen, als habe der BRENNER nach dem ersten Weltkrieg ein Programm entwor fen, das nun der Kösel-Verlag — hora et tempus est - nach dem zweiten Kriege erfüllt habe. In Wahrheit hat sich, was hier ge schehen ist, von selbst getan, ohne Plan und Absicht. Aber daß gerade dies »sich getan« hat und aus der bloßen Wahr-Nehmung offensichtlicher oder untergründiger Beziehungen ein so dichtes Netz geistiger Kontrapunktik entstanden ist, zeugt eben auch für die Wahrheit und Klarheit jener Zeitschrift, die, als ein Doku ment unseres Jahrhunderts, der Ruhm Ludwig von Fickers bleibt. -

Durham University Department of Theology and Religion
THE CATHOLIC RECEPTION OF SØREN KIERKEGAARD : WITH PARTICULAR REFERENCE TO THE WRITINGS OF HENRI DE LUBAC , HANS URS VON BALTHASAR , AND CORNELIO FABRO BY JOSHUA FURNAL SUBMITTED FOR THE DEGREE OF DOCTOR OF PHILOSOPHY DURHAM UNIVERSITY DEPARTMENT OF THEOLOGY AND RELIGION 30 July 2013 Abstract In this thesis, I argue that although he is not always recognised as such, Søren Kierkegaard has been an important ally for Catholic theologians since the early twentieth century. Moreover, properly understanding this relationship and its origins offers valuable resources and insights to contemporary Catholic theology. Of course, there are some negative preconceptions to overcome. Historically, some Catholic readers have been suspicious of Kierkegaard, viewing him as an irrational Protestant irreconcilably at odds with Catholic thought. Nevertheless, the favourable mention of Kierkegaard in John Paul II’s Fides et Ratio is an indication that Kierkegaard’s writings are not so easily dismissed. My thesis investigates the writings of emblematic Catholic thinkers in the twentieth century to assess their substantial engagement with Kierkegaard’s writings. I argue that Kierkegaard’s writings have stimulated reform and renewal in twentieth century Catholic theology, and should continue to do so today. To demonstrate Kierkegaard’s relevance in pre- conciliar Catholic theology, a number of Catholic theologians with a reform agenda need to be examined, paying close attention to their emphases and responses to Kierkegaard. I set this backdrop by investigating the wider evidence of a Catholic reception of Kierkegaard in the early twentieth century—looking specifically at influential figures like Theodor Haecker, Romano Guardini, Erich Przywara, and other Roman Catholic thinkers that are typically associated with ressourcement . -

THE WHITE ROSE Faces of a Friendship
TheThe White White Rose. Rose. FacesFaces of of a aFriendshi Friendship p But why do the concerts of today have a special avor? (…) First I think of the peo- ple that go to listen. They don't want to listen at all, in fact, because their hearts are intent on so many little things they're reluctant to forgo. Miserly and pigheaded, they close their ears before the rst note rings out. Why, in case, do they go to con- certs at all? Why indeed? Sophie Scholl THE WHITE ROSE Faces of a Friendship But why do the concerts of today have a special flavor? (...) First I think of the people that go to listen. They don’t want to listen at all, in fact, because their hearts are intent on so many little things they’re reluctant to forgo. Miserly and pigheaded, they close their ears before the first note rings out. Why, in case, do they go to concerts at all? Why indeed? Sophie Scholl But why do the concerts of today have a special flavor? (…) First I think of the peo- ple that go to listen. They don't want to listen at all, in fact, because their hearts are intent on so many little things they're reluctant to forgo. Miserly and pigheaded, they close their ears before the first note Until somebody began to bring the conver- rings out. Why, in case, do they go to con- sation round to hunger, all the while fidd- certs at all? Why indeed? ling with the wax droplets on the candles. -

Theodor Haecker (1879-1945) Und Carl Muth (1867-1944), Dem Herausgeber Der Zeitschrift Hochland
Freundeskreis Mooshausen e.V. in Zusammenarbeit mit der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt Mooshauser Gespräche zur Kirchlichen Zeitgeschichte Carl Muth und die Zeitschrift Hochland 7. – 9. November 2014 im Alten Pfarrhaus von Mooshausen Die Tagung vom 7.-9. November 2014 zu Carl Muth und die Zeitschrift HOCHLAND wurde durch eine Plakat-Ausstellung im Alten Schulhaus von Mooshausen begleitet. Da seit August 1941 eine persönliche Beziehung zu Hans Scholl und später auch zu Sophie Scholl bestand, wurde das Lebensbild von Carl Muth verbude it der frühere Ausstellug „Das Pfarrhaus vo Mooshause ud die Weiße Rose“. Ausgangspunkt für Anordnung der 16 Tafeln war, daß sich die Tafeln zu Carl Muth im Blickpunkt der Teilnehmer befinden. s. Übersicht zur Ausstellung. Die Fotos zur Vita und zum Werk von Carl Muth wurden freundlicherweise von seiner Enkelin Frau Gabrielle Bell-Muth© zur Verfügung gestellt. Die Tafeln wurden von Elisabeth Prégardier und Anne Mohr gestaltet. Ausstellung Carl Muth Altes Schulhaus Mooshausen Stellwand 3 Stellwand 4 TAFEL 12 TAFEL 13 Porträt Carl Muth Eltern Scholl Inge Scholl u. Otl Aicher Elis. Scholl u. F. Hartnagel Werner Scholl TAFEL 11 TAFEL 14 Zeitschrift HOCHLND Musik, die sie liebten Musik. die sie liebten Gedicht v. Ida F. Görres Ricarda Huch TAFEL 10 TAFEL 15 Lebensdaten Letzte Stunden Lebensdaten von Hans u. Sophie Vorbilder u. Freunde Prof. Dr. Hans Maier von Ch. Probst u. W. Graf 15. November 1944 von A. Schmorell u. K. Huber Tafel 9 Tafel 16 Herkunft Die Waage des Daseins Anna Muth Mahnmal Die Kinder Literatur Die Familie Lieblingspsalmen Eingang STELLWAND 2 STELLWAND 1 TAFEL 8 TAFEL 1 Dittlerstraße 10 Mooshausen – Denkort Dittlerstraße 10 Opfer Weiße Rose Nachbar Fugel Josef Weiger Nachbar Bergengruen Romano Guardini TAFEL 7 TAFEL 2 1953 Autoren 1 Erwin Planck 1953 Autoren 2 Opfer 23.