Quaderni Della Memoria Di Poggio Torriana
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

EN ROCCHE EN.Pdf
Places to see and itineraries Where we are Bellaria Trento Igea Marina Milano Venezia Torino Bologna Oslo Helsinki Genova Ravenna Rimini Stoccolma Mosca Firenze Dublino Ancona Santarcangelo Perugia di Romagna Londra Amsterdam Varsavia Rimini Bruxelles Kijev Poggio Berni Roma Berlino Praga Vienna Bari Parigi Monaco Napoli Torriana Budapest Verucchio Milano Montebello Bucarest Rimini Riccione Madrid Cagliari Roma Catanzaro Ankara Coriano Talamello Repubblica Atene Palermo Novafeltria di San Marino Misano Adriatico Algeri Castelleale Tunisi Sant’Agata Feltria Maioletto San Leo Montescudo Agello Maiolo Montecolombo Cattolica Petrella Guidi Sassofeltrio San Clemente Gradara Maciano Gemmano Morciano San Giovanni fiume Conca di Romagna in Marignano Ponte Messa Pennabilli Casteldelci Monte AR Cerignone Montefiore Conca Saludecio Piacenza Molino Pietrarubbia Tavoleto Montegridolfo di Bascio Carpegna Macerata Mondaino Feltria Ferrara fiume Marecchia Sassocorvaro Parma Reggio Emilia Modena Rimini Mondaino Sismondo Castle Castle with Palaeontological museum Bologna Santarcangelo di Romagna Montegridolfo Ravenna Malatesta Fortress Fortified village Torriana/Montebello Montefiore Conca Forlì Fortress of the Guidi di Bagno Malatesta Fortress Cesena Verucchio Montescudo Rimini Malatesta Fortress Fortified village Castle of Albereto San Marino San Leo Fortress Montecolombo Fortified village Petrella Guidi Fortified village and castle ruins Monte Cerignone Fortress Sant’Agata Feltria Fortress Fregoso - museum Sassocorvaro Ubaldini Fortress Distances Pennabilli -

Poggio Torriana, Lì 15.2.2014 Brevi Note Relativa All'attività Svolta Dallo
SPORTELLO UNICO ATTIVITA’ PRODUTTIVE Poggio Torriana, lì 15.2.2014 Brevi note relativa all’attività svolta dallo Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) nell’anno 2013 e alla consistenza del tessuto produttivo del territorio dell’Unione dei Comuni della Bassa Valmarecchia. Le pratiche trattate nel 2013 dallo SUAP sono complessivamente n. 1182 ; dato che conferma, in linea sostanziale l’andamento degli anni precedenti. Dall’analisi dei dati relativi alle sedi di imprese insediate nel territorio dell’Unione dei Comuni della Valle del Marecchia, emerge che l’asse portante dell’economia è rappresentato dalle piccole e medie imprese nel settore del commercio e dell’artigianato ; infatti è un dato costante in tutti e quattro i Comuni associati, che oltre il 60% delle imprese appartenga a queste due categorie. Relativamente all’entità delle imprese insediate presso ciascun Comune è possibile verificare che il dato quantitativo riflette in buona sostanza l’ordine di grandezza dei quattro Comuni: infatti a Santarcangelo di Romagna sono insediate il 63% del totale delle imprese presenti sul territorio dell’Unione dei Comuni, a Verucchio il 24%, a Poggio Berni il 9% ed a Torriana il 4%. Analizzando ogni singola categoria di attività, emerge evince quanto segue: • il settore dell’ agricoltura è ancora un settore importante dell’economia dei quattro comuni: infatti a Santarcangelo rappresentano l’11% del totale delle imprese, a Poggio Berni il 12%, a Verucchio il 9% e a Torriana il 13%; • il settore dell’ artigianato, sia produttivo che di servizio, è, insieme al commercio, la colonna portante dell’economia dei quattro comuni, anche se con percentuali variabili da Comune a Comune: infatti a Santarcangelo rappresentano il 38% del totale delle imprese, a Poggio Berni il 45%, a Verucchio il 34% ed a Torriana il 39%; • il settore del commercio (intendendo per tale tutte le forme di commercio: al dettaglio, all’ingrosso, su area pubblica, pubblici esercizi, distributori di carburante, forme speciali di vendita) a Santarcangelo di R. -

Alta Valmarecchia V
La Strategia Nazionale per le Aree Interne e i nuovi assetti istituzionali AREA INTERNA O ALTA VALMARECCHIA V I REGIONE EMILIA-ROMAGNA T A Z Z I N A G R O A E R A ' D R E I S S O D Nota introduttiva Le Aree Interne rappresentano una ampia parte del Paese. Si tratta di aree significativamente distanti dai centri di offerta di servizi essenziali (quali istruzione, salute e mobilità) ma ricche di importanti risorse ambientali e culturali, fortemente diversificate per natura e per processi di antropizzazione. Un quarto della popolazione italiana occupa queste aree, con un’estensione territoriale che supera il sessanta per cento del totale della superficie nazionale e interessa oltre quattromila comuni. Il Piano Nazionale di Riforma (PNR) ha individuato e messo in atto una Strategia che ha come obiettivo non solo la ripresa demografica, ma anche un miglioramento qualitativo di vita promuovendo per queste aree uno sviluppo intensivo (benessere e inclusione sociale) ed estensivo (lavoro e utilizzo di risorse locali) attraverso fondi ordinari della Legge di Stabilità e Fondi comunitari. La Strategia Nazionale per le Aree Interne, che coinvolge un quarto dei comuni classificati come aree interne, ha individuato e selezionato 72 aree progetto, ricadenti in ambiti territoriali omogenei, distribuite su tutto il territorio nazionale. Per esse si è avviato un processo di crescita e coesione territoriale. Il Dossier d’area organizzativo è un documento di sintesi (analitica e documentale) su alcune condizioni strutturali dell’area e sulle scelte che i comuni hanno effettuato per rafforzare la loro capacità di gestire i servizi pubblici locali e i progetti previsti dalla Strategia. -

Autorizzazione Alla Raccolta Del Legname Caduto Nell'alveo Dei Corsi D'acqua Del Bacino Dei Fiumi Uso, Marecchia, Marano, Melo, Conca, Ventena, Tavollo
AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E LA PROTEZIONE CIVILE SERVIZIO SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE RIMINI ING. SANZIO SAMMARINI Ai Comuni di: RIMINI, RICCIONE, CORIANO, MONTESCUDO, MONTECOLOMBO, GEMMANO, SAN CLEMENTE, MISANO ADRIATICO, MORCIANO DI ROMAGNA, MONTEFIORE CONCA, SALUDECIO, MONDAINO, MONTEGRIDOLFO, SAN GIOVANNI IN MARIGNANO, CATTOLICA, BELLARIA IGEA MARINA, SAN MAURO PASCOLI, SANTARCANGELO DI ROMAGNA, POGGIO TORRIANA, BORGHI, SOGLIANO SUL RUBICONE, MERCATO SARACENO, VERUCCHIO, NOVAFELTRIA, SAN LEO, TALAMELLO, MAIOLO, PENNABILLI, SANT’AGATA FELTRIA, CASTELDELCI e p.c.: ARPAE SAC Rimini Agenzia Regionale STePC Servizio Difesa del Suolo della Costa e Bonifica, E Servizio Parchi e Risorse Forestali, Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Macro Area Romagna - Parco Vena del Gesso Romagnola Unione della Romagna Faentina Riolo Terme Unione dei Comuni della ValConca Unione di Comuni Valmarecchia Tramite Corpo Forestale dello Stato, Comando Provinciale di Rimini Provincia di Rimini Prefettura Ufficio Territoriale del Governo di Rimini COMUNE DI POGGIO TORRIANA COMUNE DI POGGIO TORRIANA COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE Protocollo N.0000787/2021 del 21/01/2021 Firmatario: Sanzio Sammarini Oggetto: Ordinaria manutenzione degli alvei dei corsi d’acqua naturali; autorizzazione alla raccolta del legname caduto nell'alveo dei corsi d'acqua del bacino dei Fiumi Uso, Marecchia, Marano, Melo, Conca, Ventena, Tavollo. Considerato che: - Si registrano sempre più frequentemente eccezionali avversità atmosferiche -

Variante Soc. Vulcangas 2018
COMUNE DI POGGIO TORRIANA Provincia di Rimini COPIA ATTO DI CONSIGLIO Seduta del 21/06/2018 n. 35 Oggetto: ART. 8 DEL D.P.R. 160/2010 “RACCORDI PROCEDIMENTALI CON STRUMENTI URBANISTICI”. PROGETTO DI AMMODERNAMENTO, RIQUALIFICAZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO INDUSTRIALE, IN VARIANTE AL P.R.G. DI TORRIANA, DEL DEPOSITO DI STOCCAGGIO G.P.L. UBICATO IN VIA FAMIGNANO, PRESENTATO DALLA SOC. ITALIANA GAS LIQUIDI S.P.A. - APPROVAZIONE VERBALE CONCLUSIVO DELLA CONFERENZA DEI SERVIZI E DELLA VARIANTE URBANISTICA. L'anno duemiladiciotto il giorno ventuno del mese di giugno, alle ore 19:00, nella Sala Consiliare di Poggio Berni, si e' riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in prima convocazione e in seduta Pubblica. Risultano presenti ed assenti i seguenti Consiglieri Comunali: N Componente Carica Presenza 1 AMATI DANIELE SINDACO Sì 2 ANTONINI FRANCO CONSIGLIERE No 3 GUIDI VERENA CONSIGLIERE Sì 4 MAIULLO ALDO CONSIGLIERE Sì 5 RENZI NICOLA CONSIGLIERE Sì 6 RONCONI RITA CONSIGLIERE Sì 7 BARTOLINI ANGELA CONSIGLIERE Sì 8 RAGGINI RONNY CONSIGLIERE Sì 9 MUCCIOLI MIRKO CONSIGLIERE Sì 10 VALLI ANTONIO CONSIGLIERE Sì 11 D'AMICO FRANCESCA CONSIGLIERE No 12 SANTONI ENRICO CONSIGLIERE Sì 13 BIONDI SILVIO CONSIGLIERE Sì Presenti N. 11 Assenti N. 2 Partecipa alla seduta il Il Vice Segretario Dott.ssa Barbara Roccoli . ATTO DI CONSIGLIO Seduta del 21/06/2018 n. 35 Pag .1 COMUNE DI POGGIO TORRIANA Provincia di Rimini Daniele Amati nella sua qualita' di Sindaco ,dichiarata aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti, invita i Consiglieri a discutere sull'argomento in oggetto. -

PIANTA ORGANICA DELLE FARMACIE DEL COMUNE DI POGGIO TORRIANA Con Popolazione Di Nr
COMUNECOMUNE DIDI POGGIOPOGGIO TORRIANATORRIANA PROVINCIA DI RIMINI SETTORE 1: TERRITORIO - INNOVAZIONE - SVILUPPO Ufficio Edilizia Privata - Sportello Unico per l’Edilizia Municipio di Poggio Berni: Via Roma loc. Poggio Berni n. 25 - 47824 Poggio Torriana (RN) Tel: 0541.629701 int. 3.2 - Fax: 0541.688098 - e-mail PEC: [email protected] ALLEGATO "A" DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE n. 71 del 30.07.2018 PIANTA ORGANICA DELLE FARMACIE DEL COMUNE DI POGGIO TORRIANA con popolazione di nr. 5.200 abitanti (dati ISTAT al 01.01.2017) e con nr. 02 sedi farmaceutiche (totale) Azienda USL Della ROMAGNA Distretto di RIMINI è stabilita come segue: SEDE FARMACEUTICA NR. 01 RURALE ISTITUITA CON CRITERIO: DEMOGRAFICO oppure TOPOGRATICO STATO: aperta : PRIVATA Ubicata nella FRAZIONE di S. ANDREA – Loc. Poggio Berni In Via Santarcangiolese, Loc. Poggio Berni, nc. 3032/A Denominata Farmacia: FARMACIA POGGIO BERNI Cod. identificativo: 099 028 13154 Della quale è titolare: “FARMACIA POGGIO BERNI S.n.c. di Bonagura Antonio, Vandi Claudia e C.”, Codice Fiscale e Partita IVA 04190530404 Avente la seguente sede territoriale: (elenco vie Località Poggio Berni) abitanti ai 01.01.2017: 3436 Via Albinoni Via Acerboli Via Alighieri Via Almeda Vicolo Amatori Via Bellini Via Bervedere Via Borgo Camerano Via Caduti di Via Brandinelli Via Buccelli Via Camerano Marzabotto Via Canella Via Carducci Via Case Bruciate Via Case Nuove Via Casetti Uso Via Cella San Rocco Via Celletta Via Chiesa Camerano Via Chiesa Trebbio Via Cimitero Trebbio Via Colle degli Ulivi Via Collina Via Costa, Loc. Poggio Via Cornacchiara Via Costa del Macello Via Curiel Berni Comune di Poggio Torriana - P.I. -

Definizione Del Fabbisogno Della Struttura Complessa Di Radiologia – Ospedale Di Riccione – AUSL Della Romagna
Definizione del fabbisogno della Struttura Complessa di Radiologia – Ospedale di Riccione – AUSL della Romagna PROFILO OGGETTIVO declinato sulla base del governo clinico e delle caratteristiche organizzative e tecnico-scientifiche della struttura. Il territorio della Provincia di Rimini comprende i 25 Comuni di: Bellaria-Igea Marina, Casteldelci, Cattolica, Coriano, Gemmano, Maiolo, Misano Adriatico, Mondaino, Montefiore Conca, Montegridolfo, Montescudo-Montecolombo, Morciano di Romagna, Novafeltria, Pennabilli, Poggio Torriana, Riccione, Rimini, Saludecio, San Clemente, San Giovanni in Marignano, San Leo, Sant’Agata Feltria, Santarcangelo di Romagna, Talamello e Verucchio per una popolazione, al 01.01.2019, di 340.386 abitanti. Questo territorio si caratterizza per un’elevata densità abitativa nella fascia territoriale costiera che, inoltre, risente di un’accentuazione stagionale, in riferimento alla vocazione turistica dell'area. Nel territorio provinciale vi sono 2 Presidi Ospedalieri: quello di Rimini articolato in 3 stabilimenti situati a Rimini (sede principale), Santarcangelo e Novafeltria e quello di Riccione articolato in 2 stabilimenti situati a Riccione (sede principale) e Cattolica. Il Presidio Ospedaliero di Rimini dispone complessivamente di 597 posti letto per acuti, 36 di DH, 17 sale operatorie, 12 incubatrici, 20 culle e 42 letti di dialisi. Le UU.OO. presenti nel presidio ospedaliero sono le seguenti: Cardiologia, Chirurgia generale, Chirurgia pediatrica, Chirurgia vascolare, Dermatologia, Ematologia, Gastroenterologia, Geriatria, Hospice-Cure Palliative, Malattie Infettive, Medicina d'Urgenza, Medicina Interna e Reumatologia, Medicina Generale e Diabetologia, Nefrologia, Neonatologia, Neurologia, Neuro-Psichiatria- Infantile, Oncologia, Ortopedia e Traumatologia, Ostetricia e Ginecologia, O.R.L., Pediatria, Psichiatria, Post Acuti, Rianimazione, Terapia intensiva neonatale, Urologia, U.T.I.C., oltre ad essere sede di un DEA di 1° livello. -

COMUNE DI POGGIO TORRIANA PROVINCIA DI RIMINI SETTORE 1: TERRITORIO, INNOVAZIONE E SVILUPPO Municipio Di Torriana: Via Roma Loc
COMUNE DI POGGIO TORRIANA PROVINCIA DI RIMINI SETTORE 1: TERRITORIO, INNOVAZIONE e SVILUPPO Municipio di Torriana: Via Roma loc. Torriana n. 19 - 47824 Poggio Torriana (RN) Prot. n. 3552 Poggio Torriana lì: 25/03/2020 AGLI ORDINI PROFESSIONALI Spett.le ORDINE DEGLI ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI PROVINCIA DI RIMINI E DI FORLI’-CESENA PEC: [email protected] PEC: [email protected] Spett.le ORDINE DEGLI INGEGNERI PROVINCIA DI RIMINI E DI FORLI’-CESENA PEC: [email protected] PEC: [email protected] Spett.le FEDERAZIONE REGIONALE AGRONOMI E FORESTALI ORDINE DI FORLI’ CESENA E RIMINI PEC: [email protected] Spett.le ORDINE DEI GEOLOGI EMILIA-ROMAGNA PEC: [email protected] Spett.le COLLEGIO DEI GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI PROVINCIA DI RIMINI E DI FORLI’-CESENA PEC: [email protected] PEC: [email protected] Spett.le ORDINE DEI PERITI INDUSTRIALI PROVINCIA DI RIMINI E DI FORLI’-CESENA PEC: [email protected] PEC: [email protected] OGGETTO: Misure riguardanti il funzionamento e accesso relativo agli uffici comunali del Settore 1: Territorio, Innovazione e Sviluppo e Sportello Unico per l’Edilizia (SUE), efficaci fino al 03.04.2020. Sulla base delle disposizioni emanate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Ministero della Salute per contrastare la diffusione del Covid-19, l’Amministrazione comunale di Poggio Torriana ha disposto una serie di misure riguardanti il funzionamento e l’accesso agli uffici comunali, allo scopo di contenere e contrastare il diffondersi del virus, considerata l’evolversi della situazione edipdemiologica; Valutate le disposizioni nazionali e locali in merito, finalizzate a ridurre la mobilità e i rapporti sociali, gran parte del personale del Settore Territorio, Innovazione e Sviluppo del Comune di Poggio Torriana, non sarà regolarmente presente in ufficio almeno fino al 03/04/2020. -

Belle Spages
Wine and tourism:new perspectives for vineyard areas in Emilia-Romagna SilviaGATTI Fabrizio INCERTI Mirko RAVAGLI Cahiers d’économie et sociologie rurales, n° 62, 2002 Silvia GATTI*, Fabrizio INCERTI*, Mirko RAVAGLI* Vinettourisme: Résumé –L’Emilie-Romagne représente l’une des régions les plus importantes nouvelles perspectives d’Italie pour la production viticole, avec 12% de la productiontotale, 15% des pour les vignobles exploitations viticoles italiennes et 30% de la superficie,sachant que le vignoble d’Emilie-Romagne détient la valeur record de 63% des vignes concentrées dans la plaine. Il existe une réelle nécessité de réorganiser ce vignoble, en identifiant et en créant de nouvelles opportunités d’emplois tout en améliorant les circuits commerciaux. Contrairement aux solutions apportées dans les années 60 qui ont conduit àl’exode rural, une forte volonté se manifeste afin d’améliorer la qualification, la promotion et la valorisation du terroir àpartir d’un nombre très diversifié d’activités. Le vin représenteaujourd’hui un outil de communication et d’attraction touris- tique pour les zones rurales. La réalisation d’un projet intégré sur la production viticole et le tourisme (tel que les routes du vin) pourrait fournir une solution d’avenir pour développer la promotion du territoire et créer de réelles opportunités de développement. Al’aide d’une méthodedeclassification hiérarchique, inspirée Mots-clés: de l’approche de Ward, nous cherchons àidentifier les différentes sous-régions de vin, tourisme, analyse Romagne de vins DOC et DOCG qui montrent les éléments essentiels favorables multivariée àlamise en place de véritables politiques de tourisme du vin. Wine and tourism : Summary –The wine grape growing sector of the Emilia-Romagna region is one of the new perspectives for most relevant at national level, as it produces 12 %ofthe total Italian production. -

Lettera Generica
COMUNECOMUNE DIDI POGGIOPOGGIO TORRIANATORRIANA PROVINCIA DI RIMINI SETTORE 1: TERRITORIO - INNOVAZIONE - SVILUPPO Ufficio Edilizia Privata - Sportello Unico per l’Edilizia Municipio di Poggio Berni: Via Roma loc. Poggio Berni n. 25 - 47824 Poggio Torriana (RN) Tel: 0541.629701 int. 1.3.2 - Fax: 0541.688098 - e-mail PEC: [email protected] “ALLEGATO A" DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE n. 55 del 18.06.2020 PIANTA ORGANICA DELLE FARMACIE DEL COMUNE DI POGGIO TORRIANA con popolazione di nr. 5.227 abitanti (dati ISTAT al 01.01.2019) e con nr. 02 sedi farmaceutiche (totale) Azienda USL della ROMAGNA Ambito RIMINI - Distretto di RIMINI è stabilita come segue: SEDE FARMACEUTICA NR. 01 RURALE ISTITUITA CON CRITERIO: DEMOGRAFICO oppure TOPOGRATICO STATO: aperta : PRIVATA Ubicata nella FRAZIONE di S. ANDREA – Loc. Poggio Berni In Via Santarcangiolese, Loc. Poggio Berni, nc. 3032/A Denominata Farmacia: FARMACIA POGGIO BERNI Cod. identificativo 99028154 Della quale è titolare: “FARMACIA POGGIO BERNI S.n.c. Vandi Claudia e C.”, Codice Fiscale e Partita IVA 04190530404 Avente la seguente sede territoriale: - Confine con Comune di Verucchio – Fiume Marecchia; - Confine con Comune di Santarcangelo di Romagna, - Confine con Comune di Borghi – Fiume Uso; - Ex Confine con Torriana: Via Canella, Via Collina (dall’incrocio con via Canella all’incrocio con via Santarcangiolese – lato Torriana), Via Molino Vigne (fino all’incrocio con via Pantano), via Pantano. Comune di Poggio Torriana - P.I. 04110220409 - e-mail PEC: [email protected] Sede legale-amministrativa: Municipio di Poggio Berni - Via Roma loc. Poggio Berni n. 25 - 47824 Poggio Torriana (RN) Altra sede amministrativa: Municipio di Torriana - Via Roma loc. -
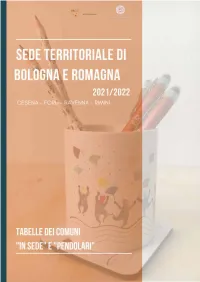
Comuni in Sede E Pendolari
Tabelle Comuni “In sede” e “Pendolari” TABELLE IN SEDE, PENDOLARI Tabella 6 - ER.GO Sede Territoriale di Bologna e Romagna Comuni considerati “in sede” Per la sede di BOLOGNA Per la sede di OZZANO DELL’EMILIA Per la sede di FORLÌ In sede In sede In sede Comune Prov Comune Prov Comune Prov Anzola dell’Emilia BO Bologna BO Bertinoro FC Argelato BO Budrio BO Castel Bolognese RA Castel San Pietro Terme BO Bentivoglio BO Castel Bolognese RA Castel Guelfo di Bologna BO Castrocaro T. e Terra del Sole FC Bologna BO Castel San Pietro Terme BO Cesena FC Budrio BO Faenza FC Dovadola FC Calderara di Reno BO Imola BO Faenza RA Camposanto MO Monterenzio BO Forlì FC Casalecchio di Reno BO Ozzano dell’Emilia BO Forlimpopoli FC Castel Bolognese RA San Lazzaro di Savena BO Gambettola FC Castel Maggiore BO Imola BO Castel San Pietro Terme BO Meldola FC Castelfranco Emilia MO Per la sede di CESENA Predappio FC Castenaso BO Rimini RN Crespellano (ora Valsamoggia) BO In sede Santarcangelo di Romagna RN Savignano sul Rubicone FC Crevalcore BO Comune Prov Faenza RA Bertinoro FC Ferrara FE Castel Bolognese RA Per la sede di RIMINI Granarolo dell’Emilia BO Cattolica RN Imola BO Cesena FC In sede Malalbergo BO Cesenatico FC Comune Prov Marzabotto BO Faenza RA Bellaria-Igea Marina RN Minerbio BO Forlì FC Bertinoro FC Modena MO Forlimpopoli FC Borghi FC Ozzano dell’Emilia BO Gabicce Mare PS Cattolica RN Pianoro BO Gambettola FC Cervia RA Cesena FC Poggio Renatico FE Gatteo FC Cesenatico FC Rubiera RE Imola BO Coriano RN Longiano FC Sala Bolognese BO Fano PS San Felice -

Decorflou® Design Omnidecor
area São Paulo Aflalo e Gasperini Arquitetos Hector Zamora Isay Weinfeld Andrade Morettin Arquitetos Tryptique Brasil Arquitetura Adriana Levisky, Anna Dietzsch Bernardes Jacobsen Arquitetura 114 spbr arquitetos Vigliecca & Assoc. Biselli + Katchborian architects Paulo Mendes da Rocha 22,00 building site Herzog & de Meuron interiors 1, DCB Bologna Muti Randolph Isay Weinfeld rivista di architettura e artigennaio/febbraio 2011 del progetto 22.00/Switzerland CHF 30,00/USA $ 40.95/Belgium design 22.00/Spain Estúdio Campana ovo design ltda 22.00/Portugal 24.80/UK GBP 19.50/Greece Canada CAD 39.95/Germany 12,00 Motta Architettura n° 46) art. 1 comma Rivista Bimestrale/Poste Italiane SpA - spedizione in abbonamento postale D.L. 353/2003 (conv.27/02/2004 Italia design focus interview design focus trasparency essay Alfonso Morone Ali Filippini object Inori, design Setsu & Shinobu Ito/Fiam Mirror Mirror, design Jasper Morrison/Glas Italia Ghost Buster, design Philippe Starck/Kartell Drop Table, design Junya Ishigami/Living Divani Pasha, design Archirivolto Design/Pedrali Vela, design Giuseppe Bavuso/Rimadesio Decorflou® Design, design Omnidecor/Omnidecor project Seves Q30 Diamante, 5+1AA Fontanot – flaghsip store Scavolini, Space Architects review factory Pilkington design focus essay flans te alo: il vetro, che soffiando prende vita flans te alo: glass receives the breath of life text by Alfonso Morone Il gesto del soffiare che dà vita resta lo stesso da secoli e questa magia, antichissima e attuale, dalle antiche fornaci vetrarie è proseguita intatta sino ai giorni nostri. L‘incanto di una plasticità gestuale che dona ad ogni oggetto la qualità irripetibile del pezzo unico.