Rapporto 2015 Gli Immigrati in Lombardia
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Migration and Development in Italy Common Home
M COMMON HOME MIGRATION AND DEVELOPMENT IN ITALY MIGRATION COMMON HOME Via Aurelia, 796 00165 Rome - Italy MIGRATION AND DEVELOPMENT [email protected] www.caritas.it IN ITALY This publication was produced in the framework of the MIND project, COMMON which has received financial support from the DEAR Programme of the European Union. The information contained in this publication does HOME not necessarily reflect the position or opinion of the European Union. series Researched and written by Sebastiano Ceschi with the support of Paolo Beccegato, Laura Stopponi, Massimo Pallottino, Oliviero Forti, Giovanna Corbatto (Caritas Italiana) and Andrea Stocchiero (FOCSIV). Contributions and editing by Olga Kadysheva, Patrick Taran, and Piyasiri Wickramasekara (Global Migration Policy Associates - GMPA) and Davide Gnes and Shannon Pfohman (Caritas Europa). This publication is part of MIND (Migration. Interconnectedness. Development.); a 3-year project, financed by the European Commission (DG DEVCO). The aim is to raise public awareness on the relation between sustainable development and migration and the European Union’s role in development cooperation. Led by Caritas Austria, the partners of the MIND project are: Caritas Bavaria (Germany), Caritas International Belgium, Caritas Bulgaria, Caritas Czech Republic, Caritas Europa, Caritas Italy, Cordaid (Caritas Netherlands), Caritas Portugal, Caritas Slovakia, Caritas Slovenia and Caritas Sweden. For more information about MIND follow the campaign: This publication was proofread by Mauricio Ruiz and Richard Tuffs Graphic design by Vanden Broele Group with the support of Leticia Lozano (Caritas Europa) Layout by Francesco Camagna Cover illustration by Jean Bernard Boulnois Published by Caritas Italiana, via Aurelia 796, Rome, Italy, May 2019. This publication was produced in the framework of the MIND project, which has received financial support from the DEAR Programme of the European Union. -

Paolo Boccagni
Paolo Boccagni Dpt. of Sociology, University of Trento - I [email protected] https://unitn.academia.edu/PaoloBoccagni +39 0461 281393 +39 340 8001021 PhD, Sociology, University of Trento, 2008 Assistant professor in Sociology, Dept. of Sociology and Social Research, University of Trento (2011-) ERC STG HOMInG, Principal Investigator (2016-2021) Holder of the National qualification as Associate professor, Sociology, 14/C1, 14/C2, 14/D1 (2013-2019) Main research interests: Migration, Home, Diversity, Care, Transnationalism, Social welfare SELECTED PUBLICATIONS Monographs Tracce transnazionali: vite in Italia e proiezioni verso casa tra i migranti ecuadoriani, Milan, Angeli, 2009. L’integrazione nello studio delle migrazioni: Teorie, indicatori, ricerche (with G. Pollini), Milan, Angeli, 2012. Cercando il benessere nelle migrazioni: l’esperienza delle assistenti familiari straniere in Trentino (with M. Ambrosini), Milan, Angeli, 2012. Journal Articles Migrants' social protection as a transnational process: public policies and emigrant initiative in the case of Ecuador, International Journal of Social Welfare, 20(3): 318-325, 2011 Migration and the global crisis: New prospects for return? The case of Ecuadorians in Europe (with F. Lagomarsino), Bulletin of Latin American Research, 30(3): 282-297, 2011 Reminiscences, patriotism, participation. Approaching external voting in Ecuadorian immigration to Italy, International Migration, 49(3): 76-98, 2011 The framing of return from above and below in Ecuadorian migration: A project, -

The Curriculum
Undergraduate Course Offerings 2019-2020 CALENDAR FALL 2019 Saturday, August 31 Opening Day New students arrive Monday, September 2 Returning students arrive Monday, October 21 and October Study Days Tuesday, October 22 Wednesday, November Thanksgiving break (begins after last academic 27–Sunday, December 1 appointment on Tuesday) Friday, December 20 Last day of classes Saturday, December 21 Residence halls close 10 a.m. SPRING 2020 Sunday, January 19 Students return Saturday, March 14–Sunday, Spring break March 22 Friday, May 8 Last day of classes Saturday, May 9 Residence halls close for first-years, sophomores, and juniors at 5 p.m. Friday, May 15 Commencement Residence halls close for seniors at 8 p.m. The Curriculum . 3 Latin . 85 Africana Studies . 3 Latin American and Latino/a Studies . 85 Anthropology . 4 Lesbian, Gay, Bisexual, and Transgender Architecture and Design Studies . 9 Studies . 86 Art History . 10 Literature . 89 Asian Studies . 14 Mathematics . 100 Biology . 18 Middle Eastern and Islamic Studies . 103 Chemistry . 22 Modern and Classical Languages and Chinese . 25 Literatures . 103 Classics . 26 Music . 104 Cognitive and Brain Science . 26 Philosophy . 116 Computer Science . 27 Physics . 120 Dance . 29 Political Economy . 122 Development Studies . 35 Politics . 123 Economics . 36 Practicum . 0 Environmental Studies . 39 Psychology . 128 Ethnic and Diasporic Studies . 41 Public Policy . 141 Film History . 42 Religion . 143 Filmmaking and Moving Image Arts . 46 Russian . 147 French . 57 Science and Mathematics . 148 Games, Interactive Art, and New Genres 59 Pre-Health Program Gender and Sexuality Studies . 60 Social Science . 149 Geography . 61 Sociology . 149 German . 64 Spanish . 154 Greek (Ancient) . -
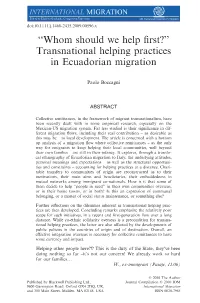
Transnational Helping Practices in Ecuadorian Migration
MIGRATION Edited by Elzbieta Gozdziak, Georgetown University doi:10.1111/j.1468-2435.2009.00596.x ‘‘Whom should we help first?’’ Transnational helping practices in Ecuadorian migration Paolo Boccagni ABSTRACT Collective remittances, in the framework of migrant transnationalism, have been recently dealt with in some empirical research, especially on the Mexican-US migration system. Far less studied is their significance in dif- ferent migration flows, including their real contribution – as desirable as this may be – to local development. The article is concerned with a bottom up analysis of a migration flow where collective remittances – as the only way for emigrants to keep helping their local communities, well beyond their own families – are still in their infancy. It explores, through a translo- cal ethnography of Ecuadorian migration to Italy, the underlying attitudes, personal meanings and expectations – as well as the structural opportuni- ties and constraints – accounting for helping practices at a distance. Chari- table transfers to communities of origin are reconstructed as to their motivations, their main aims and beneficiaries, their embeddedness in mutual networks among immigrant co-nationals. How is it that some of them decide to help ‘‘people in need’’ in their own communities overseas, or in their home towns, or in both? Is this an expression of communal belonging, or a matter of social status maintenance, or something else? Further reflections on the dilemmas inherent in transnational helping prac- tices are then developed. Concluding remarks emphasize the relatively poor scope for such initiatives, in a recent and first-generation flow over a long distance. While co-ethnic solidarity overseas is a precondition for transna- tional helping practices, the latter are also affected by the developments of public policies in the countries of origin and of destination. -
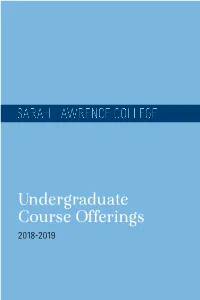
2018-2019 Calendar
Undergraduate Course Offerings 2018-2019 CALENDAR FALL 2018 Saturday, September 1 Opening Day New students arrive Monday, September 3 Returning students arrive Monday, October 22 and Tuesday, October Study Days October 23 Wednesday, November 21 - Sunday, Thanksgiving break (begins after last November 25 academic appointment on Tuesday) Friday, December 21 Last day of classes Saturday, December 22 Residence halls close at 10 a.m. SPRING 2019 Sunday, January 20 Students return Saturday, March 16 - Sunday, March Spring break 31 Friday, May 17 Last day of classes Sunday, May 19 Residence halls close for first-years, sophomores, and juniors at 5 p.m. Friday, May 24 Commencement Residence halls close for seniors at 8 p.m. The Curriculum . 3 Japanese . 80 Africana Studies . 3 Latin . 81 Anthropology . 3 Latin American and Latino/a Studies . 82 Architecture and Design Studies . 8 Lesbian, Gay, Bisexual, and Transgender Art History . 9 Studies . 83 Asian Studies . 14 Literature . 84 Biology . 18 Mathematics . 95 Chemistry . 22 Middle Eastern and Islamic Studies . 98 Chinese . 25 Modern and Classical Languages and Classics . 26 Literatures . 99 Cognitive and Brain Science . 26 Music . 100 Computer Science . 27 Philosophy . 111 Dance . 30 Physics . 114 Development Studies . 37 Political Economy . 116 Economics . 37 Politics . 117 Environmental Studies . 41 Psychology . 122 Ethnic and Diasporic Studies . 43 Public Policy . 135 Film History . 44 Religion . 137 Filmmaking and Moving Image Arts . 47 Russian . 142 French . 56 Science and Mathematics . 143 Games, Interactive Art, and New Genres 59 Pre-Health Program Gender and Sexuality Studies . 60 Social Science . 144 Geography . 61 Sociology . 144 German . 63 Spanish . -

Download the Program
Anthropology Comes Home: The Enduring Promise of a Holistic Discipline PROGRAM NORTHEASTERN ANTHROPOLOGICAL ASSOCIATION 48TH ANNUAL MEETING MARCH 7-9, 2008 UNIVERSITY OF MASSACHUSETTS AMHERST Ventura R. Pérez, Organizer Organizing Committee Members: Katie Dambach, Fundraising Coordinator Siobhan Hart, Program Coordinator Kimberly Kasper, CRM Sponsor Coordinator Angela Labrador, Program Coordinator Ann Stewart, Volunteers Coordinator Julie Woods, Book Exhibit Coordinator NEAA Executive Board: President: Amy Gazin-Schwartz, Assumption College President-elect: Barrrett Brenton, St. John's University Past-President: Grace Morth Fraser, Plymouth State College Treasurer: Alan Hersker, SUNY Potsdam Secretary: Elizabeth Fuller- Tarbox, SUNY Potsdam Editor: Jessica Skolnikoff, Roger Williams University Program chair: Ventura Pérez, University of Massachusetts Amherst Past program chair: Jack Rossen, Ithaca College Graduate Student Representative: Kris Primeau, SUNY Albany Undergraduate Student Representative: (vacant) Webmaster: David L. R. Houston, University of Vermont Archivist: H. Martin Wobst, University of Massachusetts Amherst Membership coordinator: Matthew Smith, St. Lawrence University 1 ACKNOWLEDGEMENTS This conference could not have happened without enthusiastic support and assistance on the part of many individuals here at the University of Massachusetts Amherst. I would like to especially thank the Anthropology Department Staff, especially Office Manager, Lisa Wegiel, Academic Secretary, Shelley Bellor Richotte, and the department Bookkeeper and Purchasing Agent, Grace Rock. Their help and humor made this task much easier to bear. I would also like to thank Assistant Dean of the College of Social and Behavioral Sciences Karen Schoenberger for her support of this event. Nearly the entire Department of Anthropology contributed to help make this conference a success but special recognition goes to Elizabeth Chilton, Chair of the Department, H. -

International Convention on the Protection of the Rights Of
UNITED NATIONS CMW International Convention Distr. on the Protection of the GENERAL Rights of All Migrant CMW/C/ECU/1 Workers and Members 24 January 2007 of Their Families ENGLISH Original: SPANISH COMMITTEE ON THE PROTECTION OF THE RIGHTS OF ALL MIGRANT WORKERS AND MEMBERS OF THEIR FAMILIES CONSIDERATION OF REPORTS SUBMITTED BY STATES PARTIES UNDER ARTICLE 73 OF THE CONVENTION Initial reports of States parties due in 2004 ECUADOR* * In accordance with the information transmitted to States parties regarding the processing of their reports, the present document was not formally edited before being sent to the United Nations translation services. GE.07-40215 (E) 190407 190407 CMW/C/ECU/1 page 2 CONTENTS Paragraphs Page Introduction .................................................................................................... 1 - 7 7 I. INFORMATION OF A GENERAL NATURE ................................... 8 - 102 8 A. General population and unemployment data .............................. 8 - 16 8 1. Population size and growth ............................................... 8 - 10 8 2. Unemployment .................................................................. 11 - 16 9 B. Quantitative and qualitative information on the characteristics and nature of the migration in which the State party is involved ...................................................................................... 17 - 32 11 1. Migration indicators .......................................................... 17 - 18 11 2. Immigration ...................................................................... -

Transnationalism, Immigration Stress and Subjective Well-Being Among Ecuadorian Immigrants in London
Loyola University Chicago Loyola eCommons Dissertations Theses and Dissertations 2012 Transnationalism, Immigration Stress and Subjective Well-Being Among Ecuadorian Immigrants in London Lucia E. Orellana-Damacela Loyola University Chicago Follow this and additional works at: https://ecommons.luc.edu/luc_diss Part of the Social Psychology Commons Recommended Citation Orellana-Damacela, Lucia E., "Transnationalism, Immigration Stress and Subjective Well-Being Among Ecuadorian Immigrants in London" (2012). Dissertations. 375. https://ecommons.luc.edu/luc_diss/375 This Dissertation is brought to you for free and open access by the Theses and Dissertations at Loyola eCommons. It has been accepted for inclusion in Dissertations by an authorized administrator of Loyola eCommons. For more information, please contact [email protected]. This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 License. Copyright © 2012 Lucia E. Orellana-Damacela LOYOLA UNIVERSITY CHICAGO TRANSNATIONALISM, IMMIGRATION STRESS AND SUBJECTIVE WELL-BEING AMONG ECUADORIAN IMMIGRANTS IN LONDON A DISSERTATION SUBMITTED TO THE FACULTY OF THE GRADUATE SCHOOL IN CANDIDACY FOR THE DEGREE OF DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN SOCIAL PSYCHOLOGY BY LUCIA E. ORELLANA-DAMACELA CHICAGO, ILLINOIS AUGUST 2012 Copyright by Lucia Orellana-Damacela, 2012 All rights reserved. ACKNOWLEDGMENTS Special thanks to Dr. R. Scott Tindale, my advisor at Loyola University Chicago, for his support, guidance, encouragement and patience. Thanks to Drs. Fred Bryant and Anne Sutter for their invaluable input in the design and analysis of this dissertation. Thanks to Dr. Yolanda Suarez-Balcazar, who was my mentor when I arrived at Loyola University, for her constant encouragement and crucial support. Many thanks to the people at the Ecuadorian Consulate in London, and to the social service organizations and Ecuadorian-owned businesses that opened their doors for me to conduct data collection at their premises. -

The Identity Construction of Migrants on Facebook
languages Article The Identity Construction of Migrants on Facebook Giovanna Mapelli Dipartimento di Scienze della Mediazione e di Studi Interculturali, Università degli Studi di Milano, Piazza I. Montanelli, 1—20099 Sesto San Giovanni, 20122 Milano, Italy; [email protected] Received: 8 May 2019; Accepted: 1 July 2019; Published: 4 July 2019 Abstract: Social network sites, such as Facebook, allow access to a series of resources or discursive forms that constitute a multimodal and dialogical system that transcends barriers of time and space, favouring transnational communication, something particularly important to migrants. In addition, the comments and dialogues that take place in such socialisation spaces allow us to develop a greater knowledge of the identity and positioning of the user with respect to others. With this work we analyse, from a qualitative point of view, 150 posts each containing at least five comments, published between 2017 and 2019, in each of five Facebook groups of Latin American migrants living in Italy: Uruguayans, Argentinians, Colombians, Peruvians and Venezuelans. We determine their role in the migratory process and how the digital environment affects the relationships between migrants. In addition, we investigate how the identities of migrants are negotiated and (re)defined in discursive practice. Results shows that social network sites are “transnational social spaces”, in which a community is based on bonds of solidarity that derive from a shared conception of collective identity, and they forge deterritorialised “community of feeling”. Keywords: social networks sites; immigration; identity; transnationalism; Facebook groups 1. Latin Americans in Italy After Spain, Italy is one of the main destination countries of the Latin American diaspora in Europe. -

Diasporic Ecuadorian Narratives in Southern/Mediterranean Europe
University of Massachusetts Amherst ScholarWorks@UMass Amherst Doctoral Dissertations Dissertations and Theses March 2015 Documenting the (Un)Documented: Diasporic Ecuadorian Narratives in Southern/Mediterranean Europe Esther A. Cuesta University of Massachusetts Amherst Follow this and additional works at: https://scholarworks.umass.edu/dissertations_2 Part of the Comparative Literature Commons, European Languages and Societies Commons, Latin American Languages and Societies Commons, Latin American Literature Commons, Other Film and Media Studies Commons, Other Italian Language and Literature Commons, Race, Ethnicity and Post- Colonial Studies Commons, and the Women's Studies Commons Recommended Citation Cuesta, Esther A., "Documenting the (Un)Documented: Diasporic Ecuadorian Narratives in Southern/ Mediterranean Europe" (2015). Doctoral Dissertations. 289. https://doi.org/10.7275/6460510.0 https://scholarworks.umass.edu/dissertations_2/289 This Open Access Dissertation is brought to you for free and open access by the Dissertations and Theses at ScholarWorks@UMass Amherst. It has been accepted for inclusion in Doctoral Dissertations by an authorized administrator of ScholarWorks@UMass Amherst. For more information, please contact [email protected]. DOCUMENTING THE (UN)DOCUMENTED: DIASPORIC ECUADORIAN NARRATIVES IN SOUTHERN/MEDITERRANEAN EUROPE A Dissertation Presented by ESTHER ADELINA CUESTA SANTANA Submitted to the Graduate School of the University of Massachusetts Amherst in partial fulfillment of the requirements for -

Daily Family Routines of Italian and Ecuadorian
SGOXXX10.1177/2158244015609411SAGE OpenRania et al. 609411research-article2015 Article SAGE Open October-December 2015: 1 –13 Daily Family Routines of Italian and © The Author(s) 2015 DOI: 10.1177/2158244015609411 Ecuadorian Immigrant Mothers in sgo.sagepub.com Everyday Life: A Qualitative Approach Using Diaries and Interviews Nadia Rania1, Laura Migliorini1, Stefania Rebora1, and Paola Cardinali1 Abstract This study compares Italian mothers’ and Ecuadorian immigrant mothers’ daily family routines. Thirty mothers took part in this investigation: 15 Italians (M = 37.5 years, with ages ranging from 30 to 42 years) and 15 Ecuadorians (M = 36.1 years, with ages ranging from 18 to 46 years and having lived in Italy for an average of 15 years), with children ranging in age from 4 to 8 years. The objective is to highlight the differences and similarities between the daily routines and family relations that characterize the lives of each of the two groups of participants. The instruments employed in service of these aims were in-depth interviews and diaries. The results showed similarities regarding the routines of Italian and Ecuadorian families. However, a relevant difference emerged regarding their perceptions of social support. Specifically, Italians receive more social support from their parents than do Ecuadorians, who are supported more by other relatives or by friends. Keywords routine, family relations, diary, interview Routines in the Family Context characterize it, making it unique (Fiese, 2006). Routines are modified following family life cycle transitions, so that they Cultural psychology is interested in daily practices, especially in allow families to better accommodate changes. They are charac- routines and rituals, because these are built on belonging to the terized by instrumental communication and define activities and culture and modified according to the needs of a culture’s mem- tasks that people are expected to perform in a group, such as bers.