Parma E L'italia Dal 1848 Al 1947
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Chapter One: Introduction
CHANGING PERCEPTIONS OF IL DUCE TRACING POLITICAL TRENDS IN THE ITALIAN-AMERICAN MEDIA DURING THE EARLY YEARS OF FASCISM by Ryan J. Antonucci Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of Master of Arts in the History Program YOUNGSTOWN STATE UNIVERSITY August, 2013 Changing Perceptions of il Duce Tracing Political Trends in the Italian-American Media during the Early Years of Fascism Ryan J. Antonucci I hereby release this thesis to the public. I understand that this thesis will be made available from the OhioLINK ETD Center and the Maag Library Circulation Desk for public access. I also authorize the University or other individuals to make copies of this thesis as needed for scholarly research. Signature: Ryan J. Antonucci, Student Date Approvals: Dr. David Simonelli, Thesis Advisor Date Dr. Brian Bonhomme, Committee Member Date Dr. Martha Pallante, Committee Member Date Dr. Carla Simonini, Committee Member Date Dr. Salvatore A. Sanders, Associate Dean of Graduate Studies Date Ryan J. Antonucci © 2013 iii ABSTRACT Scholars of Italian-American history have traditionally asserted that the ethnic community’s media during the 1920s and 1930s was pro-Fascist leaning. This thesis challenges that narrative by proving that moderate, and often ambivalent, opinions existed at one time, and the shift to a philo-Fascist position was an active process. Using a survey of six Italian-language sources from diverse cities during the inauguration of Benito Mussolini’s regime, research shows that interpretations varied significantly. One of the newspapers, Il Cittadino Italo-Americano (Youngstown, Ohio) is then used as a case study to better understand why events in Italy were interpreted in certain ways. -
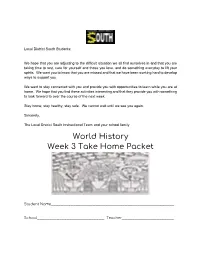
World History Week 3 Take Home Packet
Local District South Students: We hope that you are adjusting to the difficult situation we all find ourselves in and that you are taking time to rest, care for yourself and those you love, and do something everyday to lift your spirits. We want you to know that you are missed and that we have been working hard to develop ways to support you. We want to stay connected with you and provide you with opportunities to learn while you are at home. We hope that you find these activities interesting and that they provide you with something to look forward to over the course of the next week. Stay home; stay healthy; stay safe. We cannot wait until we see you again. Sincerely, The Local District South Instructional Team and your school family World History Week 3 Take Home Packet Student Name_________________________________________________________________________ School________________________________________ Teacher_______________________________ Students: Each of the Social Science Learning Opportunities Packet was developed based on a portion of the standards framework. The mini-unit you will be working on this week, is based on these questions from the framework: ● What was totalitarianism, and how was it implemented in similar and different ways in Japan, Germany, Italy, and the Soviet Union? We encourage you to engage in the Extended Learning Opportunity if you are able. Over the course of the next week, please do the activities listed for each day. Week 3, Day 1 1. Read, “Life in a Totalitarian Country” and annotate using the annotation bookmark. 2. Answer the quiz questions. 3. Write a response to this prompt:Observe: How does the text describe the relationship between fear and totalitarian governments? Week 3, Day 2 1. -

Dai Rifiuti Al Re Nasce Il Regime Fascista Fatale Per L’Italia La Miopia Della Classe Dirigente 1 Dicembre 1919
Anno XXXVII – N. 2 Dicembre 2020 AVVISO ALLE POSTE Sped. in a.p. 70% In caso di mancata consegna inviare Poste Italiane Spa – Filiale di Milano TRIMESTRALE DI CULTURA E POLITICA al CMP di Roserio per la restituzione al mittente, che si impegna a pagare la relativa tassa. DAI RIFIUTI AL RE NASCE IL REGIME FASCISTA Fatale per l’Italia la miopia della classe dirigente 1 dicembre 1919. Dal discorso della Corona: “... Il Parlamento, presidio di ogni libertà, difesa e garanzia di tutte le istituzioni democratiche, deve essere oggi più che mai circondato dalla fiducia del Paese… Il nostro Paese raggiunge con la guerra quei confini che la natura gli diede…”. 11 giugno 1921. Dal discorso della Corona “… Perché quest’opera di riassestamento proceda nella concordia delle classi sociali, occorrerà che il Parlamento rivolga l’attività propria all’ordinato ascendere delle classi lavoratrici così delle officine come dei campi… Sarà vanto di questa assemblea… rafforzare gli istituti cooperativi… per consentire alle classi operaie di abilitarsi gradualmente al difficile governo dell’attività economica”. “La rivoluzione fascista si fermò davanti a un trono”* B. Mussolini Vittorio Emanuele III si oppone al fascismo 1918 L’Italia è compiuta 20 novembre 1918. Ore 14. Camera dei Deputati. Vittorio Emanuele Orlando, presidente della Camera: “Onorevoli colleghi! L’Italia è compiuta… Le nostre istituzioni, essenzialmente democratiche, consentono ogni sviluppo e ogni trasformazione. L’Italia, che si fece pari a sé stessa nella guerra, saprà sorpassare sé stessa nella pace”(1) Riprende la vita parlamentare, ma il Direttore del Cor- riere della Sera, Luigi Albertini, senatore e membro del Fascio parlamentare di difesa nazionale, raggruppamento patriottico di partiti durante la guerra, il 21 novembre scri- ve: “I fasci devono ora rappresentare la fine dei vecchi partiti”. -

A British Reflection: the Relationship Between Dante's Comedy and The
A British Reflection: the Relationship between Dante’s Comedy and the Italian Fascist Movement and Regime during the 1920s and 1930s with references to the Risorgimento. Keon Esky A thesis submitted in fulfilment of requirements for the degree of Doctor of Philosophy, Faculty of Arts and Social Sciences. University of Sydney 2016 KEON ESKY Fig. 1 Raffaello Sanzio, ‘La Disputa’ (detail) 1510-11, Fresco - Stanza della Segnatura, Palazzi Pontifici, Vatican. KEON ESKY ii I dedicate this thesis to my late father who would have wanted me to embark on such a journey, and to my partner who with patience and love has never stopped believing that I could do it. KEON ESKY iii ACKNOWLEDGEMENTS This thesis owes a debt of gratitude to many people in many different countries, and indeed continents. They have all contributed in various measures to the completion of this endeavour. However, this study is deeply indebted first and foremost to my supervisor Dr. Francesco Borghesi. Without his assistance throughout these many years, this thesis would not have been possible. For his support, patience, motivation, and vast knowledge I shall be forever thankful. He truly was my Virgil. Besides my supervisor, I would like to thank the whole Department of Italian Studies at the University of Sydney, who have patiently worked with me and assisted me when I needed it. My sincere thanks go to Dr. Rubino and the rest of the committees that in the years have formed the panel for the Annual Reviews for their insightful comments and encouragement, but equally for their firm questioning, which helped me widening the scope of my research and accept other perspectives. -

Elenco Dei Governi Italiani
Elenco dei Governi Italiani Questo è un elenco dei Governi Italiani e dei relativi Presidenti del Consiglio dei Ministri. Le Istituzioni in Italia Le istituzioni della Repubblica Italiana Costituzione Parlamento o Camera dei deputati o Senato della Repubblica o Legislature Presidente della Repubblica Governo (categoria) o Consiglio dei Ministri o Presidente del Consiglio dei Ministri o Governi Magistratura Consiglio Superiore della Magistratura (CSM) Consiglio di Stato Corte dei Conti Governo locale (Suddivisioni) o Regioni o Province o Comuni Corte costituzionale Unione Europea Relazioni internazionali Partiti e politici Leggi e Regolamenti parlamentari Elezioni e Calendario Referendum modifica Categorie: Politica, Diritto e Stato Portale Italia Portale Politica Indice [nascondi] 1 Regno d'Italia 2 Repubblica Italiana 3 Sigle e abbreviazioni 4 Politici con maggior numero di Governi della Repubblica Italiana 5 Voci correlate Regno d'Italia Periodo Nome del Governo Primo Ministro 23 marzo 1861 - 12 giugno 1861 Governo Cavour Camillo Benso Conte di Cavour[1] 12 giugno 1861 - 3 marzo 1862 Governo Ricasoli I Bettino Ricasoli 3 marzo 1862 - 8 dicembre 1862 Governo Rattazzi I Urbano Rattazzi 8 dicembre 1862 - 24 marzo 1863 Governo Farini Luigi Carlo Farini 24 marzo 1863 - 28 settembre 1864 Governo Minghetti I Marco Minghetti 28 settembre 1864 - 31 dicembre Governo La Marmora Alfonso La Marmora 1865 I Governo La Marmora 31 dicembre 1865 - 20 giugno 1866 Alfonso La Marmora II 20 giugno 1866 - 10 aprile 1867 Governo Ricasoli -

Compare and Contrast Italian and German Nazi Ideology
1800944 Compare and contrast Italian and German Nazi Ideology Fascism is an ideology that has often been left without a solid definition, and it has been interpreted in a variety of ways.1 Fascism has been interpreted as: capitalism’s response to Communism, totalitarian ultra-nationalism, and a community focused authoritarian system which holds contradictory Socialist and conservative values. 2 3 4 Within these differing interpretations’ fascism has been described as; ultra-nationalist, authoritarian, violent, imperialist, collectivist ideology, which holds populist tendencies. Different stands of fascism also tend to add different policies which are relevant to the socio-economic context in order to appeal to the target audience, the people. Italian Fascism evolved from ‘Italian national syndicalism’, ‘revolutionary syndicalism’, and Italian nationalism taking with it their shared beliefs of productivism, and nationalism; whilst also exhibiting conventional fascist traits such as authoritarianism, imperialism, and violence. 5 6 German Fascism evolved from socialism, but also from the issues that Germany was facing in the aftermath of World War Two. German Fascism exhibited typical fascist traits such being nationalist, authoritarian, and violent, but also demonstrated socialist policies, by focusing on the betterment of the community through national projects. 7 Italian and German fascism had varying traits that appeared in different strengths, but the two different versions of fascism were similar. Both Italian and German Fascism came -

La Marcia Su Roma
MARIO BUSSONI Mattioli 1885 Mattioli LA MARCIA SU ROMA VIAGGI NELLA STORIA ® 978-88-6261-236-4 Mattioli 1885 LA MARCIA SU ROMA | BUSSONI • INTRODUZIONE STORICA • BIOGRAFIE DEI PERSONAGGI • ITINERARI STORICO-TURISTICI • INDIRIZZI UTILI LA MARCIA SU ROMA di Mario Bussoni www.viaggiestoria.com viaggi nella storia ® by www.viagginellastoria.it B Mattioli 1885 Milano Cremona Perugia Monterotondo Civitavecchia Mentana Santa Marinella Tivoli ROMA Comando Centri di Raccolta Città importante In un quadro del pittore Giacomo Balla: l'ingresso a Roma. Mentana Tivoli abc 4 La Marcia su Roma La Marcia su Roma prima edizione Aprile 2012 © Mattioli 1885 srl - Strada della Lodesana, 649/sx, Loc. Vaio, 43036 Fidenza (Parma) tel. 0524.892111 - www.mattioli1885.com Grafica e Impaginazione Officine Grafiche Multimediali Via del Torrione, 27 - 43122 Parma Viaggi nella storia ® by www.viagginellastoria.it www.viaggiestoria.com Testi: Mario Bussoni Editing: Riccardo Baudinelli Coordinamento collana: Marcello Calzolari Foto di copertina: "L'Azione", statua del Vittoriano, Roma Tutti i diritti sono riservati. La riproduzione, anche parziale e con qualsiasi mezzo, non è consentita senza la preventiva autorizzazione scritta dell’editore. Viaggi nella Storia 5 PRESENTAZIONE Celebrata dal Regime come l’epilogo della Rivoluzione fascista, cosa è stata realmente la Marcia su Roma: una semplice manifestazione di piazza, sostanzialmente sopravvalutata, un vero e proprio colpo di stato o piuttosto una manifestazione violenta, un azzardo, fortunosamente andato a buon fine? Nelle pagine che seguono ne abbiamo ricostruito con precisione la dinamica, partendo dal 24 ottobre 1922, quando, nel corso del raduno delle camicie nere a Napoli, Benito Mussolini afferma sicuro: “O ci daranno il governo o lo prenderemo calando a Roma”. -

Storia Cont.Pdf
Ministero dell’interno Dipartimento per l’amministrazione generale, per le politiche del personale dell’amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie Concorso pubblico, per titoli ed esami, a 200 posti per l’accesso alla qualifica iniziale della carriera prefettizia - Prova Preselettiva - Storia Contemporanea – n. 800 quesiti Storia Contemporanea - Difficile 1 Il 4 aprile 1949 nasceva la NATO, quali Stati ne fecero fin da subito parte? A Belgio, Canada, Danimarca, Francia, Islanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Portogallo, Regno Unito, Stati Uni B Finlandia, Canada, Polonia, Francia, Islanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Portogallo, Regno Unito, Stati Uni C Unione Sovietica, Cina, Danimarca, Francia, Islanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Portogallo, Regno Unito, Sta Uni D Belgio, Canada, Danimarca, Turchia, Islanda, Jugoslavia, Spagna, Norvegia, Paesi Bassi, Portogallo, Regno Unito, Stati Uni 2 La "rivoluzione dei garofani" portoghese ebbe, nel 1975, come effetto: A la proclamazione di indipendenza delle colonie africane B il mantenimento, da parte del governo portoghese, delle colonie africane C l'invasione militare delle colonie africane D l'instaurazione, nei territori delle colonie africane, di governi provvisori retti da militari portoghesi 3 Negli Stati Uniti il 24 ottobre 1929 si verificò un evento passato alla storia come: A il Giovedì nero B il Giovedì di sangue C il Giorno della Borsa D il Giovedì della Borsa 4 Sotto quale zar, nel 1861, fu abolita la servitù della -

Questionariostoria
QuestionarioStoria 1 In seguito a quale evento bellico l'esercito del Regno 7 A seguito di quale accusa fu sciolto il Partito d'Italia poté entrare in Roma nel 1870? Socialista Italiano nel 1894? A) Alla sconfitta dei Francesi a Sedan A) L'accusa di aver appoggiato i Fasci siciliani B) Alla sconfitta dei Prussiani a Verdun B) L'accusa di spionaggio a favore della Seconda Internazionale socialista C) Alla sconfitta degli Austriaci a Sadowa C) L'accusa di voler attentare alla vita del sovrano D) Alla sconfitta dei Francesi a Lipsia D) L' accusa di aver attentato alla vita di Umberto I 2 Come reagì il governo Rudinì alle agitazioni popolari del 1898? 8 Tra quali nazioni l'irredentismo italiano fu causa di rapporti diplomatici tesi? A) Cercò alleanze in parlamento A) L'Italia e la Polonia B) Fece importanti concessioni ai dimostranti B) L'Italia e la Grecia C) Rassegnò le dimissioni C) L'Italia e l'Impero ottomano D) Si affidò all'esercito D) L'Italia e l'Austria - Ungheria 3 Nel 1884 il governo Depretis abolì un'imposta invisa alla popolazione. Quale? 9 In quale anno morì Camillo Cavour? A) La tassa sul macinato A) Nel 1865 B) La tassa doganale regionale B) Nel 1875 C) La tassa comunale di utilizzo delle acque pubbliche C) Nel 1861 D) La tassa sulla prima casa D) Nel 1871 4 Quali direttive di politica estera adottò Antonio 10 Nel 1861 espugnò, dopo un assedio, la fortezza di Rudinì nel marzo del 1896, quando fu incaricato di Gaeta, ultima roccaforte dei Borbone; condusse nella sostituire Francesco Crispi alla guida dell'Esecutivo? Terza guerra d'indipendenza le truppe dell'esercito che operavano sul basso Po. -

Working Paper Dipartimento Di Economia Pubblica
WORKING PAPER DIPARTIMENTO DI ECONOMIA PUBBLICA Working Paper n. 141 Silvia Fedeli e Francesco Forte A survival analysis of the circulation of the political elites governing Italy from 1861 to 1994 Roma, Aprile 2011 1 Silvia Fedeli and Francesco Forte A survival analysis of the circulation of the political elites governing Italy from 1861 to 1994 Abstract We study the determinants of governments and legislatures’ survival in Italy from the unification to the end of the I Republic (1861-1994) - excluding the fascist period and the subsequent transitory institutional period, "Constituente" (1946-1948). We test whether institutional features such as electoral systems, form of State and extent of suffrage had any effect on the survival of legislatures and governments. We control for voting power of the parliamentary groups, number of parties represented in the parliament and size of the representative bodies. Unlike the political economy wisdom, we show that, over the whole period, governments and legislatures’ survivals are inversely related to the plurality electoral system. The restricted suffrage and a high voting power of the leading parties reduce the risk of anticipated end of governments. The survival of the legislatures is related to the form of state (republic) and to the voting power of the leading party. Universita’ di Roma “La Sapienza” Facolta’ di Economia Dipartimento di Economia e diritto Via del Castro Laurenziano, 9 00161 Roma – Italy E-mail: [email protected] [email protected] Tel. and Fax +39 06 4976 6399 Keywords: Elites; Survival analysis; Electoral systems; Voting power, Political institutions. 2 1. Introduction In this paper we analyze the “struggle for survival” of governments and legislatures of the Italian democratic parliaments, from the creation of the Italian state (1861) up to 1994, with the exclusion of the fascist period (i.e., the legislatures from 1924 to 1945 in which the democratic institutions were absent and of the subsequent transitory institutional period, known as "Constituente", lasting until 1948). -

Diapositiva 1
L’Italia fascista Lezioni d'Autore La crisi economica del primo dopoguerra Disoccupazione dilagante Ritorno dal fronte dei reduci Popolazione in larghissima parte rurale Industria da riconvertire dalle produzioni belliche Fallimento di molte imprese Le elezioni del 1919 Prime elezioni a suffragio universale maschile con sistema proporzionale. Affermazione dei primi partiti di massa: il Partito Socialista ottiene la maggioranza relativa con il 32,4% dei voti; il Partito Popolare ottiene il 20,6% Il nuovo governo è guidato dal liberale Francesco Saverio Nitti. Le rivendicazioni dei reduci Scontro tra: - maggioranza socialista che rivendica la sua antica posizione neutralista contro la carneficina della Grande Guerra - minoranza dei reduci che rivendicano i frutti e l’esaltazione della vittoria militare, che considerano ‘mutilata’. 1919-1920 - Il biennio rosso I socialisti guidano grandi scioperi operai e contadini e occupano fabbriche e terre. Questo crea: → Un clima di paura → Un clima di attesa di un’imminente rivoluzione bolscevica in Italia. Combattentismo: Associazione Nazionale Combattenti, movimento figlio dell’interventismo di sinistra dell’anteguerra. Nazionalismo: Associazione Nazionalista di Alfredo Rocco e Luigi Federzoni. Settembre 1919 - L’avventura fiumana Gruppi armati irregolari e reparti dell’esercito ammutinatisi, guidati da Gabriele D’Annunzio, occupano militarmente la città di Fiume per mettere la Conferenza di Parigi di fronte al fatto compiuto. Alla fine del 1920, la questione è risolta da Giolitti che, come capo del governo, manda l’esercito a disoccupare Fiume nel rispetto del trattato di Rapallo. → L’avventura fiumana rese palese a tutti l’estrema debolezza del governo. Viene svalutata l’idea stessa della democrazia rappresentativa “Il potere politico spettava direttamente ai ‘produttori’ e ai ‘combattenti’, non ai neutralisti traditori, e neppure agli screditati notabili liberali che il ‘parlamentarismo’ aveva espresso sino ad allora. -
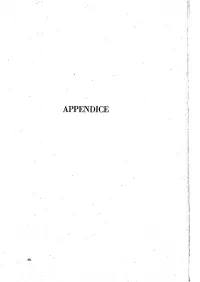
APPENDICE I - ' ' ' -Il
vi APPENDICE I - ' ' ' -il PRESIDENTI DELLA REPUBBLICA ENRICO DE NICOLA, Capo prov visorio dello Stato dal 28 giugno 1946 al 24 giugno 1947 dal 25 giugno al 31 dicembre 1947 ENRICO DE NICOLA, Presidente della Repubblica ; dal 1° gennaio 1948 all'11 maggio 1948 LUIGI EINAUDI, Presidente della Repubblica dall'll maggio 1948 >"..". r ?.-.' V-r^v;*-"^"^ - •«• « ***•••>*• , . :ir.'-.•.:••.• L T • ~ i : ~ . ..' -» "• »-1 -?. ' *- / >^1 • - A •; li ENRICO DE NICOLA 82. • ' ? LUIGI EINAUDI PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI GIOVANNI GRONCHI. dall'8 maggio 1948 PRESIDÈNTE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA IVANOE BONOMI dall'8 maggio 1948 GIOVANNI GRONCHI -J-Ì IVANOE BONOMI PRESIDENTI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI DALLA I ALLA XXVI LEGISLATURA VINCENZO GIOBERTI dall'8 maggio al 20 luglio 1848 e dal 16 ott. 30 die. 1848 IL . LORENZO PARETO dal 1° febbr. al 30 marzo 1849 III. LORENZO PARETO dal 30 luglio al 20* nov. 1849 IV . PIER DIONIGI PINELLI dal 20 die. 1849 al 25 aprile 1852 UHBANO RATTAZZI dall'll maggio 1852 al 27 ott. 1853 CARLO BON-COMPAGNI dal 16 al 21 nov. 1853 V ... CARLO BON-COMPAGNI. dal 19 die. 1853 al 16 giugno 1856 CARLO CADORNA.. dal 7 genn. al 16 luglio 1857 VI .. CARLO CADORNA. dal 14 die. 1857 al 14 luglio 1858 URBANO RATTAZZI. dal 10 genn. 1859 al 21 genn. 1860 VII . GIOVANNI LANZA dal 2 aprile al 28 die. 1860 VIII URBANO RATTAZZI. dal 18 febbr. 1861 al 2 marzo 1862 SEBASTIANO TECCHIO dal 22 marzo 1862 al 21 magg. 1863 GIOVANNI BATTISTA CASSINIS dal 25 maggio 1863 al 7 sett. 1865 IX.