Pendolaria2015, Il Rapporto
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

IMAGINE Scientific Annex 3 Exploring Soa Mobility Offer
TARGETED ANALYSIS // IMAGINE Developing a metropolitan-regional imaginary in Milan-Bologna urban region Scientific annex 3 // Exploring the state of the art in terms of in- tegrated mobility offer This Targeted Analysis is conducted within the framework of the ESPON 2020 Cooperation Programme, partly financed by the European Regional Development Fund. The ESPON EGTC is the Single Beneficiary of the ESPON 2020 Cooperation Programme. The Single Operation within the programme is implemented by the ESPON EGTC and co-financed by the European Regional Development Fund, the EU Member States, the UK, and the Partner States, Iceland, Liechtenstein, Norway, and Switzerland This delivery does not necessarily reflect the opinions of members of the ESPON 2020 Monitoring Committee. Coordination and Outreach Valeria Fedeli (Politecnico di Milano), Piera Petruzzi (ESPON EGTC) Authors POLITECNICO DI MILANO - DASTU: Prof. Valeria Fedeli, Prof. Alessandro Balducci, Prof. Ilaria Mariotti, Prof. Paolo Beria, Prof. Paolo Bozzuto, Prof. Francesco Curci, Dr Fabio Manfredini, Dr. Dante Di Matteo, Dr. Federica Rossi, Dr. Michelangelo Secchi, Dr. Luigi Carboni, Dr. Ing. Vardhman Lunkar SCIENCESPO: Prof. Marco. Cremaschi, Dr. Martina Busti, MA Rebecca Fern GLOBUS et LOCUS: Prof. Paolo Perulli, Dr. Livia D’Anna, Dr. Luca Garavaglia, Dr. Piero Bassetti, Dr. Francesco Galli Advisory group Stakeholders: Isabella Susi Botto, Carmine Pacente, Milano Metropolitan City, IT (lead stakeholder) | Silvia Bernardi, Alessandro Del Piano, Francesco Selmi, Metropolitan City of -
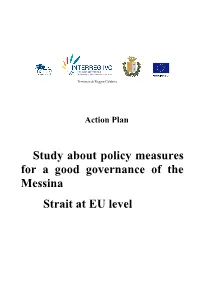
Action Plan Test
Provincia di Reggio Calabria Action Plan Study about policy measures for a good governance of the Messina Strait at EU level Index Premise Giuseppe Raffa President of the Province Section I-Nostra good practices Joint governance Chap. I- General aspects: objectives of the development plan; cross – strait aspect 1.1 Towards a model of participatory governance (Amelia Laura Crucitti) 1.2 Identity and Landscape in the Integrated Area of the Strait (Marina Arena) 1.3 Key Performance Indicators of the cities' performance levels. Comparing experiences and hypothesis testing for the Metropolitan City of the Strait (Celestina Fazia) Section II-Nostra good practices Sustainable transport Chap. II- Transports: expected outputs of the possible implementation 2.1 The transport system (Domenica Catalfamo, Giovanna Chilà) Section III-Nostra good practices Preservation of biodiversity Chap. III-Biodiversity: expected outputs of the possible implementation 3.1 Humid environment of the Messina Strait: essential habitat for the biodiversity conservation. The case of Lake Aquila (Calabria- Italia) (C. M. Musarella, G. Spampinato, S. Cannavò, F. Forestieri & E. Cano) 3.2 Characteristics and uniqueness of the ecosystem: the marine and terrestrial fauna of the Messina Strait (Gianni Giglio, Emilio Sperone) Section IV-Nostra good practices Sustainable tourism Chap. IV- Tourism: knowledge and skills 4.1. Local resources as drivers for the development of the Strait's integrated area between methodological and operational translations: shared scenarios between Reggio Calabria and Messina. The role of the metropolitan cities of Reggio Calabria and Messina in the exploitation of the local resources in the Strait Integrated Area (Alessandra Barresi, Gabriella Pultrone) 4.2 The cross- Messina strait swim Chap. -

Posillipo Finance Ii S.R.L
POSILLIPO FINANCE II S.R.L. (incorporated with limited liability under the laws of the Republic of Italy) Series 2007-1 Euro 870,000,000 Class A1 Asset-Backed Floating Rate Notes due 2035 guaranteed by Issue Price: 100% Series 2007-1 Euro 870,000,000 Class A2 Asset-Backed Floating Rate Notes due 2035 guaranteed by Issue Price: 100% Application has been made to the Commission de Surveillance du Secteur Financier for the approval of this Prospectus pursuant to Directive 2003/71/EC of the European Parliament and of the Council of 4 November 2003 (the “Prospectus Directive”) as transposed in Luxembourg on 10 July 2005 and application has been made to the Luxembourg Stock Exchange for the listing on the official list of the Luxembourg Stock Exchange and admission to trading on the Regulated Market of the Luxembourg Stock Exchange of the Series 2007-1 Euro 870,000,000 Class A1 Asset-Backed Floating Rate Notes due 2035 (the “Class A1 Notes”) and the Series 2007-1 Euro 870,000,000 Class A2 Asset-Backed Floating Rate Notes due 2035 (the “Class A2 Notes” and, together with the Class A1 Notes, the “Notes”) issued by Posillipo Finance II S.r.l., a limited liability company incorporated under the laws of the Republic of Italy (the “Issuer”). The holders of each such Class of Notes shall be referred to as the “Class A1 Noteholders” and the “Class A2 Noteholders” respectively and together collectively as the “Noteholders” and the terms and conditions of the Notes shall be referred to as the “Conditions” (and any referen ce herein to a numbered Condition is to the correspondingly numbered provision thereof). -

Ottawa's Answer to Bus Capacity
THE INTERNATIONAL LIGHT RAIL MAGAZINE www.lrta.org www.tautonline.com DECEMBER 2019 NO. 984 OTTAWA’S ANSWER TO BUS CAPACITY... Rewarding excellence at the??? 2019 Global Light Rail Awards ‘Work to do’ on sustainable transport Bremerhaven to reinstate tram service? Foshan fuel cell tram commissioning Algeria Munich £4.60 North Africa’s tram Growing light rail revolution rolls on in Bavaria’s capital European Light Rail Congress TWO days of interactive debates... EIGHT hours of dedicated networking... ONE place to be Ibercaja Patio de la Infanta Zaragoza, Spain 10-11 June The European Light Rail Congress brings together leading opinion-formers and decision-makers from across Europe for two days of debate around the role of technology in the development of sustainable urban travel. With presentations and exhibitions from some of the industry’s most innovative suppliers and service providers, this congress also includes technical visits and over eight hours of networking sessions. 2020 For 2020, we are delighted to be holding the event in the beautiful city of Zaragoza in partnership with Tranvía Zaragoza, Mobility City and the Fundación Ibercaja. Our local partners at Tranvía Zaragoza have arranged a depot tour as part of day one’s activities at the European Light Rail Congress. At the event, attendees will discover the role and future of light rail within a truly intermodal framework. To submit an abstract or to participate, please contact Matt Johnston on +44 (0)1733 367607 or [email protected] +44 (0)1733 367600 @ [email protected] www.mainspring.co.uk MEDIA PARTNERS EU Light Rail Driving innovation CONTENTS The official journal of the Light Rail 450 Transit Association DecemBER 2019 Vol. -

Naples. May 3-9, 2019
NAPLES. MAY 3-9, 2019 1 NAPLES. 2 NAPLES. Proposal Document Table of Contents Page SUMMARY 5 1. Proposed City Location: Naples 6 2. Conference Centre 7 3. Accommodation 7 4. Organization 8 5. Included in Proposal Document 9 SUPPORTING THE INITIATIVE 12 Letters of Endorsement 13 Invitation letter from SIG President 18 Candidature Sponsors 21 EXTENDED APPLICATION FORM 22 1. PROPOSED CITY LOCATION 23 Why WTC 2019 in Naples 24 2. CONFERENCE CENTRE 27 Mostra d'Oltremare 28 Key Plan 29 Accessibility 30 Spaces for WTC 2019 31 Other Facilities within Mostra d'Oltremare 39 3. ACCOMMODATION 40 Naples Hotel capacity 41 Hotel Room Block 42 GETTING THERE 45 Naples by Air 46 Naples by Train 49 Naples by Car 49 Visas 50 GETTING AROUND 51 Metro System 52 Trams and Buses 52 Public Transport App 52 Bike Sharing 53 Car Sharing 53 GOOD TO KNOW 54 Climate 55 Power Outlets 55 Typical prices of some popular items in Naples 56 4. ORGANIZATION 57 SIG Experience in Organzing Congresses 58 Synergy with the national Conference 60 Professional Congress Organizer 61 Organization Chart 62 International Steering Committee 63 3 NAPLES. Scientific Committee 63 Local Organizing Committee 64 5. INCLUDED IN PROPOSAL DOCUMENT 65 Engineering, Innovation, Archaeology, Architecture and Art 66 Engineering 67 Innovation 70 Archaeology 72 Architecture 75 Art 77 Draft Programme with Dates 82 A.A.A. On-Site Technical Visits 83 Locations for WTC 2019 Social Programme 87 Projected Fees for Delegates, Exhibitors and Sponsors 92 Draft Budget 93 The WTC's Impact on Local, National and Regional Markets 94 Naples 2019 Underground Tunnelling: History 95 Naples 2019 Underground Tunnelling: Future Perspectives 97 The Italian Context 100 6. -

CONTROLLO DELLE FLOTTE NEL TPL “AVM - Analisi Dello Stato Dell’Arte E Focus Di Approfondimento”
CONTROLLO DELLE FLOTTE NEL TPL “AVM - Analisi dello Stato dell’arte e focus di approfondimento” EDIZIONE DICEMBRE 2018 CONTROLLO DELLE FLOTTE NEL TPL Rev 3 “AVM - Analisi dello Stato dell’arte e 5 dicembre 2018 pag. 3/109 focus di approfondimento” RINGRAZIAMENTI Il presente documento è stato redatto grazie all’impegno assicurato dal GDL ITS della Commissione Tecnologica ASSTRA con i Rappresentanti delle seguenti Aziende di Trasporto Pubblico Locale: Arezzo TIEMME; Bari AMTAB; Bari FERROTRAMVIARIA; Bergamo ATB MOBILITA’; Bologna TPER; Bolzano SASA; Brescia BRESCIA MOBILITA’; Brindisi STP; Cagliari ARST; Cagliari CTM; Catania AMT; Cesena START ROMAGNA; Chieti TUA; Cosenza AMACO; Messina ATM; Milano GESTIONE GOVERNATIVA LAGHI; Napoli ANM; Napoli EAV; Napoli CONSORZIO UNICOCAMPANIA; Palermo AUTOLINEE GALLO; Roma SERVIZIMOBILITA’; Reggio Calabria ATAM; Saluzzo BUS COMPANY; San Donà di Piave ATVO; Sassari ATP; Taranto AMAT; Torino GTT; Torino 5T; Trento TT; Trieste TT; Venezia ACTV; Verona ATV. Il GDL ITS è stato coordinato da ASSTRA. Tutte le Aziende del GDL ITS hanno fornito, in alcuni casi, una partecipazione diretta alla redazione del documento, in altri casi, una verifica applicativa sullo stato di avanzamento del documento assumendone, quindi, la paternità dei contenuti. Pertanto, si ringraziano calorosamente tutti i soggetti coinvolti, certi di poter contare per il futuro sulla loro partecipazione e sulla collaborazione dei loro Rappresentanti. In particolare, si ringraziano, in ordine alfabetico, le persone che con competenza e disponibilità -

Italy Rail Report 2011 ENG-Final
The Rail Market in Italy 2011 Brooks Market Intelligence Reports, part of Mack Brooks Exhibitions Ltd www.brooksreports.com Mack Brooks Exhibitions Ltd © 2011. All rights reserved. No guarantee can be given as to the correctness and/or completeness of the information provided in this document. Users are recommended to verify the reliability of the statements made before making any decisions based on them. Contents Introduction 4 1. Government 5 Ministry of Infrastructure and Transport 5 Political and funding environment 5 Subsidised services 6 Open access and regulation 6 European projects 7 2. Italian Railways: FS Group 8 Gruppo Ferrovie dello Stato (FS Group) 8 Rete Ferroviaria Italiana SpA (RFI) 10 High-speed/high-capacity (Alta velocità/Alta capacità 10 - AV/AC) lines Urban junctions 12 Messina Straits bridge 12 Other RFI investments 13 Major international projects 14 Trenitalia SpA 16 Passenger 16 Freight 17 Traffic 18 Rolling stock 18 3. Italian regional government and local railways 21 Abruzzo 21 Basilicata 22 Calabria 22 Campania 22 Emilia-Romagna 23 Friuli-Venezia-Giulia 24 Lazio 24 Liguria 24 Lombardia 25 Marche 26 Molise 26 Piemonte 26 Puglia 26 Sardegna 28 Sicilia 28 Mack Brooks Exhibitions Ltd © 2011 2 Toscana 28 Trentino-Alto Adige 29 Umbria 29 Valle d’Aosta 30 Veneto 30 4. Open access train operators active in Italy 31 Passenger operators 31 Freight operators 32 5. Urban rail systems in Italy 35 Bergamo 35 Brescia 35 Bologna 35 Cagliari 35 Catania 36 Firenze 36 Genova 36 Messina 36 Milano 36 Napoli 37 Palermo 38 Parma 38 Roma 38 Sassari 38 Torino 39 Trieste 39 Verona 39 Mack Brooks Exhibitions Ltd © 2011 3 Introduction In terms of route-km, Italy’s railway network is the fourth largest in Europe, after those of France, Germany and Poland. -

Continuing Developments in Light Rail Transit in Western Europe United Kingdom, France, Spain, Portugal, and Italy
CLOSING GENERAL SESSION Continuing Developments in Light Rail Transit in Western Europe United Kingdom, France, Spain, Portugal, and Italy GLEN D. BOTTOMS Federal Transit Administration he primary focus of this paper was to provide a brief but informative survey of new light rail T transit applications in Western Europe, concentrating on developments and trends in the United Kingdom, France, Spain, Portugal, and Italy. Since the author’s last update in November 2000 for the 8th National Light Rail Conference, a spirited amount of activity has been observed in the countries cited above. The trend toward constructing new light rail systems, which had its genesis in France, and which has continued at a high level in that country, has generally spread throughout Western Europe and the British Isles. Light rail also continues to be implemented in progressively smaller cities than previously noted with cities having populations as low as 150,000 choosing to make significant long-term capital investments in fixed rail facilities (and willing to tax themselves to do so). The goals of all new cities implementing light rail projects in the countries examined in this paper have proven to be astonishingly similar to those of cities previously implementing light rail projects. The influence of the largely successful trailblazer systems in France cannot be underestimated [Nantes (1985) and Grenoble (1987)]. All cities expressed the urgent need to provide a viable, affordable alternative to the automobile, improve the quality of life, enhance mobility, address environmental concerns, and promote land use trends that produce energy efficient, traffic reducing development, and enhance the overall competitiveness of the city as a desirable place to live and work.