Report Evento Elba 7-11-11 DEF
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Evidence of Romanesque Architecture on Elba Alessandro Naldi Foto: Cinzia Battaglia, Gianluca Pucci, Alessandro Puorro, Leonardo G
Evidence of Romanesque architecture on Elba Alessandro Naldi Foto: Cinzia Battaglia, Gianluca Pucci, Alessandro Puorro, Leonardo G. Terreni Evidence of Romanesque architecture on Elba Divided into four parishes, being under the clerical ju- found on Elba. risdiction of the bishop of Massa Marittima, the Isle of The lack of studies about this topic results in insuffi- Elba still preserves some relevant evidence of Roman- cient researches and significant answers to certain phe- esque architecture, which on the whole represents a nomena that seem to have characteristics in common typical and interesting example of the varied cultures with the Romanesque culture of Tuscany, but some par- represented on the island, as it was a landing and cross- ticular exceptions. roads of trade from different areas. One of these is the odd case represented by the Church Unfortunately, the Romanesque architecture on Elba of Santi Pietro e Paolo (today dedicated to San Niccolò) hasn’t been much investigated, so the island is often at San Piero in Campo, which features a unique iconog- seen just as a cultural possession of Pisa. Actually, the raphy in whole Tuscany. The church has five aisles and Pisans ruled over the island between the 12th and 13th is divided into two identical naves with apse. It had two centuries, nevertheless no building features an evident altars, it didn’t have a high altar, as was the case of all Pisan origin, as it is the case of Corsica and Sardinia. Christian churches. This is a phenomenon to be found Indeed, no example of two-coloured churches is to be only in some specific areas of Italy, like in the Salento La Pieve di S. -

I Lavori Degli Alunni Che Hanno Partecipato Alla
I lavori degli alunni che hanno partecipato alla Quarta Settimana novembre 2008 Con il patrocinio di Provincia di Livorno Comune di Livorno Comuni della Provincia di Livorno Progetto editoriale e redazione testi Stefania Fraddanni Grafica e stampa Debatte Otello S.r.l. - Livorno Fondazione Cassa di Risparmi di Livorno Finito di stampare nel mese di novembre 2008 Piazza Grande, 21 - 57123 Livorno Tel. 0586 826111 - Fax 0586 230360 © copyright 2008 [email protected] www.fondazionecariliv.it ISBN: 978-88-6297-000-6 Introduzione Anche quest’anno la Fondazione Cassa di Ri- Diciassette progetti sparmi di Livorno ha organizzato la “Settimana dei Beni Culturali ed Ambientali”, la manife- stazione nata per stimolare un più stretto rap- nell’anno scolastico porto degli studenti livornesi con il territorio in cui vivono e per promuovere la scoperta e la tutela delle bellezze culturali ed ambientali di 2007 / 2008 cui è ricca la nostra provincia. Le tappe conclusive di questa quarta edizione si sono svolte dal 17 al 31 maggio 2008, con l’esposizione al pubblico dei 17 progetti presentati dagli studenti, nelle quattro mostre allestite a Livorno, Castiglioncello, Rosignano, Piombino e Portoferraio. Complessivamente, nell’anno scolastico 2007-2008, hanno lavorato ai progetti 50 classi di alunni che, come di consueto, hanno manifestato il desiderio di preservare l’ambiente e di valorizzare le numerose testi- monianze del nostro passato. Lo spirito dell’iniziativa proposta dalla Fondazione è stato pienamente recepito e sviluppato in tutti i lavori e, come nelle precedenti edizioni, gli istituti scolastici partecipanti sono stati premiati con un contributo per l’acquisto di materiale didattico, o comunque a supporto dell’attività didattica. -

Alla Cortese Attenzione Del Dottor
Il Sampierese A Foglio di attualità, costume e politica del territorio di Campo nell’Elba a cura del Centro Culturale “Le Macinelle” di S. Piero in Campo. “Facciamoci sentire per non farci seppellire” Omaggio Anno XVI, Num. 12– Dicembre 2019 Editoriale a ruota del tempo quest’anno sembra aver girato più veloce Index del solito trasportandoci quasi L Pag. 1/7 – Editoriale inavvertitamente all’epilogo di questo 2019 e già respiriamo la calda Pag. 2 - P.za della Fonte: Identità come fatto atmosfera del Natale. Si conclude culturale anche il XVI° anno dall’inizio dell’avventura de “Il Sampierese” e Pag. 3/4- Alla ricerca dell’ultimo Dio andiamo fieri così della nostra (Aldo. Simone) costanza e come di quella dei nostri affezionati Lettori. Con passione Pag. 4 - Cucina Elbana: (Stefania Calderara) abbiamo raccontato le vicende più salienti del Paese nell’ambizione di Pag. 5 - Orizzonti: Archeologia. sull’Elba farle giungere a quei Sampieresi (di Edel Rodder) “d’oltre mare” che con senso di Pag. 6 - L’Elba e le sue eccellenze ( di Stefano comprensibile nostalgia ci si Bramanti) avvicinano maggiormente leggendo le nostre righe. L’ardore e l’amore che Pag. 8/9- Lettere al Direttore portiamo per il Paese ha guidato la nostra penna. Forse le delusioni per Pag. 9 – Dicembre e le sue Storie quelle che abbiamo considerato negligenze amministrative sono state Pag. 9 - In ricordo di Alfonso D. (di G. causa di toni talvolta un po’ forti, ma Cristiano) in noi mai ha albergato l’intenzione di recare offesa; per questo chiediamo Pag. 10- Luci Accese su S. -

Insel Elba Die Lieblingsinsel Der Italiener Steht Auch Bei Deutschen, Österreichern Und Schweizern Hoch Im Kurs
Elba 163 Karten S.Karten 70/71 238/239 und S. Toscana Bei Seccheto – einer der vielen einladenden Badestrände Elbas Insel Elba Die Lieblingsinsel der Italiener steht auch bei Deutschen, Österreichern und Schweizern hoch im Kurs. Wen wundert’s – keine italienische Insel ist vom Norden aus einfacher zu erreichen als Elba. Den sonnenhungrigen Besucher erwarten abwechslungsreiche Landschaften, eine vielfältige Vegetation, lebhafte Hafenorte und idyllische Bergdörfer, spektakuläre Buchten und traumhafte Strände. Elba beeindruckt durch eine außerordentliche landschaftliche Vielfalt, die man auf so kleiner Fläche sicherlich nicht vermuten würde: flache Küstenlandschaft mit herrlichen Sandbuchten im Süden, als Kontrast der steile und kahle Granitgipfel Monte Capanne im Westen, uralte Esskastanienwälder mit dichtem Unterholz, fel- sige Küstenabschnitte, die nur durch wenige kleine Buchten unterbrochen werden, und immer wieder auch die typische mediterrane Macchia. Elba ist ausgesprochen grün, dafür sorgen die zahlreichen Quellen, die hier entspringen. Abwechslungsreich auch die Inselorte: Wer mit der Fähre ankommt, sieht zuerst die Inselhauptstadt Portoferraio – mit ihrer hektischen Neustadt (samt Fährhafen) und dem Centro storico, die ursprünglich von den Medici konzipierte Altstadt mit ihren beschaulichen Gassen. Neben den vom Tourismus geprägten Hafen- und Badeorten wie z. B. Marina di Campo und Porto Azzurro bietet die Insel auch idyllische Bergdörfer, in denen die Zeit noch immer langsamer abzulaufen scheint. Marciana Alta, Rio nell’Elba und Capoliveri sind Beispiele für die geschichtsträch- tigen Orte abseits der Küste. Kulturhistorisch und wirtschaftlich bedeutend war Elba schon unter den Etruskern, die hier Eisenerz abbauten. Die Römer taten es ihnen gleich, und dann kamen sie 164 Toscana alle: Langobarden, Sarazenen, Pisaner, Genueser, Medici und schließlich auch der große Napoleon Bonaparte, von dessen kurzem Aufenthalt auf Elba die Insel noch heute zehrt. -

Il Ruolo Degli Oppida E La Difesa Del Territorio in Etruria: Casi Di Studio E Prospettive Di Ricerca
IL RUOLO DEGLI OPPIDA E LA DIFESA DEL TERRITORIO IN ETRURIA: CASI DI STUDIO E PROSPETTIVE DI RICERCA a cura di Franco Cambi ARISTONOTHOS Scritti per il Mediterraneo antico Vol. 5 (2012) Il ruolo degli oppida e la difesa del territorio in Etruria: casi di studio e prospettive di ricerca a cura di Franco Cambi Copyright © 2012 Tangram Edizioni Scientifiche Gruppo Editoriale Tangram Srl – Via Verdi, 9/A – 38122 Trento www.edizioni-tangram.it – [email protected] Prima edizione: giugno 2012, Printed in Italy ISBN 978-88-6458-044-9 Collana ARISTONOTHOS – Scritti per il Mediterraneo antico – NIC 05 Direzione Federica Cordano, Giovanna Bagnasco Gianni Comitato scientifico Carmine Ampolo, Pietrina Anello, Gilda Bartoloni, Maria Bonghi Jovino, Giovanni Colonna, Tim Cornell, Michel Gras, Pier Giovanni Guzzo, Jean-Luc Lamboley, Mario Lombardo, Nota Kourou, Annette Rathje, Henry Tréziny La redazione di questo volume è di Enrico Giovanelli Le ricerche effettuate per la preparazione del volume sono state sostenute con i fondi del PRIN 2008 In copertina: Il mare e il nome di Aristonothos. Le “o” sono scritte come i cerchi puntati che compaiono sul cratere. Progetto grafico di copertina: Stampa su carta ecologica proveniente da zone in silvicoltura, totalmente priva di cloro. Non contiene sbiancanti ottici, è acid free con riserva alcalina. Sommario Introduzione 9 Franco Cambi Parte I: Sezione tarquiniese Introduzione alla sezione tarquiniese 19 Giovanna Bagnasco Gianni La “fortificazione” prima degli “oppida”. Posizioni territoriali strategiche -

Die Vorschau Elba
Elba - Die Vorschau 12 Elba - Hintergründe & Infos 16 Geografie und Geologie 18 Freeclimbing 73 Golf 73 Flora und Fauna 20 Mountainbiken 74 Nordic Walking 74 Klima und Reisezeit 23 Reiten 74 Segeln 74 Wirtschaft und Tauchen 77 Tourismus 26 Tennis 77 Geschichte Elbas und des Wandern 78 Toskanischen Archipels 29 Windsurfen 79 Anreise 42 Wissenswertes von A bis Z 80 Mit dem Auto oder Motorrad 42 Ärztliche Versorgung 80 Mit der Bahn 46 Diplomatische Vertretungen 81 Mit dem Flugzeug 47 Einkaufen 81 Mit dem Bus 49 Eintrittspreise 82 Mit der Mitfahrzentrale 49 Feste und Feiertage 82 Mit der Fähre ab Piombino 50 Geld 83 Stopover Piombino 51 Hunde 84 Unterwegs auf Elba 55 Informationen/ Fremdenverkehrsämter 85 Mit dem eigenen Fahrzeug 55 Internet/WLAN 86 Busverbindungen 57 Landkarten und Literatur 86 Taxis 58 Öffnungszeiten 87 Pendelboote 58 Post 88 Mietwagen und -zweiräder 58 Rauchen 88 Motorbootverleih 59 Rechnungen 88 Zu den anderen Inseln 60 Reisedokumente 88 Übernachten 61 Reiseveranstalter 89 Sprache 89 Essen und Trinken 66 Sprachkurse 90 Strom 90 Elba sportlich 71 Telefonieren 90 Baden 71 Zeitungen/Zeitschriften 91 Ausflugsboote 72 Zoll 91 Beach-Volleyball 73 http://d-nb.info/1028005571 | Elba - Reiseziele 92 Portoferraio 94 Sehenswertes in der Altstadt Sehenswertes im Hinterland von Portoferraio 106 von Portoferraio 115 Mediceische Museo Italo Bolano/ Festungsanlagen Giardino deH'Arte 115 (Fortezze Medicee) 108 Die Villa Napoleons Villa dei Mulini/ in San Martino 116 Palazzina dei Mulini Capo d'EnfolaA/iticcio 119 (Museo napoleonico) 110 -

PFV 2012-2015 Carta Degli Istituti.Pdf
CALCINAIA MONTOPOLI IN VAL D'ARNO PONTEDERA CASCINA SAN MINIATO PROVINCIA DI LIVORNO PISA r n o 6 d e l l ' A SGC U³ Piano Faunistico 2012 - 2015 MONTAIONE 0 r e PONSACCO 1 0 o 0 t 0 a l m 0 0 c o 3 S VICARELLO 8 PALAIA M ") 4 TS 1 STRUTTURE FAUNISTICHE PREVISTE ³ 3 SUGC Scala 1:100.000 - Proiez. Gauss- Boaga Centro Intermodale ST 3 0 1.000 2.000 4.000 6.000 8.000 10.000 GUASTICCE CRESPINA TS555 5 Metri PADULE 19 30 DELLA 2 COLLESALVETTI STAGNO ST CAPANNOLI 0 18 CONTESSA ") 5 LARI TS224 L E G E N D A NUGOLA VECCHIA A 48 T 1 orrente ³±2 MONTAIONE TS4a 62 28 0 17 1 U LIVORNO ZONA INDUSTRIALE g FAUGLIA A io n A.N.P.I.L. DEMANIO MILITARE e TS l 6 ¼ 21 ± ") ³ 190 91 A.A.C. FONDO CHIUSO 1 LIVORNO l S ¼ S 106 0 l ALLEVAMENTO FAUNA PER RIPOPOLAMENTO OASI FAUNISTICA MONTAIONE ¼ PARCO l 6 ³ PECCIOLI PARRANA S. MARTINO 0 ¼ 2 AREA CONTIGUA TERRICCIOLA P.N.A.T. io R U R S Ma LORENZANA ggio 69 re 7 0 DELLE TS 0 LIMONCINO AREA REGIME SPECIFICO PARCO INTERPROVINCIALE 0 LA LECCIA 287 0 PARRANA S. GIUSTO 2 8 VALLE BENEDETTA CASCIANA TERME 4 ARDENZA 275 ") 241242 103 ART. 14 PARCO PROVINCIALE R nza TS8a Rio rde d A i Rio Po pog 1 na TS5a COLOGNOLE 404 ART. 14 - AREA CONTIGUA RISERVA NAT. PROVINCIALE 112 88 MONTENERO 5BIS b ST 5ST ART. -

Ambito N°27 ISOLA D’ELBA
QUADRO CONOSCITIVO Ambito n°27 ISOLA D’ELBA PROVINCE : Livorno TERRITORI APPARTENENTI AI COMUNI : Campo nell’Elba, Capoliveri, Capraia Isola, Marciana, Marciana Marina, Porto Azzurro, Portoferrraio, Rio Marina, Rio nell’Elba L’isola d’Elba – distante 10 km dal continente – misura 27 km da est a ovest, 18 da nord a sud; é fortemente montuosa, avendo solo il 6% del territorio in pianura I monti e le colline sono in 3 settori, separati da due valichi bassissimi. Da occidente verso oriente: il mas- siccio di M. Capanne (m. 1018), il settore centrale (m. S. Martino e M. Orello, m. 370 e 377) e la striscia prospiciente la costa conti- nentale: da nord a sud, M. Serra, 422 m. (Rio Marina), m. Castello, m. 516 (Porto Azzurro), m. Calamita, m. 413 (Capoliveri). Il settore di ponente è di rocce granitiche, il settore orientale di rocce scistose metamorfiche (ferrifere). L’idrografia è modestissima, date le dimensioni e la forma dell’isola (nessun punto del territorio arriva a distare 4 km dal mare). I mag- giori torrenti discendono dal M. Capanne, (rio di Pomonte, rio di Bovalico, con foce presso Marina di Campo). L’unico centro di una certa consistenza, e con una popolazione superiore ai 10.000 abitanti è Porto Ferraio IL SISTEMA DELLE COMUNICAZIONI Oggi esiste un anello di strade provinciali intorno all’isola (a parte il territorio di Capoliveri): Negli anni ’50 la costa occidentale e quella sud erano servite da mulattiere. Esiste a Marina di Campo un piccolo campo d’aviazione privato aperto al traffico turistico (pista di m. -

Torri E Forti Della Difesa Costiera
SOTTOSISTEMA DEI BENI ARCHITETTONICI: SISTEMA DI DIFESA COSTIERO n. scheda Comune denominazione Note 1 Bibbona Forte di Bibbona 2 Campo nell'Elba Torre di Marina di Campo 3 Campo nell'Elba Torre di San Giovanni 4 Capoliveri Forte Focardo 5 Capraia Isola Forte di San Giorgio 6 Capraia Isola Torre del Porto o del Grotta 7 Capraia Isola Torre della Teia o della Regina 8 Capraia Isola Torre dello Zenobito 9 Capraia Isola Torretta del Bagno rudere 10 Castagneto Carducci Forte di Castagneto 11 Cecina Torre di Cecina 12 Cecina Casetta di Capocavallo trasformata 13 Livorno Forte dei cavalleggeri di Livorno distrutto 14 Livorno Forte di Antignano trasformato 15 Livorno Fortezza Vecchia 16 Livorno Torre del Boccale 17 Livorno Torre del Marroccone distrutta 18 Livorno Torre del Fanale o del Marzocco 19 Livorno Torre del Mulinaccio distrutta 20 Livorno Torre di San Salvatore o del Romito 21 Livorno Torre della Meloria 22 Livorno Torre di Lantignano distrutta 23 Livorno Torre di Ardenza distrutta 24 Livorno Torre di Calafuria 25 Livorno Torre di Campo al Lupo distrutta 26 Livorno Torre Nuova (Gorgona) 27 Livorno Torre Vecchia (Gorgona) rudere 28 Livorno Torre Villa Conti 29 Marciana Marina Torre degli Appiani (Marciana Marina) 30 Piombino Forte di Piombino 31 Piombino Torre di Porto Baratti 32 Piombino Casetta Falcone distrutta 33 Piombino Ridotto di Porto Vecchio distrutto 34 Piombino Ridotto di Rio Fanale rudere 35 Piombino Torre del Sale 36 Piombino Torre Mozza 37 Porto Azzurro Forte di Longone 38 Portoferraio Forte Falcone 39 Portoferraio Forte -

Piano Protezione Civile
INTERCOMUNALE di PROTEZIONE CIVILE ELBA OCCIDENTALE Comuni di Campo nell’Elba – Marciana e Marciana Marina Piano Intercomunale di Protezione Civile INTRODUZIONE A.1. RELAZIONE INTRODUTTIVA Il circondario Elba Occidentale nasce il 10 aprile 2004 grazie alla volontà delle Amministrazioni Comunali di Campo nell’Elba, Marciana e Marciana Marina le quali sottoscrivono una convenzione per la gestione associata per le attività di Protezione Civile. Il Servizio di Protezione Civile del Comune di Campo nell’Elba ed il Gruppo di Volontariato omonimo, realtà già consolidate, assumono il ruolo di Capofila nella gestione. Tale convenzione è stata modificata e nuovamente approvata, in ottemperanza alla L.R.Toscana n. 67/2003 e regolamento n. 69/R, con atti deliberativi dei tre Consigli Comunali che uniscono le forze e costituiscono così una forma associata di decentramento amministrativo per l’esercizio e delle funzioni e servizi in ambito sovracomunale. La gestione associata dei servizi comunali di Protezione Civile ha come scopo principale quello di formare un ufficio comune che svolga per conto di tutti le attività di Protezione Civile, di attuare lo strumento organizzativo dei Comuni afferenti, (Piano Intercomunale), quello di Centro situazioni e di Centro Operativo in emergenza, dare supporto ai rispettivi Sindaci nelle decisioni sugli interventi, e di ottimizzare il raccordo con le Autorità competenti, favorendo così la massima funzionalità del sistema. Uno degli aspetti di maggior interesse, in un piano di pronto intervento di protezione civile, è senz'altro quello di riuscire ad ottenere una chiara conoscenza delle proprie risorse in termini di mezzi persone e del proprio ambito territoriale, sotto l'aspetto fisico (paesaggio, aspetto territoriale), morfologico-geologico (topografia,morfologie - collina, pianura- uso del suolo, litologie), idrografico ed orografico (reticolo idrografico, corsi d'acqua, alveo, portate massime) assetto della popolazione (numero residenti suddivisi per classi di età, condizione, handicap e loro distribuzione, flussi turistici, altro). -
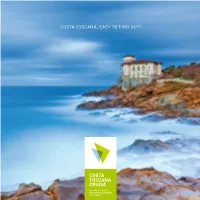
COSTA TOSCANA CRUISE 1 Incoming Projects for the Development of Tourism 2 SUMMARY
COSTA TOSCANA, EasY to FIND OUT! COSTA TOSCANA CRUISE 1 INCOMING PROJECTS FOR THE DEVELOPMENT OF TOURISM 2 SUMMARY 5 LIVORNO: THE PORT FOR TUSCANY 7 Costa TOSCANA CRUISE 13 LIVORNO AND THE GRAND DUCHY OF TUSCANY 27 Bolgheri AND THE WINE ROAD 35 Elba Island AND THE PEARLS OF THE TYRRHENIAN SEA 47 Coast OF THE Etruscans, from THE hilltops to THE SEA 58 FOLKLORE, CUISINE AND CRAFTS 3 4 LIVORNO: THE PORT FOR TUSCANY The port of Livorno is the gateway to the most desirable destinations in Tuscany, a region that offers an endless range of excursions; from artistic cities to medieval villages, with tours of its unparalleled countryside, culture, flavors and good taste. Porto Livorno 2000 operates in the cruise ship and passenger sector in the port of Livorno. It offers a wide range of services where safety and efficiency are the guiding principles; it works in conjunction with local bodies to make the most of local tourist resources. Porto Livorno 2000 manages the Cruise Terminal, the Maritime Passenger Station, information services, car parks and transportation within the Port of Livorno. 5 6 Costa TOSCANA CRUISE The Tuscan Coast has always been an important crossroad for populations and cultures, so it is no surprise that it is a unique treasure trove that has long been famous. The beauty of the countryside and pristine beaches are unparalleled; the picture-postcard views of vineyards and cypresses, archaeological sites, medieval villages, monuments and museums, the gastronomic and wine producing traditions distinguish the entire area, from the hills to the sea, from the coast to the islands. -

02 Bortolotti-Fazzuoli 97
Ofioliti, 2001, 26 (2a), 97-150 97 GEOLOGY OF CENTRAL AND EASTERN ELBA ISLAND, ITALY Valerio Bortolotti, Milvio Fazzuoli, Enrico Pandeli, Gianfranco Principi, Amedeo Babbini and Simone Corti Department of Earth Science, University of Florence and Centro di Studio di Geologia dell’Appennino e delle Catene Peri- mediterranee, C.N.R., Via G. La Pira 4, I-50121, Florence, Italy (e-mail: [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]). Keywords: stratigraphy, tectonics, geodynamics, geological map. Elba Island, Northern Apennines, Italy. RIASSUNTO L’Isola d’Elba è ubicata nel Mar Tirreno Settentrionale a metà strada fra la Toscana (Appennino Settentrionale) e Corsica (Corsica Alpina). Il complesso edificio tettonico dell’Isola d’Elba, che è considerato l’affioramento più occidentale della catena nord-appenninica, è anche noto per i suoi giacimenti minerari a ferro e per gli evidenti rapporti tra la messa in posto di corpi magmatici mio-pliocenici e le ultime fasi tettoniche tangenziali. Il rilevamento alla scala 1:10.000 e 1:5.000 (carta geologica allegata alla scala 1:15.000) ha portato alla ricostruzione di un panorama stratigrafico e strut- turale dell’Isola d’Elba centro-orientale più articolato rispetto al classico schema dei cinque “Complessi” di Trevisan (1950) e Barberi et al. (1969). Sono stati infatti distinte nove unità tettoniche appartenenti ai domini paleogeografici Toscano, Ligure (comprese Unità Ligure-Piemontesi). Prima della loro definitiva messa in posto, alcune di queste unità sono state intruse da plutoni granitoidi (monzogranito del M.