Le Macchiette Interculturali Di Renato Carosone
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

American Rock with a European Twist: the Institutionalization of Rock’N’Roll in France, West Germany, Greece, and Italy (20Th Century)❧
75 American Rock with a European Twist: The Institutionalization of Rock’n’Roll in France, West Germany, Greece, and Italy (20th Century)❧ Maria Kouvarou Universidad de Durham (Reino Unido). doi: dx.doi.org/10.7440/histcrit57.2015.05 Artículo recibido: 29 de septiembre de 2014 · Aprobado: 03 de febrero de 2015 · Modificado: 03 de marzo de 2015 Resumen: Este artículo evalúa las prácticas desarrolladas en Francia, Italia, Grecia y Alemania para adaptar la música rock’n’roll y acercarla más a sus propios estilos de música y normas societales, como se escucha en los primeros intentos de las respectivas industrias de música en crear sus propias versiones de él. El trabajo aborda estas prácticas, como instancias en los contextos francés, alemán, griego e italiano, de institucionalizar el rock’n’roll de acuerdo con sus propias posiciones frente a Estados Unidos, sus situaciones históricas y políticas y su pasado y presente cultural y musical. Palabras clave: Rock’n’roll, Europe, Guerra Fría, institucionalización, industria de música. American Rock with a European Twist: The Institutionalization of Rock’n’Roll in France, West Germany, Greece, and Italy (20th Century) Abstract: This paper assesses the practices developed in France, Italy, Greece, and Germany in order to accommodate rock’n’roll music and bring it closer to their own music styles and societal norms, as these are heard in the initial attempts of their music industries to create their own versions of it. The paper deals with these practices as instances of the French, German, Greek and Italian contexts to institutionalize rock’n’roll according to their positions regarding the USA, their historical and political situations, and their cultural and musical past and present. -

Was Ist Der FRH? HHTW001 FRH 001 - Was Ist Der FRH? HHTW001
FRH 001 - Was ist der FRH? HHTW001 FRH 001 - Was ist der FRH? HHTW001 Nr Titel Label MasterNr. Jahr Nr Titel Jahr CW RB USA GB BRD 03 HELLO STRANGER (BARBARA LEWIS) ATLANTIC 2148 1963 03 HELLO STRANGER (BARBARA LEWIS) 1963- 1 3 - - 05 A QUIET PLACE (GARNETT MIMMS & THE ENCHANTERS) UA 715 1964 05 A QUIET PLACE (GARNETT MIMMS & THE ENCHANTERS) 1964- 78 78 - - C 07 ON BROADWAY (DRIFTERS) ATLANTIC 2182 1963 07 ON BROADWAY (DRIFTERS) 1963- 7 9 - - D 08 STAND BY ME (N) (SPYDER TURNER) MGM 13617 1967 08 STAND BY ME (N) (SPYDER TURNER) 1967- 3 12 - - 10 HELLO (MIT JINGLE)* (PAUL WILLIAMS) CAPITOL 3205 1955 10 HELLO (MIT JINGLE)* (PAUL WILLIAMS) 1955- - - - - - 11 CRAZY CRAZY PARTY (CUES) PREP 104 1957 11 CRAZY CRAZY PARTY (CUES) 1957- - - - - L 13 TIPPETY TOP (RAYS) CHESS 1613 1956 13 TIPPETY TOP (RAYS) 1956- - - - - a 15 HEY BOY HEY GIRL (OSCAR MC LOLLIE & JEANETTE BAKER CLASS 228 1958 15 HEY BOY HEY GIRL (OSCAR MC LOLLIE & JEANETTE BAKER) 1958- - - - - y 17 WHEN I FOUND YOU (JERRY REED) CAPITOL 3429 1956 17 WHEN I FOUND YOU (JERRY REED) 1956- - - - - o 18 THREE ALLEY CATS (ROY HALL) DECCA 30060 1956 18 THREE ALLEY CATS (ROY HALL) 1956- - - - - u 20 TEENAGE QUEEN (LONNIE BARRON) SAGE 45-230 1956 20 TEENAGE QUEEN (LONNIE BARRON) 1956- - - - - t 21 SAY YEAH (SAMMY SALVO) RCA 47-7097 1958 21 SAY YEAH (SAMMY SALVO) 1958- - - - - 23 DEEP SEA BALL (CLYDE MC PHATTER) ATLANTIC 2060 1958 23 DEEP SEA BALL (CLYDE MC PHATTER) 1958- - - - - - 24 SHE LOVES TO ROCK (FLAIRS) ABC-PARAM. -

Cartella Stampa
10 - 12 - 16 MARZO 1 RENZO ARBORE racconta GIANNI CONTE accompagnato dalle opere di LELLO ESPOSITO 17 - 19 - 21 MARZO 2 EUGENIO BENNATO racconta FIORENZA CALOGERO accompagnata dalle opere di ENRICO BENETTA 24 - 26 - 28 MARZO 3 STEFANO BOLLANI racconta LORENZO HENGELLER accompagnato dalle opere di ROXY IN THE BOX 31 MARZO | 2 - 4 APRILE 4 TOSCA racconta SUONNO D’AJERE accompagnati dalle opere di GIUSEPPE RICCARDI 7 - 9 - 11 APRILE 5 PEPPE BARRA racconta TOMMASO PRIMO accompagnato dalle opere di CHIARA PIROLLO 14 - 16 - 18 APRILE 6 MAURIZIO DE GIOVANNI racconta FLO accompagnata dalle opere di VALERIA LAUREANO 21 - 23 - 25 APRILE * “bonus track” della rassegna MALDESTRO i concerti saranno trasmessi in streaming sul sito e la pagina Facebook del TEATRO TRIANON VIVIANI teatrotrianon.org facebook.com/teatrotrianon e condivisi sui siti di CULTURA CAMPANIA – ECOSISTEMA DIGITALE PER LA CULTURA cultura.regione.campania.it INSTREAMING.EU instreaming.eu e i canali social di MUSEO MADRE SCABEC un progetto in collaborazione con UNIONE EUROPEA progetto cofinanziato da POC Campania 2014-2020 FONDAZIONE TRIANON VIVIANI partner tecnico sponsor con il patrocinio si ringrazia Suoni contro muri Suoni contro muri è una rassegna musicale che nasce da una mia idea. Mette in scena molti talenti e fa spettacolo miscelando le arti universali. Pittura, scultura, musica che sono arti affini nonostante approccino con differenti metodi alle fasi realizzative, riuscendo però a suscitare in fase performativa emozioni molto simili. Suoni contro muri 6 testimonial per 6 musicisti accompagnati da 6 artisti di arte contemporanea in 6 concerti: ho voluto chiamare cosi questa rassegna perché i teatri sono ancòra chiusi, e gli artisti vivono un periodo di grande mortificazione, sentendosi sempre più isolati. -

Nerocaffe' (Biografia)
NEROCAFFE’ (BIOGRAFIA) La storia dei NEROCAFFE’ inizia nel gennaio 2010. Il progetto artistico, dedicato alla musica italiana d’autore, prevede un concetto universale di musica nel quale i cinque musicisti si identificano. All’interno di questa linea artistica il principio di contaminazione musicale diviene un elemento ricorrente prima, ed essenziale poi, dell’identità della band. Il repertorio si basa prevalentemente sulla musica di Renato Carosone, e sulla rivisitazione di grandi classici della tradizione italiana, scritti o interpretati da artisti come Domenico Modugno, Fred Buscaglione, Antonio De Curtis, Claudio Mattone, Armando Trovajoli, Nicola Piovani, e Giorgio Gaber. Attraverso un intenso lavoro di riarrangiamento dei brani, la band, inserisce nelle strutture musicali citazioni e riferimenti alla musica da film, pop e jazz. Grazie alle esibizioni nei club, nei teatri e nelle radio della penisola, la band si fa notare ed apprezzare per quelle che sono le sue principali peculiarità: originalità, capacità, ed una certa ricercatezza che sia però sempre facilmente fruibile. Il 2011 si segnala come un anno importante, perché segna il debutto della band all’estero. I primi concerti tenutisi a Bruxelles (dove torneranno anche l’anno seguente), donano una dimensione internazionale al gruppo, oltre a testimoniare che i NEROCAFFE’ entrano a far parte di quel ristretto numero di artisti che hanno il privilegio di rappresentare la cultura italiana all’estero. Conseguenza di ciò è l’invito del Principe Alberto di Monaco al Gran Galà della Croix Rouge Monégasque, tenutosi nello splendido scenario della “Salle des Etoiles” dello Sporting Club di Montecarlo nell’agosto del 2013. Parallelamente all’attività live, si completa la produzione del primo disco della band (intitolato Renato Carosone Tribute), ma cosa più importante nasce un suono una identità… nasce NEROCAFFE’ Nel 2016 debuttano presso il Teatro Sistina di Roma, con lo spettacolo "Carosone e dintorni..." (per l'occasione registrato dal vivo su DVD ), riscuotendo grande successo. -

Renzo Arbore E L'orchestra Italiana
RENZO ARBORE L’ORCHESTRA ITALIANA Renzo Arbore, grande appassionato di tutta la musica e profondo estimatore della Canzone Napoletana Classica è riuscito a realizzare un sogno (1991): fondare un’orchestra di 15 musicisti, tutti grandi solisti del proprio strumento (chitarre, mandolini, fisarmonica, pianoforte, tamburi, tamburelli e voci), per valorizzare e rilanciare la Canzone Napoletana in Italia e all’Estero, attraverso la rilettura dei classici partenopei, repertorio che rischiava di venire da tutti considerato come parte di un passato da dimenticare. Partito dal modello un po’ naif delle orchestre napoletane, dei primi del secolo, dove le voci ricche di pathos dei cantanti si sposavano con i ritmi e i suoni coinvolgenti delle strade di Napoli, recuperato in prima fila il suono dei mandolini, sperimenta anche originali contaminazioni con alcune sonorità e ritmi rock, blues, country, reggae e sudamericani. Immesse così nuove energie ritmiche a supporto di inedite ed accattivanti sonorità, riesce a riportare all’attenzione del grande pubblico, italiano ed estero, la melodia classica napoletana, come musica di oggi, ancora viva e capace di esprimere le emozioni più intense e travolgenti. Tra il ’92 e il ’98 completa un ambizioso progetto discografico e lo porta al successo con più di un milione di copie: 4 album antologici intitolati “Napoli. Punto e a capo”, “Napoli. Due punti e a capo”, “Napoli. Punto esclamativo!” e “Pecchè nun ce ne jammo in America?”, contenenti alcune tra le più belle e intramontabili melodie napoletane, tra cui Era de Maggio, Maria Marì!, Luna Rossa, Voce ‘e notte!, Reginella, Comme facette mammeta, Malafemmena, Mandulinata a Napule, Torna a Surriento, Aummo..Aummo, ‘O Sarracino, Silenzio cantatore, ‘O sole mio, I’te vurria vasà, Canzone appassionata, Te vojo bene assaje e tante altre. -

Tradition, Exoticism, and Cosmopolitism in Italian Popular Music (1950S-1980S)
Differentia: Review of Italian Thought Number 2 Spring Article 15 1988 Tradition, Exoticism, and Cosmopolitism in Italian Popular Music (1950s-1980s) Paolo Prato Follow this and additional works at: https://commons.library.stonybrook.edu/differentia Recommended Citation Prato, Paolo (1988) "Tradition, Exoticism, and Cosmopolitism in Italian Popular Music (1950s-1980s)," Differentia: Review of Italian Thought: Vol. 2 , Article 15. Available at: https://commons.library.stonybrook.edu/differentia/vol2/iss1/15 This document is brought to you for free and open access by Academic Commons. It has been accepted for inclusion in Differentia: Review of Italian Thought by an authorized editor of Academic Commons. For more information, please contact [email protected], [email protected]. Tradition, Exoticism and Cosmopolitism in Italian Popular Music ( 1950s-1980s) Paolo Prato INTRODUCTION Richard Wolfe's ProfessionalFake Book (Columbia Pictures Pub lications, 1983), a compilation of over 1000 songs for the club pianist-Broadway's best, contemporary hits, folk songs, movie greats, classical themes, etc.-includes nine Italian pieces. There are Neapolitan evergreens (0 sole mio, Come Back to Sorrento and Malafemmena), one a love song (Santa Lucia), another a Sicilian folk song (Eh cumpari), another an opera highlight (La donna e mobile) and three "modern" songs (Volare, Ciao ciao bambina, Cara mia) from the 1950s. The list makes up an average package of what many people outside Italy consider to be Italian popular music. The songs are part of that "knowledge at hand" (Alfred Schutz) DIFFERENT/A 2 (Spring 1988) DIFFERENT/A 196 which is necessary to cope with what is strange within everyday life routines. -

«Non Rinnego Il Passato Ma Odio Tutti I Revival»
PAG. 8 / spettacoli l'Unita / venerdì 2 novembre 1979 A colloquio con Renato Carosone RADIO COMUNE DI NICHELINO Questa PROVINCIA DI TORINO Concorso pubblico per titoli ed esami a n. 1 po volta sto di Infermiere professionale per il Cen «Non rinnego il passato tro sociale e per anziani. è davvero Scadenza ore 17 del 26 novembre 1979. Età minima anni 18. Età massima anni 35. salvo elevazioni del limite massimo di età a norma di legge. ma odio tutti i revival» per voi Titolo di studio: licenza scuola media inferiore o ti tolo equipollente e diploma di infermiere professionale. Stipendio iniziale L. 2.150.000 più scatti biennali, Ventanni dopo il suo clamoroso ritiro, il musicista spiega le ragioni di una giovani Indennità come per legge. Per chiarimenti rivolgersi al Segretario Generale scelta che lo ha portato, a quasi 60 anni, a suonare Chopin, Bach e Gershwin Dalla nostra redazione del Comune. NAPOLI — Gli asettici studi Nichelino, 26 ottobre 1979. ROMA — C'è Renato Caro cosa Ilo combinato — dice Johann Sebastian Bach. Sì. langa di invenzioni. Tutte della RAI di Napoli stanno sone al pianoforte. Silvana Renato Carosone — durante proprio quella che fa Bum quelle canzoni, così surreali subendo in questi giorni un IL SEGRETARIO GENERALE IL SINDACO Pampaninl vocia e canticchia i miei vent'anni di esilio. So Bum Bum. Con basso e bat ste, le abbiamo composte di salutare scossone. Tremano in platea, al Teatro dei Ser no sempre rimasto inchiodato teria, sissignore. Chiamiamola getto, e lui cavava fuori le gli spessi vetri costruiti a vi, manda baci dappertutto. -

The Institutionalization of Rock'n'roll in France, West Germany, Greece, and Italy (20Th Century) Historia Crítica, Núm
Historia Crítica ISSN: 0121-1617 [email protected] Universidad de Los Andes Colombia Kouvarou, Maria American Rock with a European Twist: The Institutionalization of Rock'n'Roll in France, West Germany, Greece, and Italy (20th Century) Historia Crítica, núm. 57, julio-septiembre, 2015, pp. 75-94 Universidad de Los Andes Bogotá, Colombia Available in: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=81141146006 How to cite Complete issue Scientific Information System More information about this article Network of Scientific Journals from Latin America, the Caribbean, Spain and Portugal Journal's homepage in redalyc.org Non-profit academic project, developed under the open access initiative 75 American Rock with a European Twist: e Institutionalization of Rock’n’Roll in France, West Germany, Greece, and Italy (20th Century) ❧ Maria Kouvarou Universidad de Durham (Reino Unido). : dx.doi.org/10.7440/histcrit57.2015.05 Artículo recibido: 29 de septiembre de 2014 · Aprobado: 03 de febrero de 2015 · Modicado: 03 de marzo de 2015 Resumen: Este artículo evalúa las prácticas desarrolladas en Francia, Italia, Grecia y Alemania para adaptar la música rock’n’roll y acercarla más a sus propios estilos de música y normas societales, como se escucha en los primeros intentos de las respectivas industrias de música en crear sus propias versiones de él. El trabajo aborda estas prácticas, como instancias en los contextos francés, alemán, griego e italiano, de institucionalizar el rock’n’roll de acuerdo con sus propias posiciones frente a Estados Unidos, sus situaciones históricas y políticas y su pasado y presente cultural y musical. Palabras clave : Rock’n’roll, Europe, Guerra Fría, institucionalización, industria de música. -
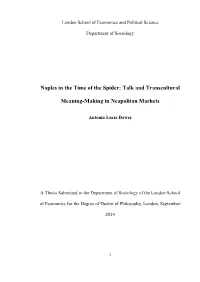
Naples in the Time of the Spider: Talk and Transcultural Meaning-Making
London School of Economics and Political Science Department of Sociology Naples in the Time of the Spider: Talk and Transcultural Meaning-Making in Neapolitan Markets Antonia Lucia Dawes A Thesis Submitted to the Department of Sociology of the London School of Economics for the Degree of Doctor of Philosophy, London, September 2014 1 Declaration I certify that the thesis I have presented for examination for the MPhil/PhD degree of the London School of Economics and Political Science is solely my own work other than where I have clearly indicated that it is the work of others (in which case the extent of any work carried out jointly by me and any other person is clearly identified in it). The copyright of this thesis rests with the author. Quotation from it is permitted, provided that full acknowledgement is made. This thesis may not be reproduced without my prior written consent. I warrant that this authorisation does not, to the best of my belief, infringe the rights of any third party. I declare that my thesis consists of 92, 745 words. Statement of use of third party for editorial help: I can confirm that my thesis was copy edited for conventions of language, spelling and grammar by Jonathan Leung, June Angelides, Kara-Louise Horne, Luigia Cuomo-Dawes, Nabila Munawar, Rebeca Hughes-Davies, and William Dawes. 2 Abstract This thesis explores the articulation of cultural meanings about belonging, entitlement and positionality that are emerging across transcultural boundaries in Neapolitan street markets. I conducted nine months of ethnographic fieldwork from licensed and unlicensed market stalls around Piazza Garibaldi central train station, working with Neapolitan and migrant street vendors. -

Music& Monuments
MUSIC& MONUMENTS M U S I C A L E V E N T S I N A B O D E S O F T H E S O U L WHO ARE WE? Music & monuments is a tourist profiled project, born from the heart of The Mousikè Association, which aims to enhance sites of great historical, artistic and cultural significance through different musical formats and ideas, accustomed for different users. CONCEPT The idea is to create greater resonance around these centers, that in themselves have a "tourist attraction" potential. So by adding the musical component, will increase the visitor's overall quality experience. ASSOCIAZIONE MOUSIKÈ ORIGINS The Mousikè Association was founded in 2008 with the aim of creating a new musical circuit based on the excellence and value of young musicians, by making them leaders within the Italian and European Music Scene. Through the format of Reviews, Workshops and Higher Education courses, this associations allows them to be engaged in the dissemination of music, which is considered a necessary means for social growth. WHY MUSIC & MONUMENSTS? Our musical initiatives have focused from the first moment on the enhancement of artistic heritage, represented by the historical sites, and creating a fusion between artistic languages, that has over the years, been popular with the public. While analyzing the great flow of tourism in recent years and considering the Italian Repertory of Music (which is among the most loved in the world), we want to offer structured proposals with the creation of Musical Formats in exclusive locations with a strong interactive vocation, to create unique experiential moments for tourists. -

Villarossavoice
Number 24 | April 2011 V illarossaVoicE S y r a c u s e U n i v e r s i t y i n F l o r e n c e points Italian Language & Culture Internships w Service Learning Lectures, Symposia, Workshops e Art, Theater, Music i Faculty Watch Outstanding Students V photo: Elijah Borek C o n t e n t s Remembering Donatella by loredana Tarini (italian Department coordinator) 4 Florence by Bus by William Partin (Emory University) 6 Me, My Host Mother and the Microwave by Judith stapleton (Franklin & Marshall college) 8 Mamma Mia by Devon ritchie (Northwestern University) 9 Silvio Berlusconi and the State of Italian Politics by Gregory Fitton (syracuse University) 10 Ninjas Exchange Conversation by students of the liceo russell-Newton 12 Scandicci Tram Ride By Mina riazi (University of california, san Diego) 13 Option II Program Spring 2011 Photo Album 14 Aula Magna (Option III Program) by alexandra lipezker (syracuse University) 15 Taking Care of the Planet by Gabriela ramirez Vargas (syracuse University) 16 Volunteering at Pantagruel Kaitlyn curran (Davidson college) 17 Learning Self-Confidence from Kids by Taylor smith (indiana University) 18 Art in Danger Margaret contompasis (sU Florence Teaching assistant) 20 Green Value: The Economic Benefits of Sustainable Design by Elena carlini (Faculty, sU Florence) 22 International Style by Peter randolph (syracuse University) 24 C o n t e n t s Fresco Painting by Diane Kunzelman and Ezio Buzzegoli (Faculty, sU Florence) 25 SU Florence Student Art Exhibition by Kirsten stromberg (Professor of Painting, sU Florence) -
Arpac E Cittadinanza Globale
ARPAC E CITTADINANZA GLOBALE La vera sfida è formare cittadini protagonisti di un mondo equo e sostenibile In una società in rapida tra- diritti e le proprie responsa- sformazione è sempre neces- bilità di cittadino di un sario rinnovare le buone mondo interdipendente e in pratiche e i saperi, soprat- costante evoluzione, contri- tutto in ambito educativo. buendo altresì al suo proce- Una delle interessanti sfide dere verso una maggiore a cui, a livello planetario, giustizia e sostenibilità. Ciò siamo oggi chiamati a ri- che il termine ecg vuole indi- spondere, è quella di “ridise- care è la necessità di mante- gnare” il quadro entro cui si nere lo sguardo aperto verso sviluppano le competenze il Pianeta, verso la globalità, dell’educazione alla cittadi- arricchendo tale ampiezza nanza globale (ecg). prospettica con il richiamo Essa intende offrire a cia- concreto all’idea di cittadi- scun abitante del pianeta la nanza, una dimensione etica possibilità di conoscere e prima che politica, che evoca comprendere, nel corso della uno status di “cittadini del sua vita, i problemi legati mondo” con responsabilità e allo sviluppo globale e di de- doveri di impegno attivo e clinare il loro significato a li- partecipativo, per la crea- vello locale e personale, zione di un mondo più giusto nonché di esercitare i propri e più equo. a pag.2 SEDI TERRITORIALI I contro BIO-ARCHITETTURA Il Dipartimento lli Arpac in materia di Lezioni all’Università sul post-emergenza rifiuti Le “case passive” di Provinciale di Avellino impianti di gestione dei rifiuti Wernwer Sobek Gli impianti di smaltimento, recupero, tratta- mento di rifiuti generano nei cittadini preoccu- pazioni per il potenziale impatto che possono avere sull’ambiente e per questi motivi si chie- dono, ai soggetti competenti, di incrementare i controlli per verificare il rispetto delle autoriz- zazioni.