Fascismo, Guerra, Violenza. Lucca 1943-1944
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Bozza (27 Marzo)
22. Il “ridotto” della Valtellina «... Le milizie fasciste di Petain si avvicinano, punteranno su Grosio per farne terra bruciata...». Giuseppe Rinaldi, Ribelli in Valgrosina Quanto ci può essere stato di serio e quanto invece di farneticante nel progetto relativo al “Ridotto alpino repubblicano” della Valtellina, ideato dal capo delle Brigate Nere Alessandro Pavolini in collaborazione con il generale Rodolfo Graziani, l’ambasciatore tedesco Rudolf Rahn e il generale delle SS Karl Wolff su... istigazione dello stesso duce del fascismo Benito Mussolini? L’ultima spiaggia alle pendici del Bernina e dell’Ortles-Cevedale, verrebbe da dire avvalendoci di un burlesco ossimoro. Sonia Residori, comunque, mostra di crederci: «Negli ultimi mesi di guerra parve prendere corpo l’“ultimo ridotto”, localizzato già nell’estate del 1944 nella Valtellina e ideato da Alessandro Pavolini, nel quale condurre l’estrema battaglia dell’onore, o meglio una resistenza a oltranza alle Armate Alleate. Si trattava di un progetto che prevedeva la distruzione di strade, ponti, dighe e ferrovie, un progetto ambizioso e delirante, per creare l’“Alcazar del fascismo” di cui parla anche Vincenzo Costa, l’ultimo federale di Milano, nelle sue memorie, un progetto di cui egli avrebbe continuato a seguire 1 Sonia Residori, Una legione in armi, lo sviluppo durante l’autunno».1 Cierre edizioni Istrevi, pag. 100. 2 Joseph Darnand (Coligny, 19 mar- zo 1897 – Châtillon, 10 ottobre Ed a maggior ragione ci devono credere i partigiani della Valtellina, come 1945), già pluridecorato sul fronte leggiamo sulle pagine biografiche di Giuseppe Rinaldi: «Da alcuni giorni si attende franco-tedesco, nel primo conflitto in alta Valtellina un nuovo massiccio rastrellamento. -
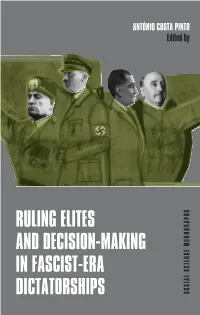
Ruling Elites.Indb
António Costa Pinto is a professor Dictators do not rule alone, and a governing elite stratum is always ANTÓNIO COSTA PINTO After the so-called ‘third wave’ of de- of politics and contemporary Euro- formed below them. This book explores an underdeveloped area in the study ANTÓNIO COSTA PINTO mocratisation at the end of the 20th pean history at the Institute of Social of fascism: the structure of power. The old and rich tradition of elite studies Edited by century had significantly increased the Sciences, University of Lisbon. He has can tell us much about the structure and operation of political power in the number of democracies in the world, been a visiting professor at Stanford dictatorships associated with fascism, whether through the characterisation of the survival of many dictatorships has University (1993) Georgetown Uni- had an important impact. Taking as the modes of political elite recruitment, or by the type of leadership, and the versity (2004), a senior associate mem- starting point the dictatorships that ber at St Antony’s College, Oxford relative power of the political institutions in the new dictatorial system. emerged since the beginning of the University (1995) and a senior visiting Analyzing four dictatorships associated with fascism (Fascist Italy, Nazi 20th century, but mainly those that fellow at Princeton University (1996) Germany, Salazar’s Portugal and Franco’s Spain), the book investigates the were institutionalised after 1945, the and at the University of California, dictator-cabinet-single party triad from -

The Power of Images in the Age of Mussolini
University of Pennsylvania ScholarlyCommons Publicly Accessible Penn Dissertations 2013 The Power of Images in the Age of Mussolini Valentina Follo University of Pennsylvania, [email protected] Follow this and additional works at: https://repository.upenn.edu/edissertations Part of the History Commons, and the History of Art, Architecture, and Archaeology Commons Recommended Citation Follo, Valentina, "The Power of Images in the Age of Mussolini" (2013). Publicly Accessible Penn Dissertations. 858. https://repository.upenn.edu/edissertations/858 This paper is posted at ScholarlyCommons. https://repository.upenn.edu/edissertations/858 For more information, please contact [email protected]. The Power of Images in the Age of Mussolini Abstract The year 1937 marked the bimillenary of the birth of Augustus. With characteristic pomp and vigor, Benito Mussolini undertook numerous initiatives keyed to the occasion, including the opening of the Mostra Augustea della Romanità , the restoration of the Ara Pacis , and the reconstruction of Piazza Augusto Imperatore. New excavation campaigns were inaugurated at Augustan sites throughout the peninsula, while the state issued a series of commemorative stamps and medallions focused on ancient Rome. In the same year, Mussolini inaugurated an impressive square named Forum Imperii, situated within the Foro Mussolini - known today as the Foro Italico, in celebration of the first anniversary of his Ethiopian conquest. The Forum Imperii's decorative program included large-scale black and white figural mosaics flanked by rows of marble blocks; each of these featured inscriptions boasting about key events in the regime's history. This work examines the iconography of the Forum Imperii's mosaic decorative program and situates these visual statements into a broader discourse that encompasses the panorama of images that circulated in abundance throughout Italy and its colonies. -

The Japanese Warrior in the Cultural Production of Fascist Italy
Revista de Artes Marciales Asiáticas Volumen 12(2), 82100 ~ JulioDiciembre 2017 DOI: 10.18002/rama.v12i2.5157 RAMA I.S.S.N. 2174‐0747 http://revpubli.unileon.es/ojs/index.php/artesmarciales Bushido as allied: The Japanese warrior in the cultural production of Fascist Italy (19401943) Sergio RAIMONDO*1,2, Valentina DE FORTUNA3, & Giulia CECCARELLI3 1 University of Cassino and South Lazio (Italy) 2 Area Discipline Orientali Unione Italiana Sport per Tutti (Italy) 3 Free Lance Translator (Italy) Recepción: 17/10/2017; Aceptación: 19/12/2017; Publicación: 27/12/2017. ORIGINAL PAPER Abstract Introduction: After the signing of the alliance among Japan, Germany and Italy’s governments in September 1940, several journals arose in order to spread the Japanese culture among people who knew very little about Italy’s new allied. Some documentaries also had the same function. Methods: The numerous textual and iconographical references concerning the Japanese warriors’ anthropology published in some Italian magazines during the 1940s have been compared, as well as to the few Italian monographs on the same theme and to some documentaries by Istituto Nazionale Luce, government propaganda organ. This subject has also been compared to the first Italian cultural production, concerning Japan, which dated back to the first decades of the 20th century. Moreover different intellectuals’ biographies of those times have been deeply analyzed. Results: Comparing to each other the anthropological references about Japan in the Italian cultural production during the Second World War, we can notice a significant ideological homogeneity. This can be explained through their writers’ common sharing of the militaristic, hierarchical and totalitarian doctrine of the Fascist Regime. -

Performing Fascism: Opera, Politics, and Masculinities in Fascist Italy, 1935-1941
Performing Fascism: Opera, Politics, and Masculinities in Fascist Italy, 1935-1941 by Elizabeth Crisenbery Department of Music Duke University Date:_______________________ Approved: ___________________________ Bryan Gilliam, Advisor ___________________________ Benjamin Earle ___________________________ Philip Rupprecht ___________________________ Louise Meintjes ___________________________ Roseen Giles Dissertation submitted in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy in the Department of Music in the Graduate School of Duke University 2020 ABSTRACT Performing Fascism: Opera, Politics, and Masculinities in Fascist Italy, 1935-1941 by Elizabeth Crisenbery Department of Music Duke University Date:_______________________ Approved: ___________________________ Bryan Gilliam, Advisor ___________________________ Benjamin Earle ___________________________ Philip Rupprecht ___________________________ Louise Meintjes ___________________________ Roseen Giles An abstract of a dissertation submitted in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy in the Department of Music in the Graduate School of Duke University 2020 Copyright by Elizabeth Crisenbery 2020 Abstract Roger Griffin notes that “there can be no term in the political lexicon which has generated more conflicting theories about its basic definition than ‘fascism’.” The difficulty articulating a singular definition of fascism is indicative of its complexities and ideological changes over time. This dissertation offers -

Andreides Gábor: Mussolini És a Fasiszta Vezérek
Ára: 600 Ft Elfizetknek: 500 Ft 4. 9 9 770083 626008 1 9 0 0 4 am 201 TERJESZTI A MAGYAR POSTA - oly VILÁG vf Elfizethet személyesen a postahelyeken és a kézbesítknél, vagy a Központi Hírlap Iroda zöldszámán: 06-80/444-444, .) é e-mailen: [email protected], faxon: 1-303-3440, 41 vagy levélben a Magyar Posta Zrt. Központi Hírlap Iroda, . ( Budapest 1008 címen. 9 Számonként megvásárolható a Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézetében (1097 Budapest, Tóth Kálmán utca 4., A BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT telefon: 224-6700/4624, 4626 mellék), illetve a Penna Bölcsész Könyvesboltban (1053 Budapest, Magyar utca 40., telefon: 06 30/203-1769). TÖRTÉNETTUDOMÁNYI INTÉZETÉNEK FOLYÓIRATA ANDREIDES GÁBOR MUSSOLINI ÉS A FASISZTA VEZÉREK ALESSANDRO VAGNINI AZ OLASZ KÜLPOLITIKA ÉS MAGYARORSZÁG JUHÁSZ BALÁZS A FASIZMUS KATONAPOLITIKÁJA LÉNÁRT T. ANDRÁS A FASIZMUS VÁLTOZATAI SPANYOLORSZÁGBAN A Világtörténet 2019-es évfolyamának megjelentetését a Magyar Tudományos Akadémia és a Nemzeti Kulturális Alap támogatja FEJÉRDY ANDRÁS TÉNET 9. (41.) 2019. 4. RÁKOSI MÁTYÁS, AZ OLASZ BALOLDALI PÁRTOK ÉS A FASISZTA HATALOMÁTVÉTEL ÖR T G Á SZEMLE SZILÁGYI ÁGNES JUDIT, MAXIMILIANO GABRIEL GREGORIO VIL CERNADAS, MIRJANA POLI BOBI, ZEIDLER MIKLÓS ÍRÁSAI vt2019-4_borító 2019. november 26. 13:01:14 VILÁGTÖRTÉNET A Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézetének folyóirata Szerkesztők Skorka Renáta (főszerkesztő) Bíró László, Stefano Bottoni, Katona Csaba, Martí Tibor (szerkesztők) Szerkesztőbizottság Glatz Ferenc (elnök), Borhi László, Erdődy Gábor, Fischer Ferenc, Fodor Pál, Klaniczay Gábor, 2019. 4. 9. (41.) évfolyam Majoros István, Mihalik Béla Vilmos, Pók Attila, Poór János TARTALOM 100 éves a fasizmus (Andreides Gábor – Juhász Balázs) 497 Tanulmányok Andreides Gábor: Mussolini és a fasiszta vezérek 499 Pasquale Fornaro: A rezsim egyik „perifériája”. -

A Myth and Reality in the Fascist War: the Ministry of Popular
Myth and Reality in the Fascist War: The Ministry of Popular Culture and Italian Propaganda on the Bombing of Civilians, 1938-1943 Luigi Petrella Doctor of Philosophy School of History, Classics and Archaeology 26 October 2015 a Abstract New studies that focus on the air bombardment of civilians in Italy during the Second World War regard the Italian home front as a privileged ‘observation post’ from which to study the relationship between Fascism and society during the years of the collapse of Mussolini’s regime. Yet the role of propaganda, on the specific aspect of people vulnerability to total war, in influencing that relationship, has received little attention. The main aim of this work is to reconstruct the narrative of bombing and of civilians’ life in Italy during the first phase of the war (1940-1943) as it emerges from reports, stories and works of invention in the Italian media. These have been compared with both the public reaction and the regime propaganda that had constructed some of the most powerful ideological tenets of the Italian Fascism during the 1930s, first of all the myth of air power and the creation of a ‘new man’. Investigating specific sections of the home front and situating the breakup of the Italian morale at the time of the first serious setbacks of Mussolini’s armies at the end of 1940, this research focuses in particular on the effectiveness - or otherwise - of government policies in steering the media and cultural activities that reflected life in wartime Italy. Drawing mostly on primary sources such as government papers, personal memoirs, censored letters and confidential reports, the study argues that propaganda’s failure to continue to bolster Fascist myths was due both to the catastrophic impact of war on civilians’ life and to institutional and political flaws. -

American Sympathizers with Italian Fascism A
The Machine Has a Soul: American Sympathizers with Italian Fascism A Dissertation submitted to the Faculty of the Graduate School of Arts and Sciences of Georgetown University in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy in History By Catherine Susan Mary Hull, M.A. Washington, DC December 12, 2017 Copyright 2018 by Catherine Susan Mary Hull All Rights Reserved ii THE MACHINE HAS A SOUL: AMERICAN SYMPATHIZERS WITH ITALIAN FASCISM Catherine Susan Mary Hull, M.A. Thesis Advisor: Michael Kazin, Ph.D. ABSTRACT Americans across the political and cultural spectrum sympathized with Italian fascism in the interwar years. This dissertation demonstrates that American fascist sympathizers believed that Italy was coping better with the challenges of modernity than the United States. Fascist sympathizers argued that fascist squads revived older values of service and honor, even as Mussolini kept pace with a fast-moving society. They claimed that the corporate state was an up-to-date form of government, which protected Italians from the worst effects of the global depression. And, as the fascist state became increasingly totalitarian, they represented Italy as a place where men and women could transcend the grit and grind of modern life to find inner peace. American fascist sympathizers had various goals when they invoked Italy’s apparent successes in managing the challenges of modernity. First, they aimed to expose faults in their own society: the numbing effects of standardization; the erosion of higher ideals; the failure of government to protect Americans from the ravages of industrialization. Second, they suggested solutions to the United States’ problems: the reform of government to promote expertise in policymaking; and measures to create jobs and support the return to a simpler life. -

Il Duce Racconta Il Gran Consiglio
•• Nella sede storica della Rai, in via Asia M La giustizia nell'Alto medioevo è il tema Gadda radiofonico go a Roma, proposlo un itinerario attraverso La giustizia della settima di studi organizzata a Spoleto dal 7 autografi e prime edizioni dello scrittore al 13 aprile per iniziativa del centro studi sull'Al Ascoltatelo nel Medio Evo to medioevo. Si tratta di 25 lezioni cui partecipe lombardo. In uno spazio audiovisivo posso ranno studiosi di fama intemazionale. Fra gli al alla mostra Rai no essere ascoltati i programmi ideati per la Un convegno tri Harald Siems tratterà il tema dei giudici giusti radio da Carlo Emilio Gadda e le quattro in e corrotti dal tardo antico al primo novecento di via Asiago terviste che egli concesse alla televisione. a Spoleto occidentale ySiijjA **-*"jr.j. .j/? ma •• ! 1 gennaio 1944 a Vero «buzzino», truce e fanatico quindi si era seduto di schie leazzo, lo definiva un «sudicio na. Quella mattina di cinquan personaggio chiave della re- Cinquantanni fa a Verona un plotone di volontari giustiziava il genero na. Un milite aveva legato le furfante». Hitler, tra l'altro, era ta anni fa, nel poligono di tiro a pubblichctta di Salò. La do mani a tutti mentre Gottardi sicuro che il Duce non avreb segno del Forte San Procolo,... manda di grazia era stata pre gridava: «Viva l'Italia, viva il be mai fatto fucilare il padre viene fucilato Galeazzo Ciano, \ sentata da Ciano, nella can del Duce e altri quattro «traditori» del regime. Tragedia del potere, Duce, viva il fascismo». Pare- degli adorati nipotini e il mari genero del Duce, ex «delfino» ] celleria del Tribunale speciale schi e De Bono gridarono, in to della figlia più amata. -
Carlo Alberto Biggini: Il Custode Degli Ultimi “Segreti” Di Mussolini. Dalla
Carlo Alberto Biggini: il custode degli ultimi “segreti” di Mussolini. Dalla Basilica del Santo di Padova alla clinica milanese “San Camillo“ (26 luglio – 19 novembre 1945) Pubblicato su 1 giugno 2011 Carlo Alberto Biggini, rinomato professore di diritto costituzionale, nacque a Sarzana – un paese in provincia di La Spezia – il 9 dicembre 1902, da Maria Accorsi e da Ugo, un avvocato di estrazione socialista. Dopo aver conseguito brillantemente, nel novembre del 1928, la laurea in Legge presso l’ateneo di Genova, l’anno seguente si laureò a Torino anche in scienze politiche riportando la prestigiosa votazione di 110, lode e dignità di stampa. Il suo cursus studiorum si concluse nell’ottobre del 1930 con il conseguimento di un altro titolo accademico, quello in scienze corporative, stavolta presso l’università di Pisa. Inoltre, proprio nell’aprile di quell’anno, aveva coronato anche il suo sogno d’amore impalmando a La Spezia Maria Bianca Mariotti. Durante i suoi anni giovanili seguì le orme paterne abbracciando gli ideali socialisti finché, nel maggio del 1928, si verificò una repentina conversione al fascismo che lo indusse a chiedere perfino la tessera del P.N.F. Questa fase importante della sua vita, inoltre, coincise anche con la sua definitiva consacrazione sia a livello accademico e sia nell’ambito dell’establishment fascista, dove ricoprì varie cariche di un certo prestigio. Difatti a suggellare la sua affermazione giunse, il 6 febbraio del 1943, la nomina a ministro dell’Educazione Nazionale in sostituzione di Giuseppe Bottai, che -
La Repubblica Sociale Italiana E La Persecuzione Degli Ebrei
Corso di Laurea Magistrale in Storia dal Medioevo all’età contemporanea Tesi di laurea La Repubblica sociale italiana e la persecuzione degli ebrei Relatore Ch. prof. Simon Levis Sullam Correlatori Ch. prof. Alessandro Casellato Ch. prof. Marco Fincardi Laureanda Sara Garbarino matr. 802883 Anno Accademico 2016/2017 Indice Introduzione 1 I. Il contesto italiano 6 I.1 Lo sviluppo delle teorie razziste e i rapporti con la legislazione coloniale 10 I.2 La formazione della legislazione antiebraica 16 II. La RSI e l’inasprimento delle persecuzioni 22 II.1 I provvedimenti contro gli ebrei 33 II.1.1 Il Manifesto di Verona 34 II.1.2 Le Costituzioni 37 II.1.3 Le leggi e gli atti amministrativi 44 II.2 L’Ispettorato generale per la razza 64 Bibliografia 81 Introduzione A partire dalla fine della seconda guerra mondiale uno dei maggiori meriti rivendicati a favore dagli italiani fu l’aiuto da loro prestato agli ebrei1. Attraverso i canali diplomatici e attraverso la stampa, tra la proclamazione dell’armistizio nel settembre 1943 e il primo dopoguerra (fino al 1947) una tenace azione governativa mirò a valorizzare il comportamento italiano in guerra, non solo nel proprio paese ma anche nei territori occupati (dai Balcani alla Francia), in contrapposizione alla brutale “soluzione finale” tedesca. Il tentativo di oscurare le responsabilità italiane, a svantaggio dell’alleato tedesco, rispondeva – come ha recentemente spiegato Filippo Focardi – alle intenzioni dell’establishment monarchico e dell’élite politica antifascista, tese ad evitare una pace punitiva per il Paese. Fu questa un’azione che portò alla creazione nel lungo periodo di una zona d’ombra nella memoria pubblica nazionale sul secondo conflitto mondiale, finendo per diffondere un’immagine auto-assolutoria della tragica esperienza fascista2. -

Italian Fascism, 1915–1945, Second Edition
Italian Fascism, 1915–1945 Second Edition Philip Morgan Italian Fascism, 1915–1945 The Making of the 20th Century David Armstrong, Lorna From Versailles to Maastricht: International Lloyd and John Redmond Organisation in the Twentieth Century V.R. Berghahn Germany and the Approach of War in 1914, 2nd edition Raymond F. Betts France and Decolonisation, 1900–1960 John Darwin Britain and Decolonisation: The Retreat from Empire in the Post-War World Ann Lane Yugoslavia: When Ideals Collide Robert Mallett Mussolini and the Origins of the Second World War, 1933–1940 Sally Marks The Illusion of Peace: International Relations in Europe, 1918–1933, 2nd edition Philip Morgan Italian Fascism, 1915–1945, 2nd edition A.J. Nicholls Weimar and the Rise of Hitler, 4th edition R.A.C. Parker Chamberlain and Appeasement: British Policy and the Coming of the Second World War Anita J. Prazmowska Eastern Europe and the Origins of the Second World War G. Roberts The Soviet Union and the Origins of the Second World War Alan Sharp The Versailles Settlement: Peacemaking in Paris, 1919 Zara S. Steiner and Britain and the Origins of the First World War, Keith Neilson 2nd edition Samuel R. Williamson Austria–Hungary and the Origins of the First World War R. Young France and the Origins of the Second World War Italian Fascism, 1915–1945 Second Edition Philip Morgan © Philip Morgan 2004 All rights reserved. No reproduction, copy or transmission of this publication may be made without written permission. No paragraph of this publication may be reproduced, copied or transmitted save with written permission or in accordance with the provisions of the Copyright, Designs and Patents Act 1988, or under the terms of any licence permitting limited copying issued by the Copyright Licensing Agency, 90 Tottenham Court Road, London W1T 4LP.