Scarica Il Volume N. 6 in .Pdf
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Naureen Rana M
BIODIVERSITY OF SOIL MACROINVERTEBRATES IN LOW AND HIGH INPUT FIELDS OF WHEAT (Triticum aestivum L.) AND SUGARCANE (Saccharum officinarum L.) IN DISTRICT FAISALABAD By Naureen Rana M. Sc. (U.A.F) A THESIS SUBMITTED IN THE PARTIAL FULFILLMENT OF REQUIREMENT FOR THE DEGREE OF DOCTOR OF PHILOSOPHY IN ZOOLOGY DEPARTMENT OF ZOOLOGY AND FISHERIES FACULTY OF SCIENCES UNIVERSITY OF AGRICULTURE FAISALABAD 2012 DECLARATION I hereby declare that the contents of the thesis, “Biodiversity of soil macro invertebrates in low and high input fields of wheat (Triticum aestivum L.) and sugarcane (Saccharum officinarum L.) in district Faisalabad” are product of my own research and no part has been copied from any published source (except the references, standard mathematical or equations/formula/protocols etc). I further declare that this work has not been submitted for award of any other diploma/degree. The university may take action if the information provided is found incorrect at any stage, (In case of any default the scholar will be proceeded against as per HEC plagiarism policy). Signature of the student Name: Naureen Rana Regd. No. 1987-ag-988 To The Controller of Examinations, University of Agriculture, Faisalabad. We, the Supervisory Committee, certify that the contents and form of the thesis submitted by Mrs. Naureen Rana 1987-ag-988 have been found satisfactory and recommend that it be processed for evaluation by the External Examiner (s) for the award of degree. SUPERVISORY COMMITTEE ____________________________ CHAIRPERSON: Prof. Dr. Shahnaz Akhter Rana ____________________________ MEMBER: Dr. Hammad Ahmed Khan __________________ MEMBER: Prof. Dr. Anjum Suhail DEDICATED TO MY MOTHER ACKNOWLEDGEMENTS I feel highly privileged to take this opportunity to express my heartiest gratitude and deep sense of indebt to my worthy supervisor, Prof. -

Guidelines for the Capture and Management of Digital Zoological Names Information Francisco W
Guidelines for the Capture and Management of Digital Zoological Names Information Francisco W. Welter-Schultes Version 1.1 March 2013 Suggested citation: Welter-Schultes, F.W. (2012). Guidelines for the capture and management of digital zoological names information. Version 1.1 released on March 2013. Copenhagen: Global Biodiversity Information Facility, 126 pp, ISBN: 87-92020-44-5, accessible online at http://www.gbif.org/orc/?doc_id=2784. ISBN: 87-92020-44-5 (10 digits), 978-87-92020-44-4 (13 digits). Persistent URI: http://www.gbif.org/orc/?doc_id=2784. Language: English. Copyright © F. W. Welter-Schultes & Global Biodiversity Information Facility, 2012. Disclaimer: The information, ideas, and opinions presented in this publication are those of the author and do not represent those of GBIF. License: This document is licensed under Creative Commons Attribution 3.0. Document Control: Version Description Date of release Author(s) 0.1 First complete draft. January 2012 F. W. Welter- Schultes 0.2 Document re-structured to improve February 2012 F. W. Welter- usability. Available for public Schultes & A. review. González-Talaván 1.0 First public version of the June 2012 F. W. Welter- document. Schultes 1.1 Minor editions March 2013 F. W. Welter- Schultes Cover Credit: GBIF Secretariat, 2012. Image by Levi Szekeres (Romania), obtained by stock.xchng (http://www.sxc.hu/photo/1389360). March 2013 ii Guidelines for the management of digital zoological names information Version 1.1 Table of Contents How to use this book ......................................................................... 1 SECTION I 1. Introduction ................................................................................ 2 1.1. Identifiers and the role of Linnean names ......................................... 2 1.1.1 Identifiers .................................................................................. -

Modern Taxonomic and Biogeographic Approaches to Biodi - Versity in the Mediterranean Area
Biodiversity Journal , 2017, 8 (1): 49–58 MONOGRAPH Modern taxonomic and biogeographic approaches to biodi - versity in the Mediterranean area Alessandro Minelli Department of Biology, University of Padova, Via Ugo Bassi 58 B, I 35131 Padova, Italy; email: [email protected] ABSTRACT I review here examples of recent progress in the taxonomy and biogeography of Mediter- ranean taxa. Morphological approaches have still much to offer, as shown by a study of the Sicilian species of the wingless weevil genus Pseudomeira Stierlin, 1881 (Coleoptera Curculionidae). A systematic analysis of molecular markers, however, is revealing a huge number of previously unsuspected cryptic species, as in the scarab genus Pachypus Dejean, 1821 (Coleoptera Pachypodidae). Other molecular studies have revealed very deep phylo - geographic structure in the Corsican brook salamander; the presence of six or more species hitherto lumped under Rumina decollata (Linnaeus, 1758) (Pulmonata Subulinidae), in a snail genus in which biparental and uniparental reproduction coexist; the conservation of the same male pheromone in vicariant species of the scarab beetles of the genus Osmoderma Lepeletier et Serville, 1828 (Coleoptera Cetoniidae); the interplay of vicariance and dispersal events in giving rise to the different taxa of the land snail genus Chilostoma Fitzinger, 1833 (Gastropoda Helicidae) inhabiting the Greek islands. Further examples of modern biogeographic studies are a morphometric analysis revealing the preferential localization of steep slopes of phenetic diversity of seven butterfly species groups in the Tuscan archipelago and across the Strait of Messina; a research on tenebrionid beetles showing that present distribution patterns are not completely explained by postglacial recolonization from Pleistocenic refugia; a comparative analysis of the diversity of patterns (explained in part by vicariance, in part by dispersal) in the biota on the two shores of the Strait of Gibraltar. -

99-106 AENSI Journals
Advances in Environmental Biology, 10(7) July 2016, Pages: 99-106 AENSI Journals Advances in Environmental Biology ISSN-1995-0756 EISSN-1998-1066 Journal home page: http://www.aensiweb.com/AEB/ Malacofauna diversity in Kabylia region (Algeria) Bouaziz-Yahiatene Houria and Medjdoub -Bensaad Ferroudja 1Laboratoire de production, sauvegarde des espèces menacées et des récoltes. Influence des variations climatiques. Département de Biologie. Faculté des Sciences Biologiques et Sciences Agronomiques. Université Mouloud Mammeri de Tizi -Ouzou. 15000 Algérie Address For Correspondence: Bouaziz-Yahiatene Houria, Laboratoire de product ion, sauvegarde des espèces menacées et des récoltes. Influence des variations climatiques. Département de Biologie. Faculté des Sciences Biologiques et Sciences Agronomiques. Université Mouloud Mammeri d e Tizi-Ouzou. 15000 Algérie E-mail: [email protected] This work is licensed under the Creative Commons Attribution International License (CC BY). http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Received 12 June 2016; Accepted 28 July 2016; Available online 25 August 2016 ABSTRACT The terrestrial malacofauna of Kabylia is largely unknown until today. For this reason we are led to establish a qualitative and quantitative inventory of snails at 4 stations at different altitudes ( along transect from the sea to the mountains). This work foc uses on the identification of the different species and their presence and abundance at several stations in the region. Sampling is performed on a surfa ce of 100 m2, during a period from June 2012 to May 2013. The sampling method used is hunting for sweet, wet weather in sight. Land snails are also recovered on boards previously raised, which have serve d their shelter. -

Guía De Los Caracoles Terrestres De Andalucía
El presente trabajo se enmarca en el Programa de Actuaciones para la Conservación y Uso sostenible de los caracoles terrestres de Andalucía, en el que colaboran, desde 2002, la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía y el Departamento de Fisiología y Zoología de la Universidad de Sevilla. La edición de la obra es fruto de la colaboración entre la Fundación Gypaetus y la Consejería de Medio Ambiente. Edición: Fundación Gypaetus. Dirección facultativa: Fernando Ortega Alegre. Autores: Antonio Ruiz Ruiz, Ángel Cárcaba Pozo, Ana I. Porras Crevillen y José R. Arrébola Burgos. Fotografía: Antonio Ruiz Ruiz, Alberto Martínez Ortí (págs. 211, 241). Diseño gráfico y maquetación: Carlos Manzano Arrondo y Juan A. Martínez Camúñez. I.S.B.N.: 84-935194-2-1. Depósito legal: 4 Sumario Presentación . 6 1. Introducción a la Guía de los caracoles terrestres de Andalucía a. La Guía y su estructura . 12 b. Uso de la guía . 22 c. Morfología de la concha en los caracoles terrestres . 26 d. Biología y ecología de los caracoles terrestres . 36 e. Normativa ambiental . 45 f. Localización, observación, estudio, identificación y conservación de caracoles terrestres . 49 2. Ordenación sistemática y catálogo de especies . 58 3. Glosario de términos . 278 4. Abreviaturas . 283 5. Indice de nombres científicos. 284 6. Bibliografía . 290 7. Agradecimientos . 299 8. Claves de símbolos . 300 5 Presentación de la Consejera de Medio Ambiente. Uno de los términos claves en Conservación es el de Biodiversidad o Diversidad Biológica. Alude a la gran variedad de formas y patrones de vida existente sobre el planeta y a los complejos ecológicos en los que se integran. -

Newsletter Raccolte 1 06.10.2006
NEWSLETTER Unifi ORGANIZZAZIONE, PERSONE E VALORI NELL’ATENEO DI FIRENZE Speciale Raccolte Numero 1 i 6 ottobre 2006 f MUSEO DI STORIA NATURALE Uni rassegna 2005/2006 Rassegna: Numero 41 - 4 maggio 2005 Numero 42 – 15 giugno 2005 Numero 43 – 18 luglio 2005 Numero 44 – 16 settembre 2005 Numero 45 – 27 ottobre 2005 Numero 46 – 13 dicembre 2005 Numero 47 – 23 gennaio 2006 Numero 48 – 20 febbraio 2006 Numero 49 – 27 marzo 2006 Numero 50 – 26 aprile 2006 Numero 51 – 23 maggio 2006 Numero 52 – 22 giugno 2006 Numero 53 – 18 luglio 2006 Numero 54 – 21 settembre 2006 Elenco pubblicazioni - anno 2005 Numero speciale a cura di: Cristina Andreani, Alba Scarpellini e Paola Zampi Hanno collaborato Catherine Cheselka e Riccardo Ciulla N E W S L T R 1 NEWSLETTER Unifi ORGANIZZAZIONE, PERSONE E VALORI NELL’ATENEO DI FIRENZE Speciale Raccolte Numero 1 6 ottobre 2006 MUSEO DI STORIA NATURALE rassegna 2005/2006 2 pag. 3 Il Museo di Storia Naturale a 230 anni dalla sua istituzione Quest’anno si celebra un duplice, importante anniversario. Ricorrono infatti i 460 anni della nascita dell’Orto Botanico, noto anche come Giardino dei Semplici, ed i 230 anni della istituzione del Museo di Storia Naturale, di cui lo stesso Orto Botanico fa parte. Proprio il 21 febbraio 1775 fu emanato, dal Granduca Pietro Leopoldo, il “motuproprio” (ordine ufficiale del Granduca) con cui veniva fondato l’Imperiale e Reale Museo di Fisica e Storia Naturale, la cui direzione venne affidata all’abate Felice Fontana, eminente naturalista trentino e figura di primo livello nel panorama scientifico dell’epoca. -

Nota Preliminare Sulle Emergenze Faunistiche Della Lunigiana (Toscana Nord-Occidentale, Italia)
View metadata, citation and similar papers at core.ac.uk brought to you by CORE provided by Florence Research SIMONE CIANFANELLI, STEFANO VANNI, GIANNA INNOCENTI, ANNAMARIA NISTRI & PAOLO AGNELLI NOTA PRELIMINARE SULLE EMERGENZE FAUNISTICHE DELLA LUNIGIANA (TOSCANA NORD-OCCIDENTALE, ITALIA) ESTRATTO dagli ANNALI del MUSEO CIVICO di STORIA NATURALE “G. DORIA” Vol. 108 - 3 NOVEMBRE 2016 GENOVA 2016 275 SIMONE CIANFANELLI*, STEFANO VANNI*, GIANNA INNOCENTI*, ANNAMARIA NISTRI* & PAOLO AGNELLI* NOTA PRELIMINARE SULLE EMERGENZE FAUNISTICHE DELLA LUNIGIANA (TOSCANA NORD-OCCIDENTALE, ITALIA) INTRODUZIONE La Lunigiana è un territorio compreso tra Liguria e Toscana, corrispondente al bacino idrografico del Fiume Magra. Ne fanno parte 25 comuni, di cui 11 liguri e 14 toscani. In questo contributo verranno considerati i soli dati relativi ai comuni toscani (Aulla, Bagnone, Casola in Lunigiana, Comano, Filattiera, Fivizzano, Fosdinovo, Licciana Nardi, Mulazzo, Podenzana, Pontremoli, Tre- sana, Villafranca in Lunigiana, Zeri). Le ricerche faunistiche effettuate nell’ultimo trentennio in quest’area sono piuttosto scarse e spesso occasionali e di regola non legate a progetti specifici strutturati (BODON & CIANFANELLI 2002; BODON et al. 2005a, 2005b; VANNI & MAGRINI 1984). Nel 1996, tut- tavia, abbiamo eseguito alcune indagini zoologiche in vari territori dell’area in esame nell’ambito del Progetto “BioItaly-Natura 2000” e più di recente (2013-2016) nella parte montana della Lunigiana. La storia geologica di questo territorio ha determinato un’in- teressante area di transizione tra la fauna ligure e quella toscana e, allo stesso tempo, i reticoli idrografici, come il bacino del Fiume Magra rimasto geologicamente isolato, hanno contribuito alla spe- ciazione di alcune entità, tanto che a oggi si possono enumerare vari endemiti, come per esempio alcuni Molluschi della famiglia degli Idrobidi: Alzoniella microstoma Bodon & Cianfanelli, 2002, A. -
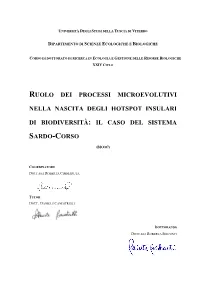
Ruolo Dei Processi Microevolutivi Nella
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA TUSCIA DI VITERBO DIPARTIMENTO DI SCIENZE ECOLOGICHE E BIOLOGICHE CORSO DI DOTTORATO DI RICERCA IN ECOLOGIA E GESTIONE DELLE RISORSE BIOLOGICHE XXIV CICLO RUOLO DEI PROCESSI MICROEVOLUTIVI NELLA NASCITA DEGLI HOTSPOT INSULARI DI BIODIVERSITÀ: IL CASO DEL SISTEMA SARDO-CORSO (BIO/07) COORDINATORE DOTT.SSA ROBERTA CIMMARUTA TUTOR DOTT. DANIELE CANESTRELLI DOTTORANDA DOTT.SSA ROBERTA BISCONTI INDICE PREMESSA 4 1. INTRODUZIONE 5 2. BISCONTI R., CANESTRELLI D., NASCETTI G., 2011. GENETIC DIVERSITY AND EVOLUTIONARY HISTORY OF THE TYRRENHIAN TREEFROG HYLA SARDA (ANURA: HYLIDAE): PIECING THE PUZZLE OF CORSICA-SARDINIAN BIOTA. BIOLOGICAL JOURNAL OF THE LINNEAN SOCIETY 103: 159-167. 10 2.1 Introduction 11 2.2 Materials e methods 13 2.3 Results 15 2.4 Discussion 17 2.5 Tables and figures 21 3. BISCONTI R., CANESTRELLI D., COLANGELO P., NASCETTI G., 2011. MULTIPLE LINES OF EVIDENCE FOR DEMOGRAPHIC AND RANGE EXPANSION OF A TEMPERATE SPECIES (HYLA SARDA) DURING THE LAST GLACIATION. MOLECULAR ECOLOGY 20: 5313-5327. 26 3.1 Introduction 27 3.2 Materials and methods 30 3.2.1 Sampling and laboratory procedures 30 3.2.2 Genetic data analysis 30 3.2.3 Species Distribution Modelling 33 3.3 Results 36 3.3.1 Genetic data 36 3.3.2 Species Distribution Modelling 38 1 3.4 Discussion 39 3.4.1 Evolutionary history of H. Sarda 39 3.4.2 Perspectives and conclusions 42 3.5 Tables and figures 44 4. BISCONTI R., CANESTRELLI D., SALVI D., NASCETTI G., 2012. A GEOGRAPHIC MOSAIC OF EVOLUTIONARY LINEAGES WITHIN THE INSULAR ENDEMIC NEWT EUPROCTUS MONTANUS. -

Contribució Al Coneixement De La Fauna Invertebrada Del Parc Natural Comunal De Les Valls Del Comapedrosa
zoologia. Contribució al coneixement de la fauna invertebrada del Parc Natural Comunal de les Valls del Comapedrosa. Contribució al coneixement de la fauna invertebrada del Parc Natural Comunal de les Valls del Comapedrosa Catàlegs preliminars dels lepidòpters ropalòcers, els ortòpters i els mol·luscs Jordi Nicolau, Vicent Borredà i Alberto Martínez Aporia crataegi. 22 la larevista revista del cenma del cenma > > > l Parc Natural Comunal de les Valls del Comapedrosa és al nord-oest del Principat d’Andorra, a la parròquia de la Massana. Fou declarat l’any 2006 Ei té una superfície de 1.542,6 ha. Entre els objectius de l’espai protegit, de- finits en l’Ordinació (BOPA núm. 62, any 18, de 9 d’agost de 2006), s’inclou el de «millo- rar el coneixement dels diferents components del parc, especialment dels més rellevants per a la seva gestió». La majoria de projectes de recerca dins l’àmbit biològic, duts a terme des de l’òrgan gestor del parc, fan referència a la fauna vertebrada (Biocom, 2005 i 2007; Guixé, 2008) i a la flora vascular (Carrillo et al., 2005 i 2007; Or- gué, 2007). També s’han dut a terme, però, alguns estudis sobre la fau- na invertebrada. Així, l’any 2006 es redactà el catàleg preliminar dels lepidòpters ropalòcers (papallones diürnes) (Biocom, 2006); el 2009, el dels ortòpters (saltamartins i llagostes) (Nicolau, 2009), i, el 2008, el dels mol·luscs (cargols i llimacs) (Borredà et al., 2008). En aquest article es resumeixen els tres treballs esmentats i, en alguns casos, se n’actualitzen els re- sultats, que tenen un interès especial atès que la fauna invertebrada és una de les grans desconegudes de l’espai i també del con- junt del Principat, i versen sobre grups dels dos ti- pus o fílums faunístics més diversos: els ar- tròpodes, cas dels le- pidòpters ropalòcers i els ortòpters, i els mol·luscs. -

Xerosecta (Xeromagna) Adolfi (Pfeiffer, 1854) Nombre Común: No Existe Tipo: Mollusca / Clase: Gastropoda / Orden: Pulmonata / Familia: Hygromiidae
Xerosecta (Xeromagna) adolfi (Pfeiffer, 1854) Nombre común: No existe Tipo: Mollusca / Clase: Gastropoda / Orden: Pulmonata / Familia: Hygromiidae Categoría UICN para España: EN B1ab(i,ii,iii,iv)+2ab(i,ii,iii,iv) Categoría UICN Mundial: LR/nt Foto: Antonio Ruiz Ruiz Antonio Ruiz Foto: IDENTIFICACIÓN Especie muy similar a Xerosecta cespitum (Draparnaud, 1801), aunque algo más sólida, con coloración de fondo más clara (parduzca, crema o blanco cretáceo), última vuelta menos del doble de ancho que la penúltima (más del doble en X. cespitum) y con una escultura más marcada de cóstulas apretadas (Ruiz et al., 2006). Para una correcta identificación se precisa estudio anatómico; véase Arrébola (1995). V: 5-5,75. ∅ = 12,5-18,5 mm. h = 9-13,3 mm. ÁREA DE DISTRIBUCIÓN Endemismo almeriense (Puente, 1994; Arrébola, 1995), de la provincia murciano-almeriense y el sec- tor almeriense. Está presente en las series de vegetación termomediterráneo alpujarreño-almeriense se- miárida de Maytenus (arto) y murciano-almeriense, semiárido-árido de Zyziphus (azufaifo). Su exten- sión de presencia se estima en 431 km2 (polígono convexo mínimo) (UICN, 2001). Está presente en el llano del Campo de Dalías y en la depresión de Níjar. El sustrato es detrítico calizo y no supera los 200 m de altitud. Ha sido hallada en Almería: 2 localidades en el Ejido, una de ellas en el Paraje Natural Punta Entinas-Sabinar, y 2 localidades en Níjar. Se han excluido, al considerarse erróneas, las citas de la provincia de Granada (Alonso, 1975). También las citas referidas como “Almería” sin otra especificación (Hidalgo, 1875; Servain, 1880; Clessin, 1881; Caziot, 1904; Ortiz de Zárate, 1950; Ortiz de Zárate, 1991). -

Liste De Référence Annotée Des Mollusques Continentaux De France Annotated Checklist of the Continental Molluscs from France
MalaCo Le journal de la malacologie continentale française www.journal-malaco.fr MalaCo (ISSN 1778-3941) est un journal électronique gratuit, annuel ou bisannuel pour la promotion et la connaissance des mollusques continentaux de la faune de France. Equipe éditoriale Jean-Michel BICHAIN / Strasbourg / [email protected] Xavier CUCHERAT / Audinghen / [email protected] Benoît FONTAINE / Paris / [email protected] Olivier GARGOMINY / Paris / [email protected] Vincent PRIÉ / Montpellier / [email protected] Pour soumettre un article à MalaCo : 1ère étape – Le premier auteur veillera à ce que le manuscrit soit conforme aux recommandations aux auteurs (consultez le site www.journal-malaco.fr). Dans le cas contraire, la rédaction peut se réserver le droit de refuser l’article. 2ème étape – Joindre une lettre à l’éditeur, en document texte, en suivant le modèle suivant : "Veuillez trouvez en pièce jointe l’article rédigé par << mettre les noms et prénoms de tous les auteurs>> et intitulé : << mettre le titre en français et en anglais >> (avec X pages, X figures et X tableaux). Les auteurs cèdent au journal MalaCo (ISSN1778-3941) le droit de publication de ce manuscrit et ils garantissent que l’article est original, qu’il n’a pas été soumis pour publication à un autre journal, n’a pas été publié auparavant et que tous sont en accord avec le contenu." 3ème étape – Envoyez par voie électronique le manuscrit complet (texte et figures) en format .doc et la lettre à l’éditeur à : [email protected]. Pour les manuscrits volumineux (>5 Mo), envoyez un courriel à la même adresse pour élaborer une procédure FTP pour le dépôt du dossier final. -

G. FALKNER, T. RIPKEN & M. FALKNER Index De La
Mollusques continentaux de France – G. FALKNER, T. RIPKEN & M. FALKNER Index de la partie "Taxonomie" – C. AUDIBERT Légende : -en italique : les espèces suivi du genre entre parenthèses -en gras : les genres et les familles -en gras + italique : les sous-genres, tribus et sous-familles -en majuscules : les taxons de rang supérieur à celui de la famille (e.g. SUPER-FAMILLE) Les sous-espèces ne sont pas indexées. Rappel : pp 26-57 : liste taxonomique de référence pp 58-63 : liste synoptique simplifiée * pp 64-178 : commentaires * dans cette partie, la liste est présentée sur 2 colonnes ; dans l'index la colonne de gauche est repérée par la lettre a, la colonne de droite par la lettre b (e.g. Zonitoides excavatus, 61a se trouve p61, dans la colonne a), ce qui facilite le repérage dans la liste. abbreviata (Bythinella) 31, 59a, 86 Abida 38, 60b, 109 Acanthinula 37, 60a Acanthinulinae 37 ACHATINOIDEA 41 acicula (Cecilioides) 41, 61a Acicula 27, 58a, 69-70 Aciculidae 27, 58a Acroloxidae 32, 59b ACROLOXOIDEA 32 Acroloxus 32, 59b acropachia (Tacheocampylaea) 53, 63a, 166 acrotricha (Chilostoma) 52, 63a, 162 ACTAEOPHILA 35 aculeata (Acanthinula) 37, 60a acuta (Cochlicella) 48, 62b acuta (Hydrobia) 28, 58b, 74-75 acuta (Physella) 33, 59b, 96-97 adjaciensis (Oxychilus) 44, 61a, 129 adolphi (Deroceras) 47, 62a Aegopinella 44, 61b, 129 aginnica (Cernuella) 51, 63a agreste (Deroceras) 47, 62a Agriolimacidae 47, 62a Agriolimacinae 47 Albea 47 albipes (Limax) 46, 61b, 133 albus (Gyraulus) 34, 59b algirus (Zonites) 45, 61b Alinda 41 alliarius (Oxychilus)