Ciò Che Conta È La Bicicletta
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

8 Miles Round Trip) S
Horace Huffman Loop Downtown Dayton ± (8 Miles Round Trip) S t i l l w a t e r n R i v ! e ^ Helena Street Bridge r !P ! Closed for Construction ! Through December 2017 !!P G re a t M ia m i R iv e r Webster Street Bridge Closed for Construction Through December 2017 Deeds Point ! MetroPark !^ ½ Korean War Mad River Veterans Memorial ! ½ ^ River Run ! Dayton Art Wall Mural ½! ½! e Institute ½! cap rS ive ins R nta Fou Pedestrian !n Bridge T ^ ½! S ! Y RiverScape A W MetroPark D A O R B . N !^ W ol f Cr eek ½! Dayton Aviation Heritage Site !^ !^ EXPLANATION Trails Dayton Loop (8 Miles) !^ Temporary Detour Route Great Miami River Trail Mad River Trail !^ Stillwater River Trail Wolf Creek Trail Community Path !^ Access !!P Vietnam Veterans !!P Parking ½! Overlook n ! Restroom Sources: Esri, HERE, DeLorme, Intermap, increment P Corp., GEBCO, USGS, FAO, NPS, NRCAN, GeoBase, IGN, Kadaster NL, Ordnance Attraction ½! Survey, Esri Japan, METI, Esri China (Hong Kong), swisstopo, MapmyIndia, © OpenStreetMap contributors, and the GIS User Community Miles 0 0.25 0.5 1 Horace Huffman Loop Ride – 8 Miles Round Trip Downtown Dayton MCD’s riverfront property has hosted multi‐purpose trails for more than 40 years. Explore Dayton’s original 8‐mile loop of the Great Miami River Recreation Trail – championed by the late Horace Huffman, Jr., chairman of Huffy Bicycles. This trail was dedicated during a huge riverfront celebration in 1976. Parking Several public parking places are available around the loop, including Island MetroPark, 101 East Helena Street, Dayton, Ohio 45404. -

MS-1 PART III Photographs
MS-1: Wright Brothers Collection PART III WRIGHT FAMILY PHOTOGRAPH COLLECTION This series includes many original photographic prints made by the Wrights from their own negatives shortly after the images were taken. The Wrights exposed at least 303 gelatin dry plate negatives in the course of documenting their process of invention. All of their glass plate negatives were given to the Library of Congress in 1949, but many of their original prints remained with the Estate of Orville Wright. Many of the Wright Brothers’ original negatives were damaged in Dayton’s great flood of 1913, when they were submerged for up to four days. The Wright State University collection includes some images for which no negatives exist at the Library of Congress and so many of these prints are unique. In addition, this collection includes hundreds of prints collected by the Wrights through their association with other aviation pioneers such as Octave Chanute, and a great variety of aeronautical prints either collected by them, or sent to them by well-wishers through the years. While the major prints exist in both collections, both the Wright State University collection and the Wright collection in the Prints and Photographs Division of the Library of Congress contain many images that are unique to each collection. Wilbur and Orville Wright began photographing their experiences on the Outer Banks using a 4 x 5 inch dry plate camera. In 1902 they purchased a Korona view camera which used 5 x 7 inch dry plates. They developed their negatives and made prints in the darkroom they set up at their home in Dayton. -

Shinola Case Study
by Matthew Fisher & Blodwen Tarter Shinola: What’s Next for a Brand Linked to Detroit’s Manufacturing Heritage? Martin Digger had recently applied for a job at Shinola, the Detroit-based company that manufactures consumer products ranging from watches to bicycles. He was excited about the possibility of returning to his hometown to use his new marketing degree as a brand assistant. To prepare for his interview, he walked to the closest coffee shop, ordered an extra-large coffee, and opened his laptop to review the history of the firm and Shinola’s products. He was glad to see that the articles overwhelmingly praised the company. According to the Shinola website, Of all the things we make, the return of manufacturing jobs might just be the thing we’re most proud of. Shinola is founded in the belief that products should be well-made and built to last. Across a growing number of categories, Shinola stands for skill at scale, the preservation of craft, and the beauty of industry.1 Those values resonated with Martin and his hopes for both Detroit and his own work. However, Martin paused when he came across one article that was critical of the firm. Shinola’s entire presence is predicated on its ties to the City of Detroit. The justification for the cheapest men’s watch being $550? For bicycles that cost a minimum of $1,950? American manufacturing costs more. Quality materials cost more. American products are inherently worth more. Like buying a pair of Toms helps some poor Third World kid, by buying a two thousand dollar bike you’re doing your part to help rebuild a fallen American city. -

Cycles À St Etienne - Loire
, cycles à St Etienne - Loire ♦ Dacheville * ; cycles garantis toutes pi A A * , cycles à Choisy - Val de Marne ♦ A A * ; cycles Amand Augustin à Rouvroy - Pas de Calais ● A & A - (USA) ♦ Abalde José * ; cycles & motos à Vigo - Galice - Espagne ● Abandon Racing - (Russie) à vérifié ● A.B.C * ; cycles ♦ Abel Jacques (..1909..) , fournitures générales pour cycles 8 Rue Vauban à Lyon - Rhône ● ABG (France) moteur auxiliaire ● Abingdon ● ABM voir American Bicycle Manufacturing (USA) ♦ AC * ; cycles à Senones - Vosges ♦ AC * , cycles à Dijon - Côte d'Or ♦ Accary * , cycles à La Chapelle sous Dun - Saône et Loire ● Accles & Pollock - (UK) ♦ ACE ♦ Achalm * ; cycles ♦ Achilles *, cycles à Wilhelshaven -Allemagne ♦ Acia * , cycles à Dijon - Côtes d'Or ♦ A C L * ; cycles à Lyon - Rhône ♦ A C M * , cycles garantis à Courbevoie - Seine ♦ A.C.M.A * , cycles France ♦ Actis * ; cycles à St Denis - Seine ♦ Activa * ; cycles marque déposée à Paris ♦ Activa * , cycles à Arles - Bouches du Rhône ♦ Active * , cycles A Demont à Lausanne - Suisse ♦ Adek ♦ Adelaar * , cycles Jos Grauls à Hasselt - Belgique ● Ader ♦ Adger L. , cycles et autos ● Adler - (Allemagne) ♦ Admiral , cycles Arnold Schwinn & Co à Chicago - USA ♦ Admiral * ; cycles à Paris ● Adonis (Allemagne) ● A.D. Stump où ADS (1914 à 2003) (USA) ● Aero * ; cycles - ♦ Aero Confort * ; cycles & motos ♦ Aerof * ; cycles ● Aeromarine Molding and Engineering voir A’ME (USA) ● Aeron voir Ridley (Belgique) ● Afer ♦ A.G ( ..1907..) ♦ Agache * (..1929..1960..) , cycles marque déposée 26 Rue de l'Industrie à Tourcoing- Nord ♦ Agami * ; manufacture des cycles Agami à Raismes - Nord ● AGB ♦ A.G.S * ; cycles à St Denis -Seine st Denis ● Agnew (1879) (UK) ♦ Agrea * ; cycles de luxe ♦ Aïdys * , cycles à Clichy - Haute de Seine ♦ Aigle * ; cycles "Nec plus ultra" marque déposée ♦ Aigle , marque de chez Godmard ,(...1912..) , constructeur - mécanicien - 30 Rue Moret à Paris . -

Richard's 21St Century Bicycl E 'The Best Guide to Bikes and Cycling Ever Book Published' Bike Events
Richard's 21st Century Bicycl e 'The best guide to bikes and cycling ever Book published' Bike Events RICHARD BALLANTINE This book is dedicated to Samuel Joseph Melville, hero. First published 1975 by Pan Books This revised and updated edition first published 2000 by Pan Books an imprint of Macmillan Publishers Ltd 25 Eccleston Place, London SW1W 9NF Basingstoke and Oxford Associated companies throughout the world www.macmillan.com ISBN 0 330 37717 5 Copyright © Richard Ballantine 1975, 1989, 2000 The right of Richard Ballantine to be identified as the author of this work has been asserted by him in accordance with the Copyright, Designs and Patents Act 1988. • All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in or introduced into a retrieval system, or transmitted, in any form, or by any means (electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise) without the prior written permission of the publisher. Any person who does any unauthorized act in relation to this publication may be liable to criminal prosecution and civil claims for damages. 1 3 5 7 9 8 6 4 2 A CIP catalogue record for this book is available from the British Library. • Printed and bound in Great Britain by The Bath Press Ltd, Bath This book is sold subject to the condition that it shall nor, by way of trade or otherwise, be lent, re-sold, hired out, or otherwise circulated without the publisher's prior consent in any form of binding or cover other than that in which it is published and without a similar condition including this condition being imposed on the subsequent purchaser. -

Anche Il Tour Barcolla E Speriamo Che Eddy Merckx Riesca a Tenerlo in Piedi
l'Unità / lunìdì 27 giugno 1977 -*• *-»• V • - - SPOrt /'PAG. 9 Sorrento: Paolini riveste la maglia tricolore ,\ i. 4- £"- tì, ì la Scic di Boronchellì ho dominoto il Giro di Campania Giovedì inizierà la sessantaquattresima edizione della corsa per la maglia gialla Anche il Tour barcolla e speriamo che e Moser è terzo Eddy Merckx riesca a tenerlo in piedi Sprint a sette: alla ruota di Paolini s'è piazzato Bergamo Subito i Pirenei e nel finale le Alpi - Van Impe spiccherà il volo in montagna? • Pure Thevenet e Zoetenielk in lizza per il successo Giovedì prossimo, in piena re e finisce nella schiera de scalata di Avoriaz dovrebbe presto verificheremo e sapre Guascogna, terra dei moschet gli incompetenti. Un Tour sen invece portare fieno nella ca mo. tieri di Alessandro Dumas, za richiami specifici per il scina di Lucien il quale gio Bernard Thevenet cercherà dell'Armagnac e del signor grande pubblico italiano si cherà grosso sulle Alpi, il 18 di risorgere. Spettacoloso due Assenti Maertens e Moser Messegues, un notissimo erbo gnifica un mese di stasi, di e 19 luglio, sotto il telone del anni fa, si era dato alla dol rista consultato dai campioni vuoto, un grave colpo al dare l'Alpe d'Huez in particolare. ce vita ed era precipitato. Il di ogni disciplina sportiva, ini e all'avere del nostro bilan Sulla carta i tre moschet Thevenet che nel '76 abban zierà il sessantaquattresima cio. Il Giro zoppica nonostan tieri del prossimo Giro di dona prima di Tulle sembra Giro di Francia. La località te le ciance, i proclami, te Francia sono Merckx. -
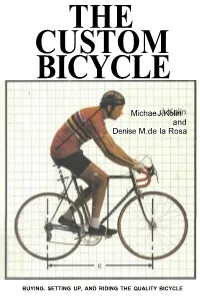
The Custom Bicycle
THE CUSTOM BICYCLE Michae J. Kolin and Denise M.de la Rosa BUYING. SETTING UP, AND RIDING THE QUALITY BICYCLE Copyright© 1979 by Michael J. Kolin and Denise M. de la Rosa All rights reserved. No part of this publication may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopy, recording, or any information storage and retrieval system, without the written permission of the publisher. Book Design by T. A. Lepley Printed in the United States of America on recycled paper, containing a high percentage of de-inked fiber. 468 10 9753 hardcover 8 10 9 7 paperback Library of Congress Cataloging in Publication Data Kolin, Michael J The custom bicycle. Bibliography: p. Includes index. 1. Bicycles and tricycles—Design and construction. 2. Cycling. I. De la Rosa, Denise M., joint author. II. Title. TL410.K64 629.22'72 79-1451 ISBN 0-87857-254-6 hardcover ISBN 0-87857-255-4 paperback THE CUSTOM BICYCLE BUYING, SETTING UP, AND RIDING i THE QUALITY BICYCLE by Michael J. Kolin and Denise M. de la Rosa Rodale Press Emmaus, Pa. ARD K 14 Contents Acknowledgments Introduction Part I Understanding the Bicycle Frame CHAPTER 1: The Bicycle Frame 1 CHAPTER 2: Bicycle Tubing 22 CHAPTER 3: Tools for Frame Building 3 5 Part II British Frame Builders CHAPTER 4: Condor Cycles 47 CHAPTER 5: JRJ Cycles, Limited 53 CHAPTER 6: Mercian Cycles, Limited BO CHAPTER 7: Harry Quinn Cycles, Limited 67 CHAPTER 8: Jack Taylor Cycles 75 CHAPTER 9: TI Raleigh, Limited 84 CHAPTER 10: Woodrup Cycles 95 Part III French Frame Builders CHAPTER 11: CNC Cycles 103 CHAPTER 12: Cycles Gitane 106 CHAPTER 13: Cycles Peugeot 109 THE CUSTOM BICYCLE Part IV Italian Frame Builders CHAPTER 14: Cinelli Cino & C. -

38 2000 Tobacco Industry Projects—A Listing (173 Pp.) Project “A”: American Tobacco Co. Plan from 1959 to Enlist Professor
38 2000 Tobacco Industry Projects—a Listing (173 pp.) Project “A”: American Tobacco Co. plan from 1959 to enlist Professors Hirsch and Shapiro of NYU’s Institute of Mathematical Science to evaluate “statistical material purporting to show association between smoking and lung cancer.” Hirsch and Shapiro concluded that “such analysis is not feasible because the studies did not employ the methods of mathematical science but represent merely a collection of random data, or counting noses as it were.” Statistical studies of the lung cancer- smoking relation were “utterly meaningless from the mathematical point of view” and that it was “impossible to proceed with a mathematical analysis of the proposition that cigarette smoking is a cause of lung cancer.” AT management concluded that this result was “not surprising” given the “utter paucity of any direct evidence linking smoking with lung canner.”112 Project A: Tobacco Institute plan from 1967 to air three television spots on smoking & health. Continued goal of the Institute to test its ability “to alter public opinion and knowledge of the asserted health hazards of cigarette smoking by using paid print media space.” CEOs in the fall of 1967 had approved the plan, which was supposed to involve “before-and-after opinion surveys on elements of the smoking and health controversy” to measure the impact of TI propaganda on this issue.”113 Spots were apparently refused by the networks in 1970, so plan shifted to Project B. Project A-040: Brown and Williamson effort from 1972 to 114 Project AA: Secret RJR effort from 1982-84 to find out how to improve “the RJR share of market among young adult women.” Appeal would 112 Janet C. -

Bicycleshow 2014
bespoked THEUKHANDMADE BICYCLESHOW 2014 Show Guide 11TH -13TH APRIL 2014 LEE VALLEY VELOPaRK, LONDON www.bespoked.cc facebook.com/ukhandmadebicycleshow @bespokedUKHBS Welcome to Bespoked 2014 - The UK Handmade Bicycle Show A celebration of the handmade bicycle industry. It’s a very exciting time for frame building at the moment. The depth of talent and level of bespoked enthusiasm is quite astonishing. The craftsmanship on display here is amongst the best in the world. The people who make these wonderful bicycles are the people you will meet and talk with at the show. They are the ones with the skills to tailor a bicycle to meet your 2015 requirements to make the bike of your dreams. We would like to thank everyone who has attended and all those exhibiting for making this year’s show happen. BRISTOL Thank you to Lindsay Gray for all her help and support with the organisation of the show 17TH -19TH APRIL 2015 and of us! Thank you to Ben Broomfield for photographing the show and the exhibitors work. Don’t forget to vote for your favourite exhibitor and have the chance to win some lovely Vulpine clothing. The voting slip is on the back of your entry ticket. The winner will be THEUKHANDMADE announced on Sunday afternoon. We hope that you enjoy the show! Tessa and Phil Taylor BICYCLESHOW Organisers , Bespoked 2015 Show Photographer Visit www.bespoked.cc to register your interest www.benbroomfield.com Kemp House, Suite 1165, 152 City Road, London EC1V 2NX 07734852620 [email protected] Bespoked 2014 is proudly supported by: Printed on 100% recycled paper using vegetable based inks by: Taylor Brothers Bristol Ltd 13-25 Wilder Street - Bristol - BS2 8PY www.taylorbros.uk.com bespoked taLKS Friday 11th April - Launch 2014 Awards 16.00 - 17.00 - RattleCAD - Bicycle Design Software - In this talk rattleCAD will be presented with its BEST IN SHOW - supported by Reynolds main features and the parametric model based on stack and reach will be discussed against seat BEST ROAD BIcycle - supported by Columbus and toptube length. -

Ah9alfa Romeo E9è Puzza Di Bruciato E Di... Sorprese
GIOVEDÌ 5 APRILE 1984 l'Unità - SPORT 17 Oggi si corre il Giro dell'Umbria (in TV2 dalle 15.50) Uingegner Chiti parla dei problemi che affliggono la scuderia milanese Torna Beppe Saronni, ma 9 9 il pronostico dice Prim AH Alfa Romeo e è puzza Contini e Baronchelli di bruciato e di... sorprese Il capitano della «Del Tongo» verso la buona condizione dopo il Il buon piazzamento a Rio non cancella le diffìcoltà - Pessimismo per Kyalami: «Una «ritiro» in Riviera - Assente Moser sofferente per una discopatia macchina nuova ha bisogno di molte cure» - «Forse in Belgio saremo in 'pole position'» altri sono andati in fumo per colpa delle reno quello dell'Alfa Romeo. turbine. E le turbine non le faccio io. Sono «Io non vado in giro a dire che gli altri © cose che succedono. Ha visto la BMW? sono bischeri. E se qualcuno parla male di © Anche loro ne hanno buttati via tre. E la me è un emerito imbecille». Dal nostro inviato MILANO — «È un miracolo: andrò al san Renault? Ne hanno rotti sei. E che, io sarei Se non si ripetesse il miracolo di Rio, ha TORGIAN'O — In un calendn- .1 tuario di Loreto» aveva esclamato dopo più bischero degli altri? Le dicevo: stavo in paura di perdere il posto?. rio affollato e irrazionale il Giro i 5» ui aver visto Eddie Checver tagliare il tra' pena perché non avevamo ancora espe «Ma che discorsi sono questi? Allora, dell'Umbria appare all'improv 2 guardia di Rio de Janeiro in quarta posi perché le Ferrari sono andate male, caccia O w •••-"•y<M rienza su quanto avrebbe consumato in ga viso — dopo una prima colloca N zione. -

Bespoked THEUKHANDMADE BICYCLESHOW 2016
bespoked THEUKHANDMADE BICYCLESHOW 2016 n so y D ah nn Ha SHOW GUIDE . BRUNEL’S OLD STATION . ENGINE SHED . 15TH - 17TH APRIL 2016 Welcome to Bespoked 2016 - The UK Handmade Bicycle Show A celebration of handmade bicycles and those who make them. We are delighted to welcome you back to Bristol for the 6th annual Bespoked, Europe’s biggest Take your road cycling to the next level showcase of handmade bicycles and their makers. 100 of the world’s finest artisan bicycle framebuilders and bicycle goods designers have gathered at Brunel’s Old Station bringing with GET 3 ISSUES them unique handmade bicycles and fine cycling components, apparel and accessories, many unveiled for the first time. As well as classically beautiful bikes of all disciplines you can expect to see groundbreaking design and alternative visions from people who think outside the box. Bespoked FOR JUST £5 is the highlight in the framebuilders’ calendar and they all work hard to bring something special to For the world’s best rides, the latest bikes and must- the show. Also on show will be handmade cycle accessories, bicycle components, cycling apparel, have gear, expert advice and the stories behind the footwear, art and literature from Brooks England, Findra, Quoc and Boneshaker Magazine to name a biggest names in cycling, try Cyclist magazine today. few. London cycle café Look Mum No Hands will be serving delicious artisan coffee, craft beer and homemade food. We would like to thank everyone who has attended and all those exhibiting for making this year’s show happen. Thank you to Linny Gray and Poppy Smith for all their help and support with the organisation of the show. -

20 21 V Ademe
2021 vademecum 2021VADEMECUM ASSOCIAZIONE CORRIDORI CICLISTI PROFESSIONISTI ITALIANI Via Piranesi 46, 20137 Milano Tel. +39 02 66 71 24 51 - Fax +39 02 67 07 59 98 [email protected] - www.accpi.it 2021 VADEMECUM ACCPI - LA STORIA LO “STORICO” PROGETTO NACQUE IN TRATTORIA Fatto lo statuto, elaborato dall’avvocato Orsi, costituita ufficialmente l’associazione, Cino Cinelli primo ed indiscusso presidente. Era un ciclismo vivo ma disarticolato, quello Cinelli primo ed indiscusso presidente. Rimaneva dell’immediato dopoguerra. Cinelli aveva vinto il problema di tirare dalla propria parte i nomi l’ultima Sanremo “bellica”, 1943, ma a quel punto importanti, le vedette, ai quali – si diceva all’epoca – era già il passato. Coppi aveva invece intascato la la nascita di un sindacato piaceva assai poco. Magni classicissima del ‘46, lui era il presente e il futuro. sposò immediatamente la causa, diventandone Ma i problemi, quelli veri, orbitavano soprattutto in un presto uno dei motori propulsori. Né si dovette ciclismo gregario, povero, qualche volta addirittura aspettare molto perchè anche Fausto Coppi e affamato. Il baratro che correva tra gli stipendi dei Gino Bartali dessero la loro adesione. E così campioni e quelli degli uomini di sostegno era un l’Associazione prese forza, convinzione nei propri discorso a latere, praticamente senza via d’uscita, mezzi. Sostenne battaglie importanti soprattutto in un sistema spietatamente meritocratico come con gli industriali delle case ciclistiche che fino ad quello delle corse in bicicletta. allora l’avevano fatta da padroni. Rimaneva la piaga degli indipendenti, assoldati solo quando faceva comodo, per il resto costretti a mendicare grami ingaggi nelle poche corse minori o circuiti ad ingaggi in cui riuscivano ad attaccarsi un numero sulla schiena.