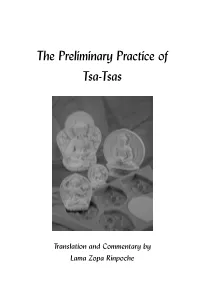- G L O S S A R I O
- T I B E T A N O
TRASLITTERAZIONE E PRONUNCIA DELL’ ALFABETO TIBETANO
- A
- A ;
E aperta, se nella stessa sillaba è seguita dalla finale D, Æ, L, N, ¹, S
AI A’I AU B
E lunga chiusa E lunga aperta, con l’eventuale aggiunta di una I brevissima O lunga chiusa B ; U semivocale, nella sillaba “ba” isolata ; o in una sillaba che comincia per “dba”; o se è preceduta da sillaba (della stessa parola) terminante con vocale, L,Ó,R,’ MUTA, se – iniziale - è seguita da consonante diversa da H,R,Y; nonché nelle sillabe “dbe,dbi,dbo,dbu”
BR BY
D pronunciata simultaneamente a una debole R con la lingua contro il palato G dolce di “gelo” Y, se nella stessa sillaba è preceduta da D
CD
C dolce di “cece” D ; MUTA, se – iniziale – è seguita da consonante diversa da H,R,W,Y; oppure se è finale
- Æ
- D con la lingua rivolta all’indietro contro il palato
DR DW DZ E
D pronunciata simultaneamente a una debole R con la lingua contro il palato DZ dolce di “bazza“ E chiusa ; sovente I breve quasi E (ingl. tin), quando è finale di sillaba.
- G
- G dura di “gatto“;
MUTA, se – iniziale - è seguita da consonante diversa da H,R,W,Y scarsamente udibile, se è finale oppure se si trova nella finale GS
GR GW H
D pronunciata simultaneamente a una debole R con la lingua contro il palato G dura di “gatto” H aspirata come nell’ingl. “heart” (se preceduta da una consonante, forma con questa un’unica emissione di fiato)
HR ø
H seguita da una R appena accennata. I lunga
- J
- G dolce di “gelo”
- K
- K ;
MUTA, se – iniziale - è seguita da consonante diversa da H,R,W,Y
- KHR
- T (con la lingua contro il palato) pronunciata aspirata in un’unica emissione di
fiato
KR KW L
T pronunciata simultaneamente a una debole R con la lingua contro il palato KL ; MUTA, se – iniziale – è seguita da consonante diversa da H o W
LW M
LM; MUTA, se – iniziale – è seguita da altra consonante
- Ï
- M o N (nasalizza la vocale precedente)
MR MY Ñ
MGN di “gnomo” GN di “gnomo“
2
2 Da altri trascritta NY.
3
- Ó
- NG dell’ingl. “long“
- ¹
- N pronunciata con la lingua rivolta all’indietro contro il palato
NR O
N pronunciata con la lingua rivolta all’indietro contro il palato O chiusa ; Ö, se nella stessa sillaba è seguita dalla finale D, Æ, L, N, ¹, S
- PHR
- T (con la lingua contro il palato) pronunciata aspirata in un’unica emissione di
fiato
PHY PR PY R
C dolce di “cece” pronunciata aspirata in un’unica emissione di fiato T pronunciata simultaneamente a una debole R con la lingua contro il palato C dolce di “cece” R; MUTA, se – iniziale – è seguita da consonante diversa da W
RW S
RS dura di “cassa”; MUTA, se – iniziale – è seguita da consonante diversa da R o W; oppure se è finale SC di “scena”
4
ê
- å
- KH pronunciata in un’unica emissione di fiato;
SC (di “scena”) sforzato con la lingua ripiegata all’indietro verso il palato, in parole sanscrite
SR êR
S dura di “cassa” SC di “scena”
SW í
S dura di “cassa” T pronunciata con la lingua rivolta all’indietro contro il palato
- THR
- T (con la lingua contro il palato) pronunciata aspirata in un’unica emissione di
fiato
TR TS U
T pronunciata con la lingua rivolta all’indietro contro il palato Z sorda di “mazza“ U ; Ü, se nella stessa sillaba è seguita dalla finale D, Æ, L, N, ¹, S
U’I W
Ü lunga, con l’eventuale aggiunta di una I brevissima U semivocalico di “quando” ; MUTA, se nella stessa sillaba è preceduta da altra consonante.
YZó
I semivocalico di “iena”. S dolce di “rosa” J francese di “jour”, ma più palatale (cioè, quasi sc di scena)
5
ZL ‘
Dmuta.
6
Le altre lettere hanno la stessa pronuncia dell’italiano.
ACCENTO TONICO : tralasciando i toni alto e basso (con cui vengono pronunciate le lettere dell’alfabeto), va detto che l’accento tonico cade generalmente sull’ultima sillaba, ma non sempre: ad es., san-pà, delègs, mo-mò (raviolo), mò-mo (nonna), blò-saÒ, æè-rab, byaÒ-cùb. Cade solitamente sul radicale e non sulle desinenze grammaticali. Nei composti cade sull’ultima parte della composizione.
3 Da altri trascritta NG. 4 Da altri trascritta SH, á o Ç. 5 Da altri trascritta ZH. 6 Da altri trascritta È.
GLOSSARIO A
A-BAR SAÓS-RGYAS RGYA-MTSHO: vissuto dal 1653 al 1705, fu nominato reggente del 5° Dalai Lama nel 1679. Studioso di rango, fu letterato e medico famoso.
A-CE : sorella maggiore.
A-CHE LHA-MO :
“sorella-dea” : attrice di teatro.
A-CHI CHOS-KYI SGROL-MA:
Protettrice del Dharma (dharmapõla) la cui pratica fu introdotta da ‘Bri-guÒ A-chi, matriarca del lignaggio ‘Bri-guÒ bKa’-brgyud.
E’ raffigurata di color bianco, usualmente seduta su un leone delle nevi, ma può anche essere in piedi. Il suo aspetto non è irato (come invece avviene per i dharmapõla), bensì pacifico.
A-CHU: a) parola che esprime la sensazione di freddo, come l’italiano “brrr”; b) nome di un inferno freddo (sanscr. huhuva).
A-DKAR-GYI THEG-PA: il Veicolo della A bianca.
AH-LA-LA: il suono di una grande risata.
A-KHRID:
“La guida della A”: un gter-ma dello rDzogs-chen bon riscoperto in Tibet dal santo rMe’u dgoÒs-mdzod ri-khro chen-po (1038-1096) e contenente degli insegnamenti simili al Sems-sde dei rÑiÒ-ma-pa.
A-KHU: zio.
÷-LI: v. õli.
AM-CHI : medico. Vedi sub cikitsavidyõ.
A-MDO : vasta regione del Tibet nord-orientale, oggi comprendente la maggior parte della provincia cinese del Qinghai e la prefettura Kanlho del Gansu. E’ nota anche come provincia Dotoh. Insieme al Khams e al dbUs-gTsaÒ è una delle 3 regioni storiche del Tibet.
A-MO-LI-KA: un tipo di pietra squadrata e nera.
A-MYES RMA-CHEN: altro nome di rMa-chen sPom-ra.
A-NE : zia.
A-NI RJE-BTSUN SGROL-MA:
“Monaca venerabile Tara” è una donna che ha personificato il principio della Åõkinú e che ha raggiunto l’Illuminazione, ispirandoci ad aver fiducia nel Dharma e a seguirne l’esempio.
Era nata in una ricca famiglia di nomadi del Tibet orientale. A 16 anni i genitori pensarono al suo matrimonio, ma lei fuggì da casa per acquisire gli insegnamenti del Dharma che desiderava ardentemente. Per molti giorni viaggiò sola, incurante dei pericoli, fino a Nyingma Shungse, un monastero di suore vicino a Lhasa e qui si fece monaca. Dopo alcuni anni di studio e pratica andò al monastero di Shingdu Rinpoche e fece alcuni ritiri di 3 anni. Fece un ritiro di 3 mesi dello Dzog-chen: un ritiro al buio totale e completamente isolata da ogni contatto umano. Seguì una pratica detta “Devcholin”, in cui essa rimase su una pietra consacrata per 90 giorni senza cibarsi. Andò al monte Kailash e lo circumambulò 13 volte, facendo prostrazioni complete.
Quando scoppiò la guerra con la Cina, si recò in India e si stabilì al monastero di
Dejung Rinpoche, dove essa e il suo attendente costruirono una capanna nella giungla. Qui, nei pressi del Campo per rifugiati tibetani di Lobersing, in Orissa, pregò e meditò – isolata – per circa 2 anni.
Un giorno arrivò alla sua capanna un taglialegna: preoccupato da vari problemi, le richiese un “mo” (divinazione). Lei gli diede delle informazioni esatte, che consentirono una rapida soluzione della situazione. Ben presto la notizia si diffuse nel Campo e i rifugiati si rivolsero a lei per un aiuto contro le malattie. Essa prese allora una bottiglia piena d’acqua e durante le sue meditazioni vi soffiò sopra: una sola goccia di quell’acqua curava ogni tipo di malattia, anche del bestiame. Un anno salvò i raccolti: si fece portare un po’ di terra dai campi, vi soffiò sopra e la fece spargere sugli appezzamenti. Da allora gli elefanti, gli orsi e i cinghiali non vennero più a mangiare le messi.
Essa non aveva alcuna paura dei serpenti velenosi che le strisciavano attorno. E gli orsi venivano a mangiare le gtor-ma dopo le sue cerimonie rituali. Anche le iene la lasciavano in pace.
Il suo corpo era radiante; eppure mangiava scarsamente, solo una scodella di latte con un po’ di farina di grano.
Nel 1979 ha preannunciato la sua prossima morte. Due giorni dopo si ammalava.
La mattina successiva molti testimoni sentirono versi simili a quelli di strani uccelli, mai uditi prima. Dopo poche ore il suo attendente li informò del suo trapasso: essi si recarono alla capanna e lì videro Ani che aveva assunto la stessa postura di buddha êõkyamuni quando morì. Per 3 giorni e 3 notti assistettero il corpo, che era caldo, senza segni di decomposizione. Esso si rimpicciolì un po’. E il giorno prima della cremazione colarono da una narice un leggero flusso rosso e dall’altra uno bianco: sono i segni di una grande realizzazione yogica.
Quando la pira fu accesa, dal cielo terso cadde una pioggerellina. Molti arcobaleni attraversarono il fumo. Cinque enormi uccelli volteggiarono fino alla totale consumazione del corpo e poi svanirono: erano 5 Åõkinú che scortavano Ani alla Terra Pura. Nelle sue ceneri si trovarono innumerevoli reliquie (riÒ-bsrel), dotate del potere di guarire e di influsso benefico.
A-NI-LA : il titolo con cui normalmente ci si rivolge ad una monaca (letteralmente significa “zia” + il suffisso onorifico “la”).
A-NU: v. anu-yoga.
ANU-YO-GA’I YAN-LAG-GI DBAÓ BRGYAD-BRGYA SO-GCIG :
“le 831 iniziazioni secondarie dell’anuyoga”.
A-RAG: whisky tibetano: liquore fortemente alcolico ottenuto per distillazione dal chaÒ.
A-RO GTER:
“a-ro” significa “gusto della (primordiale) lettera A)”, mentre “gter” è abbreviazione di “gter-ma”.
E’ un lignaggio non monastico (Òag-pa) all’interno della tradizione rñiÒ-ma-pa e tratta tutti gli argomenti buddhisti dal punto di vista dello rdzogs-chen: pertanto le sue pratiche (sems-sde, kloÒ-sde e man-Òag-sde) sono più semplici rispetto alle elaborate sõdhana del buddhismo tantrico e possono quindi essere più adatte a chi ha poco tempo perché lavora o ha famiglia, cioè ad ogni ceto sociale.
Gli insegnamenti provengono da (Ngak’chang Drüpchen) Aro Yeshe, che era figlio di (Khyungchen) Aro Lingma (1886-1923), lo scopritore (gter-ston) dell’A-ro gter e incarnazione di Jo-mo sMan-mo; quest’ultimo era incarnazione di Ma-cig Labsgron ed emanazione di Ye-æes mTsho-rgyal.
A-RTSHO BAN-DE BCO-BRGYAD: i 18 Mendicanti di Artso, che diffusero pratiche distorte di tantra buddhista.
A-RU-RA: v. harútaki.
A-êAD:
"A verticale": vedi a-thuÒ.
A-THUÓ:
"A breve": la forma della lettera A rossa tibetana visualizzata all'ombelico nel corso della pratica del gtum-mo. Vedi a-æad.
A-TI: v. ati-yoga.
A-TSA-RA (õcõrya):
-“maestro” d’origine indiana; -nel ‘cham è un buffone (o clown) che impersona in modo caricaturale un dotto indiano; -specie di folletto della grandezza di un pollice, col corpo di ferro e due occhi sproporzionatamente grandi.
A-YU MKHA’-‘GRO: una “Åõkinú samsarica” (1839-1953), che fu maestra di rdzogs-chen e vajrayõna nel Tibet orientale, nota per il suo “ritiro al buio (mun mtshams)” e per la pratica del gcod.
GLOSSARIO B
(NB.- Il suono iniziale tibetano traslitterato con grafemi DB, RB e SB;
- B
- può essere reso anche coi
il suono iniziale tibetano traslitterato con BR può essere reso anche coi grafemi BZL, DR, GR, GRW, KR, PR, SGR, SKR, SPR, TR, ZL; il suono iniziale tibetano traslitterato con BY può essere reso anche coi grafemi DBY e SBY)
BABS-LUGS CHEN-PO GSUM :
“i 3 grandi lignaggi” : v. brgyud-pa gsum.
BA-DAN: v. patõka.
BAD-'BUR: lo strato di piccole assi di legno che si trova subito sotto il tetto nelle costruzioni tibetane, sottotetto.
BAD-KAN: v. kapha.
‘BAG : maschera.
BAG-CHAGS : predisposizioni inconsce, tracce karmiche, cioè inclinazioni e tendenze derivanti da karma passati : v. võsanõ e gñis-‘dzin.
BAG-CHAGS-KYI SGRIB-PA: v. võsanõvaraÐa.
BAG-CHAGS YID-LUS :
“corpo mentale fatto di tendenze inconscie” : il principio cosciente del defunto - nel bar-do - costituito dalla somma delle esperienze karmiche, inclinazioni, tendenze ed abitudini inconscie nate dall’esistenza samsarica ; e dotato pertanto della capacità di proiettare una nuova esistenza da quelle stesse determinate.
BA-GLAÓ-SPYOD :
“gioia delle mandrie”, “godimento dei bovini” : v. Godanúya.
BAG-LA ÑAL: v. anuæaya.
BAG-MED: v. pramõda.
BAG-RTSIS: il settore dell'astrologia relativo ai matrimoni.
BAG-YOD: v. apramõda.
BAID¿RYA: v. vaižrya.
BAI-RO-TSA-NA: v. Vairocana.
BAL-BZA’:
“La principessa nepalese”, cioè BhÕkutú, che nel 632 sposò il re tibetano SroÒ-btsam sGam-po. Vedi sub Jo-khaÒ.
BAL-MO : donna nepalese.
(BAL-MO BZA’) KHRI-BTSUN: v. Khri-btsun.
BAM : a) riunire in serie ; b) rancido, che marcisce o si deteriora.
BA-MO : mucca, vacca. Vedi sub pañcõmÕta.
‘BA’-MO : strega, maga. Le “3 streghe (‘ba’-mo gsum)” della Scuola Sa-skya-pa sono Mamo
Rikye, Namka Drolma e Shangmo, spesso riconoscibili per un grande ornamento floreale che adorna la loro fronte. Sono protettori mondani particolarmente difficili da controllare e ritenuti essere la causa di malattie fisiche e mentali per i deboli di cuore.
BAM-RIL : cadavere umano recente ed intatto.
BAM-RO : a) cadavere ; b) effigie di legno o di pasta usata in certi rituali di annientamento simbolico dei nemici del Dharma.
BAN-BON : monaci buddhisti e bon.
BAN-DE: religioso.
BAN-DHA : v. kapõla.
BAÓ-MDZOD LTA-BU'I SEMS-BSKYED: v. koæapanacittotpõda.
‘BAÓS : suddito.
‘BAÓS-SU (‘KHOL, MCHI) : gente comune, vassalli.
‘BA’-PO: mago, stregone. La magia è un modo per evocare e sfidare l’energia per ottenere determinati effetti – la cui efficienza peraltro dipende dallo stato mentale del praticante e da altri fattori secondari.
BAR : centrale, intermedio; il centro, il mezzo tra due opposti.
‘BAR-BA GSUM :
“le 3 fiamme” : cioè l’avvampare del piacevole calore nel corpo (lus-la bde-drod), della potenza nella parola (Òag-la nus-pa), della realizzazione nella mente (sems-la rtogs-pa).
'BAR-BA'I 'OD-CAN-MA: v. sub EkaviËæati Tõrõ.
‘BAR-BA SPUN-BDUN: i “7 Fratelli splendenti” sono un gruppo di 7 dharmapõla tibetani, che comandano le divinità native tibetane degli btsan. I 7 avevano cercato di impedire la propagazione del Dharma nel Paese delle Nevi, ma furono soggiogati da Padmasambhava mediante la meditazione su Hayagrúva. Sono noti anche come “dam-can mched-bdun, dragbtsan mched-bdun, btsan-rgod ‘bar-ba, btsan-rgod zaÒs-ri spun-bdun”.
‘BAR-‘BRUG: il lignaggio Intermedio dei ‘brug-pa (in contrapposizione agli altri due lignaggi, detti stod-‘brug e smad-‘brug).
BAR-BSKAL: v. antarakalpa.
BAR-CHAD: v. núvaraÐa.
BAR-CHAD KUN-SEL:
“Colui che dissipa tutti gli ostacoli”, un gter-ma comune a Chögyur Lingpa e a Jamyang Khyentse Wangpo (19° sec.).
BAR-CHAD-MED LAM: v. anantariya-mõrga.
BAR-CHAD-MED LAM DAÓ RNAM-GROL LAM GAÓ YAÓ MA-YIN-PA’I YE- êES: “saggezza dell’equilibrio meditativo che non è né sentiero ininterrotto (anantariyamõrga) né liberato (vimukti-mõrga)”: saggezza in equilibrio meditativo nella fase iniziale, che non è ancora antidoto al suo specifico “oggetto di abbandono (hõna)”.
BAR-DO :
“tra due, intermedio” : stato intermedio, di cui esistono numerosi tipi, il più noto dei quali è quello tra la morte e la successiva rinascita, durante il quale la coscienza assume un “corpo fatto di mente” formato dalle tendenze karmiche (bag-chags yidlus). Vedi antarõbhava e Na-ro chos drug.
BAR-DO-BA:
“l’essere del bar-do”, cioè il corpo sottilissimo (æin-tu phra-pa’i lus) che viene assunto spontaneamente al momento della morte. La sua causa materiale è costituita dal sottilissimo “rluÒ che sostiene la vita” (che dimora nell’ “indistruttibile goccia” nel cakra del cuore) quando esce dal corpo fisico unitamente alla “mente sottilissima”. Si tratta del risultato di un processo di completa identificazione tra la mente ed una forma corporea immateriale, ma percepita come reale (analogamente al corpo in un sogno). L’essere che si trova nel bar-do si nutre di odore e la durata massima della sua vita è di sette settimane, se sta per rinascere come essere umano.
BAR-DO DAÓ-PO’I ‘OD-GSAL:
“Chiara Luce del primo bar-do”: è la prima delle 3 fasi della radiosità interiore che si sperimentano nel processo della morte. Le prime 2 sorgono durante il ‘chi-kha’i bar-do, mentre la 3ª si identifica con la comparsa delle Divinità Pacifiche ed Irate durante il chos-ñid bar-do.
BAR-DO GCOD-PA:
"la pratica del bar-do", uno dei "Sei yoga di Nõropa", nel quale ci si esercita nella meditazione in modo che al momento della morte sia possibile riconoscere la natura della mente evitando di attraversare la difficile esperienza del bar-do.
BAR-DO GSUM-PA: il 3° bar-do: v. dharmatõntarõbhava.
BAR-DO'I GDAMS-PA: v. antarõbhavayoga.
BAR-DO'I RLUÓ-LUS: v. antarõbhavavõyukõya.
BAR-DO[’I] THOS-‘GROL [CHEN-MO]:
“la [grande] liberazione mediante l’ascolto nel bar-do”, uno dei 6 “metodi per ottenere l’Illuminazione senza meditazione” (cioè mediante l’udire, il vedere, l’indossare, l’assaggiare, il ricordare e il toccare) trasmessi da Padmasambhava e rivelati da Karma gLiÒ-pa ; il testo che contiene le istruzioni relative al punto 1., noto in Occidente come “libro tibetano dei morti”. Le istruzioni del bar-do qui contenute derivano dai cd. Tantra rDzogs-chen (che sono gli insegnamenti originali dello rdzogs-chen, compilati dal primo maestro in forma umana, dGa’-rab rDo-rje, ma risalenti all’õdibuddha Samantabhadra).
BAR-DO’I RTSA-TSHIG:
“Versi-radice dei 6 bar-do”.
BAR-DO’I SNAÓ-BA YID-KYI LUS: corpo mentale dell’esperienza apparizionale nel bar-do.
BAR-DO ‘JIGS-SKYOB-MA’I SMON-LAM:
“Preghiera che protegge dalla paura dei bar-do”.
BAR-DO ‘PHRAÓ-SGROL-GYI SMON-LAM:
“Preghiera aspirazione che libera dai pericolosi sentieri dei bar-do”.
BAR-DOR 'DA'-BA: v. antarõparinirvõyin.
BAR-DO RNAM BóI :
“i 4 stati intermedi” : quello del luogo di nascita (skye-gnas-kyi bar-do), quello del momento della morte (‘chi-kha’i bar-do), quello della realtà (chos-ñid bar-do), quello della rinascita (srid-pa bar-do).
BAR-DO SPYI-DON THAMS-CAD RNAM-PA GSAL-BAR BYED-PA DRAN-
PA’I ME-LOÓ: “Specchio della consapevolezza che spiega tutti gli aspetti dei bar-do” di Tsele Natsok Rangdrol.
BAR-DO THOS-GROL:
“Liberazione dal [o: nel] bar-do mediante l’ascolto”: testo appartenente al ciclo gterma di Padmasambhava “Kar-gliÒ ²i-khro”, venne messo per iscritto nel 760 c. e riscoperto (ed ampliato) dal gter-ston Karma gLiÒ-pa nel 14° sec. La maggior parte delle visioni descritte è connessa alla pratica thod-rgal dello rDzogs-chen.
BAR-DO óI-KHRO: "Le divinità pacifiche ed irate del bar-do" sono le divinità che appaiono al 'corpo mentale' del defunto nei vari giorni del "bar-do della dharmatõ". Si tratta di
--42 divinità pacifiche (²i-ba’i lha ²e-gñis), che escono dal cuore del defunto; --10 vidyõdhara (5 maschili e 5 femminili), che provengono dalla gola del defunto; --58 divinità irritate (khro-bo lha bcu-lÒa-brgyad), che emanano dalla sua testa. Sono quindi in totale 110 le divinità del bar-do, anche se si parla spesso di "100 divinità pacifiche ed irate" (²i-khro rigs-brgya) omettendo i vidyõdhara (dato che sono una via di mezzo tra le pacifiche e le irritate). Il suddetto totale arriva poi a 112 divinità se alle irate si aggiungono Mahottara-Heruka e Krodheævarú (che stanno all’origine di tutte le altre 58 divinità irate, delle quali sono la quintessenza personificata) e a 120 divinità se si aggiungono le 8 Grandi Proiettatrici (sPor-byed chen-mo).
Queste deità non sono altro che l'espressione della natura ultima e pura della mente del defunto; vanno pertanto da lui riconosciute come tali, senza lasciarsi sedurre da altre apparenze luminose, più attraenti ma di natura samsarica, che si producono simultaneamente.
Lo stato naturale della mente è detto “rig-pa” (vidyõ), che non è altro che la ‘natura di buddha’ (tathõgatagarbha) presente da sempre in ogni essere senziente. Esso ha il duplice aspetto di vacuità (o purezza primordiale) e di chiarezza (o presenza spontanea): dal primo punto di vista, esso non risiede in nessuna parte in particolare, ma dal punto di vista della sua natura spontaneamente presente esso si manifesta nelle strutture del corpo sottile sotto forma di ‘gocce essenziali’ o sfere luminose (thig-le). Di conseguenza, si afferma che esso risiede particolarmente
--nel cuore, dove i thig-le costituiscono l’essenza delle 42 deità pacifiche, che sono il dispiegarsi della saggezza dei 5 Jina delle 5 Famiglie di buddha;
--nel cervello, dove il dinamismo delle 5 saggezze si esprime nel maÐÅala delle 58 deità irate.
Il maÐÅala che raggruppa le 100 deità pacifiche ed irate personifica così tutte le qualità del tathõgatagarbha presenti nell’individuo.
a] Le 42 Divinità pacifiche 1° giorno:
Buddha maschile: Buddha femminile:
Vairocana [÷kõæõ]dhõtvúævarú
2° giorno:
- Buddha maschile:
- AkØobhya1
Buddha femminile: Bodhisattva maschili: Bodhisattva femminili:
Locanõ KØitigarbha, Maitreya Lõsyõ, PuØpõ
3° giorno:
- Buddha maschile:
- Ratnasambhava
Mõmakú ÷kõæagarbha, Samantabhadra Mõlyõ, Dh¾põ
Buddha femminile: Bodhisattva maschili: Bodhisattva femminili:
4° giorno:
- Buddha maschile:
- Amitõbha
Buddha femminile: Bodhisattva maschili: Bodhisattva femminili:
PõÐÅarõ[vasinú] Avalokiteævara, Mañjuærú Gútõ, ÷lokõ
5° giorno:
- Buddha maschile:
- Amoghasiddhi
Buddha femminile: Bodhisattva maschili: Bodhisattva femminili:
[Samaya]tõrõ VajrapõÐi, [Sarva]núvaraÐa-viØkambhin Gandhõ, Nartú2