Diritti Tv: Il Mondo Del Calcio Tra Business E Antitrust
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
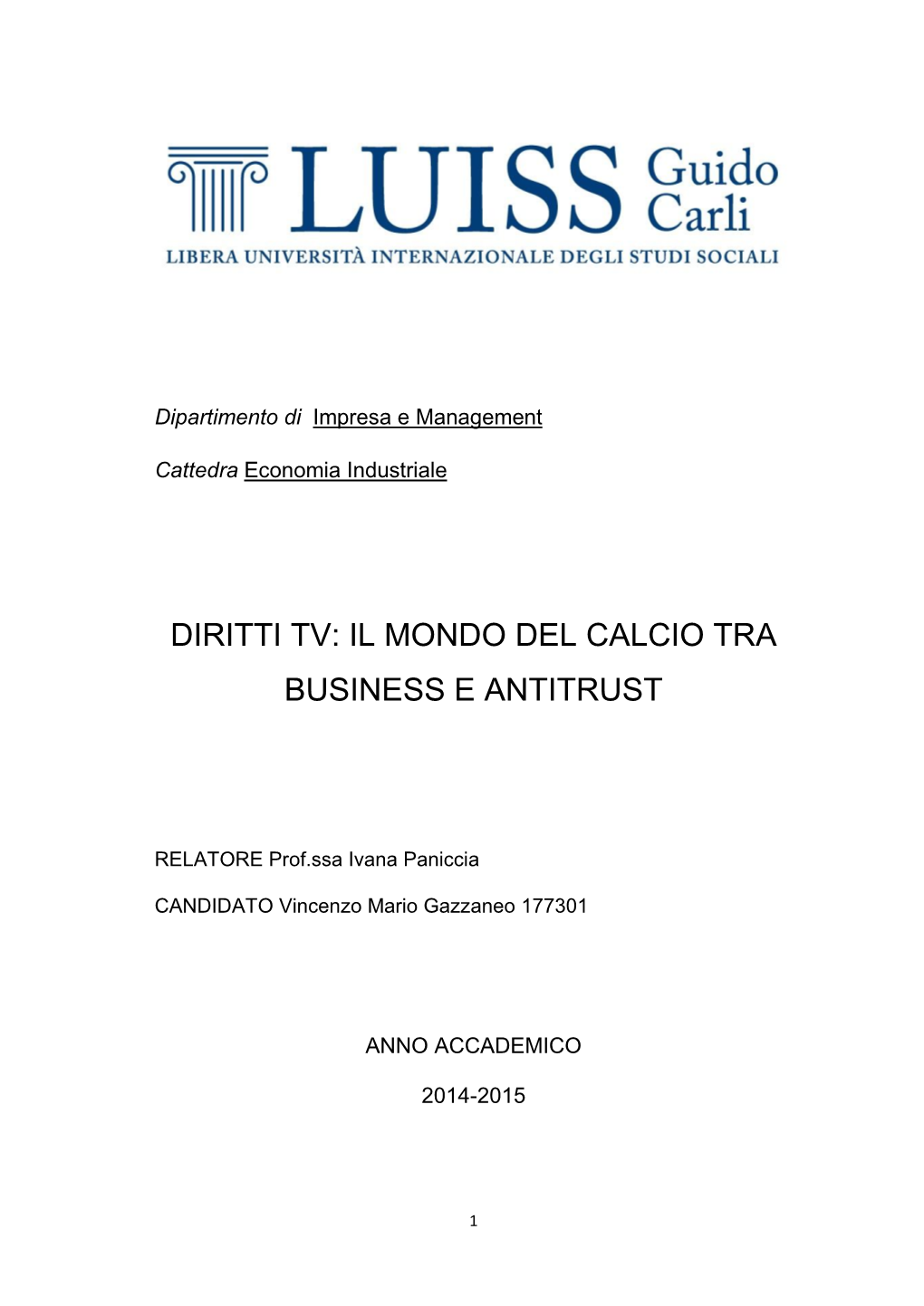
Load more
Recommended publications
-

Il Paradosso Delle Tv Locali
Corso di Laurea magistrale in Marketing e Comunicazione Tesi di Laurea Far West digitale: il paradosso delle tv locali Relatore Prof.ssa Cinzia Colapinto Correlatore Prof. Carlo Bagnoli Laureanda Linda Giacomello Matricola 816892 Anno Accademico 2011 / 2012 SOMMARIO INTRODUZIONE .................................................................................................................................. 7 I. CAPITOLO – LA METAMORFOSI DELLA TELEVISIONE ............................ 14 1.1 I MEDIA ...................................................................................................................................... 14 1.2 ECONOMIA DELLA TELEVISIONE .................................................................................................. 17 1.2.1 La catena del valore del mercato televisivo .......................................................................... 19 1.2.2 Modello delle cinque forze di Porter applicato al settore televisivo ....................................... 21 1.2.3 Peculiarità dell’impresa televisiva ........................................................................................ 23 1.2.4 Il settore televisivo italiano: una overview ............................................................................ 29 1.3 BREVE STORIA SULLA LEGISLAZIONE TELEVISIVA ITALIANA ........................................................... 31 1.4 DAL MONOPOLIO PUBBLICO ALLA LEGGE GASPARRI: LA VIA ITALIANA AL DIGITALE TERRESTRE ..... 35 II. CAPITOLO – IL DIGITALE TERRESTRE NELLO SCENARIO ITALIANO -

Investment Opportunity
Strictly confidential Investment opportunity June 2012 Disclaimer This document (the “Document”) has been drawn up by Mediobanca S.p.A. (“Mediobanca”) and Citi Global Markets, Ltd. (“Citi”) on the basis of information publicly available and provided by Telecom Italia S.p.A. (“Telecom Italia”) and Telecom Italia Media S.p.A.. Mediobanca and Citi assumed and relied, without independent verification, upon the accuracy and completeness of such information. Neither Mediobanca nor Citi nor any of their directors, executives or employees assume responsibility for, and make any representation or warranty (express or implied) with respect to, the accuracy or completeness of the information contained herein, and expressly disclaim, and it is recognized that they have no liability for, any statements, express or implied, contained in, or any errors in or omissions from, this Document. In furnishing this Document Mediobanca and Citi do not undertake any obligation to provide the recipient with access to any additional information nor to update or otherwise revise this Document. This Document speaks only as of the date it is given, and the views expressed are subject to change based upon a number of factors, including market conditions. The Document is being provided to you for information and illustration purposes only and is purely indicative in nature; accordingly, the Document in no way constitutes a proposal to execute a contract or an offering of financial products to the public, nor advice or a recommendation to purchase or sell any financial product whatsoever. This Document does not constitute an opinion by Mediobanca or Citi as to the fairness to anyone of the terms of any actual or proposed transaction. -

Antongiulio Panizzi Televisione
ANTONGIULIO PANIZZI REGISTA - AUTORE TELEVISIONE 2017 Grande Fratello VIP 2 - Autore Reality Show prodotto da Endemol Shine per Canale 5. Record di ascolti con una media del 25% 2017 Fuori Luogo – Italia Fragile Autore e regista Speciale condotto da Mario Tozzi dai luoghi del terremoto in Italia centrale. Prodotto e trasmesso da RaiUno. 2017 Autore: Ci vediamo da Arianna (80 puntate) talk show quotidiano condotto da Arianna Ciampoli. In onda alle 13.50 su TV2000 prodotto da FremantleMedia. 2017 Autore: Chopped (10 puntate). Cooking show condotto da Gianmarco Tognazzi. Prodotto da 3zero2 per FoodNetwork Italia. 2016 Autore e Regista: La Casa Bianca. Programma documentaristico in 7 puntate sulle elezioni presidenziali americane, Rai Tre 2016 Regista e Autore: My Way, the rise and fall of Silvio Berlusconi documentario con Alan Friedman creato con repertorio, riprese originali e interviste a Silvio Berlusconi a Arcore e Milanello. Prodotto da Leone Film Group e Challian. Distribuito da Netflix. 2016 Autore: I Colori dell’Amore (12 episodi) reality show per Real Time 2016 Lezione al Politecnico di Milano-Polo Territoriale di Mantova, Mantova/Architettura “Dall’Architettura alla TV”, analisi del rapporto tra l’architettura contemporanea e le scenografie dei programmi televisivi italiani. Bett. One | Via Barberini, 29 00187 Roma | tel. 06 4820663 | fax 06 4827513 [Digitare qui] [Digitare qui] 2016 Autore al montaggio: La Cuoca Bendata gara culinaria condotta da Benedetta Parodi per Real Time prodotto da Magnolia. 2015 Regista/Autore: i Tre Tromboni documentario per la serie Talenti in onda su Classica HD di Sky. 2015 Regista/Autore: L’Accademia, il Barbiere e Ponnelle documentario per la serie Talenti in onda su Classica HD di Sky. -

La Serie a in Televisione E Allo Stadio: Presentazione Del Dataset Audiball 1.0
RIVISTA DI ISSN 1825-6678 DIRITTO ED ECONOMIA DELLO SPORT Vol. XI, Fasc. 1, 2015 LA SERIE A IN TELEVISIONE E ALLO STADIO: PRESENTAZIONE DEL DATASET AUDIBALL 1.0 di Raul Caruso* e Marco Di Domizio** ABSTRACT: Il presente lavoro illustra i principali contenuti di un nuovo dataset (AUDIBALL 1.0) creato sull’audience televisiva delle partite di Serie A italiana per il periodo compreso tra il 2008 ed il 2014. La raccolta di dati relativi all’affluenza negli stadi, all’audience televisiva, alla collocazione nel tempo delle partite, incrociate con le caratteristiche demografiche ed economiche delle squadre partecipanti, ci ha permesso di costruire un dataset strutturato in forma di panel composto da 734 osservazioni (partite) ripetute per un periodo compreso tra uno e sei anni. Dall’analisi delle circa 340.000 osservazioni sono emersi alcuni aspetti significativi rispetto alle difficoltà del massimo campionato italiano di calcio di aumentare le presenze negli stadi e di mantenere alti standard di audience televisiva. La disponibilità di informazioni estraibili da AUDIBALL 1.0 può stimolare eventuali approfondimenti che possono interessare tanto il mondo della ricerca, quanto quello degli stakeholders, Lega, Federazione, editori radio- televisivi e della carta stampata. JEL: C80, L83. Keywords: Panel data, Serie A, Attendance, Audience, AUDIBALL 1.0. SOMMARIO: Introduzione – 1. AUDIBALL 1.0: costruzione e composizione – 2. La Serie A alla televisione – 3. La Serie A allo stadio – 4. Possibili linee di ricerca applicata – Conclusioni – Bibliografia ____________________ ∗ Università Cattolica del Sacro Cuore, CSEA e Istituto di Politica Economica, [email protected]. ∗∗ Facoltà di Scienze Politiche, Università degli Studi di Teramo. -

Del Apagón Analógico a La Liberación Del Dividendo Digital
UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID FACULTAD DE CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL Y PUBLICIDAD II TESIS DOCTORAL Del apagón analógico a la liberación del Dividendo Digital. Análisis del fracaso de la TDT como medio de difusión de televisión de pago en España MEMORIA PARA OPTAR AL GRADO DE DOCTOR PRESENTADA POR Enrique Domingo Garcés DIRECTOR Francisco García García Madrid, 2015 © Enrique Domingo Garcés, 2015 UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID FACULTAD DE CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN Departamento de Comunicación Audiovisual y Publicidad II Del apagón analógico a la liberación del Dividendo Digital. Análisis del fracaso de la TDT como medio de difusión de televisión de pago en España. Memoria para optar al grado de doctor presentada por Enrique Domingo Garcés Bajo la dirección del doctor Francisco García García Madrid, 2015 Enrique Domingo Garcés 2 Del apagón analógico a la liberación del Dividendo Digital. Análisis del fracaso de la TDT como medio de difusión de televisión de pago en España. I. Agradecimientos. Esta tesis es fruto de la disciplina y de la doctrina de la constancia en el trabajo. Ha sido una carrera de fondo y de velocidad al mismo tiempo, cargada de un sacrificio voluntario para llegar a un fin mejor cargado de satisfacciones. Con ello, quiero agradecer triplemente y en primer lugar, sin importar el orden de los factores, a tres piezas clave sin las cuales esta tesis simplemente no hubiera existido. Francisco García García, mi director de tesis, ha sido quien ha sabido encontrarme cuando estaba perdido y quien me ha animado en todo momento a continuar con el empeño. -

Manuale Sul Digitale Terrestre Dvb-T
MANUALE SUL DIGITALE TERRESTRE DVB-T © 2010 – IW2BSF Rodolfo Parisio COME SI COLLEGA IL DECODER DTT F. Impianto Hi-Fi o Dolby 5.1 o 7.1 G. Opzionale RISINTONIZZARE IL DECODER Ogni tanto conviene farlo per memorizzare i NUOVI canali ! In genere si va’ nel MENU del telecomando del decoder o tv e dal menu si seleziona Opzione INSTALLAZIONE si sceglie la voce RICERCA CANALE o SINTONIZZA o (Reinstalla Canali) e si preme il tasto OK. ORDINARE I CANALI : In genere meglio nel menu disabilitare LCN ! Prendere nota dei canali contenuti in ogni mux, cancellare i canali scegliere la modalità senza LCN disabilitare l'aggiornamento automatico se presente fare la ricerca in "manuale" scegliendo di volta in volta il mux che comprende i propri preferiti (li aggiungerà nell'ordine nel quale sono stati cercati. Utilizzare le liste preferiti ed usare sempre quelle (che forse è più semplice). LCN = lista dei canali in ordine TASTO EPG E’ la guida tv che e’ molto meglio del vecchio Televideo. Si scorre i programmi con Tasti SU e GIU’ e premendo tasto OK si viene portati sul canale scelto. (in genere funziona con decoder interattivi con bollino blu DGTVi). In alcuni decoder e’ denominato GUIDE. Visualizza le informazioni dei vari Canali relative ai programmi della settimana. 4 TASTI COLORATI Servono per utilizzare i servizi multimediali. Premendo il tasto ROSSO si avviano I servizi che si possono vedere direttamente sul lo schermo del televisore (solo con i decoder interattivi MHP e non quindi con gli economici zapper) . E di volta in volta nella parte bassa dello schermo viene spiegato a cosa servono Gli altri tasti colorati. -

Study on Sports Organisers' Rights in the European Union
Study on sports organisers’ rights in the European Union Final Report February 2014 Europe Direct is a service to help you find answers to your questions about the European Union. Freephone number (*): 00 800 6 7 8 9 10 11 (*) The information given is free, as are most calls (though some operators, phone boxes or hotels may charge you). More information on the European Union is available on the Internet (http://europa.eu). Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2014 © European Union, 2014 Reproduction is authorised provided the source is acknowledged. HOW TO OBTAIN EU PUBLICATIONS Free publications: • one copy: via EU Bookshop (http://bookshop.europa.eu); • more than one copy or posters/maps: from the European Union’s representations (http://ec.europa.eu/represent_en.htm); from the delegations in non-EU countries (http://eeas.europa.eu/delegations/index_en.htm); by contacting the Europe Direct service (http://europa.eu/europedirect/index_en.htm) or calling 00 800 6 7 8 9 10 11 (freephone number from anywhere in the EU) (*). (*) The information given is free, as are most calls (though some operators, phone boxes or hotels may charge you). Priced publications: • via EU Bookshop (http://bookshop.europa.eu). Priced subscriptions: • via one of the sales agents of the Publications Office of the European Union (http://publications.europa.eu/others/agents/index_en.htm). EAC/18/2012 Study on sports organisers’ rights in the European Union T.M.C. Asser Instituut / Asser International Sports Law Centre Institute for Information Law - University of Amsterdam February 2014 EUROPEAN COMMISSION Directorate-General for Education and Culture Directorate Youth and Sport Unit Sport This report has been prepared by the T.M.C. -

Hv2009 03-12 Art Intro St.Indd
CH E T NOVEMBRE 2009 NOVEMBRE i SAT, DTT, IPTV e HDTV TV digitale Come scegliere? Cosa vedere? A che prezzo? LE NUOVE OFFERTE TV Le piattaforme, i bouquet, i canali e le diverse opzioni pay-per-view GUIDA ALL’ACQUISTO Ricevitori DTT: zapper e interattivi Ricevitori SAT: free-to-air e common interface Maxi TV Full HD: LCD e Plasma Garanzia troppo stretta? Con ESTENDO ti metti al sicuro Tv digitale la svolta multipiattaforma Il prossimo Natale porta in dono ai telespettatori italiani la Tv digitale SAT, DTT, IPTV e HDTV di grande qualità. Satellite, Digitale Come scegliere, cosa vedere, a che prezzo? terrestre e IPTV sono ormai realtà L’universo televisivo italiano ha recentemente intra- alla portata di tutte le tasche, con preso la lenta e lunga conversione verso il digitale, l’eccezionale aggiunta dell’Alta che dovrebbe concretizzarsi entro il 12 dicembre Defi nizione per rendere sempre più 2012. Data fatidica (12/12/12) per tutti i possessori di un televisore: da quel giorno nulla sarà più come coinvolgente l’intrattenimento domestico prima e tutti i canali e i programmi si potranno ve- dere esclusivamente attraverso un Tv color digitale Marco Scurati oppure tramite un decoder collegato al “vecchio” Tv. Ma non stiamo parlando di futuro, bensì di un pre- sente già ampiamente rappresentato dalla ridon- utti parlano della “nuova” televisione, dante offerta di televisione digitale, tanto irresisti- digitale e interattiva, ma anche ad Al- bile quanto diversifi cata nella sua seducente offerta Tta Defi nizione e on demand. Facile pre- multipiattaforma: SAT, DTT e IPTV. vedere che sotto l’albero per le feste di Natale il E arriviamo al dunque: come scegliere, cosa vedere, decoder la faccia da padrone nella classifi ca delle abbonamenti alle IPTV: i canali pay accessibili, a che prezzo? Per ora la parte del leone la fa il sa- sorprese. -

Le Pay TV in Italia: Sviluppo Tecnologico E Strategie Aziendali
ALMA MATER STUDIORUM – UNIVERSITÀ DI BOLOGNA SCUOLA DI SCIENZE Corso di Laurea in Informatica per il Management Le Pay TV in Italia: sviluppo tecnologico e strategie aziendali Tesi di laurea in Strategia Aziendale Relatore Presentata da: Chiar.mo Prof. Andrea Veronesi Edoardo Mollona Sessione II Anno accademico 2013/2014 i Sommario Introduzione ................................................................................................................................. 1 Capitolo 1 - Boom digitale: dalla metà degli anni novanta a oggi, come sono nate e come si sono sviluppate le tecnologie a servizio dei media .................................................................... 3 La televisione .......................................................................................................... 4 Smartphone ............................................................................................................. 8 Internet .................................................................................................................. 10 Conclusioni ........................................................................................................... 14 Bibliografia del capitolo 1 ..................................................................................... 17 Capitolo 2 - Strategie delle aziende ad alto tasso tecnologico ................................................ 19 La tecnologia come strumento di strategia competitiva ........................................ 19 2.1.1 Diritti di proprietà ...................................................................................... -

Il Caso Content Is King, Brands Are Castles
28° EDIZIONE PREMIO MARKETING SIM 2016 IL CASO CONTENT IS KING, BRANDS ARE CASTLES 1 1. FOX INTERNATIONAL CHANNELS ITALY Fox International Channels Italy nasce nel 2003 e in pochissimi anni diventa uno dei player di maggior successo nel comparto delle pay tv in Italia. Con un portafoglio di dieci canali televisivi satellitari distribuiti in esclusiva da Sky Italia, Fox Italia offre al suo pubblico prodotti televisivi internazionali e produzioni originali nazionali. Fox Italia ha adottato un business model innovativo per il sistema televisivo, che pone il marketing allo stesso livello gerarchico della programmazione. In un settore da sempre guidato da logiche di prodotto (i programmi e il palinsesto), ha deciso di focalizzare la sua strategia su un elemento che in genere non viene considerato nel mix di un canale tv: il brand. In pratica, la tradizionale marca del canale televisivo si trasforma, cresce e acquista personalità, identità, reputazione e soggettività competitiva. Il TvBrand rappresenta qualcosa di definito, caratterizzato, noto e riconoscibile per conquistare la preferenza del telespettatore. Focus LA BRAND EXTENSION in tv Fox Italia è stata la prima azienda televisiva italiana ad adottare una strategia di brand extension dei canali, moltiplicando il brand FOX in formule specifiche - impostata sia sulla tematica (es. Fox Crime) che sul target (es. Fox-Life) – ma sempre mantenendo una stretta coerenza con il posizionamento del brand madre FOX. Questo ha permesso di sfruttare la forza dell’identità visiva del brand “madre” per conquistare nuovi target specifici, mantenendo sempre la promessa di visione1 che il telespettatore attribuisce ai canali Fox. In questo modo il gruppo Fox ha ampliato la copertura del mercato, aumentando allo stesso tempo gli ascolti2. -

The Decline of Professional Football in Italy IZA DP No
IZA DP No. 7018 The Decline of Professional Football in Italy Tito Boeri Battista Severgnini November 2012 DISCUSSION PAPER SERIES Forschungsinstitut zur Zukunft der Arbeit Institute for the Study of Labor The Decline of Professional Football in Italy Tito Boeri IGIER - Bocconi University, CEPR and IZA Battista Severgnini Copenhagen Business School Discussion Paper No. 7018 November 2012 IZA P.O. Box 7240 53072 Bonn Germany Phone: +49-228-3894-0 Fax: +49-228-3894-180 E-mail: [email protected] Any opinions expressed here are those of the author(s) and not those of IZA. Research published in this series may include views on policy, but the institute itself takes no institutional policy positions. The IZA research network is committed to the IZA Guiding Principles of Research Integrity. The Institute for the Study of Labor (IZA) in Bonn is a local and virtual international research center and a place of communication between science, politics and business. IZA is an independent nonprofit organization supported by Deutsche Post Foundation. The center is associated with the University of Bonn and offers a stimulating research environment through its international network, workshops and conferences, data service, project support, research visits and doctoral program. IZA engages in (i) original and internationally competitive research in all fields of labor economics, (ii) development of policy concepts, and (iii) dissemination of research results and concepts to the interested public. IZA Discussion Papers often represent preliminary work and are circulated to encourage discussion. Citation of such a paper should account for its provisional character. A revised version may be available directly from the author. -

Antongiulio Panizzi Television
ANTONGIULIO PANIZZI DIRECTOR – AUTHOR TELEVISION 2017 Grande Fratello VIP 2 – Author, Reality Show produced by Endemol Shine for Canale 5 2017 Fuori Luogo – Italia Fragile Author and director with Mario Tozzi produced by RaiUno. 2017 Author: Ci vediamo da Arianna (80 episodes) talk show with Arianna Ciampoli. 13.50 on TV2000 produced by FremantleMedia. 2017 Author: Chopped (10 puntate). Cooking show with Gianmarco Tognazzi. Produced by 3zero2 for FoodNetwork Italia. 2016 Author and Director: La Casa Bianca. documentaries in 7 episodes on the american elections, Rai Tre 2016 Author and director: My Way, the rise and fall of Silvio Berlusconi, dicumentary with Alan Friedman Producedy by Leone Film Group and Challian. Distribuitio NetfliX. 2016 Author: I Colori dell’Amore (12 episodi) reality show for Real Time 2016 Lezione al Politecnico di Milano-Polo Territoriale di Mantova, Mantova/Architettura “Dall’Architettura alla TV”,. 2016 Editing Author: La Cuoca Bendata with Benedetta Parodi for Real Time produced by Magnolia. 2015 Director and Author: i Tre Tromboni documentary on Classica HD Sky. Bett. One | Via Barberini, 29 00187 Roma | tel. 06 4020663 | fax 06 4827513 [Digitare qui] [Digitare qui] 2015 Director and Author: L’Accademia, il Barbiere e Ponnelle documentary for Classica HD- Sky. 2015 Director and Author: Il Flautino – on Classica HD - Sky 2015 Author: Lucky Ladies Napoli (6 episodi) reality show per Fox Life prodotto da Fremantle Media. 2014 Autore: “About Love” (5 episodi) docu-reality per Italia 1. Produced by Endemol, project chief Federico Moccia 2014 Author: Detto Fatto (189 episodes) with Caterina Balivo on Rai 2, produced by Endemol.