Vedi Documento
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
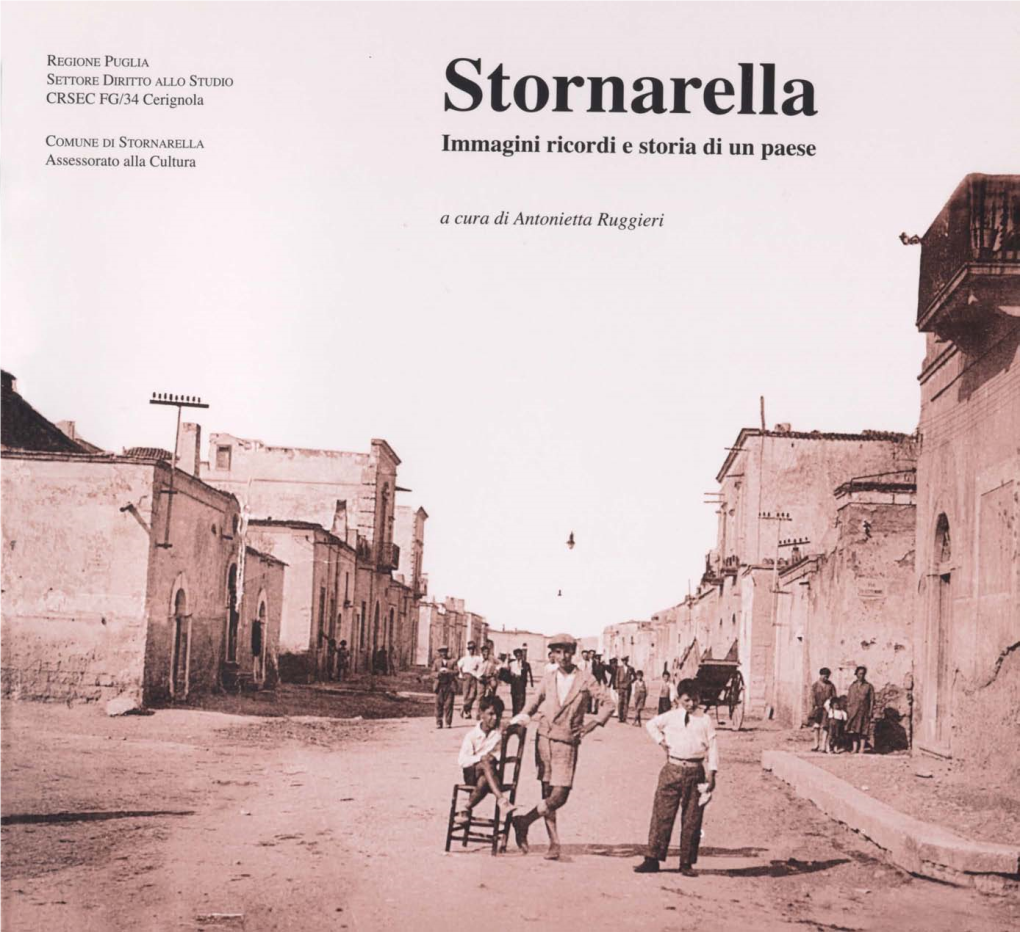
Load more
Recommended publications
-
Stornarella Orta Nova Carapelle Foggia Stornara
POSTA DELLE CANNE S.r.l. FOGGIA PROGETTO DEFINITIVO CARAPELLE PER LA REALIZZAZIONE DI UN PARCO EOLICO RICADENTE NEI COMUNI DI ORTA NOVA E ORDONA (FG) IN LOCALITA' "POSTA DELLE CANNE" E “MASCITELLI” TM Tecnico ing. Danilo Pomponio Via Napoli, 363/I - 70132 Bari - Italy tel (+39) 0805046361 - fax (+39) 0805619384 10 www.bfpgroup.net - [email protected] Collaborazioni AZIENDA CON SISTEMA GESTIONE QUALITÀ E AMBIENTE ing. Milena Miglionico UNI EN ISO 9001:2015 UNI EN ISO 14001:2015 ing. Antonio Crisafulli OHSAS 18001:2007 CERTIFICATO DA CERTIQUALITY ing. Tommaso Mancini ing. Giovanna Scuderi ing. Dionisio Staffieri ing. Giuseppe Federico Zingarelli geom. Francesco Mangino 8 geom. Claudio A. Zingarelli 6 ORTA NOVA Responsabile commessa ing. Danilo Pomponio 1 9 7 TAVOLA TITOLO COMMESSA TIPOLOGIA 20053 D 2 V05 Stralcio planimetrico CODICE ELABORATO degli Ambiti Territoriali Estesi DW20053D-V05 REVISIONE del PUTT/p (ATE) SOSTITUISCE SOSTITUITO DA 00 CODICE ELABORATO CODICE ELABORATO AREA STAZIONE Tutte le informazioni tecniche contenute nel presente documento sono di proprieta' esclusiva della Studio 4 FOGLIO Tecnico BFP S.r.l e non possono essere riprodotte, divulgate o comunque utilizzate senza la sua preventiva NOME FILE SCALA TERNA 1/1 autorizzazione scritta. All technical information contained in this document is the exclusive property of Studio DW20053D-V05.dwg 1:25.000 3 Tecnico BFP S.r.l. and may neither be used nor disclosed without its prior written consent. (art. 2575 c.c.) ORDONA SSE UTENTE REV DATA MODIFICA DISEGNATO CONTROLLATO APPROVATO 00 25/07/2020 Emissione Scuderi Miglionico Pomponio CONDIVISA 01 02 5 03 04 05 Disegno elaborato con sistema CAD. -

Stornarella Orta Nova Ascoli Satriano Stornara Ordona
Canale Ponte Rotto POSTA DELLE CANNE S.r.l. PROGETTO DEFINITIVO PER LA REALIZZAZIONE DI UN PARCO EOLICO Canale Pescia RICADENTE NEI COMUNI DI ORTA NOVA E ORDONA (FG) IN LOCALITA' "POSTA DELLE CANNE" E “MASCITELLI” MANFREDONIA MANFREDONIA FOGGIA TM Tecnico ing. Danilo Pomponio Via Napoli, 363/I - 70132 Bari - Italy tel (+39) 0805046361 - fax (+39) 0805619384 www.bfpgroup.net - [email protected] Collaborazioni AZIENDA CON SISTEMA GESTIONE QUALITÀ E AMBIENTE ing. Milena Miglionico UNI EN ISO 9001:2015 UNI EN ISO 14001:2015 ing. Antonio Crisafulli OHSAS 18001:2007 CERTIFICATO DA CERTIQUALITY ing. Tommaso Mancini ing. Giovanna Scuderi Canale Piluso ing. Dionisio Staffieri ing. Giuseppe Federico Zingarelli geom. Francesco Mangino geom. Claudio A. Zingarelli Responsabile commessa ing. Danilo Pomponio Torrente Carapelle TAVOLA TITOLO COMMESSA TIPOLOGIA Torrente Cervaro Canale Ponte Rotto Torrente Carapelle Lettura del PPTR - 20053 D V02 CODICE ELABORATO Struttura idro-geo- morfologica DW20053D-V02 REVISIONE Analisi delle Componenti Geomorfologiche e Analisi SOSTITUISCE SOSTITUITO DA 00 delle Componenti Idrogeologiche CODICE ELABORATO CODICE ELABORATO Tutte le informazioni tecniche contenute nel presente documento sono di proprieta' esclusiva della Studio FOGLIO Tecnico BFP S.r.l e non possono essere riprodotte, divulgate o comunque utilizzate senza la sua preventiva NOME FILE SCALA autorizzazione scritta. All technical information contained in this document is the exclusive property of Studio DW20053D-V02.dwg 1/1 Tecnico BFP S.r.l. and may neither be used nor disclosed without its prior written consent. (art. 2575 c.c.) 1:30.000 REV DATA MODIFICA DISEGNATO CONTROLLATO APPROVATO 00 25/07/2020 Emissione Scuderi Miglionico Pomponio 01 02 03 04 FOGGIA 05 CARAPELLE Disegno elaborato con sistema CAD. -

Consiglio Generale Degli Ospizi Bilanci Delle Opere Pie
ARCHIVIO DI STATO DI FOGGIA CONSIGLIO GENERALE DEGLI OSPIZI BILANCI DELLE OPERE PIE Numero d'ordine Anno Distretto o Comune dove si trovano gli enti di beneficenza Osservazioni del volume circondario ai quali si riferiscono i bilanci 1 1812 Foggia Foggia. 2 1812 Foggia Cerignola. 3 1812 Foggia Monte Sant'Angelo 4 1812 Foggia Manfredonia. 5 1812 San Severo Serracapriola. 6 1818 Bovino Bovino, Panni. 7 1818 Bovino Deliceto, Sant' Agata. 8 1818 Foggia Cerignola. 9 1818 Foggia Manfredonia. 10 1818 Foggia Monte Sant'Angelo 11 1822 Foggia Cerignola. 12 1822 Foggia Manfredonia. 13 1822 Foggia Monte Sant'Angelo 14 1822 Foggia Celenza, San Marco la Catola, Carlantino. 15 1822 Bovino Deliceto, Sant'Agata. 16 1822 Bovino Foggia, Volturara, Lucera, Biccari, Alberona, Roseto, Volturino, San Bartolomeo, Motta, I volumi 16-18 non sono stati discussi degli enti morali, Stornarella, Casaltrinità, Manfredonia, Vieste, Bovino, Panni, Castelluccio dei Sauri, Troia, bensì dei comuni; per tale ragione si è provveduto a Castelluccio Valmaggiore, Faeto, Anzano, Sant'Agata, Accadia, Monteleone, Ascoli, Candela, sistemarli tra gli stati discussi del 3° ufficio dell'Intendenza. Montefalcone, Greci, Ginestra, Savignano, Deliceto. Cfr. inventario del fondo Intendenza, governo e prefettura di Capitanata, Atti , b. 1073 17 1823 San Severo San Severo, Castelnuovo, Casalvecchio, Casalnuovo, Pietra, Celenza, Carlantino, San Marco la Catola, Serracapriola, Chieuti, Torremaggiore, San Paolo, Apricena, Lesina, Poggio Imperiale, Sannicandro, San Marco in Lamis, San Giovanni Rotondo, Rignano, Cagnano, Carpino, Vico, 18 1823 Bovino Candela, Accadia, Deliceto, Sant' Agata, Anzano, Monteleone, Greci, Ginestra, Montefalcone, Savignano, Castelfranco, Bovino, Panni, Faeto, Castelluccio Valmaggiore, Celle, Troia. 19 1827 Bovino Deliceto, Sant' Agata. -

N. 164). L.31.7.1956, N. 936). N. 1465 in GU 20 Ott., N. 263; DPR 4
IL DISS ESTO GEOLOGICO E GEOAM BI ENTALE IN ITALIA PUGLIA 207 1.16. CRONISTORIE PUG U ES I Tra i comuni maggiormente colpiti, tutti in pro vincia di Foggia, risultano Accadia, Anzano di Puglia. AscoLi Satriano, Bicca ri, Bovino, Candela, Castell uccio Valfortore, Celle S. Vito, Deli ceto, Faeto, Orsara di /8-23 ago!to /948. - Scosse sismiche interessano Pu g li a, Panni, Rocchetta S. Antonio, Roseto Valfor gran parte del Gargano e del Tavoliere fo ggiano. I tore, S. Agata di Pug lia, Troia (fonti: DPR 19. 10.1962, centri abitati più danneggiati ri sultano quelli dj Vieste n. 1465 in GU 20 ott., n. 263; DPR 4.12.1962, n. (365 fabbricati tra lesionati e inagibili), S. Giovanni 1829 in GU 2.1.1 963, n. 19; Cavallo e Penta, 1964; Rotondo, S. Marco in Lamis, Ascoli Satriano, Stornara Spadea e al., 1985). (una casa crollata, 155 abitazioni tra pericolanti e lesionate), S. Severo (40 fabbricati inabitabili). 28 agosto 1962. - Terremoto (<<ell enico») di magni Lo Stato dichiara danneggiati 31 comuni, dj mdo 7 con epicentro nella parte meridionale del cu i 29 in provincia di Foggia e 2 in provincia Pelopo nneso si ri sente con intensità del VI g rado in di Bari (tab. 79). alcuni comuni delle province di Bari (Ru vo, Terlizzi), Brindisi (S. Donaci, Mesagne, Latiano) e Taranto (Manduria, Pulsano). D an ni di un certo rilievo su bi Tab. 79. - Comuni dichiarati danneggiati in Puglia, periodo scono soltanto qu elle costruzioni che erano già deboli sismi-co 18-23 agosto 1948. -

Scuola Secondaria Di I Grado Anno Scolastico: 2021/22 Ufficio Scolastico Provinciale Di: Foggia
DISPONIBILITA' CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO ANNO SCOLASTICO: 2021/22 UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI: FOGGIA CODICE CODICE DISPONIBILITA' DISPONIBILITA' CODICE SCUOLA DENOMINAZIONE SCUOLA CLASSE DI DENOMINAZIONE CLASSE DI CONCORSO TIPO DENOMINAZIONE COMUNE AL 31/08 AL 30/06 CONCORSO POSTO FGCT70900B DISTRETTO 032 - FOGGIA A022 ITAL.,STORIA,ED.CIVICA,GEOG.SC.I GR XJ FOGGIA 1 FGCT71000G DISTRETTO N.35 - TRINITAPOLI A022 ITAL.,STORIA,ED.CIVICA,GEOG.SC.I GR XJ TRINITAPOLI 9H FGCT71000G DISTRETTO N.35 - TRINITAPOLI A023 ITALIANO PER ALLOGLOTTI XJ TRINITAPOLI 1 FGCT71000G DISTRETTO N.35 - TRINITAPOLI A028 MATEMATICA E SCIENZE XJ TRINITAPOLI 1 FGCT71000G DISTRETTO N.35 - TRINITAPOLI A060 TECNOLOGIA SC. I GR. XJ TRINITAPOLI 1 FGCT71100B C.T.P. STORNARELLA A022 ITAL.,STORIA,ED.CIVICA,GEOG.SC.I GR XJ STORNARELLA 1 FGCT71100B C.T.P. STORNARELLA A028 MATEMATICA E SCIENZE XJ STORNARELLA 1 FGCT71100B C.T.P. STORNARELLA A060 TECNOLOGIA SC. I GR. XJ STORNARELLA 1 FGCT71100B C.T.P. STORNARELLA AB25 LINGUA STRANIERA (INGLESE) XJ STORNARELLA 1 FGCT712007 C.T.P. MONTI DAUNI A028 MATEMATICA E SCIENZE XJ BOVINO 1 FGCT712007 C.T.P. MONTI DAUNI A060 TECNOLOGIA SC. I GR. XJ BOVINO 1 FGCT712007 C.T.P. MONTI DAUNI AB25 LINGUA STRANIERA (INGLESE) XJ BOVINO 1 FGMM00400C S.S. 1 G. "G. BOVIO" A001 ARTE E IMMAGINE SC. I GR. NN FOGGIA 1 FGMM00400C S.S. 1 G. "G. BOVIO" A049 SC. MOT. E SPORT. SC. I GR. NN FOGGIA 1 FGMM00400C S.S. 1 G. "G. BOVIO" AB25 LINGUA STRANIERA (INGLESE) NN FOGGIA 9H FGMM00400C S.S. -

Inquadramento Su
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 A A REGIONE PUGLIA B B PROVINCIA DI FOGGIA DELICETO C C CERIGNOLA D D LEGENDA Elettrodotto AT SE TERNA E ASCOLI SATRIANO Area di progetto E SANT'AGATA DI PUGLIA Sottostazione Elettrica F F Cavidotto Esterno G G Elettrodotto AT CANDELA Limite comunale H H Limite Regionale ORDONA ORTA NOVA CASTELLUCCIO DEI SAURI STORNARA CERIGNOLA REGIONE PUGLIA PROVINCIA DI FOGGIA ORSARA DI PUGLIA STORNARELLA BOVINO L L ASCOLI SATRIANO PANNI REGIONE PUGLIA CERIGNOLA PROVINCIA DI FOGGIA DELICETO CERIGNOLA ACCADIA Elettrodotto AT SE TERNA ASCOLI SATRIANO SANT'AGATA Area di progetto DI PUGLIA CANDELA M ROCCETTA M Area di progetto ROCCETTA ANZANO DI PUGLIA SANT'ANTONIO REGIONE PUGLIA PROVINCIA DI FOGGIA REGIONE PUGLIA LAVELLO REGIONE PUGLIA SANT'ANTONIO PROVINCIA DI FOGGIA SCAMPITELLA LACEDONIA REGIONE BASILICATA PROVINCIA DI POTENZA REGIONE CAMPANIA MELFI VALLATA PROVINCIA DI FOGGIA PROVINCIA DI AVELINNO MONTEVERDE N BISACCIA N AQUILONIA REGIONE PUGLIA RAPOLLA VENOSA P PROVINCIA DI FOGGIA P Area di progetto Q Q LACEDONIA REGIONE BASILICATA PROVINCIA DI POTENZA R R BFP BFP BFP 00 20/11/2020 first issue ZINGARELLI MIGLIONICO BISCOTTI REV. DATE DESCRIPTION PREPARED CHECKED APPROVED CONTRACTOR'S LOGO PROJECT: REGIONE CAMPANIA MELFI CANDELA Via Napoli, 363/I - 70132 Bari - Italy tel (+39) 0805046361 - fax (+39) 0805619384 S www.bfpgroup.net - [email protected] S AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE QUALITA' UNI EN ISO 9001:2015 FILE NAME: UNI EN ISO 14001:2015 PROVINCIA DI AVELINNO OHSAS 18001:2007 GRE.EEC.D.24.IT.W.15001.00.057.00_INQUADRAMENTO IGM CAVIDOTTO MT ESTERNO CLASSIFICATION: FORMAT: SCALE: PLOT SCALE: SHEET: A0 1:25000 1 di / of 1 UTILIZATION SCOPE: TITLE: INQUADRAMENTO IGM Engineering & Construction CAVIDOTTO MT ESTERNO T MONTEVERDE GRE VALIDATION T VALIDATED BY GRE CODE VERIFIED BY GROUP FUNCTION TYPE ISSUER COUNTRY TEC. -

Prefettura Di Foggia 41
ARCHIVIO DI STATO DI FOGGIA PREFETTURA DI FOGGIA CONTI CONSUNTIVI DEI COMUNI SERIE I 1861-1873 BUSTA FASCICOLI COMUNI ANNI OSSERVAZIONI 1 1 Alberona 1861 2 Apricena 1861 3 Ascoli 1861 4 Biccari 1861 2 5 Candela 1861 6 Carlantino 1861 7 Carpino 1861 8 Casalnuovo 1861 3 9 Casalvecchio di Puglia 1861 10 Castelluccio Valmaggiore 1861 11 Castelnuovo della Daunia 1861 12 Celenza Valfortore 1861 13 Cerignola 1861 14 Faeto 1861 4 15 Lesina 1861 16 Lucera 1861 17 Manfredonia 1861 ARCHIVIO DI STATO DI FOGGIA, inventario del fondo PREFETTURA DI FOGGIA, CONTI CONSUNTIVI DEI COMUNI, SERIE I E II BUSTA FASCICOLI COMUNI ANNI OSSERVAZIONI 5 18 Motta Montecorvino 1861 19 Orta 1861 20 Panni 1861 21 Pietra Montecorvino 1861 22 Poggio Imperiale 1861 23 Rignano Garganico 1861 6 24 Rodi Garganico 1861 25 Roseto Valfortore 1861 26 San Ferdinando di Puglia 1861 27 San Marco in Lamis 1861 7 28 San Marco la Catola 1861 29 Sannicandro Garganico 1861 30 San Paolo di Civitate 1861 31 Sant'Agata di Puglia 1861 8 32 Torremaggiore 1861 33 Troia 1861 34 Vico Garganico 1861 35 Vieste 1861 9 1 Alberona 1862 2 Ascoli Satriano 1862 3 Biccari 1862 4 Bovino 1862 10 5 Cagnano Varano 1862 6 Candela 1862 7 Carlantino 1862 Pagina 2 ARCHIVIO DI STATO DI FOGGIA, inventario del fondo PREFETTURA DI FOGGIA, CONTI CONSUNTIVI DEI COMUNI, SERIE I E II BUSTA FASCICOLI COMUNI ANNI OSSERVAZIONI 8 Carpino 1862 11 9 Casalnuovo Monterotaro 1862 10 Castelluccio dei Sauri 1862 11 Castelluccio Valmaggiore 1862 12 Castelnuovo della Daunia 1862 13 Celenza Valfortore 1862 14 Cerignola 1862 12 15 -

Lands to Discover
LANDS TO DISCOVER PIANA DEL TAVOLIERE LAG Lands of Art and Tastes Cerignola, Orta Nova, Stornara, Stornarella, Carapelle, Ordona This booklet has a very specific aim: to bring to light an area of great variety, which also has a number of common threads – these six towns on the Lower Tavoliere Plain. On the one hand is Cerignola, and on the other what used to be known as the five Royal Sites: a brave agricultural colonisation experiment carried out in the late 18th century at the behest of the Neapolitan king, A Ferdinand I. Six towns lying on the Apulian plain between the Ofanto and Fortore rivers. Each with its own history, rooted in a past that may be ancient or more recent, sometimes touched by the grand events of history. Each with its own archaeological sites or historical monuments. Each with its own vibrant, ageless religious and social traditions. Each with its own lively economy based mainly on picking and processing the fruits of the land. We would like to invite you to visit these treasures - their monuments and processions, food and landscapes, wines, history and everything about this generous land will simply amaze you. We’ll be waiting! Piana del Tavoliere LAG CERIGNOLA History tactic of using a fixed obstacle to counter charges by the frightening formations of pikemen; their victory led to the Cerignola’s roots apparently date back to the 10th-11th Spanish occupying southern Italy for the next three centuries. century: that is when it was first mentioned both in a document of the Diplomatic Code of Bari dating back to In the 17th century, new lords entered the scene: the 1150, which mentions a “domum Malgerii Cidoniole” and Pignatellis of Monteleone, the Pignatellis of Bisaccia, the also in the 10th century cathedral in the medieval quarter dukes of Egmont; and in 1672 Sabatini the tabularius drew known as the Terra vecchia, or “Old Land”. -

Maths Challenge 2020 Elenco Ammessi Alla Prova Finale*
MATHS CHALLENGE 2020 ELENCO AMMESSI ALLA PROVA FINALE* *Alla prova finale sono ammessi gli studenti che si sono classificati nelle prime 10 posizioni della graduatoria di Istituto inclusi eventuali ex-equo. COGNOME NOME CLASSE Totale Istituto ALAOUI OMAR VC 78 I.I.S. "Federico II" - Apricena VERZINO GIULIANA VC 78 I.I.S. "Federico II" - Apricena MANUPPELLI ANTONIO VB 78 I.I.S. "Federico II" - Apricena RENDINA GIANLUCA VC 78 I.I.S. "Federico II" - Apricena GIAMMARIO PIERMATTEO VC 78 I.I.S. "Federico II" - Apricena ANTONINO LEONARDO VG 75 I.I.S. "Federico II" - Apricena DANIELE VINCENZO VC 73 I.I.S. "Federico II" - Apricena MILONE LEONARDO VC 68 I.I.S. "Federico II" - Apricena MERLINO SIMONE VB 68 I.I.S. "Federico II" - Apricena MASTRODOMENICO GIUSEPPE VC 66 I.I.S. "Federico II" - Apricena I.I.S."IPSAR - MORO" - Margherita CAFAGNA LUIGI IV 85 di Savoia I.I.S."IPSAR - MORO" - Margherita LAMONACA ANDREA IV 81 di Savoia I.I.S."IPSAR - MORO" - Margherita RIONTINO ANNA PIA IV 80 di Savoia I.I.S."IPSAR - MORO" - Margherita GORGOGLIONE ANTONIO IV 80 di Savoia I.I.S."IPSAR - MORO" - Margherita GORGOGLIONE ANDREA IV 75 di Savoia I.I.S."IPSAR - MORO" - Margherita CIMINIELLO ANNAPIA IV 75 di Savoia I.I.S."IPSAR - MORO" - Margherita CAPODIVENTO ANGELA IV 75 di Savoia Maths Challenge 2020 Ammessi Prova Finale del 28 febbraio 2020 I.I.S."IPSAR - MORO" - Margherita GENTILE MARTINA IV 75 di Savoia I.I.S."IPSAR - MORO" - Margherita DILECCE NICOLA V 70 di Savoia I.I.S."IPSAR - MORO" - Margherita VITOBELLO NICOLA IV 70 di Savoia Istituto Tecnico "Giannone-Masi" -

Informativa Del 13/07/2021 13/07/2021
REGIONE PUGLIA Presidenza della Giunta Regionale Sezione Protezione Civile - Centro Funzionale Decentrato SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ ABBRUCIAMENTO STOPPIE Informativa del 13/07/2021 Previsione dei fattori meteorologici e ambientali che concorrono al rischio di propagazione degli incendi su scala comunale ai sensi della L.R. 38/2016 – DGR 1149 del 28/06/2018 per la pratica del ringrano e piro trattamenti dei residui vegetali Quadro normativo: Legge n. 353/2000: "Legge-quadro in materia di incendi boschivi" Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 01 Luglio 2011: "Direttiva in materia di lotta attiva agli incendi boschivi" Deliberazione della Giunta Regionale Puglia n. 2181 del 26 Novembre 2013: "Dichiarazione di attività del Centro Funzionale Decentrato della regione Puglia" Legge regionale n. 38/2016: "Norme in materia di contrasto agli incendi boschivi e di interfaccia" Decreto attuativo del Capo del Dipartimento della Protezione Civile Rep. n. 2513 del 28/06/2017 Deliberazione della Giunta Regionale Puglia n. 585 del 10 Aprile 2018: "Piano di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi 2018-2020" Decreto del Presidente della Giunta Regionale Puglia n. 213 del 27 Aprile 2020: "Dichiarazione dello stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi nell’anno 2020, ai sensi della L. 353/2000, della L.r. 38/2016 e della L.r. 53/2019" 13/07/2021 Descrizione CONSENTITO Abbruciamento consentito Abbruciamento non consentito: Accadia, Acquaviva Delle Fonti, Adelfia, Alberona, Altamura, Anzano Di Puglia, Apricena, -
États Membres Producteurs ; Communautés Européennes
10. 8 . 90 Journal officiel des Communautés européennes N0 L 214/ 1 I (Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité) RÈGLEMENT (CEE) N° 2341/90 DE LA COMMISSION du 30 juillet 1990 fixant les rendements en olives et en huile pour la campagne 1989/1990 LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, considérant que, compte tenu des donnees reçues, il y a lieu de fixer ces rendements comme indiqué à l'annexe I ; vu le traité instituant la Communauté économique euro péenne, considérant que les mesures prévues au présent règlement vu le règlement n0 136/66/CEE du Conseil, du 22 sont conformes à l'avis du comité de gestion des matières septembre 1966, portant établissement d'une organisation grasses, commune des marchés dans le secteur des matières grasses ('), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n0 . 2902/89 Q, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT : vu le règlement (CEE) n0 2261 /84 du Conseil, du 17 juillet 1984, arrêtant les règles générales relatives à l'octroi Article premier de l'aide à la production d'huile d'olive et aux organisa tions de producteurs (3), modifié en dernier lieu par le 1 . Pour la campagne 1989/ 1990, les rendements en olives et en huile ainsi que les zones de production y affé règlement (CEE) n0 1226/89 (4), et notamment son arti rentes sont fixés à l'annexe I. cle 19, considérant que, aux fins de l'octroi dé l'aide à la produc 2. La délimitation des zones de production fait l'objet tion, pour les oléiculteurs qui produisent moins de 400 de l'annexe II. -

DSS San Severo (Apricena, Chieuti, Lesina, Poggio Imperiale, San
ALLEGATO B – ELENCO STRUTTURE COINVOLTE E REFERENTI AFFERENTI ALLA ASL FOGGIA E AI DISTRETTI SOCIO-SANITARI DISTRETTO SOCIO SANITARIO/COMUNI AFFERENTI REFERENTE SEDE TELEFONO EMAIL DSS San Severo (Apricena, Chieuti, Lesina, Dr.ssa Luigia Pia Devanna P.O. “T. Masselli-Mascia”, viale 0882200577 [email protected] Poggio Imperiale, San Paolo di Civitate, San Teresa Masselli Mascia 28, 0882200565 Severo, Serracapriola, Torremaggiore) 71016 San Severo DSS San Marco in Lamis (Rignano Garganico, Via del Campo s.n.c., 71015 0882200729 San Giovanni Rotondo, San Marco in Lamis, Dr.ssa Lina Franca Basile [email protected] San Nicandro Garganico 0882200728 Sannicandro Garganico) DSS Vico del Gargano (Cagnano Varano, Via di Vagno 2, 71018 Vico del Carpino, Ischitella, Isole Tremiti, Rodi Gargano, Dr.ssa Maria Rosa Maroni 0884920809 [email protected] Gargano Vico Del Gargano, Vieste, Peschici) DSS Manfredonia (Manfredonia, Mattinata, Monte Via Barletta 2, 71043 Dr.ssa Angela Maria Colella 0884510465 [email protected] Sant' Angelo, Zapponeta) Manfredonia Ex Ospedale “T. Russo”, Viale DSS Cerignola (Carapelle, Cerignola, Ordona, 0885419226 Dr. Andrea Bianco XX Settembre 2, 71042 [email protected] Stornara, Stornarella) 0885419355 Cerignola DSS Lucera (Alberona, Biccari, Carlantino, Casalnuovo Monterotaro, Casalvecchio di Puglia, P.O. “F. Lastaria”, Viale Castelnuovo Della Daunia, Celenza Valfortore, Dr. Giuseppe Grosso Francesco Lastaria, 71036 0881543518 [email protected] Lucera, Motta Montecorvino,