It1130004 - Lago Di Bertignano E Stagni Di Roppolo
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
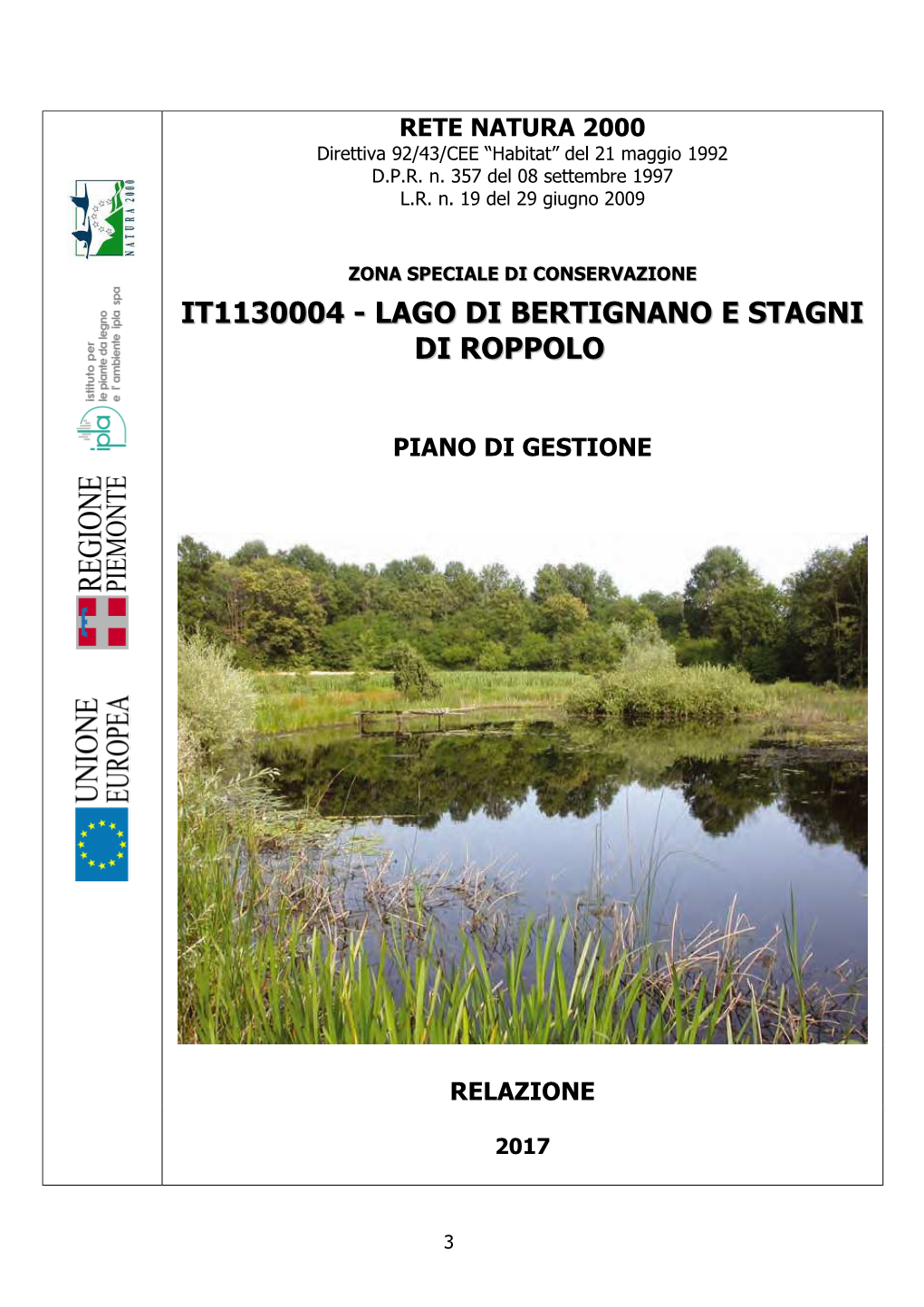
Load more
Recommended publications
-

Valledora Piemonte
BRIEFING Requested by the PETI committee Fact Finding visit to Italy (Valledora-Piemonte) 17 -18 December The aim of this briefing is to provide summarised information for the delegation of the Committee on Petitions which is to visit the above-mentioned Valledora area in the Piedmont Region of Italy from 17 to 18 December 2018. The fact-finding visit will include meetings with representatives of the government, local authorities and civil society. The Valledora site, located in the provinces of Biella and Vercelli, forms a natural link between the two historic provinces and is made up of significant elements of environmental biodiversity and Responsible research administrator: Giorgio Mussa Policy Department for Citizens' Rights and Constitutional Affairs Directorate-General for Internal Policies PE 608.849–December 2018 EN Fact Finding visit to Italy ( Valledora- Piemonte) landscape value. The area is situated close to the Anfiteatro Morenico di Ivrea1 (SCI, Site of Community Interest) and Lake Viverone2 (SPA - Special Protection Area). The plain is traversed by major irrigation channels bringing water from the Dora Baltea and Po. The densely populated area forms part of the populous Piedmont Region (with approximately 4 400 000 residents) which was designated by the Lonely Planet guide as the best tourist destination for 2019. The Valledora area has for many years been at the heart of major gravel and sand extraction operations, due to its favourable geological substrate, for use in building. Abandoned quarries have often been replaced and refilled with waste landfills. Petition No 0909-20163 criticises the serious environmental deterioration of the Valledora area, which at one time was predominantly agricultural. -

13 2020 02 Derenne Impaginato FD
VOL . 13 2020 PP . 9-14 ISSN 1974-7985 https://doi.org/10.6092/ ISSN .1974-7985/37099 “F ACIES E CULTURE NELL ’ETÀ DEL BRONZO ITALIANA ?” ACADEMIA BELGICA , R OMA , 3-4 DICEMBRE 2015 I LIVELLI DELL ’ETÀ DEL BRONZO DELLA GROTTA DELL ’EREMITA IN PIEMONTE (VERCELLI , ITALIA ): PRIMI DATI CRONOLOGICI E CULTURALI 1 1 1 Eve Derenne , Stefano Viola , Marie Besse PAROLE CHIAVE : Grotta; Alpi occidentali; Monte Fenera; età del Bronzo. KEYWORDS : Cave; Western Alps; Fenera Mount; Bronze Age. RIASSUNTO Il contributo presenta i primi risultati degli scavi archeologici diretti dalla prof.ssa Marie Besse, presso il sito della grotta Eremita tra il 2012 e il 2015. La grotta Eremita si trova nel cuore del massiccio calcareo del Monte Fenera, vicino a Borgosesia (Vercelli), noto per le sue numerose grotte, molte delle quali contengono resti archeologici che vanno cronologicamente dal Paleolitico al Medioevo. Questa particolare situazione può essere spiegata da due elementi: l'unicità del massiccio dal punto di vista geologico rispetto al resto dell'area e la sua posizione strategica ai piedi delle Alpi meridionali, rendendolo una possibile tappa per le persone che attraversano le Alpi. L'interesse dei ricercatori del Laboratorio di archeologia e antropologia preistorica è iniziato dopo la scoperta di un bottone in osso attribuito all'età del Rame nella grotta Eremita alla fine degli anni '80 dal Gruppo Archeologico e Speleologico di Borgosesia (GASB). I primi sondaggi hanno confermato l'importanza di questo sito archeologico con la scoperta di uno spillone e di alcuni elementi di ornamento a spirale in bronzo. Ulteriori scavi iniziati nel 2013 hanno permesso di identificare due livelli particolarmente significativi: il primo (US 10) è un sottile livello limoso che contiene numerosi resti di carbone. -

Incontro Per Il Contratto Di Lago Di Viverone
Incontro per il Contratto di Lago di Viverone MAGGIO 2015 RTI [PIANO DI AZIONE S&T Società Cooperativa Achab s.r.l. Co.r.in.te.a. soc coop PIANO DI COMUNICAZIONE E Endaco s.r.l. PARTECIPAZIONE] SOMMARIO DEL PIANO 1 Premessa .................................................................................................................................. 2 2 Introduzione ............................................................................................................................... 3 2.1 Un piano “preliminare” (propedeutico) ............................................................................... 3 2.2 Sintetico quadro d’insieme del contesto socio-territoriale .................................................. 3 2.3 Criticità e risorse (in relazione alla possibilità di informazione/comunicazione) ................ 4 3 Comunicazione e partecipazione nel Contratto di Lago ............................................................ 5 3.1 La Direttiva Quadro sulle Acque (DQA) e la partecipazione pubblica ............................... 5 3.2 La convenzione di Aarhus ................................................................................................. 7 3.3 La partecipazione pubblica ai CdL ..................................................................................... 8 4 Analisi dei target presenti ........................................................................................................ 12 4.1 Target “interno” ............................................................................................................... -

Guida Alla Scoperta Di Roppolo
COOPERATIVA SOCIALE C’ERA L’ACCA Guida alla scoperta di Roppolo C’ERA L’ACCA Società Cooperativa Sociale 11100 Aosta Sede: Via Xavier de Maistre 19 [email protected] cell. 347-1639197 5 Partita Iva e codice fiscale 0108548007 Iscritta al Registro Regionale Enti Cooperativi Sezione a Mutualità prevalente n. A174567 1 Il presente documento riporta quanto contenuto nell’audio guida predisposta nell’ambi- to del progetto PSR 2014-2020 Regione Piemonte e descrive cosa offre il territorio del Comune di Roppolo e gli interventi che sono stati fatti per accrescerne la fruibilità. Indice e indicazioni generali Il documento raccoglie le informazioni che vi accompagneranno alla scoperta del territo- rio del Comune di Roppolo, raccontando le sue risorse e unicità, dai punti di vista stori- co, archeologico e naturalistico. Il testo vuole essere uno strumento di supporto alla visita e complementare ai pannelli tattilo descrittivi posizionati in tre punti suggestivi del territorio comunale; i punti sono: - Roppolo Centro, vicino al municipio, a lato del campanile della Chiesa parrocchiale; - nella borgata di San Vitale a lato della Chiesa, presso l’area attrezzata per tutti e punto di partenza per le aree naturalistiche; - presso i ruderi della chiesa di Sant’Elisabet, punto di partenza per le mete storico/ar- cheologiche; Il documento si compone di 13 paragrafi: 1. Descrizione a supporto delle informazioni contenute nel pannello tattile Roppolo Centro 2. Descrizione del progetto realizzato nell’ambito del Piano di Sviluppo Rurale 2014-2020 sottomisura 7.5.1. 3. Descrizione degli interventi realizzati dal progetto 4. Cenni sull’Anfiteatro Morenico di Ivrea – AMI e L’Alta Via dell’AMI 5. -

I Contratti Fiumi E Laghi 2012.Indd
nalisi delle politiche Direzione Programmazione Strategica, Politiche Territoriali ed Edilizia corso Bolzano, 44 – 10121 Torino Tel. + 39 011 4321428 – fax + 39 011 4324804 e-mail [email protected] I CONTRATTI Settore Programmazione Negoziata Via Lagrange, 24 – 10123 Torino Tel. + 39 011 4323989 – fax + 39 011 4325560 DI FIUME E DI LAGO e-mail [email protected] IN PIEMONTE Siti web www.regione.piemonte.it/sit POLITICHE PER LA TUTELA www.regione.piemonte.it/edilizia www.regione.piemonte.it/programmazione E IL MANTENIMENTO DELLA RISORSA ACQUA Il Settore Programmazione Negoziata svolge attività di programmazione, monitoraggio e valutazione delle La ricerca “Programmazione negoziata nel settore ambientale: politiche dedicate allo sviluppo socio – economico e al riequilibrio territoriale fi nanziate con le risorse aggiuntive i Contratti di fi ume e di lago”, i cui esiti presentiamo in questo Rapporto, è stata promossa dalla nazionali e regionali intersettoriali, attuate con strumenti di programmazione negoziata. Direzione Regionale Programmazione Strategica, Politiche Territoriali ed Edilizia con la collaborazione della Direzione Ambiente della Regione Piemonte, e realizzata dall’Istituto di Ricerche Economico Il Settore Tutela Ambientale delle Acque svolge attività di rilevamento delle caratteristiche qualitative e Sociali del Piemonte . quantitative dei corpi idrici superfi ciali e sotterranei e dello stato degli ecosistemi acquatici; designazione e classifi cazione delle acque in funzione degli obiettivi di qualità; designazione delle aree a specifi ca tutela; predisposizione di modelli per la previsione e lo studio dei fenomeni di criticità; tutela dagli inquinamenti Il lavoro si colloca nel quadro delle attività defi nite con l’Accordo di Programma Quadro “Azioni di puntuali e diff usi; pianifi cazione di tutela delle acque. -

Contratto Di Lago Di Viverone VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA – Rapporto Ambientale
Contratto di Lago di Viverone VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA – Rapporto Ambientale 1 Contratto di Lago di Viverone VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA – Rapporto Ambientale SOMMARIO ELENCO FIGURE........................................................................................................................................................................................................... 3 1 PREMESSA......................................................................................................................................................................................................... 5 1.1 MOTIVAZIONI E CARATTERISTICHE DEL CONTRATTO DI LAGO ............................................................................................5 1.2 IL PROCESSO DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS) .......................................................................................6 1.3 FINALITA’ E CONTENUTI DEL RAPPORTO AMBIENTALE DI VAS ............................................................................................8 2 IL CONTRATTO DI LAGO DI VIVERONE........................................................................................................................................................ 10 2.1 INQUADRAMENTO NORMATIVO E PROGRAMMATICO ........................................................................................................10 2.2 OBIETTIVI ..........................................................................................................................................................................12 -

Scarica La Brochure
LANDSCAPES & SANCTUARIES FROM ALPS TO SEA Paesaggi & Santuari The Piedmont Bike Experience 1 Bielmonte Oropa N Oasi Zegna – Oropa 2 Oasi Zegna O E Distance: 31 km 1 Ascend: +774 m S Biella Descend: -1118 m Oropa - Biella 3 Distance: 45,5 km 2 Ascend: +891 m CONQUER Santhia 4 Descend: -1621 m Vercelli Biella – Santhià Distance: 43 km 4 3 Ascend: +513 m Descend: -298 m Casale Monferrato Santhià – Vercelli – Casale Monferrato Distance: 59 km 4 Ascend: +135 m ME. 5 6 Descend: -70 m Alessandria Casale Monferrato - Alessandria Tortona Distance: 51 km 5 Ascend: +328 m 7 Descend: -308 m Castigliole d’Asti Acqui 10 Novi Ligure Alessandria - Tortona Terme Distance: 51 km Info: Via Roma 99/100 - 13835, Trivero Valdilana (BI) - Italia Alba 11 8 6 Ascend: +88 m I WILL 9 Ovada Descend: -110 m 12 Tortona – Novi Ligure Tel. +39 015 7591445 - [email protected] Pedaggera Distance: 38 km 7 Ascend: +310 m Descend: -390 m 13 www.alpibiellesi.eu Novi Ligure - Ovada Ceva Distance: 32,5 km 8 Ascend: +443 m CONQUER Descend: -444 m 14 Ovada – Acqui Terme Distance: 30 km Ormea 9 Ascend: +547 m Ligurian Sea Descend: -516 m Acqui Terme – Castigliole d’Asti 15 Distance: 40 km 10 Ascend: +810 m YOU. Descend: -729 m Imperia Castigliole d’Asti - Alba Consorzio Turistico Alpi Biellesi Discover our tracks: 16 Distance: 28 km Sanremo 11 Ascend: +463m Descend: -528 m alpi_biellesi Alba - Pedaggera Distance: 33 km Description 12 Ascend: +838 m Descrizione Descend: -290 m More than 600 km in 16 stages to discover the beauties of Piedmont Pedaggera - Ceva and Liguria. -

Vercelli Nel Secolo Xii
SOCIETÀ STORICA VERCELLESE nel trentennale di fondazione con la collaborazione della Società per gli Studi Storici di Cuneo e dell’Associazione Casalese Arte e Storia VERCELLI NEL SECOLO XII ATTI DEL QUARTO CONGRESSO STORICO VERCELLESE Vercelli, Salone S. Eusebio - Seminario 18 - 19 - 20 ottobre 2002 VERCELLI 2005 1 2 BIBLIOTECA DELLA SOCIETÀ STORICA VERCELLESE Volume pubblicato con il contributo determinante della Fondazione Cassa di Risparmio di Vercelli 3 4 SOCIETÀ STORICAO VERCELLESE FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI VERCELLI nel trentennale di fondazione con la collaborazione della Società per gli Studi Storici di Cuneo e dell’Associazione Casalese Arte e Storia VERCELLI NEL SECOLO XII ATTI DEL QUARTO CONGRESSO STORICO VERCELLESE Vercelli, Salone S. Eusebio - Seminario 18 - 19 - 20 ottobre 2002 VERCELLI 2005 5 6 PREFAZIONE La Società Storica Vercellese ha voluto celebrare i trent’anni della sua esistenza promuovendo un ciclo di studi su un periodo storico fon- damentale per Vercelli, ma poco studiato: il secolo XII. L’idea di indire un congresso proprio su questo secolo è stata corag- giosa, anche perché non era facile trovare in breve tempo (due anni, approssimativamente) studiosi preparati ed idonei ad affrontare e supe- rare difficoltà di ricerca veramente notevoli. La Fondazione Cassa di Risparmio non a caso si è unita alla Società Storica Vercellese per organizzare questo Congresso, che segna l’avvio di un nuovo ed essenziale progetto di studi sul glorioso medioevo ver- cellese. Il secolo XII è troppo importante nella storia di Vercelli per non compiere il massimo sforzo per dare finalmente un contributo decisivo alla sua conoscenza. In effetti, il secolo XII, su cui verte questo congresso, è un secolo pochissimo studiato dalla storiografia vercellese, direi quasi negletto, a causa della documentazione scarsa di fronte a problemi storici di non facile soluzione. -

Le Acque Di Balneazione Dei Laghi Viverone, Sirio, Candia E Avigliana
Le acque di balneazione dei 2010 laghi Viverone, Sirio, Candia e Avigliana Grande Redazione Testi/Text/Rédaction des textes/Textredaktion Pierluigi Fogliati - Arpa Piemonte, Dipartimento di Torino Francesca Vietti - Arpa Piemonte, Dipartimento di Biella Paolo Demaestri, Luigi Guidetti, Silvia Padulazzi - Arpa Piemonte, Dipartimento del Verbano Cusio Ossola Elaborazioni cartografiche/Cartographic production/Conception et réalisation cartographique/Kartographische Bearbeitung Isabella Tinetti, Luca Forestello, Romina Di Paolo, Enrico Bonansea - Arpa Piemonte, Sistema Informativo Ambientale Fotografie/Photographs/Photographies/Fotos Archivio Arpa Piemonte - Immagine di copertina, Michele Lattanzio Traduzione/Translation/Traduction/Übersetzung ACTA, Torino Coordinamento editoriale/Editing/Coordination éditoriale/Redaktionskoordination Elisa Bianchi - Arpa Piemonte, Comunicazione istituzionale Ideazione e progetto grafico/Graphic project/Conception et projet graphique/Entwurf und grafische Gestaltung Art Café Adv, Torino Finito di stampare nel mese di giugno 2010 dalla Litografia Viscardi, Alessandria Printed in June 2010 at Litografia Viscardi, Alessandria Fini d’imprimer au mois de juin 2010 par la Litografia Viscardi, Alessandria Drucklegung im Juni 2010 in Der Druckerei Litografia Viscardi, Alessandria Copyright © 2010, Arpa Piemonte Via Pio VII, 9 - 10135 Torino - Italia Arpa Piemonte scegliendo di stampare questa brochure su carta Revive Pure White Silk in 115g, certificata FSC 100% Riciclato ed Ecolabel, ha contribuito alla salvaguardia -

Progetto Di Recupero Del Lago Di Viverone - Relazione Finale
Progetto di recupero del Lago di Viverone - relazione finale - Il Direttore del CNR-ISE Il Dirigente Responsabile ARPA Biella (Dott. Rosario Mosello) (Dott.ssa Antonella Pannocchia) Giugno 2006 Autori: CNR-ISE Alcide Calderoni (Capitoli: 10, 11) Marzia Ciampittiello (Capitoli: 2, 3, 4, 6, 11) Riccardo de Bernardi (Capitoli: 10, 11) Gaetano Galanti (Capitoli: 1, 11, 12, 13) Alessandro Oggioni (Capitoli: 2, 3, 4, 5, 6, 11, 13) ARPA-Biella Matteo Massara (Capitoli: 5, 11, 12) Francesca Vietti (Capitoli: 5, 7, 8, 9, 11) hanno inoltre collaborato: CNR-ISE Gabriele Tartari Paola Giacomotti Arianna Orrù ARPA-Biella Chiara Cisaro Gianfranco Piancone Aldo Tocchio 2 INDICE Indice....................................................................................................................................................3 1. Introduzione .....................................................................................................................................4 2. Inquadramento Geografico e Territoriale ........................................................................................5 3. Idrogeologia del Bacino Imbrifero...................................................................................................7 4. Reticolo Idrografico .......................................................................................................................10 5. Uso del suolo..................................................................................................................................15 6. Bilancio idrologico -

Climate Change Impacts on Alpine Lakes
Climate Change Impacts on Alpine Lakes Summary Introduction.................................................................................................................................... 7 1. Climate change and alpine lakes.......................................................................................... 8 . Global Climate Change ......................................................................................................... 9 . Definitions...................................................................................................................... 9 . Climate.change.in.the.past............................................................................................ 9 . Human.caused.climate.change....................................................................................10 . Consequences.of.present.climate.change...................................................................11 . Future.climate.change..................................................................................................11 Climate change and lakes .................................................................................................. 11 Impacts.on.physical,.chemical.and.biological.lake.parameters...................................12 . Conclusions..................................................................................................................13 . References................................................................................................................... 16 . List.of.figures................................................................................................................20 -

It1110020 - Lago Di Viverone
RETE NATURA 2000 Direttiva 2009/147/CEE “Uccelli” del 30 novembre 2009 Direttiva 92/43/CEE “Habitat” del 21 maggio 1992 D.P.R. n. 357 del 08 settembre 1997 L.R. n. 19 del 29 giugno 2009 ZONA SPECIALE DI CONSERVAZIONE e ZONA DI PROTEZIONE SPECIALE IT1110020 - LAGO DI VIVERONE PIANO DI GESTIONE RELAZIONE 2017 Sito IT1110020 “Lago di Viverone” Piano di Gestione Revisione generale, elaborazione finale del Piano di Gestione e coordinamento normativo per l’approvazione Regione Piemonte, Settore Biodiversità e Aree naturali Redazione dello studio propedeutico al Piano di Gestione Istituto Piante da Legno e l’Ambiente Ringraziamenti Edoardo Martinetto, Loredana Guglielmetto Mugion e Diego Marra per le informazioni relative alla localizzazione di specie erbacee rare della flora. Ferruccio Campese per aver reso disponibile l’imbarcazione utilizzata durante le prospezioni floristiche sul lago. Foto di copertina E. Manghi – Archivio Ce.D.R.A.P. Regione Piemonte Lo studio propedeutico al presente Piano è stato redatto nel 2011 con il finanziamento del PSR 2007/2013 – Misura 323, Azione 1. 2 Sito IT1110020 “Lago di Viverone” Piano di Gestione INDICE INTRODUZIONE 8 SIC, ZSC e Rete Natura 2000 ...................................................................................... 10 MOTIVI DI ISTITUZIONE DEL SITO IT1110020 “LAGO DI VIVERONE” .......................... 13 PARTE I QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO 14 1.NORME DI RIFERIMENTO ........................................................................................ 16 1.1 - DIRETTIVE EUROPEE E CONVENZIONI INTERNAZIONALI..................................... 16 1.2 - LEGISLAZIONE NAZIONALE E REGIONALE DI RIFERIMENTO PER MATERIA .......... 22 1.3 - STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE TERRITORIALI ESISTENTI ................................ 29 PARTE II ANALISI CONOSCITIVE, ESIGENZE ECOLOGICHE E PROBLEMATICHE DI CONSERVAZIONE 37 2 – ASPETTI SOCIO-ECONOMICI E ATTIVITÀ UMANE .................................................. 40 12.1 - CARATTERISTICHE AMMINISTRATIVE E TERRITORIALI ....................................