Lo Sgabello Delle Muse
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
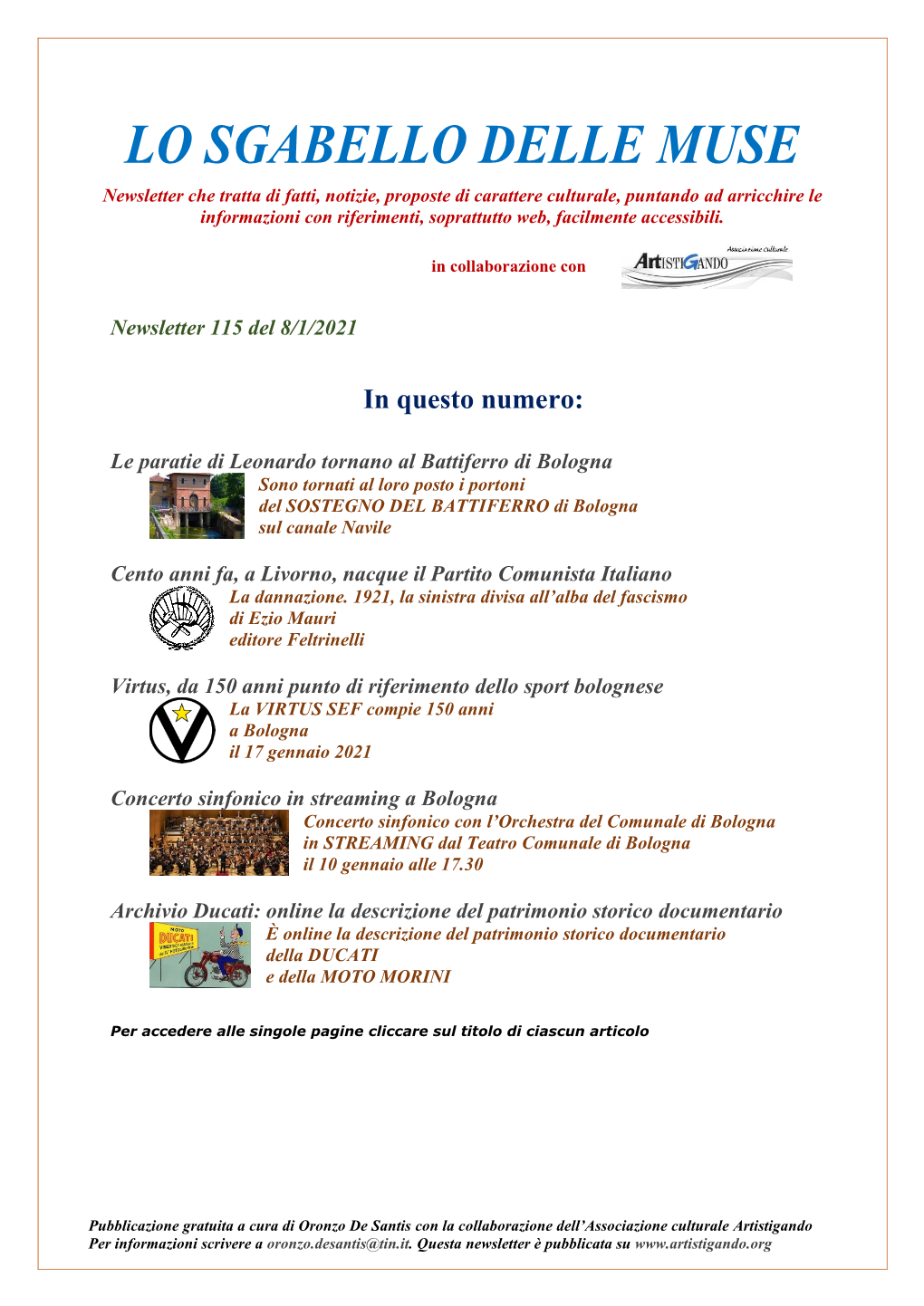
Load more
Recommended publications
-

Giochi Olimpici Tokyo
#NothingButAzzurri @ITALBASKET GIOCHI OLIMPICI TOKYO Via Vitorchiano, 113 - 00189 Roma www.fip.it #NothingButAzzurri @ITALBASKET FEDERAZIONE ITALIANA PALLACANESTRO Via Vitorchiano, 113 00189 Roma [email protected] Fax-mail 06.62276220 All rights reserved ©2021 copyright Federazione Italiana Pallacanestro GIOCHI OLIMPICI TOKYO 25 LUG - 7 AGO Ufficio Stampa Nazionale maschile GIOCHI OLIMPICI Francesco D’Aniello [email protected] TOKYO [email protected] 2 Giochi Olimpici - girone B mob. 333.5785720 3 Giochi Olimpici - precedenti e roster avversarie girone B 08020600244 25 LUG - 7 AGO 4 Giochi Olimpici - le squadre degli altri gironi 5 Roster Nazionale maschile Settore Squadre 6-7 Marco Spissu Nazionali Maschili Massimo Valle 8-9 Niccolò Mannion [email protected] 10-11 Stefano Tonut 12-13 Danilo Gallinari 14-15 Nicolò Melli 16-17 Simone Fontecchio 18-19 Amedeo Tessitori 20-21 Giampaolo Ricci 22-23 Riccardo Moraschini 24-25 Michele Vitali 26-27 Achille Polonara 28-29 Alessandro Pajola 30-31 Lo staff Progetto grafico Alessandro Orrico (file23) 32-33 Record - Precedenti ai Giochi Olimpici Foto Ciamillo-Castoria /Brondi/Ceretti GRUPPO B FORMULA GRUPPO B - LE AVVERSARIE DELL’ITALIA Domenica 25 luglio Martedì 3 agosto Il torneo Olimpico si disputa dal 25 luglio al 7 Germania-Italia 82-92 Quarti di finale agosto. Le 12 squadre qualificate sono divise AUSTRALIA Precedenti Australia-Nigeria 84-67 Giovedì 5 agosto in tre gironi da quattro formazioni ciascuno. Mercoledì 28 luglio Semifinali Accedono ai quarti di finale le prime due clas- #4 Chris Goulding (1988, 192, G, Melbourne) 28 partite (14 vinte/14 perse) sificate di ogni girone e le due migliori terze. -

Enel-EA7 Game Notes
25 SCUDETTI SERIE A 2012/13 REGULAR SEASON 14° GIORNATA 3 COPPE CAMPIONI DOMENICA 13 GENNAIO ORE 20.00 1 INTERCONTINENTALE ENEL BRINDISI EA7 EMPORIO ARMANI MILANO 2 KORAC PALA ELIO PENTASSUGLIA BRINDISI 3 COPPA COPPE GAME NOTES 4 COPPE ITALIA 20 SCUDETTI GIOVANILI PALLACANESTRO OLIMPIA MILANO S.S.R.L. piazzale Lotto, 15 (presso Palalido) - 20148 Milano–Italy Tel +39 0270001615 Fax +39 02740608 Capitale Sociale € 3.000.000,00 i.v. - Registro Imprese Milano / Codice Fiscale / Partita IVA 01852920154 - R.E.A. 1406310 Società a socio unico soggetta ad attività di direzione e coordinamento di Giorgio Armani S.p.A. EA7 EMPORIO ARMANI OLIMPIA MILANO (Record: 7-7; Casa: 2-7; Fuori: 5-2) N. Giocatore Ruolo Altezza Nato il… Cifre stagione 5 Jacopo Giachetti Playmaker 1.90 7/12/1983 0.6 ppg, 1.9 minuti 25 SCUDETTI 7 Malik Hairston Guardia/ala 1.98 23/2/1987 13.6 ppg, 56.1% 2p, 3.2 rpg 9 Antonis Fotsis Ala 2.09 1/ 4/1981 7.4 ppg, 57.1% 2p, 42.6% 3p 13 David Chiotti Ala/centro 2.05 9/9/1984 2.1 ppg, 68.4% 2p, 1.7 rpg 15 Ioannis Bourousis Centro 2.13 17/11/1983 11.9 ppg, 62.3% 2p, 6.6 rpg 18 Nicolò Melli Ala 2.05 26/1/1991 5.2 ppg, 3.2 rpg, 79.2% tl 22 JR Bremer Play/guardia 1.90 19/9(1980 4.7 ppg, 3.7 apg, 1.3 rec. 3 COPPE CAMPIONI 23 Keith Langford Guardia 1.92 24/8/1983 14.7 ppg, 45.2% 3p, 93.9% tl 25 Alessandro Gentile Guardia/ala 2.00 12/11/1992 6.0 ppg, 1.9 rpg, 1.5 apg 30 Marques Green Playmaker 1.65 18/3/1982 10.0 ppg, 66.7% 3p, 7.0 apg 55 Gianluca Basile Guardia 1.92 24/1/1975 3.6 ppg, 1.6 rpg Allenatore: SERGIO SCARIOLO Assistenti: Mario Fioretti, Alberto Rossini; 1 INTERCONTINENTALE Preparatore Atletico: Massimo Annoni; Resp.Medico: Marco Bigoni Medici: Matteo Acquati, Diego Gaddi, Gabriele Cirillo. -

Comunicando 010 2007 4
Sport Tempo Libero Viaggi Spettacoli 2009 Estate Attualità News, iniziative Notizie e convenzioni per i Soci UniCredit Group Cultura Circolo Roma Convenzioni Questa rivista è consultabile anche dal portale di gruppo oppure accedendo dal sito www.unicreditcircoloroma.it Sommario Commissioni EDITORIALE .................... Consiglio Organizzative Storia e sport: da Olimpia a Pechino pag. 4 TURISMO Direttivo Angeletti Emilio 06/54632862-2374 SOLIDARIETÀ PRESIDENTE: Marino Francesco 06/5035245-246 ....................pag. 5 Carimini Stefano Mazzocco Roberto 06/54457108 “La Gabbianella”: risate di solidarietà Napoleoni Claudio 329/0028999 ........................pag. 5 De Razza Antonio [email protected] “Mais Onlus”: Maratonina di Roma VICE PRESIDENTE: SOLIDARIETÀ/ASSISTENZA ....................pag. 6 Carimini Stefano 06/54632526 Notizie dal Gruppo Donatori Sangue Giacci Roberto .............. Curatola Vincenzo 347/9546687 Forum SAD: per il sostegno a distanza pag. 6 Lombardi Alessandro SEGRETARIO: 06/87191096 06/87189557 331/8735227 SPETTACOLO Mazzocco Roberto Piovano Giovanni 393/1415487 ....................pag. 7 CULTURA LʼAllegra Compagnia a “Tuttinscena” CONSIGLIERI: CONOSCERE ROMA/ARCHEOLOGIA UNIONE PENSIONATI De Razza Antonio Napoleoni Claudio 329/0028999 AUDIO/MUSICA/HI-FI ........................pag. 8 Flavioni Elisabetta Capitani Riccardo 06/940168214 Breve storia del Gruppo Regionale ................ Fontemaggi Orazio MICOLOGIA/NATURA/AMBIENTE Assemblea della Segreteria Nazionale pag. 9 Innominati Alessandro Carimini -

Dražen Petrović: La Leyenda Del Indomable
Amado y odiado con la misma intensidad y en proporciones muy parejas, Dražen Petrović ha terminado siendo mucho más que un simple jugador de baloncesto. Su presencia en la cancha, sus provocaciones continuas y su personalidad le convirtieron pronto en un líder. Los avatares de su vida deportiva (jugó en el Madrid después de haber sido su verdugo) y su prematura muerte a los 28 años en un absurdo accidente de coche, cuando estaba en el mejor momento de su carrera deportiva, triunfando en los Nets, hacen que hoy su recuerdo forme parte de la leyenda. Por eso es uno de los grandes mitos del deporte en general y del baloncesto en particular. Juan Francisco Escudero Dražen Petrović: La leyenda del indomable ePub r1.0 Banshee 02.06.14 Título original: Dražen Petrović: la leyenda del indomable Juan Francisco Escudero, 2012 Diseño de cubierta: Inma Bordell Editor digital: Banshee ePub base r1.1 Este libro va dedicado a mi familia, amigos, amantes del deporte del baloncesto y, por supuesto, a Pilar y a la pequeña Alexandra. Gracias a Álvaro Chávarri y Diego Moldes por la aportación de datos y fotos. A Iván Fernández por sus ideas sobre el capítulo de declaraciones. Ta la embajada de Croacia. También, y especialmente, a todos los genios transgresores que fueron olvidados por el paso del tiempo y la aparición de los mediocres… Prólogo LOLO SAINZ UANDO Juan Francisco Escudero Centró en mi despacho del estadio Santiago Bernabéu hace aproximadamente un año para pedirme que le hablara de Drazen Petrovic porque tenía la intención de escribir un libro sobre su vida, un inmenso escalofrío recorrió mi cuerpo, ya que en un instante se agolparon en mi mente todos aquellos momentos vividos alrededor de este genuino y genial jugador de baloncesto —hago mención especial del deporte que practicaba, por todos ustedes conocido, porque Drazen, desde el cielo, no me perdonaría jamás que no nombrara junto a su nombre el gran amor de su vida, el baloncesto—, desde el prisma de jugador contrario y como jugador del Real Madrid, por aquel entonces entrenado por un servidor de ustedes. -
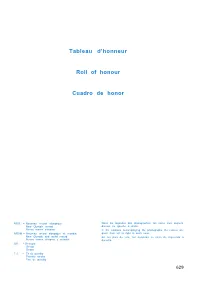
Tableau Dhonneur
Tableau d’honneur Roll of honour Cuadro de honor NRO = Nouveau record olympique Dans les legendes des photographes, les noms sont toujours New Olymplc record donnes de gauche a droite. Nueva marca olimpica. In the captions accompanying the photographs the names are NROM = Nouveau record olympique et mondial given from left to right in each case. New Olymplc and world record En los pies de foto, los nombres se citan de izquierda a Nueva marca olimpica y mundial. derecha. GR = Groupe Group Grupo. T. S. = Tir de penalty Penalty stroke Tiro de penalty 629 ● 5000 m 1. Said Aouita (MAR) (NRO) 13’05”59 Athlétisme 2. Markus Ryffel (SUI) 13’07”54 3. Antonio Leitao (POR) 13’09”20 Athletics 4. Tim Hutchings (GBR) 13’11”50 5. Paul Kipkoech (KEN) 13’14”40 Atletismo 6. Charles Cheruiyot (KEN) 13’18”41 ● 10 000 m 1. Alberto Cova (ITA) 27’47”54 2. Michael Mc Leod (GBR) 28’06”22 3. Mike Musyoki (KEN) 28’06”46 4. Salvatore Antibo (ITA) 28’06”50 1. Hommes - Men - Hombres 5 . Christoph Herle (FRG) 28’08”21 6. Sosthenes Bitok (KEN) 28’09”01 ● 100 m 1. Carl Lewis (USA) 9”99 ● 110 m haies, hurdles, vallas 2. Sam Graddy (USA) 10”19 1. Roger Kingdom (USA) (NRO) 13”20 3. Ben Johnson (CAN) 10”22 2. Greg Foster (USA) 13”23 4. Ron Brown (USA) 10”26 3. Arto Bryggare (FIN) 13”40 5. Michael Mc Farlane (GBR) 10”27 4. Mark McKoy (CAN) 13”45 6. Ray Stewart (JAM) 10”29 5. -
Results from the Games of the Xxiiird Olympic Games
Tableau d’honneur Roll of honour Cuadro de honor NRO = Nouveau record olympique Dans les légendes des photographies, les noms sont toujours New Olympic record donnés de gauche à droite. Nueva marca olimpica. In the captions accompanying the photographs the names are NROM = Nouveau record olympique et mondial given from left to right in each case. New Olympic and world record En los pies de foto, los nombres se citan de izquierda a Nueva marca olimpica y mundial derecha GR = Groupe Group Grupo. T.S. = Tir de penalty Penalty stroke Tiro de penalty. 629 • 5000 m 1. Said Aouita (MAR) (NRO) 13’05”59 Athlétisme 2. Markus Ryffel (SUI) 13'07"54 3. Antonio Leitao (POR) 13’09”20 Athletics 4. Tim Hutchings (GBR) 13’11”50 5. Paul Kipkoech (KEN) 13’14”40 Atletismo 6. Charles Cheruiyot (KEN) 13’18”41 • 10 000 m 1. Alberto Cova (ITA) 27’47”54 • 10 000 m 2. Michael MC Leod (GBR) 28’06”22 3. Mike Musyoki (KEN) 28’06”46 1. Alberto Cova (ITA) 27'47"54 2. 4. Salvatore Antibo (ITA) 28'06"50 Martti Vainio (FIN) 27'51"10 Michael MC Leod (GBR) 5. Christoph Herle (FRG) 28'08"21 3. 28'06"22 4. 6. Sosthenes Bitok (KEN) 28’09”01 Mike Musyoki (KEN) 28'06"46 5. Salvatore Antibo (ITA) 28'06"50 6. Christoph Herle (FRG) 28'08"21 • 100 m 1. Carl Lewis (USA) 9”99 • 110 m haies, hurdles, vallas 2. Sam Graddy (USA) 10”19 1. Roger Kingdom (USA) (NRO) 13”20 3. -

Eurobasket 2015
MEDIA GUIDE PIETRO ARADORI ANDREA BARGNANI MARCO BELINELLI RICCARDO CERVI ANDREA CINCIARINI MARCO CUSIN LUIGI DATOME AMEDEO DELLA VALLE DANILO GALLINARI ALESSANDRO GENTILE DANIEL HACKETT NICOLO’ MELLI DAVIDE PASCOLO GIUSEPPE POETA ACHILLE POLONARA LUCA VITALI EUROBASKET 2015 www.fip.it Federbasket App @italbasket FIPufficiale fipbasketv italbasket PIANETA BASKET.COM LA TV DELLA FEDERAZIONE ITALIANA PALLACANESTRO Ogni giorno, in diretta e in HD, le rubriche dedicate alla pallacanestro italiana, i campionati di Serie A2 (Gold e Silver), la Serie A1 femminile, i tornei ed i Campionati Europei delle Nazionali DA OGGI NON VEDRAI ALTRO MEDIA GUIDE FEDERAZIONE ITALIANA PALLACANESTRO UFFICIO STAMPA www.fip.it AREA MARKETING EVENTI COMUNICAZIONE Francesco D’Aniello Via Vitorchiano, 113 - 00189 Roma [email protected] Federbasket App [email protected] [email protected] fax-mail 06.62276220 tel. 06.33481350 - 333.5785720 @italbasket All rights reserved © 2015 copyright SETTORE SQUADRE NAZIONALI MASCHILI www.facebook.com/FIPufficiale Federazione Italiana Pallacanestro Massimo Valle SOLO SU SKY SPORT HD [email protected] www.youtube.com/fipbasketv Dati statistici aggiornati al 24 luglio 2015 tel. 06.33481324 italbasket 4 La storia della FIP/ Italian Basketball Federation History 5 Presidenti e Segretari Generali / Presidents and Secretaries General 6-7 La formula e il calendario delle partite / Formula and Schedule 9 La Nazionale Maschile / Men’s National Team 10 Il roster / The roster 12 Allenatore / Coach Simone Pianigiani 13 Vice Allenatore /Assistant -

Bilancio Sociale 2013-2014
4 1 0 2 e 3 1 0 2 Bilancio Sociale Sociale 2013 e 2014 RESPONSABILITÀ, IMPEGNO, COMMUNITY Bilancio All rights reserved © 2015 Federazione Italiana Pallacanestro Via Vitorchiano, 113 - 00189 Roma www.fip.it Bilancio Sociale 2013 e 2014 RESPONSABILITÀ, IMPEGNO, COMMUNITY Bilancio Sociale 2013 e 2014 Responsabilità, Impegno, Community A cura della Federazione Italiana Pallacanestro in collaborazione con CSR Sport www.fip.it [email protected], [email protected] Foto: Archivio FIP, Ciamillo-Castoria, Matteo Cirelli, MCA CSR Sport - “Community Social Responsability per lo Sport” è un gruppo di pro- fessionisti con esperienze e competenze diversificate. CSR Sport vuole supportare il mondo dello sport e le organizzazioni che ne fanno parte nella diffusione della cultura della Responsabilità Sociale, attraverso strumenti e progetti di ricerca, informazione, formazione e consulenza specificamente ideati e realizzati. Bilancio sociale 2013 e 2014 4 Responsabilità, Impegno, Community Indice Sezione 1 - IdentItà e Governance 11 Sezione 2 - attIvItà 57 Mission 13 Settore Squadre Nazionali 59 Governance 15 Settore Giovanile Minibasket Scuola 83 Organi Federali Centrali 16 Comitato Nazionale Allenatori 92 Organi di Giustizia 18 Comitato Italiano Arbitri 94 Ufici Federali 20 Settore Organizzazione Territoriale 95 Individuazione e relazioni con gli stakeholder 25 Settore Agonistico 96 I numeri 30 Area Marketing Eventi Comunicazione 97 Commissione Tecnica di Controllo 98 5 Sezione 3 - reSponSabIlItà SocIale 101 Sezione 4 - GeStIone del capItale 125 -

2000-2001 HISTORY History 2000 2000-2001
EUROLEAGUE BASKETBALL OFFICIAL GUIDE 2007-2008 2000-2001 HISTORY history 2000 2000-2001 2001 ÍÍ REGULAR SEASON MVP Dejan Tomasevic KK Buducnost Podgorica Í Í FINAL FOUR MVP Manuel Ginobili Virtus Kinder Bologna EUROLEAGUE PLAYERS OF THE WEEK WEEK 1 PANAGIOTIS LIADELIS PAOK Thessaloniki WEEK 6 DARKO KRUNIC KK Zadar WEEK 2 DEJAN TOMASEVIC KK Buducnost Podgorica WEEK 7 GREGOR FUCKA Paf Bologna GIANLUCA BASILE Paf Bologna WEEK 8 KEBU STEWART Hapoel Jerusalem VIRTUS KINDER UU WEEK 3 MILENKO TOPIC KK Buducnost Podgorica WEEK 9 DEREK HAMILTON St. Petersburg Lions BOLOGNA 2000-2001 WEEK 4 DEJAN TOMASEVIC KK Buducnost Podgorica WEEK 10 MARCELO NICOLA Benetton Treviso Euroleague Champions WEEK 5 DEREK HAMILTON St. Petersburg Lions All-Euroleague Teams ALL-EUROLEAGUE 1ST TEAM ALL-EUROLEAGUE 2ND TEAM LOUIS BULLOCK Müller Verona JAMEIL RICH Lugano Snakes ALPHONSO FORD Peristeri Athens PANAGIOTIS LIADELIS PAOK Thessaloniki DEREK HAMILTON St. Petersburg Lions PAU GASOL FC Barcelona GREGOR FUCKA Paf Bologna YOANNIS GIANNOULIS PAOK Thessaloniki DEJAN TOMASEVIC KK Buducnost Podgorica RASHARD GRIFFITH Virtus Kinder Bologna 4 Euroleague Basketball Official Guide 2007-2008 5 history 2000-2001 FINALS REGULAR SEASON Game 1 BOLOGNA • April 17, 2001 RESULTS STANDINGS GROUP A GROUP B GROUP A TG W L P+ P- KINDER BOLOGNA • TAU VITORIA 65-78 (14-18,16-28,19-19,16-13) WEEK 1-6 WEEK 1-6 Paf 10 8 2 812 760 I KINDER: Ginobili 8, Abbio 10, Bonora 2, Jestratijevic, Frosini 11, Andersen 12, Rigaudeau 4, Smodis 4, Jaric 14 Lugano-Zadar 75-74, 79-118 Charleroi-St.Petersburg 80-68, 77-83 Peristeri 10 7 3 841 786 DNP: Ambrassa. -
Media Guide 4-22
MEDIA GUIDE SLOVENIA EUROBASKET 2013 SEPTEMBER4-22 SETTEMBRE4-22 MEDIA GUIDE SLOVENIA EUROBASKET 2013 4-22 SEPTEMBER SETTEMBRE 4-22 FEDERAZIONE ITALIANA PALLACANESTRO ITALIAN BASKETBALL FEDERATION Area Marketing Eventi Comunicazione Via Vitorchiano, 113 – 00189 Roma UFFICIO STAMPA - PRESS OFFICE Mimmo Cacciuni +39 335.7743460 Francesco D’Aniello +39 333.5785720 Giancarlo Migliola +39 392.8240634 Francesco Oddone +39 338.3799448 www.fip.it [email protected] - [email protected] +39 06 36856500 All rights reserved – Tutti i diritti riservati © 2013 Copyright Federazione Italiana Pallacanestro @italbasket www.facebook.com/FIPufficiale www.youtube.com/fipbasketv Aggiornato al 16 agosto 2013/Last update Aug 16th 2013 OPERAZIONE EUROPA LA NAZIONALE SLOVENIA ITALIANA DI BASKET 2013 MASCHILE AI CAMPIONATI EUROPEI SETTEMBRE4-22 @italbasket www.fip.it www.facebook.com/FIPufficiale www.youtube.com/fipbasketv 4-5 Road to Slovenia : Come ci siamo qualificati /How we qualified 6-7 La formula e il calendario delle partite / Competition System and Schedule 8 Podi Eurobasket / EuroBasket Podia 12 Presidenti e Segretari Generali / Presidents and Secretaries General 13 Il Roster / The Roster 14 Commissario Tecnico / Head Coach Simone Pianigiani 16 Lo Staff / The Staff 24 La Squadra / The Team 57 I precedenti / Previous Games 58 Le avversarie / The Opponents 61 Record azzurri / The Records INDEX 62 Tutti gli allenatori / All Time Head Coaches 62 I migliori realizzatori di tutti i tempi / All time best scorers 63 Gli Azzurri con più di 100 presenze / Azzurri with more than 100 games 64 Top scorer in una partita / Top Scorer in one single game 65 I piazzamenti / Rankings The medals we won 66 Le medaglie vinte / INDICE / 68 Le migliori vittorie / Best victories 69 Le peggiori sconfitte/ Worst losses 71 Edizioni precedenti/ Past competitions Progetto grafico: file23 - grafica e immagine Foto: Agenzia Ciamillo-Castoria 3 Stampa: Arti Grafiche Ramberti srl EUROBASKET 2013 15 AGOSTO 8 SETTEMBRE 2012 QUALIFYING ROUND ITALIA-PORTOGALLO 97-45 (24-7; 50-20; 75-29) Edg nee, Mutaf ne. -

MILANO-BOLOGNA: I PRECEDENTI Virtus Bologna Contro Olimpia Milano È Una Delle Grandi Classiche Del Basket Italiano
SERIE A – 6° GIORNATA EA7 EMPORIO ARMANI SEGAFREDO BOLOGNA EA7 EMPORIO ARMANI MILANO (4-1) N. Giocatore Età Altezza Ruolo Statistiche Serie A 0 Andrew Goudelock 28 1.91 Guardia 16.8 ppg, 66.7% t2p, 4.0 rpg 5 Vladimir Micov 32 2.01 Ala 10.0 ppg, 88.9% tl 7 Davide Pascolo 27 2.03 Ala forte 3.0 ppg, 3.5 rpg, 1.0 stop. 9 Mantas Kalnietis 31 1.95 Playmaker - 13 Simone Fontecchio 22 2.03 Ala 1.7 ppg, 0.7 rpg 15 Kaleb Tarczewski 24 2.13 Centro - 20 Andrea Cinciarini 31 1.90 Playmaker 3.6 ppg, 1.6 rpg, 1.4 apg 22 Marco Cusin 32 2.11 Centro 3.8 ppg, 2.4 rpg, 70.0% t2p 23 Awudu Abass 24 2.00 Ala 4.0 rpg, 66.7% t3p, 2.0 rpg 24 Amath M’Baye 28 2.06 Ala forte 5.8 ppg, 66.7% t2p, 4.8 rpg 25 Jordan Theodore 28 1.83 Playmaker 11.0 ppg, 48.6% t2p, 3.8 apg 28 Patric Young (i) 25 2.09 Centro - 34 Cory Jefferson 27 2.06 Ala-centro 3.0 ppg, 2.8 rpg, 62.5% t2p 45 Dairis Bertans 28 1.93 Guardia 10.0 ppg, 71.4% t3p, 1.5 rpg 77 Arturas Gudaitis 24 2.11 Centro 12.0 ppg, 8.8 rpg, 71.4% t2p Capo allenatore: SIMONE PIANIGIANI Assistenti Allenatori: Massimo Cancellieri, Mario Fioretti, Marco Esposito, Stefano Bizzozero. Preparatore Atletico: Giustino Danesi, Luca Agnello (assistente) SEGAFREDO BOLOGNA (3-2) N. -

Uropei Ci Siamo
Periodico bimestrale di notizie, informazioni e news dell’AssociAzione GiocAtori BAsket e del Fondo di Fine CarrierA Numero 9 · oTToBre/NoVemBre 2010 3 UROPEI3 2011 CI SIAMO Anche gli assi NBA con l’Italia in Lituania SONDAGGIO UBE SURVEY oSCAr eLeNI SerIe A PoST CArrIerA Lettera ai ragazzi I commenti alle novità LGS, lavoriamo per voi della Giba sull‘utilizzo degli stranieri pag_pubb210x297_stampa.pdf 1 19/10/10 16.54 Z D O F H " E F .&%*0-"/6.#&45#3"/%4 . */7&45*.&/5**/6/ .0/%0$)&$3&4$& /FJQSPTTJNJEJFDJBOOJMBDSFTDJUBFDPOPNJDB OFMNPOEPTBSËNPMUPGPSUFÒJNQPSUBOUFQPUFS C CFOFmDJBSFEJRVFTUBDSFTDJUBEJWFSTJmDBOEP M HMJJOWFTUJNFOUJJOUVUUPJMNPOEP Y .FEJPMBOVN#FTU#SBOETÒVOGPOEP CM EhJOWFTUJNFOUPDIFIBBMMBCBTFJMQSFTUJHJP MY FMFDBQBDJUËEFMMFHSBOEJTPDJFUËEJHFTUJPOF CY JOUFSOB[JPOBMJFMBRVBMJUËEFMMBDPOTVMFO[BF CMY EFMMFTQFSJFO[B.FEJPMBOVN K $IJFEJBMUVP'BNJMZ#BOLFS¥HSB[JFBMVJ ÒJMNPOEPDIFWJFOFEBUF OPOJMDPOUSBSJP Ennio Doris Presidente di Banca Mediolanum XXXCBODBNFEJPMBOVNJU .FTTBHHJPQSPNP[JPOBMF.FEJPMBOVN#FTU#SBOETÒVOGPOEPDPNVOFEJJOWFTUJNFOUPEJ.FEJPMBOVN *OUFSOBUJPOBM'VOET1SJNBEFMMhBEFTJPOFMFHHFSFJM1SPTQFUUP*OGPSNBUJWPEJTQPOJCJMFQSFTTPHMJ6GmDJEFJ ¥ 'BNJMZ#BOLFS FTVMTJUPXXXCBODBNFEJPMBOVNJU 2 L`editoriale Professionismo e dintorni di Giuseppe Cassì Marco Mordente e Mariachiara care riceverà parecchie decine di (lavoratore / non lavoratore; profes- Franchini sono i capitani delle Na- migliaia di euro a titolo di trat- sionista / dilettante), a prescindere ed zionali di basket Maschile e Fem- tamento di fine rapporto; gode di indipendentemente dalla natura