Tanzio Da Varallo.Pdf
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
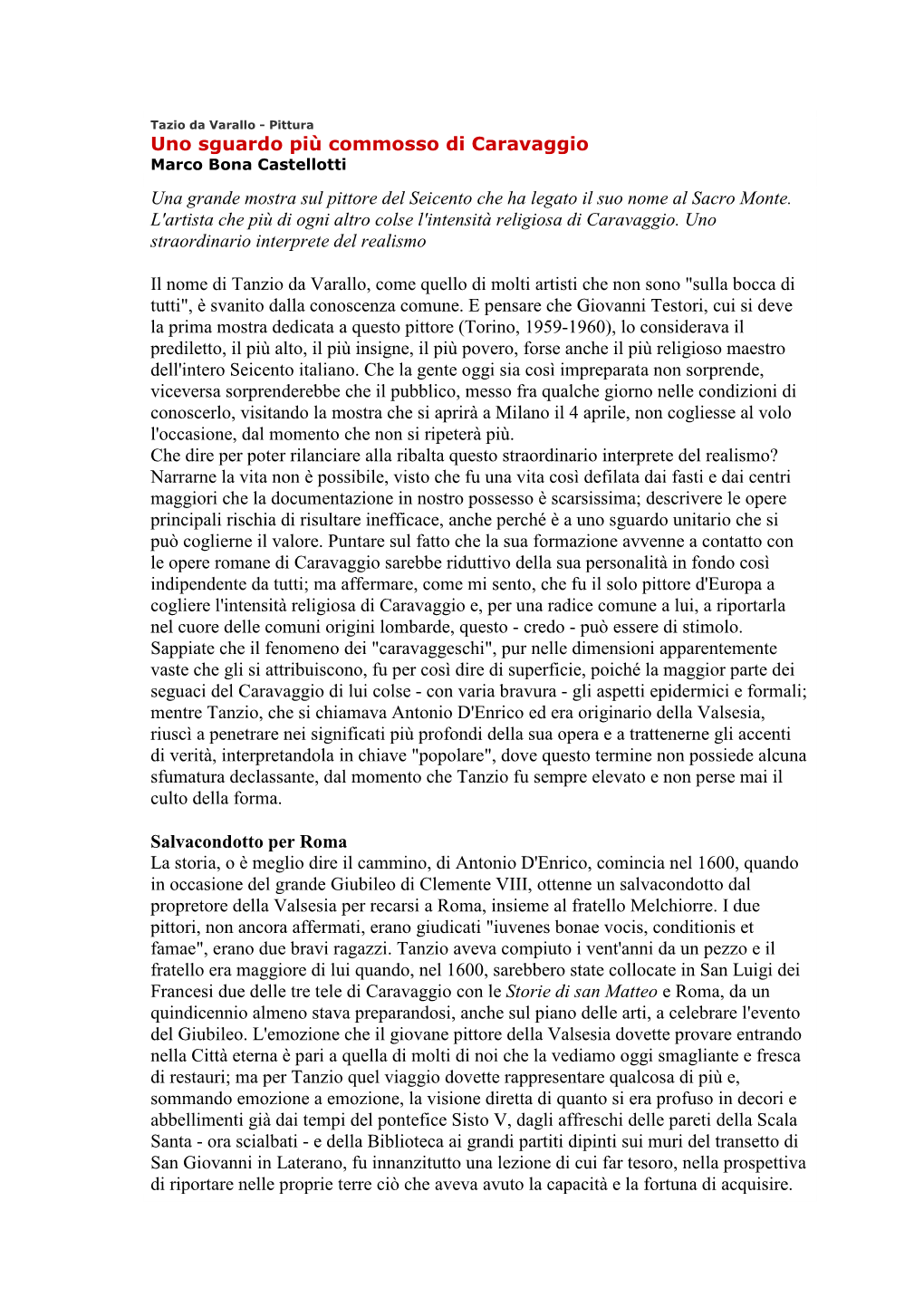
Load more
Recommended publications
-

Sacro Monte Di Varallo
SACRI MONTI DI PIEMONTE E LOMBARDIA - UNESCO WORLD HERITAGE Briga (CH) SACRO MONTE DI VARALLO Locarno (CH) Surface area: 22 hectares United Nations Sacri Monti del Piemonte Riserva speciale DOMODOSSOLA Educational, Scientific and e della Lombardia Sacro Monte Cultural Organization Iscritti nella lista del Patrimonio di Varallo Lugano (CH) Mondiale nel 2003 Elevation: 455 - 650 metres GHIFFA SS33 Environment: Mountain SS34 Verbania OSSUCCIO SS340 Aosta-Ginevra (CH) VARESE Como Sacro Monte VARALLO ORTA A26 SP229 A9 OROPA A8-A26 A5 SP299 A8 SP144 Borgomanero di Varallo Biella Romagnano SP338 Venezia SP230 A4 PROTECTED AREA Cuorgné Ivrea The Sacro Monte di Varallo is the most important of the SS565 A4-A5 Novara MILANO Valperga pre-alpine Sacro Monte both for its artistic and historical Vercelli Bologna BELMONTE A4 Firenze significance and for its naturalistic make-up, rich in SP460 Roma M. Dallago SP590 A26-A4 A26 autochthonous and exotic plants arranged following the Serralunga Photo SP457 Casale Monferrato patterns of the Italian Renaissance gardens which aimed at CREA TORINO emphasizing the nearby architectural structures. Although Savona Moncalvo Alessandria-Genova the territory of the Reserve has been profoundly altered by man, after years of gradual abandonment, the forest covering has slowly been returning floral elements that Access to the Sacred Mount is free of charge have developed and today accounts for more than 421 HOW TO GET THERE species. Inside the sacred area, the natural environment Note: Access by bus is subject to specific rules and payment has been strongly shaped by man to resemble the typical Info and permits: Municipal Police of Varallo - tel +39 0163 562727 gardens of Renaissance Italy. -

Jerusalem in Renaissance Italy the Holy Sepulchre on the Sacro Monte of Varallo
Jerusalem In Renaissance Italy 215 Chapter 9 Jerusalem in Renaissance Italy The Holy Sepulchre on the Sacro Monte of Varallo Bram de Klerck The iconography of St Charles Borromeo (1538–84) contains some interesting instances of the kneeling saint in the immediate vicinity of the recumbent fig- ure of the deceased Christ. The Saviour’s largely nude body, head sometimes still crowned with thorns, is placed on a catafalque or marble slab. An example is a painting executed after 1615 for the Church of Santi Carlo e Giustina in Pa- via, by the Milanese artist Giulio Cesare Procaccini (1574–1625), now in Milan, Pinacoteca di Brera (Fig. 9.1). The work represents St Charles, dressed as a car- dinal, kneeling and looking up to an angel who is pointing at the body of Christ.1 What is especially striking in this painting and images like it is that they suggest the real presence of the sixteenth-century Milanese archbishop at Christ’s bier. By uniting the figures of Christ and St Charles in one and the same space, realistically proportioned to each other, the painters emphasize that, to the saint, the body of the dead Christ is almost tangible. It is as if, long after the biblical events of Christ’s crucifixion and burial, Borromeo found a miraculous way to go back in time some one-and-a-half millennia to find the Saviour’s body inside the hermetically closed tomb. However improbable the scene may appear, these paintings reflect a spe- cific religious experience and practice, as they are documented in the earliest written accounts of Charles Borromeo’s life. -

Michelangelo Merisi (Caravaggio) Was Born in Milan in 1571 But, As Far As Art History Is Concerned, He Was Born in Rome Shortly After He Turned Twenty
Before and after Caravaggi o Directions for an itinerary in the Pinacoteca 1. Simone Peterzano Venus and Cupid with Two Satyrs in a Landscape 54 6 1 3 2. Giovan Paolo Lomazzo 2 Self-Portrait as Abbot of the Academy of Val de Bregn Michelangelo Merisi (Caravaggio) was born in Milan in 1571 but, as far as art history is concerned, he was born in Rome shortly after he turned twenty. In fact, no painting of his is known prior to his arrival in the capital. But his education in Lombardy was fundamental to his forma - tion, as was understood and explained by the art historian 3. Vincenzo Campi Roberto Longhi in the early decades of the twentieth century. The Fruit Seller Several of the paintings conserved at Brera assist in explaining which figurative experiences that Caravaggio observed in Lombardy attracted him and helped to develop his notion of painting, and which works struck him so forcefully as to remain part of his compositional baggage. Among those PAInteRS thAt weRe ConteMPoRARy with him, Simone Peterzano [1] is naturally important, whose workshop he entered at the age of thirteen. It was from Peterzano that he learnt to describe form carefully without the aid of design; also dry chromatic variations, like those in the drape on which Venus lies. 4. Moretto da Brescia Similarly, the intellectualistic experimentation of Giovan Paolo Saint Francis of Assisi Lomazzo [2], painter, theoretician and poet, left its mark. the three-quarter pose with the foreshortened shoulder, direct gaze, and the complexity of pictorial meanings struck Caravaggio, which he echoed in the Young Sick Bacchus (Galleria Borghese, Rome). -
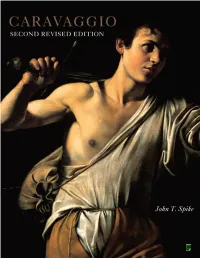
Caravaggio, Second Revised Edition
CARAVAGGIO second revised edition John T. Spike with the assistance of Michèle K. Spike cd-rom catalogue Note to the Reader 2 Abbreviations 3 How to Use this CD-ROM 3 Autograph Works 6 Other Works Attributed 412 Lost Works 452 Bibliography 510 Exhibition Catalogues 607 Copyright Notice 624 abbeville press publishers new york london Note to the Reader This CD-ROM contains searchable catalogues of all of the known paintings of Caravaggio, including attributed and lost works. In the autograph works are included all paintings which on documentary or stylistic evidence appear to be by, or partly by, the hand of Caravaggio. The attributed works include all paintings that have been associated with Caravaggio’s name in critical writings but which, in the opinion of the present writer, cannot be fully accepted as his, and those of uncertain attribution which he has not been able to examine personally. Some works listed here as copies are regarded as autograph by other authorities. Lost works, whose catalogue numbers are preceded by “L,” are paintings whose current whereabouts are unknown which are ascribed to Caravaggio in seventeenth-century documents, inventories, and in other sources. The catalogue of lost works describes a wide variety of material, including paintings considered copies of lost originals. Entries for untraced paintings include the city where they were identified in either a seventeenth-century source or inventory (“Inv.”). Most of the inventories have been published in the Getty Provenance Index, Los Angeles. Provenance, documents and sources, inventories and selective bibliographies are provided for the paintings by, after, and attributed to Caravaggio. -

SACRO MONTE DE VARALLO Locarno (CH)
SACrI MOnTI DU PIÉMOnTE ET DE lOMbArDIE Briga (CH) SACrO MOnTE DE VArAllO Locarno (CH) United Nations Sacri Monti del Piemonte Riserva speciale Surface: 22 hectares Educational, Scientific and e della Lombardia Cultural Organization Iscritti nella lista del Patrimonio Sacro Monte DOMODOSSOLA Mondiale nel 2003 Lugano (CH) di Varallo Altitude: 455 - 650 mètres GHIFFA SS33 Position: montagne SS34 Verbania Propriété: Commune de Varallo OSSUCCIO SS340 VARESE Sacro Monte Aosta-Ginevra (CH) VARALLO Como OrTA A26 SP229 A9 OROPA A8-A26 A5 SP299 A8 SP144 Borgomanero de Varallo Biella Romagnano SP338 Venezia SP230 A4 ZOnE PrOTÉgÉE ET MIlIEU Cuorgné Ivrea Le Sacro Monte préalpin de Varallo est le plus important, SS565 A4-A5 Novara MILANO Valperga aussi bien du point de vue artistique et religieux que du Vercelli Bologna A4 Firenze bElMOnTE point de vue naturel, à cause de la richesse des plantes M. Dallago SP460 A26-A4 Roma SP590 autochtones et exotiques organisées selon le schéma A26 Photo Serralunga des jardins à l’italienne de la Renaissance dans le but SP457 Casale Monferrato CREA de mettre en valeur l'ensemble architectural. Bien que TOrInO Moncalvo le territoire de la Réserve ait été profondément modifié Savona Alessandria-Genova par l'homme, à la suite de nombreuses années d'abandon progressif, la forêt s'est reconstituée lentement et la L’accès au Mont Sacré est libre et l’entrée est gratuite composante floricole s'est enrichie au point que 421 remarque: l’Accès en bus est réglementé et payant. Pour plus d'informations et espèces ont été -
UNDISCOVERED ITALY © Elio Pallard Choir, Culture & Cuisine March 16 – 27, 2019 with Hamilton College’S G
UNDISCOVERED ITALY © Elio Pallard Choir, Culture & Cuisine March 16 – 27, 2019 with Hamilton College’s G. Roberts Kolb, the Marjorie and Robert W. McEwen Professor of Music & Lauralyn Kolb, Lecturer in Music (Voice) © Megan Mallen © Markus Bernet Dear Hamilton Alumni, Parents, and Friends, I invite you to discover areas “off-the-beaten” path in northern Italy on this remarkable and exclusive Hamilton Global Adventure. Those of us who sing will rehearse twice and then perform three concerts and participate in two masses. The trip also features wonderful guided excursions, including walks in historic villages with medieval houses and charming alleys, viewing magnificent art and architecture, and many exceptional culinary experiences. To top it off, our travels will take place amid spectacular landscapes, with two beautiful Italian lakes (Orta and Maggiore) and backdrops such as rolling hills of vineyards and the snow-capped Italian Alps. Our group will enjoy all excursions and included meals together, but you may choose to upgrade from comfortable, 3-star hotels to more luxurious 4-star hotels if you wish. Highlights of this unique trip are many, and include: Choir: • Two rehearsal sessions at Lake Orta; • Concerts in the parish church of Stresa, the Sanctuary of Santa Maria Assunta, and the ancient monastery of Sacra di San Michele; © R. Todd Nielsen • Mass participation in the Royal Church of San Lorenzo (Turin) and the Parish Church of Pollenzo. Culture (nine excursions with art historian guides): • Hiking in a 16th-century religious “theme park” (a UNESCO World Heritage site); • Magnificent Renaissance and Baroque art (frescoes and sculptures) and architecture (cathedrals, churches, and castles); • Turin’s Holy Shroud; • Ancient Roman ruins in Turin and Pollenzo; • Guided tour of Turin’s Egyptian Museum (the world’s second most important Egyptian collection) and Turin’s sumptuous Royal Palace© R.© ToddRufus46 (another Nielsen UNESCO World Heritage site); • Milan’s Dominican convent with Leonardo da Vinci’s Last Supper (a UNESCO World Heritage site). -

INTRODUCTION Between 1600 and 1650 a Surprisingly Novel Kind of Art Evolved in Rome
INTRODUCTION Between 1600 and 1650 a surprisingly novel kind of art evolved in Rome. The favourable economic situation – Catholic reform was 400 on the advance, ensuring plentiful commis- sions from ecclesiastical quarters – attracted artists from other regions of Italy as well as from France and the Low Countries. With- in a very short space of time the papal city transformed itself into an artistic centre of almost irresistible influence. The art of this time was marked by a hitherto unprecedent- ed visual munificence, a lively mixture of realism and imagination, and not least by a highly emotional character. It all began around the year 1600, when the Milanese artist Michelangelo Merisi da Cara- vaggio (1571–1610) created a furore with his paintings in Rome. With their thrilling nat- uralism, dramatic use of light and shade (chiaroscuro) and powerful narrative structure, Caravaggio’s works represent a caesura in the history of European painting. A younger generation of artists with an international out- look – today referred to as the Caravaggists – adopted his radical style of painting, dissemin- ating it across large parts of Italy and the rest of Europe. Only a few years after Caravaggio’s death the Neapolitan-born artist Gian Lorenzo Bernini (1598–1680) entered the Roman art scene, quickly rising to become its new star. The exhibition is divided into sections His figures were imbued with passionate according to concepts that were common movement from the start. He visualized even in contemporary discourse about art: mera- invisible forces, not least those of the psyche, viglia & stupore (wonderment & astonish- by painterly use of light and moving drapery. -
Leggi Estratto Del Libro
Autore: Alberto Paleari Editore: MonteRosa edizioni Via Vigne snc - 28836 Gignese (VB) [email protected] www.monterosaedizioni.it Stampa: Press Grafica ISBN: 9788832260045 Marzo 2020 Tutti i diritti riservati ©MonteRosa edizioni Cartina: Maria Paleari Foto di copertina: Casa walser in Val Vogna (particolare) Alberto Paleari La finestrella delle anime Sulle tracce dei Walser dalla Valsesia alla Valle Strona Introduzione Una storia d’amore Il mio amore per la Valsesia nacque qualche anno fa quan- do conobbi le opere del pittore di Alagna Antonio d’Enrico, detto Tanzio da Varallo, che nel gelido e oscuro Seicento, il vero secolo buio dell’Europa (altro che il medioevo) scese dal Monte Rosa a riscaldare e illuminare con la sua arte i cuori e gli occhi dei con- temporanei e lasciò a Varallo, alla Valsesia e a molte città italiane, alcuni dipinti fra i più preziosi e indimenticabili della nostra pittura. Il suo primo quadro che vidi, nella chiesa di San Brizio a Va- gna di Domodossola, fu la grande pala d’altare della Visitazione di Maria Vergine, del 1626, in cui mi sembrò che la giovanissima Madonna assomigliasse, come se ne fosse la sorella, a un’amica di Alagna della mia figlia più giovane. Il fatto che i tratti di quella Madonna di quasi quattrocento anni fa fossero ancora fra noi, e che la modella avrebbe potuto essere un’antenata dell’amica di mia figlia, mi incuriosirono, mi fecero innamorare di quel quadro e mi spinsero a fare delle ricerche sul pittore che l’aveva dipinto. Le ricerche durarono due anni, in cui visitai in lungo e in largo la Valsesia e i luoghi in tutta Italia dove si trovavano le opere di Tan- zio da Varallo. -
![Credo Che […] Il Centro Del Quadro](https://docslib.b-cdn.net/cover/8178/credo-che-il-centro-del-quadro-8248178.webp)
Credo Che […] Il Centro Del Quadro
TANZIO. UN CARAVAGGESCO TRA I PESTANTI. Di Patrizia Pomella «Credo che […] il centro del quadro non sia soprattutto la battaglia, questo viluppo, questa specie di orrendo e bellissimo agglomerato di corpi e di cavalli, ma sia l’Angelo, che è il fulcro della poesia di questo quadro di Tanzio sia lì è visibile, direi quasi tangibile, toccabile, passando dal bozzetto al quadro. L’unica variante veramente decisiva è data dall’Angelo: l’Angelo che nel bozzetto cade, precipita sì, ma secondo un modello di caduta direi quasi canonico, caravaggesco ancora, nel quadro cambia; cioè non è più l’Angelo che cade, è un ragazzo di montagna, è un giovane che discende, che adopera il suo passo come se invece di cadere dalle nubi, cadesse, venisse giù da delle rocce del Monte Rosa sopra il Riale dove Tanzio era nato». (Giovanni Testori) Antonio d’Enrico detto il “Tanzio” nacque a "Riale di Novara (1593-1615) Carlo Bascapè e da di Alagna" in Valsesia, in una famiglia di artisti Girolamo D’Adda, che motivarono la scelta della attivi e documentati dal 1586 al Sacro Monte di famiglia D’Enrico di un aggiornamento romano di Varallo. Tanzio, facendolo rientrare in tempo utile per la Si ignora la sua data di nascita, ma è logico realizzazione delle cappelle più prestigiose. pensare che non sia troppo lontana dal 1575. Il Pertanto, il periodo iniziale della sua formazione primo documento scritto riguardante Tanzio risale rimane al momento oscuro anche se è verosimile al febbraio del 1600 ed è costituito dal che il suo primo apprendistato artistico sia lasciapassare che il propretore della Valsesia maturato nell’ambito della tradizione scultorea concesse ad Antonio ed a suo fratello Melchiorre della valle e della bottega di famiglia. -

SACRO MONTE of VARALLO Locarno (CH)
SACrI MOnTI OF PIEDMOnT AnD lOMbArDY Briga (CH) SACrO MOnTE OF VArAllO Locarno (CH) United Nations Sacri Monti del Piemonte Riserva speciale Surface area: 22 hectares Educational, Scientific and e della Lombardia Cultural Organization Iscritti nella lista del Patrimonio Sacro Monte DOMODOSSOLA Mondiale nel 2003 Lugano (CH) di Varallo Elevation: 455 - 650 metres GHIFFA SS33 Environment: Mountain SS34 Verbania Property: Commune of Varallo OSSUCCIO SS340 VARESE Sacro Monte Aosta-Ginevra (CH) VARALLO Como OrTA A26 SP229 A9 OROPA A8-A26 A5 SP299 A8 SP144 Borgomanero of Varallo Biella Romagnano SP338 Venezia SP230 A4 PrOTECTED ArEA Cuorgné Ivrea The Sacro Monte di Varallo is the most important of the SS565 A4-A5 Novara MILANO Valperga pre-alpine Sacro Monte both for its artistic and historical Vercelli Bologna A4 Firenze bElMOnTE significance and for its naturalistic make-up, rich in M. Dallago SP460 Roma SP590 A26-A4 A26 autochthonous and exotic plants arranged following the Photo Serralunga SP457 Casale Monferrato patterns of the Italian Renaissance gardens which aimed at CREA TOrInO emphasizing the nearby architectural structures. Although Savona Moncalvo Alessandria-Genova the territory of the Reserve has been profoundly altered by man, after years of gradual abandonment, the forest Access to the Sacred Mount is free of charge covering has slowly been returning floral elements that hOW TO gET ThErE have developed and today accounts for more than 421 Note: Access by bus is subject to specific rules and payment species. Inside the sacred area, the natural environment Info and permits: Municipal Police of Varallo - tel +39 0163 562727 has been strongly shaped by man to resemble the typical By car: Motorway A26, exit Romagnano-Ghemme, SP 299 direction Alagna, exit Varall, directions for Sacro Monte by cableway and on road (follow the specific signs) gardens of Renaissance Italy. -

PDF Hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen
PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen The following full text is a publisher's version. For additional information about this publication click this link. http://hdl.handle.net/2066/61787 Please be advised that this information was generated on 2021-09-26 and may be subject to change. Painters of Reality. Cremona and New York Review by: Bram De Klerck The Burlington Magazine, Vol. 146, No. 1216, Collectors and Patrons (Jul., 2004), pp. 489-491 Published by: The Burlington Magazine Publications Ltd. Stable URL: http://www.jstor.org/stable/20073631 . Accessed: 04/04/2012 08:00 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. The Burlington Magazine Publications Ltd. is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to The Burlington Magazine. http://www.jstor.org EXHIBITION REVIEWS Painters of reality Cremona and New York byBRAM DE KLERCK Open University of theNetherlands, andLeiden University a small ALTARPiECE, painted by Lorenzo ' Lotto around 1523 for the church of SS. jt?ESB?r ^???iW??w ^^^^H^S^^^^^R Trinit? in Bergamo, depicts the Holy Trinity an in unusual way (cat. p. 134). Above a land scape, Christ stands on a double rainbow, the dove of the Holy Spirit over his head, wh?e .y .;..?f.T**ri-'r- a ^ft ^F God the Father is represented by vague a cloudy oudine against briUiant yeUow back ground. -

PDF Hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen
PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen The following full text is a publisher's version. For additional information about this publication click this link. http://hdl.handle.net/2066/61787 Please be advised that this information was generated on 2021-09-28 and may be subject to change. Painters of Reality. Cremona and New York Review by: Bram De Klerck The Burlington Magazine, Vol. 146, No. 1216, Collectors and Patrons (Jul., 2004), pp. 489-491 Published by: The Burlington Magazine Publications Ltd. Stable URL: http://www.jstor.org/stable/20073631 . Accessed: 04/04/2012 08:00 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. The Burlington Magazine Publications Ltd. is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to The Burlington Magazine. http://www.jstor.org EXHIBITION REVIEWS Painters of reality Cremona and New York byBRAM DE KLERCK Open University of theNetherlands, andLeiden University a small ALTARPiECE, painted by Lorenzo ' Lotto around 1523 for the church of SS. jt?ESB?r ^???iW??w ^^^^H^S^^^^^R Trinit? in Bergamo, depicts the Holy Trinity an in unusual way (cat. p. 134). Above a land scape, Christ stands on a double rainbow, the dove of the Holy Spirit over his head, wh?e .y .;..?f.T**ri-'r- a ^ft ^F God the Father is represented by vague a cloudy oudine against briUiant yeUow back ground.