(Pratovecchio-Stia; AR). Programma Di Indagini Archeologiche
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
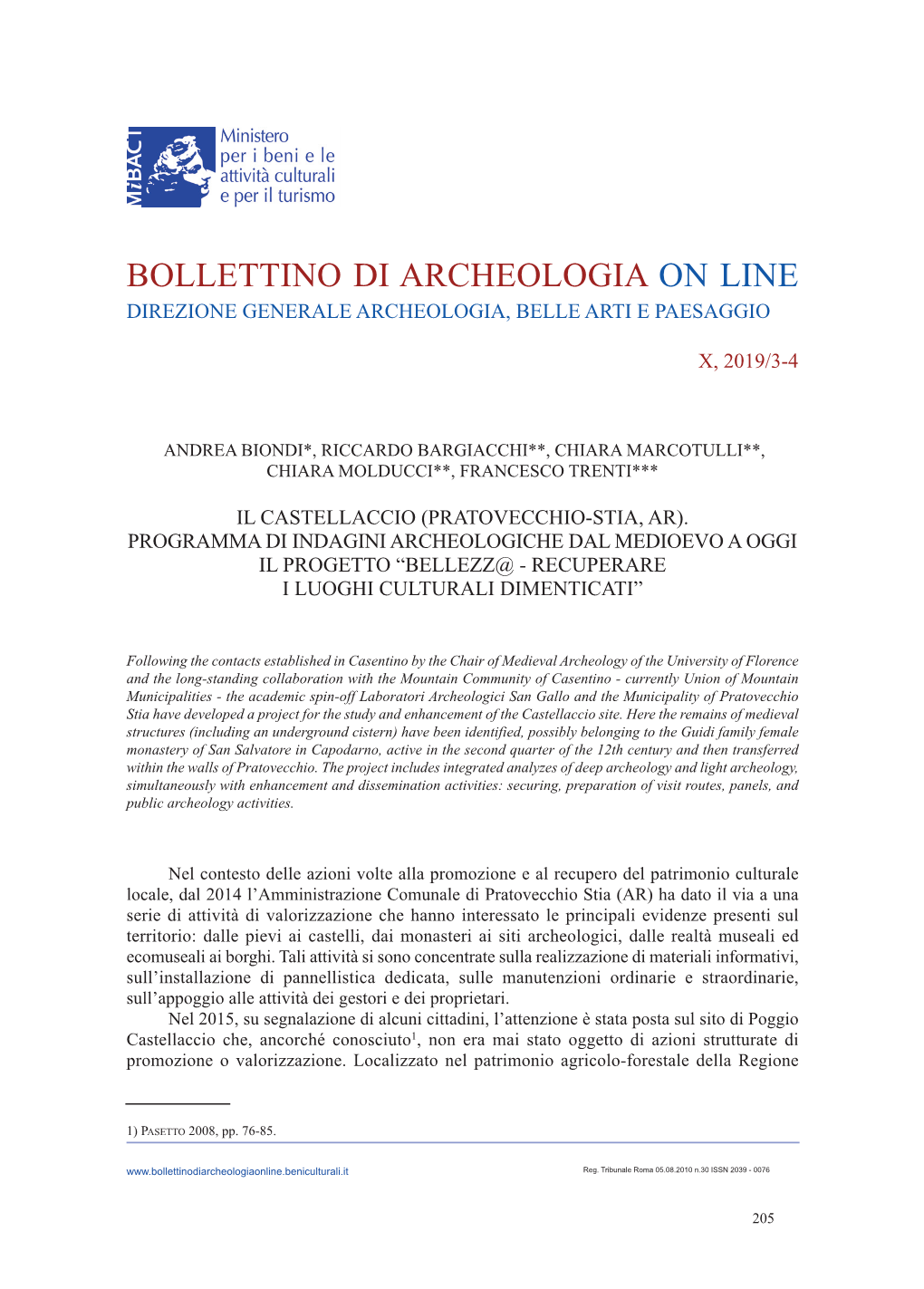
Load more
Recommended publications
-

Using Slideformap and Soslope to Identify Susceptible Areas to Shallow Landslides in the Foreste Casentinesi National Park (Tuscany, Italy)
EGU21-14454 https://doi.org/10.5194/egusphere-egu21-14454 EGU General Assembly 2021 © Author(s) 2021. This work is distributed under the Creative Commons Attribution 4.0 License. Using SlideforMAP and SOSlope to identify susceptible areas to shallow landslides in the Foreste Casentinesi National Park (Tuscany, Italy) Ilenia Murgia1,2, Filippo Giadrossich3,4,5, Marco Niccolini2, Federico Preti3,6, Yamuna Giambastiani3,7,8, Gian Franco Capra1,5, and Denis Cohen9 1Department of Architecture, Design and Urban Planning, University of Sassari, Via Piandanna, 4, 07100 Sassari, Italy. 2D.R.E.Am. Italia Soc. Coop. Agr., Via Garibaldi, 3, 52015 Pratovecchio Stia (AR) 3AIPIN (Italian Soil and Water Bioengineering Association), Via San Bonaventura 13, 50145 Firenze 4Nuoro Forestry School, Department of Agricultural, University of Sassari, Viale Italia, 39, 07100 Sassari, Italy 5Desertification Research Centre, University of Sassari, Viale Italia, 39, 07100 Sassari, Italy. 6Department of Agricultural, Food, Environmental and Forestry Sciences and Technologies, University of Florence, 50144 Firenze, Italy 7CNR-IBE National Research Council Institute of BioEconomy, 50019 Sesto F.no, Firenze, Italy 8Bluebiloba Startup Innovativa SRL, Firenze, Italy 9Department of Earth and Environmental Science, New Mexico Tech, New Mexico, Socorro, USA SlideforMAP and SOSlope are part of a suite of software available through ecorisQ (www.ecorisq.org), an international, non-profit association promoting solutions for risk reduction of natural hazards. SlideforMap is a probabilistic model that quantifies the stabilizing effect of vegetation at the regional scale and localizes potential areas where forest protection could be improved. SOSlope is a hydro-mechanical model that computes the factor of safety at the slope scale, using a strain-step discrete element method, which includes the effects of vegetation root structure and composition. -

Passion for Cycling Tourism
TUSCANY if not HERE, where? PASSION FOR CYCLING TOURISM Tuscany offers you • Unique landscapes and climate • A journey into history and art: from Etruscans to Renaissance down to the present day • An extensive network of cycle paths, unpaved and paved roads with hardly any traffic • Unforgettable cuisine, superb wines and much more ... if not HERE, where? Tuscany is the ideal place for a relaxing cycling holiday: the routes are endless, from the paved roads of Chianti to trails through the forests of the Apennines and the Apuan Alps, from the coast to the historic routes and the eco-paths in nature photo: Enrico Borgogni reserves and through the Val d’Orcia. This guide has been designed to be an excellent travel companion as you ride from one valley, bike trail or cultural site to another, sometimes using the train, all according to the experiences reported by other cyclists. But that’s not all: in the guide you will find tips on where to eat and suggestions for exploring the various areas without overlooking small gems or important sites, with the added benefit of taking advantage of special conditions reserved for the owners of this guide. Therefore, this book is suitable not only for families and those who like easy routes, but can also be helpful to those who want to plan multiple-day excursions with higher levels of difficulty or across uscanyT for longer tours The suggested itineraries are only a part of the rich cycling opportunities that make Tuscany one of the paradises for this kind of activity, and have been selected giving priority to low-traffic roads, white roads or paths always in close contact with nature, trying to reach and show some of our region’s most interesting destinations. -

Arezzo-Patovecchio-Stia.Pdf
IN CASO DI SCIOPERO O TRASPORTO FERROVIARIO TOSCANO S.p.A. TRASPORTO FERROVIARIO TOSCANO S.p.A. DI VARIAZIONI IN CASO DI SCIOPERO O DI PROGRAMMATE AL VARIAZIONI PROGRAMMATE SERVIZIO, SARANNO AL SERVIZIO, SARANNO AFFISSI OPPORTUNI AFFISSI OPPORTUNI AVVISI AI AVVISI AI VIAGGIATORI VIAGGIATORI NELLE NELLE STAZIONI E STAZIONI E FERMATE. FERMATE. ORARIO DAL 11 GIUGNO 2019 AL 14 DICEMBRE 2019 ORARIO DAL 11 GIUGNO 2019 AL 14 DICEMBRE 2019 INFORMAZIONI AL N. VERDE: INFORMAZIONI AL N. LE CORRISPONDENZE CON I TRENI DI ALTRE IMPRESE DOVRANNO VERDE: Riduzione Servizio: dal 11/6 al 15/9 LE CORRISPONDENZE CON I TRENI DI ALTRE IMPRESE Riduzione Servizio: dal 11/6 al 15/9 ESSERE VERIFICATE DAI VIAGGIATORI CONSULTANDO AL DOVRANNO ESSERE VERIFICATE DAI VIAGGIATORI MOMENTO IL RELATIVO ORARIO PUBBLICO. 800.922.984 Festivi: domenica e 15/8 - 1/11 - 8/12 CONSULTANDO AL MOMENTO IL RELATIVO ORARIO PUBBLICO. 800.922.984 Festivi: domenica e 15/8 - 1/11 - 8/12 TRENI AREZZO PRATOVECCHIO STIA TRENI PRATOVECCHIO STIA AREZZO TRENO n° 1156 1160 1162 1164 b168 1168 1170 b172 1672 6172 6174 b178 6178 1180 6182 b184 1184 b186 1186 1190 b192 1192 1194 TRENO n° 1151 1153 1155 6157 6159 b159 1159 1161 1163 b167 6167 6171 6173 b175 6175 b179 1179 6181 1183 b185 1185 b187 1187 categoria (v. note) RL RL RL RL BUS RL RL BUS RL RL RL BUS RL RL RL BUS RL BUS RL RL BUS RL RL categoria (v. note) RL RL RL RL RL BUS RL RL RL BUS RL RL RL BUS RL BUS RL RL RL BUS RL BUS RL LIMITAZIONI (v. -

Get App Autumn in Casentino
Autumn in Casentino, Tuscany To admire the more photogenic colors, savor the most authentic flavors and discover the lesser-known villages and monuments, come with us to the Casentino, the higher ground and upper valley of the Arno river. Autumn is a second spring, when every leaf is a flower (Albert Camus) CONSUMA PASS CASTEL SAN NICCOLO’ The Casentino covers a valley running roughly Castel San Niccolò is a superb example of between Florence and Siena and belongs to medieval architecture. It is scattered in numerous the province of Arezzo. For convenience, our ancient hamlets. Of particular interest is the 1 journey starts in Florence, but you can decide to 4 parish of San Martino in Vado, an start in Arezzo or in other places in Tuscany and 11th-century Romanesque church that is re-arrange the itinerary as you prefer. perfectly preserved and whose creation is owed Arriving from Florence you'll cross the Consuma to the famous Countess Matilde di Canossa. In Pass (1050 m elevation): a perfect spot for a Castel San Niccolò stop at one of the traditional autumn snack: schiacciata flat bread Prosciutto del Casentino producers and stuffed with mushrooms. taste one of the famous local cold cuts made with pigs raised outdoor. STIA In Stia, often called the "source of the Arno", POPPI although the real source is in “Capo d’Arno” Because it is strategically placed with trade routes admire Porciano Castle, the Church of St. Mary passing through it, Casentino has been a much 2 delle Grazie and the Florentine Palagio. disputed area in the past; today’s legacy includes North of Stia (at 1380 m on Monte Falterona) 5 some really outstanding castles and fortifications. -
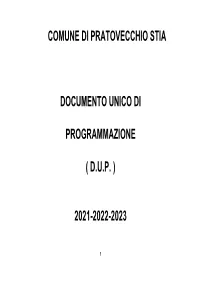
Comune Di Pratovecchio Stia Documento Unico Di Programmazione
COMUNE DI PRATOVECCHIO STIA DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE ( D.U.P. ) 2021-2022-2023 1 INDICE GENERALE PREMESSA 1. La sezione strategica 2. L’analisi di contesto 2.1. Popolazione 2.2. Condizione socio-economica delle famiglie 2.3. Economia insediata 2.4. Territorio 2.5. Struttura organizzativa 2.6. Strutture operative 2.7. Organismi e modalità di gestione dei servizi pubblici locali - Organismi gestionali 2.7.1. Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente 2.7.2. Società partecipate 3. Accordi di programma 4. Altri strumenti di programmazione negoziata 5. Funzioni esercitate su delega 6. Indirizzi generali di natura strategica relativi alle risorse e agli impieghi e sostenibilità economico finanziaria attuale e prospettica 6.1. Gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche 6.2. Fonti di finanziamento 6.3. Analisi delle risorse 6.3.1. Entrate tributarie 6.3.2. Entrate da contributi e trasferimenti correnti 6.3.3. Entrate da proventi extra-tributari 6.3.4. Analisi delle risorse finanziarie in conto capitale 6.3.5. Futuri mutui 6.3.6. Verifica limiti di indebitamento 6.3.7. Proventi dei servizi dell'ente 6.3.8. Proventi della gestione dei beni dell'ente 2 6.4. Equilibri di bilancio 6.5. Quadro generale riassuntivo 7. Linee programmatiche di mandato 7.1. Stato di attuazione delle linee programmatiche di mandato 2021 – 2023 8. Ripartizione delle linee programmatiche di mandato declinate in missioni e programmi 9. La sezione operativa 10. Gli investimenti 11. Servizi e forniture 12. La spesa per le risorse umane 13. Le variazioni del patrimonio 14. Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa 15. -

Tabelle Viciniorità
SISTEMA INFORMATIVO DEL MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE SS-13-HA-XXO25 27/02/16 TABELLA DI VICINIORITA' PAG. 1 PROVINCIA DI: AREZZO IDENTIFICATIVO ZONALE A291 030 DESCRIZIONE ANGHIARI PRG DENOMINAZIONE IDZ CAP PRG DENOMINAZIONE IDZ CAP 1 SANSEPOLCRO I155 030 52037 2 MONTERCHI F594 030 52035 3 CAPRESE MICHELANGELO B693 030 52033 4 PIEVE SANTO STEFANO G653 030 52036 5 AREZZO A390 031 52100 6 CAPOLONA B670 031 52010 7 SUBBIANO I991 031 52010 8 CIVITELLA IN VAL DI CHIANA C774 031 52040 9 BADIA TEDALDA A541 030 52032 10 CASTIGLION FIORENTINO C319 032 52043 11 MONTE SAN SAVINO F628 031 52048 12 CASTIGLION FIBOCCHI C318 031 52029 13 MARCIANO DELLA CHIANA E933 032 52047 14 FOIANO DELLA CHIANA D649 032 52045 15 LUCIGNANO E718 032 52046 16 CORTONA D077 032 52044 17 LATERINA E468 028 52020 18 PERGINE VALDARNO G451 028 52020 19 CHIUSI DELLA VERNA C663 029 52010 20 BUCINE B243 028 52021 21 MONTEVARCHI F656 028 52025 22 SAN GIOVANNI VALDARNO H901 028 52027 23 CASTEL FOCOGNANO C102 029 52016 24 BIBBIENA A851 029 52011 25 CHITIGNANO C648 029 52010 26 POPPI G879 029 52014 27 SESTINO I681 030 52038 28 PRATOVECCHIO STIA M329 029 52017 29 TALLA L038 029 52010 30 ORTIGNANO RAGGIOLO G139 029 52010 31 LORO CIUFFENNA E693 028 52024 32 TERRANUOVA BRACCIOLINI L123 028 52028 33 CAVRIGLIA C407 028 52022 34 CASTELFRANCO PIANDISCO M322 028 52020 35 CASTEL SAN NICCOLO' C263 029 52018 36 MONTEMIGNAIO F565 029 52010 SISTEMA INFORMATIVO DEL MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE SS-13-HA-XXO25 27/02/16 TABELLA DI VICINIORITA' PAG. -

2.1 Il PIT – Piano Di Indirizzo Territoriale Regionale
19 2. Il Quadro di riferimento sovracomunale: piani/programmi di area vasta e gli strumenti della pianificazione sovraordinata 2.1 Il P.I.T. – Piano di Indirizzo Territoriale regionale La ricerca di una comune sinergia tra gli obiettivi, gli indirizzi e le scelte di piano degli strumenti di competenza della Regione e della Provincia e quelli locali interni al Piano Strutturale, auspicata come si è accennato sulla legislazione toscana regionale per garantire un organico e funzionale sistema di programmazione e pianificazione, ha impegnato il gruppo di lavoro fin dall’atto di avvio del procedimento sia per caratterizzare il quadro conoscitivo e le linee di sviluppo dell’area, ma soprattutto per rendere conformi i criteri e le direttive del Piano Strutturale alle prescrizioni del PIT regionale e del Piano di Coordinamento provinciale. Per quanto riguarda il PIT, (approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n.12 del 25 Gennaio 2000) questo strumento rappresenta l’atto di programmazione con il quale la Regione Toscana in attuazione della legge urbanistica e in conformità con le indicazioni del Programma Regionale di Sviluppo, stabilisce gli orientamenti per la pianificazione degli Enti Locali e definisce gli obiettivi operativi della propria politica territoriale. Rappresenta cioè lo strumento regionale per il governo del territorio che individua e indirizza le politiche territoriali a carattere strategico che appaiono necessarie per innescare processi di miglioramento delle condizioni di sviluppo, per ricercare elementi di maggiore -

Valori Agricoli Medi Della Provincia Annualità 2017
Ufficio del territorio di AREZZO Data: 16/03/2017 Ora: 14.41.13 Valori Agricoli Medi della provincia Annualità 2017 Dati Pronunciamento Commissione Provinciale Pubblicazione sul BUR n.1 del 28/02/2017 n.- del - REGIONE AGRARIA N°: 1 REGIONE AGRARIA N°: 2 CASENTINO ALTO TEVERE Comuni di: BIBBIENA, CASTEL FOCOGNANO, CASTEL SAN NICCOLO, Comuni di: BADIA TEDALDA, CAPRESE MICHELANGELO, PIEVE CHITIGNANO, CHIUSI DELLA VERNA, MONTEMIGNAIO, SANTO STEFANO, SESTINO ORTIGNANO RAGGIOLO, POPPI, PRATOVECCHIO, STIA, SUBBIANO, TALLA, PRATOVECCHIO STIA COLTURA Valore Sup. > Coltura più Informazioni aggiuntive Valore Sup. > Coltura più Informazioni aggiuntive Agricolo 5% redditizia Agricolo 5% redditizia (Euro/Ha) (Euro/Ha) BOSCO CEDUO E MISTO 4000,00 SI SI 4000,00 SI SI BOSCO D`ALTO FUSTO 4600,00 4400,00 CASTAGNETO DA FRUTTO 5000,00 5800,00 COLTURE IN SERRA 50000,00 11-DA VALUTARE A PARTE 50000,00 11-DA VALUTARE A PARTE GLI IMPIANTI E GLI IMPIANTI E ATTREZZATURE FISSE) ATTREZZATURE FISSE) COLTURE ORTIVE A PIENO CAMPO 50000,00 50000,00 FRUTTETO SPECIALIZZATO 18000,00 11-DA VALUTARE A PARTE 13000,00 7-TRATTASI DI IMPIANTI DI GLI IMPIANTI E ETA MEDIA A PARTIRE ATTREZZATURE FISSE) DALLA MESSA IN DIMORA) 7-TRATTASI DI IMPIANTI DI 11-DA VALUTARE A PARTE ETA MEDIA A PARTIRE GLI IMPIANTI E DALLA MESSA IN DIMORA) ATTREZZATURE FISSE) Pagina: 1 di 12 Ufficio del territorio di AREZZO Data: 16/03/2017 Ora: 14.41.13 Valori Agricoli Medi della provincia Annualità 2017 Dati Pronunciamento Commissione Provinciale Pubblicazione sul BUR n.1 del 28/02/2017 n.- del - INCOLTO PRODUTTIVO E STERILE 1500,00 9-TERRENO NON IDONEO 1500,00 6-TERRENO NON IDONEO ALLA COLTIVAZIONE CHE, ALLA COLTIVAZIONE CHE SENZA INTERVENTO DELLA DIA SPONTANEAMENTE UN MANO DELL UOMO, DIA UN PRODOTTO VALUTABILE PRODOTTO VALUTABILE ANCHE MINIMO) ANCHE MINIMO. -

ALLEGATO 1 Relazioni Di Traffico
Contratto di servizio per il trasporto pubblico ferroviario di interesse regionale e locale 2015-2023 tra Regione Toscana e Trasporto Ferroviario Toscano ALLEGATO 1 Relazioni di traffico Il presente allegato è composto da numero 1 pagina oltre la copertina Allegato 1 Relazione Arezzo – Stia treni feriali autobus feriali autobus festivi per Stia per Arezzo per Stia per Arezzo per Stia per Arezzo 1156 1153 b1194 b168 b159 6158 1155 b172 b167 1160 6157 b178 b175 1162 1157 b184 b179 1164 1159 b186 b185 1170 1161 b192 b187 1172 1163 1174 6167 6176 6171 6178 6173 1180 6175 6182 1179 1184 6181 1186 1183 1190 1185 1192 1187 Relazione Arezzo - Sinalunga treni feriali autobus feriali autobus festivi per Sinalun per Arezzo per Sinal per Arezzo per Sinal per Arezzo 6007 1004 b27 b26 1009 1006 b39 b30 1017 6008 1019 1010 1021 1012 6023 1018 6025 6022 6027 6026 6029 6028 1033 6030 1037 1032 1039 1038 6043 6040 Le corse evidenziate presentano delle particolarità di circolazione per le quali si rimanda al Programma di Esercizio di cui all'Allegato 2 I servizi sostitutivi bus sono trasferiti in corso di esecuzione del contratto al gestore unico regionale dei servizi su gomma 1 Contratto di servizio per il trasporto pubblico ferroviario di interesse regionale e locale 2015-2023 tra Regione Toscana e Trasporto Ferroviario Toscano ALLEGATO 2 Programma d’esercizio Il presente allegato è composto da numero7 pagine oltre la copertina Allegato 2 Sinalunga - Arezzo n° giorni n° treno / composiz garantito in tempo tempo mezzo posti origine destinazione ore p. ore a. -

Comune Di Montevarchi Provincia Di Arezzo
COMUNE DI MONTEVARCHI PROVINCIA DI AREZZO DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 22 DEL 28/03/2019 OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI (TARI), ANNO 2019. 1) APPROVAZIONE DEL PEF (PIANO ECONOMICO FINANZIARIO) PER L’ANNO 2019. 2) APPROVAZIONE TARIFFE PER L'ANNO 2019. 3) DIFFERIMENTO DEL TERMINE PER IL PAGAMENTO DELLA PRIMA RATA PER L'ANNO 2019. L'anno 2019, il giorno ventotto del mese di Marzo alle ore 14:30 nella sala consiliare si è riunito il Consiglio Comunale. Risultano presenti: Pres. Ass. CHIASSAI MARTINI SILVIA Sindaco X ROSSI CLAUDIO Presidente X ALLEGRUCCI LORENZO Consigliere X BECATTINI LORENZO Consigliere X VELOTTO ARTURO Consigliere X BENCINI ALESSANDRA Consigliere X LUCCHESINI FRANCESCA Consigliere X RENZI FRANCESCO Consigliere X GHEZZI MARIO Consigliere X LOMBARDI TIZIANA Consigliere X PESUCCI ANDREA Consigliere X RICCI PAOLO ANTONIO Consigliere X GRASSO FRANCESCO MARIA Consigliere X NORCI CARLO Consigliere X BERTINI ELISA Consigliere X NERI FRANCESCA Consigliere X CAMICIOTTOLI FABIO Consigliere X TOTALE 13 4 Presiede il Presidente del Consiglio Comunale, Claudio Rossi. Partecipa alla seduta il Segretario Generale, dDott.ssa Milaneschi Rita. Partecipa alla seduta il Segretario della Presidenza del Consiglio Comunale. Grasso contesta l'urgenza sull'atto. Presidente: l'atto è stato dato a tutti lunedì scorso. Grasso esce presenti 12. Camiciottoli: non abbiamo il parere del revisore dei conti. Lamenta come si è operato. Spiega Bucciarelli. C'è un refuso (parte deliberativa 3 va cassato da “confermando ...in poi). Camiciottoli ho l'impressione che si giochi. Il tempo di esame è stato poco. Il costo del servizio aumenta del 7%. Non si è inciso sul servizio come si doveva. -

3 Primariaprospettoxruoli Rev2
TipoP CODICE Progressiv Assegnato a il Asegnato a il Tipo osto Ist IstNome SCUOLA TIPO SCUOLA COMUNE o POSTO 19/08/2019 (GM) 27/08/2019 (GM/GAE) AN ARIC81100B I.C. PETRARCA AREE81101D NORMALE MONTEVARCHI 1 Magini Riccarda AN ARIC81100B I.C. PETRARCA AREE81101D NORMALE MONTEVARCHI 2 Croce Ivana AN ARIC81100B I.C. PETRARCA AREE81101D NORMALE MONTEVARCHI 3 Cuccorese Claudia AN ARIC81100B I.C. PETRARCA AREE81101D NORMALE MONTEVARCHI 4 Maiello AN ARIC81100B I.C. PETRARCA AREE81101D NORMALE MONTEVARCHI 5 Fratini Cristina AN ARIC812007 I.C. ALTO CASENTINO - STIA AREE81202A NORMALE PRATOVECCHIO STIA 1 Iacchi Marina GM AN ARIC812007 I.C. ALTO CASENTINO - STIA AREE81202A NORMALE PRATOVECCHIO STIA 2 Faltoni Monica GAE AN ARIC812007 I.C. ALTO CASENTINO - STIA AREE81202A NORMALE PRATOVECCHIO STIA 3 Feola Bruna GAE AN ARIC812007 I.C. ALTO CASENTINO - STIA AREE81202A NORMALE PRATOVECCHIO STIA 4 Marino Annita Maria AntoniettaGAE AN ARIC812007 I.C. ALTO CASENTINO - STIA AREE81202A NORMALE PRATOVECCHIO STIA 5 AN ARIC81600E I.C. GIOVANNI XXIII AREE81601L NORMALE TERRANUOVA BRACCIOLINI 1 Tancredi Rosella AN ARIC81700A I. C. DON LORENZO MILANI AREE81703E NORMALE CASTELFRANCO PIANDISCO' 1 Agnolucci Giada AN ARIC820006 "F.MOCHI" LEVANE AREE82004B NORMALE MONTEVARCHI 1 Grazzini Chiara AN ARIC820006 "F.MOCHI" LEVANE AREE82004B NORMALE MONTEVARCHI 2 Lampo Giovanna AN ARIC820006 "F.MOCHI" LEVANE AREE82004B NORMALE MONTEVARCHI 3 Nardi Sandra AN ARIC820006 "F.MOCHI" LEVANE AREE82004B NORMALE MONTEVARCHI 4 Carrozza Filomena GM AN ARIC820006 "F.MOCHI" LEVANE AREE82004B -

Capitolato Ultimo
COMUNE DI BIBBIENA (Provincia di Arezzo) CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA BIBBIENA-SUBBIANO-CASTIGLION FIORENTINO-PRATOVECCHIO STIA OC CENTRALE UNICA DI COMMITTENTA TRA I COMUNI DI BIBBIENA – SUBBIANO - CASTIGLION FIORENTINO – PRATOVECCHIO STIA CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO PROCEDURA APERTA SVOLTA IN MODALITÀ TELEMATICA PER LA PARZIALE ESTERNALIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO DEL COMUNE DI CASTIGLION FIORENTINO (in esecuzione della Determinazione del Responsabile del Settore 3 n. 589 del 06/06/2019) CIG: 7929404F2B INDICE TITOLO I CARATTERISTICHE GENERALI DEL SOGGETTO AFFIDANTE Art. 1 – Amministrazione aggiudicatrice Art. 2 – Luogo di espletamento dei servizi TITOLO II CONDIZIONI GENERALI DELL’AFFIDAMENTO Art. 3 – Oggetto dell’affidamento Art. 4 – Modalità di esecuzione del servizio Art. 5 – Caratteristiche dei mezzi Art. 6 – Durata del contratto Art. 7 – Entità dell’appalto Art. 8 – Personale Art. 9 – Obblighi assicurativi e responsabilità Art.10 – Obbligatorietà della presa visione dei percorsi TITOLO III ADEMPIMENTI CONSEGUENTI ALL’AGGIUDICAZIONE Art. 11 – Periodo di prova Art. 12 – Controllo del servizio: verifica di conformità Art. 13 – Corrispettivo Art. 14 – Penali Art. 15 – Risoluzione del contratto Art. 16 – Variazioni del contratto Art. 17 – Servizi aggiuntivi Art. 18 – Stipula del contratto Art. 19 – Cauzione definitiva Art. 20 – Spese contrattuali 1 COMUNE DI BIBBIENA (Provincia di Arezzo) CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA BIBBIENA-SUBBIANO-CASTIGLION FIORENTINO-PRATOVECCHIO STIA Art. 21 – Controversie e Commissione arbitrale Art. 22 – Riferimenti alle leggi TITOLO I CARATTERISTICHE GENERALI DEL SOGGETTO AFFIDANTE In esecuzione della determinazione a contrarre del Responsabile del Settore 3 “Tecnico, Trasporti, Patrimonio” N.589 del 06/06/2019 per il tramite della Centrale Unica di Committenza Bibbiena – Subbiano – Castiglion Fiorentino – Pratovecchio Stia, in attuazione di quanto disposto dall’art.