Conchig,L,Ie I
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
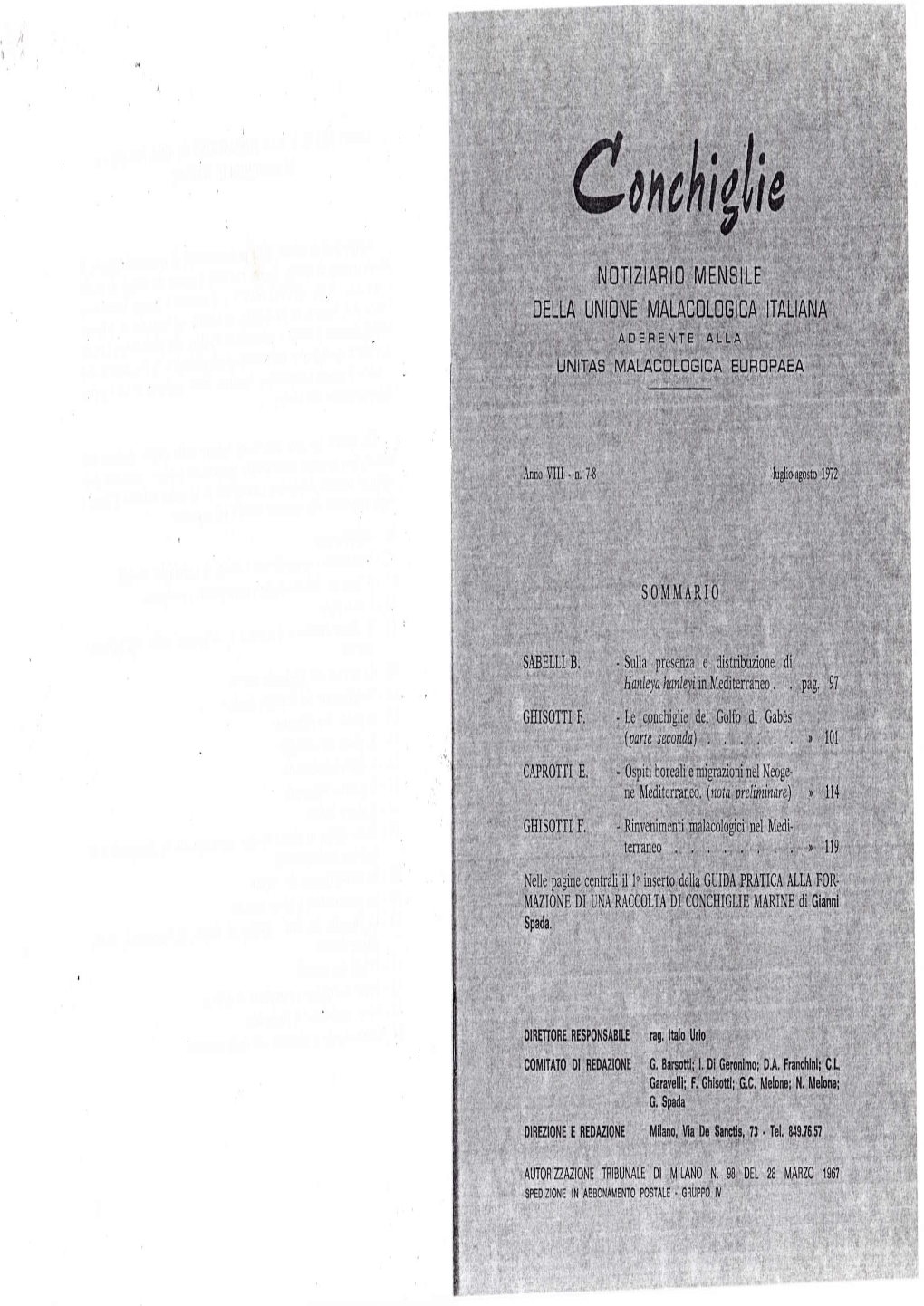
Load more
Recommended publications
-

Chrysallida, Ondina (S.N
BASTERIA, 60: 45-56, 1996 Nordsieck’s Pyramidellidae (Gastropoda Prosobranchia): A revision of his types. Part 1: The genera Chrysallida, Ondina (s.n. Evalea) and Menestho J.J. van Aartsen Adm. Helfrichlaan 33, 6952 GB Dieren, The Netherlands & H.P.M.G. Menkhorst Natuurmuseum Rotterdam, P.O. Box 23452, 3001 KL Rotterdam, The Netherlands In the seventies F. Nordsieck introduced many new nominal taxa in the Pyramidellidae His material ofthe (Opisthobranchia). original genera Chrysallida, Ondina (s.n. Evalea) and Menestho has been revised. For some taxa lectotypes are designated. For Odostomia (Evalea) elegans A. is described. Adams, 1860, a neotype is designated. In addition Ondina jansseni sp. nov. Key words: Gastropoda,Opisthobranchia, Pyramidellidae, Chrysallida, Ondina, Evalea, Menestho, nomenclature. INTRODUCTION In the beginning of the seventies, many new nominal taxa of Atlantic and Mediter- ranean Pyramidellidae were published by F. Nordsieck. These taxa have been a source of difficulty ever since, because the descriptions were not always good enough for The if of Nordsieck's hand and had recognition. figures, published anyway, were own to more artistic than scientific value. It has therefore been a longstanding wish critically revise all these the basis of the material. taxa on type Thanks to the highly appreciated help ofDr. RonaldJanssen, curator of the Mollusca in the Senckenberg Museum, Frankfurt, Germany, we were able to consult the collec- tion of F. Nordsieck, now in the collection of that museum. A ofall with has summary new taxa, references, already been published by R. Janssen (1988). From this list, containing the names of more than 400 alleged new species, varieties it becomes obvious that it is task for subspecies, or forms, an impossible any author to revise these all. -

Coen's Pyramidellidae (Gastropoda Heterobranchia): a Revision of Types
Biodiversity Journal, 2015, 6 (1): 415–430 MONOGRAPH Coen’s Pyramidellidae (Gastropoda Heterobranchia): a revision of types Pasquale Micali1*, Italo Nofroni2, Riccardo Giannuzzi Savelli3, Francesco Pusateri4 & Stefano Bartolini5 1Via Papiria 17, 61032 Fano, Pesaro-Urbino, Italy; e-mail: [email protected] 2Via B. Croce 97, 00142 Roma, Italy; e-mail: [email protected] 3Via Mater Dolorosa 54, 90146 Palermo, Italy; e-mail: [email protected] 4Via Castellana 64, 90135 Palermo, Italy; e-mail: [email protected] 5Via E. Zacconi 16, 50137 Florence, Italy; e-mail: [email protected] *Corresponding author ABSTRACT Coen introduced several new nominal taxa in the Pyramidellidae and in most Mollusca families. The Coen types, now at the Hebrew University of Jerusalem, have been examined; most of them are holotypes or lectotypes. Some lectotypes were already selected by van Aartsen, as stated in the label, therefore we have not done any further selection of types. The new pyramidellid species have been practically identified and named by Monterosato, and were all found in shell grit collected on the beach of Lido (a small island in front of Venice). None of the Coen’s new species seems to be valid. KEY WORDS Coen collection; Pyramidellidae; Adriatic Sea; Mediterranean Sea. Received 29.10.2014; accepted 20.12.2014; printed 30.03.2015 Proceedings of the Eighth Malacological Pontine Meeting, October 4th- 5th, 2014 - San Felice Circeo, Italy INTRODUCTION The first Coen’s work is dated 1914, when he was about 40 years old, but his name was already Giorgio Silvio Coen (1873-1951) was born in present in the malacological world, because there Venice, graduated as a civil engineer in the presti- was a Turbonilla coeni Preston, 1905 possibly gious University of Padua and spent his life in (because the Author did not indicate the origin of Venice. -

The Ultrastructure of Spermatozoa and Spermiogenesis in Pyramidellid Gastropods, and Its Systematic Importance John M
HELGOLANDER MEERESUNTERSUCHUNGEN Helgol~inder Meeresunters. 42,303-318 (1988) The ultrastructure of spermatozoa and spermiogenesis in pyramidellid gastropods, and its systematic importance John M. Healy School of Biological Sciences (Zoology, A08), University of Sydney; 2006, New South Wales, Australia ABSTRACT: Ultrastructural observations on spermiogenesis and spermatozoa of selected pyramidellid gastropods (species of Turbonilla, ~gulina, Cingufina and Hinemoa) are presented. During spermatid development, the condensing nucleus becomes initially anterio-posteriorly com- pressed or sometimes cup-shaped. Concurrently, the acrosomal complex attaches to an electron- dense layer at the presumptive anterior pole of the nucleus, while at the opposite (posterior) pole of the nucleus a shallow invagination is formed to accommodate the centriolar derivative. Midpiece formation begins soon after these events have taken place, and involves the following processes: (1) the wrapping of individual mitochondria around the axoneme/coarse fibre complex; (2) later internal metamorphosis resulting in replacement of cristae by paracrystalline layers which envelope the matrix material; and (3) formation of a glycogen-filled helix within the mitochondrial derivative (via a secondary wrapping of mitochondria). Advanced stages of nuclear condensation {elongation, transformation of fibres into lamellae, subsequent compaction) and midpiece formation proceed within a microtubular sheath ('manchette'). Pyramidellid spermatozoa consist of an acrosomal complex (round -

Nachruf Fritz Nordsieck (Aus Archiv Für Molluskenkunde 118)
Band 118 Nummer 4/6 Archiv für Molluskenkunde der Senckenber gischen Natur forschenden Gesellschaft Organ der Deutschen Malakozoologischen Gesellschaft Begründet von Prof. Dr. W. K obelt Weitergeführt von Dr.W. W enz, Dr. F. H aas und Dr. A. Zilch Herausgegeben von Dr. R. J anssen Arch. Moll. | 118 (1987) | (4/6) 1 105-128 | Frankfurt am Main, 01. 07. 1988 Fritz Nordsieck (1906-1984) 105 Am 23.5.1984 verstarb im Alter von 78 Jahren Dr.F ritz N ordsieck, der mit seinen Büchern über die europäischen Meeresmollusken weit über Deutschland hinaus bekannt geworden war. F ritz N ordsieck wurde am 8.3.1906 als drittes von vier Kindern eines kaufmänni schen Angestellten in Düsseldorf geboren. Trotz widriger Umstände — sein Vater war Kriegsinvalide geworden, die Mutter frühzeitig gestorben — nahmF ritz N ordsieck nach dem Abitur das Studium der Wirtschafts- und Sozialwissenschaften auf. Sein Studium an der Universität Köln von 1925—1930 mußte er sich durch Eigenarbeit und Darlehen selbst finanzieren. Nach der Promotion war er an der Universität Köln zunächst als wissen schaftlicher Assistent in den Fächern Betriebswirtschaft und Betriebsorganisation tätig, bevor er ab 1934 wissenschaftlicher Referent am Deutschen Gemeindetag in Berlin wurde. In dieser Zeit fungierteN ordsieck auch als Hauptschriftleiter der Zeitschrift für öffentli che Wirtschaft. Eine Habilitation scheiterte 1936 aus politischen Gründen. Während der Zeit in Berlin verfaßte N ordsieck etliche Bücher über Betriebsorganisation, Organisa tionslehre und kommunale Verwaltung, die in mehreren Auflagen erschienen. 1934 heirateteF ritz N ordsieck nach gemeinsamem Studium und Assistententätigkeit seine Frau H ildegard. Es wurden ihnen fünf Kinder geboren, von denen sich sein Sohn H artmut ebenfalls der Malakologie zugewandt hat. -

Turritella Communis (Risso, 1826)
ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΗΣ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑΣ ΜΙΚΡΟΠΑΛΑΙΟΝΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΙΖΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια Αρκαδιανού Μαρία Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: Γεραγά Μαρία Τριμελής Επιτροπή: Γεραγά Μαρία Παπαθεοδώρου Γεώργιος Ηλιόπουλος Γεώργιος 0 Πάτρα, 2019 Αφιερώνεται στην οικογένειά μου που με στηρίζει σε κάθε νέο ξεκίνημα σε κάθε απόφαση… Ευχαριστίες… Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους καθηγητές Γεραγά Μαρία και Παπαθεοδώρου Γεώργιο που μου έδωσαν τη δυνατότητα να εκπονήσω τη διπλωματική μου εργασία στον τομέα της Περιβαλλοντικής Ωκεανογραφίας δείχνοντάς μου εμπιστοσύνη και προσφέροντάς μου πολύτιμη βοήθεια. Τον καθηγητή μου Ηλιόπουλο Γεώργιο και την Δρ. Παπαδοπούλου Πηνελόπη για την πολύτιμη βοήθεια τους, την καθοδήγηση, τις χρήσιμες συμβουλές και τη στήριξη. Την Υποψήφια Διδάκτορα Τσώνη Μαρία για τις συμβουλές της στο χειρισμό ορισμένων λογισμικών. Την Υποψήφια Διδάκτορα Πρανδέκου Αμαλία για τις συμβουλές της. Τον φίλο μου Ανδρέα για τη στήριξη και την υπομονή του. Τέλος, θέλω να εκφράσω ένα μεγάλο ευχαριστώ στην οικογένειά μου που με στήριξε με κάθε τρόπο σε όλη τη διάρκεια των σπουδών μου και υπήρξαν σημαντικοί αρωγοί όλα αυτά τα χρόνια. 1 Ευχαριστίες……………………………………………………………………………………………………….....................1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ………………………………………………………………………………………………………………………………3 Σκοπός…………………………………………………………………………………………………..................3 1. ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΛΕΤΗΣ………………………………………………………………………………………………3 1.1Γενικά …………………………………………………………………………………………………………………3 -

The Lower Pliocene Gastropods of Le Pigeon Blanc (Loire- Atlantique, Northwest France). Part 5* – Neogastropoda (Conoidea) and Heterobranchia (Fine)
Cainozoic Research, 18(2), pp. 89-176, December 2018 89 The lower Pliocene gastropods of Le Pigeon Blanc (Loire- Atlantique, northwest France). Part 5* – Neogastropoda (Conoidea) and Heterobranchia (fine) 1 2 3,4 Luc Ceulemans , Frank Van Dingenen & Bernard M. Landau 1 Avenue Général Naessens de Loncin 1, B-1330 Rixensart, Belgium; email: [email protected] 2 Cambeenboslaan A 11, B-2960 Brecht, Belgium; email: [email protected] 3 Naturalis Biodiversity Center, P.O. Box 9517, 2300 RA Leiden, Netherlands; Instituto Dom Luiz da Universidade de Lisboa, Campo Grande, 1749-016 Lisboa, Portugal; and International Health Centres, Av. Infante de Henrique 7, Areias São João, P-8200 Albufeira, Portugal; email: [email protected] 4 Corresponding author Received 25 February 2017, revised version accepted 7 July 2018 In this final paper reviewing the Zanclean lower Pliocene assemblage of Le Pigeon Blanc, Loire-Atlantique department, France, which we consider the ‘type’ locality for Assemblage III of Van Dingenen et al. (2015), we cover the Conoidea and the Heterobranchia. Fifty-nine species are recorded, of which 14 are new: Asthenotoma lanceolata nov. sp., Aphanitoma marqueti nov. sp., Clathurella pierreaimei nov. sp., Clavatula helwerdae nov. sp., Haedropleura fratemcontii nov. sp., Bela falbalae nov. sp., Raphitoma georgesi nov. sp., Raphitoma landreauensis nov. sp., Raphitoma palumbina nov. sp., Raphitoma turtaudierei nov. sp., Raphitoma vercingetorixi nov. sp., Raphitoma pseudoconcinna nov. sp., Adelphotectonica bieleri nov. sp., and Ondina asterixi nov. sp. One new name is erected: Genota maximei nov. nom. is proposed for Pleurotoma insignis Millet, non Edwards, 1861. Actaeonidea achatina Sacco, 1896 is considered a junior subjective synonym of Rictaxis tornatus (Millet, 1854). -

NEAT Mollusca
NEAT (North East Atlantic Taxa): Scandinavian marine Mollusca Check-List compiled at TMBL (Tjärnö Marine Biological Laboratory) by: Hans G. Hansson 1994-02-02 / small revisions until February 1997, when it was published on Internet as a pdf file and then republished August 1998.. Citation suggested: Hansson, H.G. (Comp.), NEAT (North East Atlantic Taxa): Scandinavian marine Mollusca Check-List. Internet Ed., Aug. 1998. [http://www.tmbl.gu.se]. Denotations: (™) = Genotype @ = Associated to * = General note PHYLUM, CLASSIS, SUBCLASSIS, SUPERORDO, ORDO, SUBORDO, INFRAORDO, Superfamilia, Familia, Subfamilia, Genus & species N.B.: This is one of several preliminary check-lists, covering S Scandinavian marine animal (and partly marine protoctistan) taxa. Some financial support from (or via) NKMB (Nordiskt Kollegium för Marin Biologi), during the last years of the existence of this organization (until 1993), is thankfully acknowledged. The primary purpose of these checklists is to faciliate for everyone, trying to identify organisms from the area, to know which species that earlier have been encountered there, or in neighbouring areas. A secondary purpose is to faciliate for non-experts to put as correct names as possible on organisms, including names of authors and years of description. So far these checklists are very preliminary. Due to restricted access to literature there are (some known, and probably many unknown) omissions in the lists. Certainly also several errors may be found, especially regarding taxa like Plathelminthes and Nematoda, where the experience of the compiler is very rudimentary, or. e.g. Porifera, where, at least in certain families, taxonomic confusion seems to prevail. This is very much a small modernization of T. -

Heterobranchia (Gastropoda) from the Jurassic Deposits of Russia A
ISSN 0031-0301, Paleontological Journal, 2019, Vol. 53, No. 11, pp. 1162–1187. © Pleiades Publishing, Ltd., 2019. Heterobranchia (Gastropoda) from the Jurassic Deposits of Russia A. V. Guzhov* Borissiak Paleontological Institute, Russian Academy of Sciences, Moscow, 117647 Russia *e-mail: [email protected] Received March 11, 2018; revised November 30, 2018; accepted December 28, 2018 Abstract—Small gastropods from the Jurassic deposits of the European Russia, united into the lower Hetero- branchia or Allogastropoda, are described. The families of Ampezzanildidae, Cimidae, Cornirostridae, Ebal- idae, and Stuoraxidae are distinguished, and a set of taxa is given without reference to a definite family. The family Ampezzanildidae from the Jurassic deposits is described for the first time on the basis of the mass material, ascribed to the new genus Zizipupa gen. nov. with the sole species of Z. costata sp. nov. The family Cim- idae includes the genera of Cristalloella, Rotfanella, Urlocella, and Unzhispira gen. nov. with species C. spiralo- costata (Gründel, 1998), R. gerasimovi sp. nov., R. reticulata sp. nov., Urlocella undulata sp. nov., and Unzhispira minuta sp. nov. The genus Heteronatica gen. nov. is included into the family Cornirostridae. This genus is the first siphonostomatous representative of the given family including the sole long-living species H. globosa sp. nov., which is subdivided into subspecies H. globosa globosa and H. globosa promota subsp. nov. The family Ebalidae is represented by the genus Ebala, shells of which are distributed from the Middle Oxfordian to the Middle Volgian. The family Stuoraxidae is described based on two genera Stuoraxis and Aneudaronia gen. nov., including species of S. -

Tertiary and Quaternary Fossil Pyramidelloidean Gastropods of Indonesia
Tertiary and Quaternary fossil pyramidelloidean gastropods of Indonesia E. Robba Robba, E. 2013. Tertiary and Quaternary fossil pyramidelloidean gastropods of Indonesia. Scripta Geo- logica, 144: 1-191, 1 appendix, 1 table, 25 plates. Leiden, April 2013. E. Robba, Università di Milano Bicocca, Dipartimento di Scienze Geologiche e Geotecnologie, Piazza della Scienza 4, 20126 Milano, Italy ([email protected]). Key words – Gastropoda, Pyramidelloidea, taxonomy. The pyramidelloidean gastropods newly collected from one stratigraphic section and two spot localities in the Rembang anticlinorium (Middle Miocene, northeastern Java) are described and those of various ages in the collections of the Naturalis Biodiversity Center in Leiden are reviewed. A total of 111 species are covered in this paper; another 22 taxa dealt with by previous authors, of which the material was not available, are briefly commented on in an appendix. The “Rembangian” (Middle Miocene) assemblage consists of 89 spe- cies. Four are identified as formerly described species, namelyLeucotina speciosa (Adams), Megastomia regina (Thiele), Exesilla dextra (Saurin) and Exesilla splendida (Martin); 52 are proposed as new; most of the others almost certainly represent previously undescribed species, but cannot be named because of inadequate ma- terial. Parodostomia jogjacartensis (Martin), Parodostomia vandijki (Martin) and Pyramidella nanggulanica Finlay, described from the Eocene deposits of Java, seem to be restricted to that epoch. The Neogene fauna appears to be composed almost entirely of extinct species. Only Leucotina speciosa (Adams), Megastomia regina (Thiele), Longchaeus turritus (Adams), Pyramidella balteata (Adams), Exesilla dextra (Saurin) and Nisiturris alma (Thiele) are still present in modern Indo-West Pacific faunas. Most Neogene species seem to be endemic of the Indonesian Archipelago; relationships with other West Pacific fossil faunas have been noted for only a few taxa. -

Conchigl,Ie T{OTIZIARIO MENSILE DELLA UNIONE MALACOLOGICA ITALIANA Aoeflente ALLA UNITAS MA.LACOLOGICA EUROPAEA
Conchigl,ie T{OTIZIARIO MENSILE DELLA UNIONE MALACOLOGICA ITALIANA AOEFlENTE ALLA UNITAS MA.LACOLOGICA EUROPAEA Anno IX - n. 11-12 novembre dicembre 1971 SOA{MARIO DI GERONIMO l. - Tiberia octagia,?a n. sp.di Pyrami- d e I I i d a e (Gastropoda, Opistobran- chia) del Mediterraneo pag.2l? CAPROTTI E. Il genere I/phis DENys DE MoNrFoBr, 1810 nel Pliocene mediterraneo " 223 MALDOI.IADO QUILES A. - Segnalazione di un Nassa- ridae nuovo per il Mediterraneo " 231 CARICATI A. - Reperti inconsueti' dalle coste occi- dentali africane , 235 CASAMOR L. - Un « Cementerio de Conchas " al lar- go di Pineda de Mar (Costa catalana) , 239 GHISOTTI F. - Metodi e Tecniche: r,produzione di conchiglie con gomme di silicone " 242 DI GERONIMO I. - OrrAvIo PRroLo (1890 - 1973) (Necro- logio) " 246 DIBEITORE RESPONSABILE rag. ltalo Urio DIRETTOBESCIENIIFICO dott. FernandoGhisotti DIREZIONE E REDAZIONE Milano, Via De Sanctis, 73 . lel. 849.76.57 AUTORIZZAZIONE TRIBUNALE DI MILANO N,98 DEL 28 MARZO I967 SPEOIZIONE IN ABOONAMENIO POSTAIE.GRUPPO IV UNIONE MALACOLOCìICA ITALIANA MALACOLOGI ITALIANI ILLUSTRI SOCI SOSTENITORI L. 10.000 QUOTE DI ADESIONE SOCI ORDINARI L. 5.000 SOCI GIOVANI L. 2.500 I FILIPPo BUoNANNI " Alla categoria "SOCI GIOVANI" appartengono tutti gli iscritti di età non superiore ad annils , (art. 4 dello Statuto). I Nacque a Roma il 7 gennaio 1638 e ivi morì il 30 marzo 1225. Nella domanda di adesione i . Soci Giovani, devono indicare la loro i data di nascita. Notaio nella Compagnia di cesù e prefetto della bibtioreca del I Le quote di adesione possono essere inviate con versamento sul c/c Collegio Romano, FrllPpo BUoNANNT fu erudito nel senso pitr ampio postale n.3-42684 Ìntestato al rag. -

View of Morphological and Molecular Evidence Is Consistent with an Origin of Rhodopemorpha Slugs Among Shelled ‘Lower Heterobranchia’
At the limits of a successful body plan – 3D microanatomy, histology and evolution of Helminthope (Mollusca: Heterobranchia: Rhodopemorpha), the most worm-like gastropod Brenzinger et al. Brenzinger et al. Frontiers in Zoology 2013, 10:37 http://www.frontiersinzoology.com/content/10/1/37 Brenzinger et al. Frontiers in Zoology 2013, 10:37 http://www.frontiersinzoology.com/content/10/1/37 RESEARCH Open Access At the limits of a successful body plan – 3D microanatomy, histology and evolution of Helminthope (Mollusca: Heterobranchia: Rhodopemorpha), the most worm-like gastropod Bastian Brenzinger1,2*, Gerhard Haszprunar1,2 and Michael Schrödl1,2 Abstract Background: Gastropods are among the most diverse animal clades, and have successfully colonized special habitats such as the marine sand interstitial. Specialized meiofaunal snails and slugs are tiny and worm-shaped. They combine regressive features – argued to be due to progenetic tendencies – with convergent adaptations. Microscopic size and concerted convergences make morphological examination non-trivial and hamper phylogenetic reconstructions. The enigmatic turbellarian-like Rhodopemorpha are a small group that has puzzled systematists for over a century. A preliminary molecular framework places the group far closer to the root of Heterobranchia – one of the major gastropod groups – than previously suggested. The poorly known meiofaunal Helminthope psammobionta Salvini-Plawen, 1991 from Bermuda is the most worm-shaped free-living gastropod and shows apparently aberrant aspects of anatomy. Its study may give important clues to understand the evolution of rhodopemorphs among basal heterobranchs versus their previously thought origin among ‘higher’ euthyneuran taxa. Results: We describe the 3D-microanatomy of H. psammobionta using three-dimensional digital reconstruction based on serial semithin histological sections. -

Collected During the Dutch CANCAP and MAURITANIA Expeditions in the South-Eastern Part of the North Atlantic Ocean (Part 1)
Pyramidellidae (Mollusca, Gastropoda, Heterobranchia) collected during the Dutch CANCAP and MAURITANIA expeditions in the south-eastern part of the North Atlantic Ocean (part 1) CANCAP-project. Contributions, no. 119 J.J. van Aartsen, E. Gittenberger & J. Goud Aartsen, J.J. van, E. Gittenberger & J. Goud. Pyramidellidae (Mollusca, Gastropoda, Heterobranchia) collected during the Dutch CANCAP and MAURITANIA expeditions in the south-eastern part of the North Atlantic Ocean (part 1). Zool. Verh. Leiden 321, 15.vi.1998:1-57, figs 1-68.— ISSN 0024-1652/ISBN 90-73239-66-4. J.J. van Aartsen, Admiraal Helfrichlaan 33, NL 6952 GB Dieren, The Netherlands. E. Gittenberger, Department of Evertebrata, National Museum of Natural History, P.O. Box 9517, NL 2300 RA Leiden, The Netherlands (e-mail: [email protected]). J. Goud, Department of Evertebrata, National Museum of Natural History, P.O. Box 9517, NL 2300 RA Leiden, The Netherlands (e-mail: [email protected]). Key words: Pyramidellidae; new species; North Atlantic Ocean. The species of the Pyramidellidae collected during several expeditions in the south-eastern part of the North Atlantic Ocean are listed, with locality data, depth ranges, and notes on nomenclature, system- atics and distribution. The samples classified with the genera Pyramidella, Tiberia, Adelactaeon, Odetta, Folinella, Ondina, Odostomia, Puposyrnola and Eulimella (partly) are dealt with in this paper. In total 64 species are reported from the research area, 32 of which are described as new to science; one nomen novum is introduced. Lectotypes of Aclis tricarinata Watson, 1897, Monoptygma puncturata Smith, 1872, Odetta sulcata de Folin, 1870, and Odostomia sulcifera Smith, 1872, are designated and figured.