Francesca Da Rimini. Tragedia in Cinque Atti
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
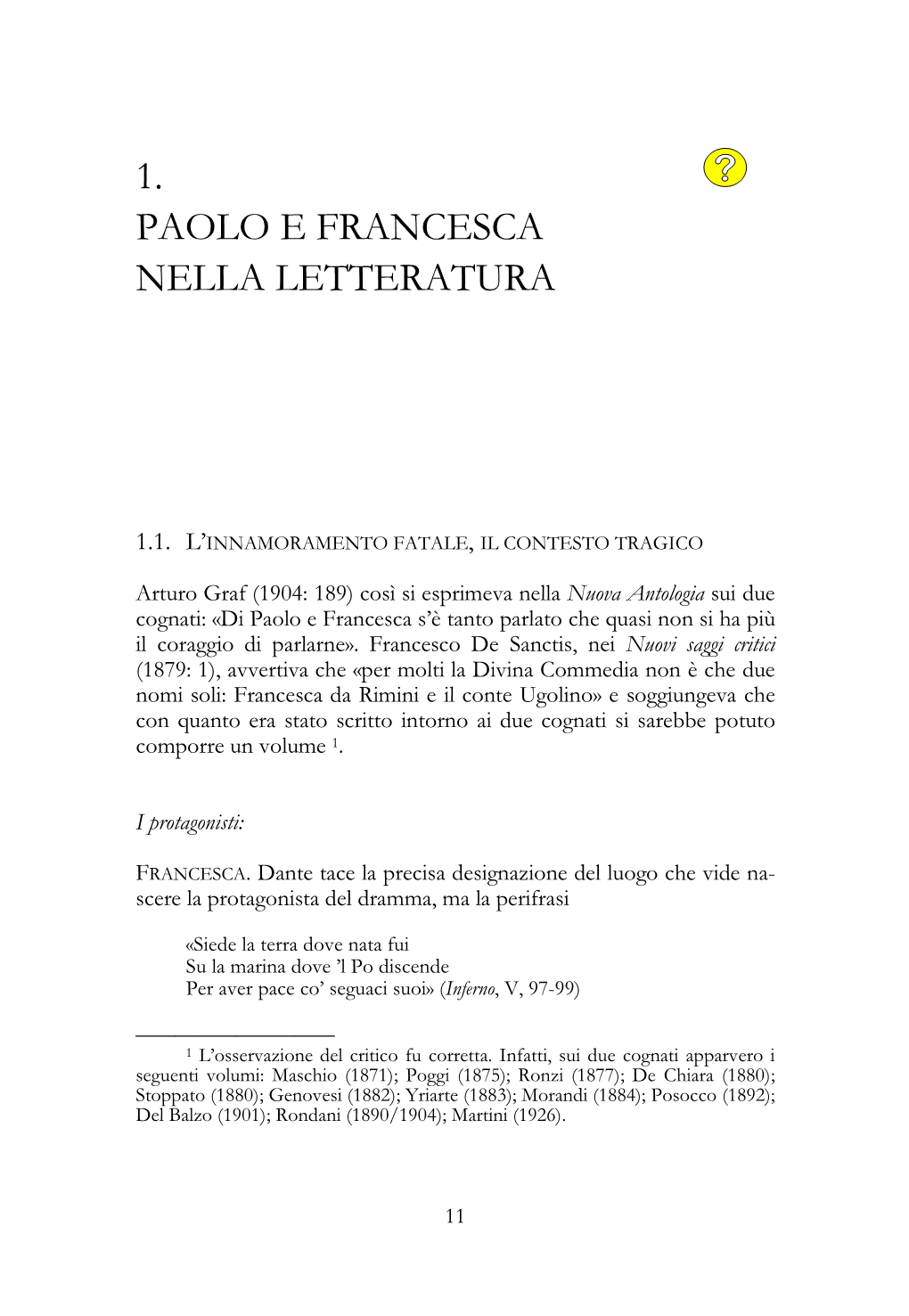
Load more
Recommended publications
-

EN ROCCHE EN.Pdf
Places to see and itineraries Where we are Bellaria Trento Igea Marina Milano Venezia Torino Bologna Oslo Helsinki Genova Ravenna Rimini Stoccolma Mosca Firenze Dublino Ancona Santarcangelo Perugia di Romagna Londra Amsterdam Varsavia Rimini Bruxelles Kijev Poggio Berni Roma Berlino Praga Vienna Bari Parigi Monaco Napoli Torriana Budapest Verucchio Milano Montebello Bucarest Rimini Riccione Madrid Cagliari Roma Catanzaro Ankara Coriano Talamello Repubblica Atene Palermo Novafeltria di San Marino Misano Adriatico Algeri Castelleale Tunisi Sant’Agata Feltria Maioletto San Leo Montescudo Agello Maiolo Montecolombo Cattolica Petrella Guidi Sassofeltrio San Clemente Gradara Maciano Gemmano Morciano San Giovanni fiume Conca di Romagna in Marignano Ponte Messa Pennabilli Casteldelci Monte AR Cerignone Montefiore Conca Saludecio Piacenza Molino Pietrarubbia Tavoleto Montegridolfo di Bascio Carpegna Macerata Mondaino Feltria Ferrara fiume Marecchia Sassocorvaro Parma Reggio Emilia Modena Rimini Mondaino Sismondo Castle Castle with Palaeontological museum Bologna Santarcangelo di Romagna Montegridolfo Ravenna Malatesta Fortress Fortified village Torriana/Montebello Montefiore Conca Forlì Fortress of the Guidi di Bagno Malatesta Fortress Cesena Verucchio Montescudo Rimini Malatesta Fortress Fortified village Castle of Albereto San Marino San Leo Fortress Montecolombo Fortified village Petrella Guidi Fortified village and castle ruins Monte Cerignone Fortress Sant’Agata Feltria Fortress Fregoso - museum Sassocorvaro Ubaldini Fortress Distances Pennabilli -

FELLINI's ITINERARY MUSEUM “LUIGI TONINI” Via Tonini 1, Tel 0541 793851 15
you are here! Pennabilli San Leo Republic Mondaino of San Marino Casteldelci Montefiore Gradara Conca Montescudo Verucchio Santarcangelo Torriana and di Romagna Montebello San Giovanni in Marignano Arch of Augustus Malatesta Temple Sismondo Castle Galli Theatre Cinema Fulgor Tiberius Bridge Skyscraper Lighthouse P.le Fellini / Grand Hotel P.le Boscovich / Canal port YOU ARE HERE! ancient name (Ariminus) baptized the city. Emblematic representation of this 10 TIMES RIMINI ancient heritage is the Domus del Chirurgo (Surgeon’s House), the archaeo- Rimini, or rather Ariminum, was established in 268 B.C. thanks to the work and logical site in the central Piazza Ferrari, where you can admire a third-century Ten as the districts that, from north to south, follow one another along the sea, house. Prestigious mosaics and frescoes describe a residence for private use in- genius of the Romans. The 2287 years since its foundation until today have seen each with its peculiarity that makes it unique and special. Starting from Torre tended for the practice of medical-surgical and pharmaceutical profession. The it change many times: Roman Ariminum, medieval municipality, Malatesta town Pedrera, the northernmost locality that takes its name from a saracen tower Domus has returned the richest surgical set of the Roman world: the exception- and Lordship, therapeutic and bathing center with the first beach resort in the that is visible in the vicinity of the beach. Continuing with the area of Viserbel- al collection of 150 iron and bronze instruments is on display at the Museo della nineteenth century, holiday capital, Fellini’s place of memory. -

Francesca Da Rimini
FRANCESCA DA RIMINI Tragedia in quattro atti. testi di Tito II Ricordi musiche di Riccardo Zandonai Prima esecuzione: 19 febbraio 1914, Torino. www.librettidopera.it 1 / 45 Informazioni Francesca da Rimini Cara lettrice, caro lettore, il sito internet www.librettidopera.it è dedicato ai libretti d©opera in lingua italiana. Non c©è un intento filologico, troppo complesso per essere trattato con le mie risorse: vi è invece un intento divulgativo, la volontà di far conoscere i vari aspetti di una parte della nostra cultura. Motivazioni per scrivere note di ringraziamento non mancano. Contributi e suggerimenti sono giunti da ogni dove, vien da dire «dagli Appennini alle Ande». Tutto questo aiuto mi ha dato e mi sta dando entusiasmo per continuare a migliorare e ampliare gli orizzonti di quest©impresa. Ringrazio quindi: chi mi ha dato consigli su grafica e impostazione del sito, chi ha svolto le operazioni di aggiornamento sul portale, tutti coloro che mettono a disposizione testi e materiali che riguardano la lirica, chi ha donato tempo, chi mi ha prestato hardware, chi mette a disposizione software di qualità a prezzi più che contenuti. Infine ringrazio la mia famiglia, per il tempo rubatole e dedicato a questa attività. I titoli vengono scelti in base a una serie di criteri: disponibilità del materiale, data della prima rappresentazione, autori di testi e musiche, importanza del testo nella storia della lirica, difficoltà di reperimento. A questo punto viene ampliata la varietà del materiale, e la sua affidabilità, tramite acquisti, ricerche in biblioteca, su internet, donazione di materiali da parte di appassionati. -

Gradara °°°°°
Notizie su GRADARA °°°°° Posizione Il colle di Gradara (m. 142 di altitudine, in provincia di Pesaro e Urbino) è situato nell'entroterra della riviera marchigiano-romagnola, poco distante dal mare; è dominato dalla maestosa rocca circondata da un piccolo borgo medievale e da una doppia cinta muraria. Luogo di piacevoli delizie fin dall'antichità, come conferma la plausibile derivazione del suo nome da "grata aura" (aria gradita, salubre), Gradara si inserisce in un paesaggio suggestivo, sovrastando la valle del Taviolo, con il colore ocra dei mattoni del castello che risalta sull'azzurro del cielo e il verde delle campagne circostanti. Dalla sommità lo sguardo può spingersi fino al mare Adriatico, a nord, o verso il monte Carpegna, ad ovest. Per la sua posizione Gradara ha rivestito per secoli un ruolo strategico di fondamentale importanza. Fin dai tempi antichi crocevia di traffici e genti, la località è stata uno dei principali teatri degli scontri tra le milizie fedeli al Papato e le turbolente signorie marchigiane e romagnole. IL BORGO e IL CASTELLO: la storia L'imponente complesso monumentale di Gradara è costituito da un castello-fortezza (la rocca) e dall'adiacente borgo medievale, protetto da una cinta muraria esterna che si estende per quasi 800 metri. Il mastio, torrione principale, con i suoi 30 metri di altezza domina l'intera vallata. Il nucleo più antico, una casa-torre, fu costruito attorno al 1150 dai fratelli Piero e Rodolfo della famiglia nobiliare pesarese dei De Griffo (o Grifo). Gradara fu poi affidata al condottiero dei Guelfi di Romagna, Malatesta da Verucchio (detto Il Centenario o Il Vecchio, il dantesco Mastin Vecchio), capostipite dei Malatesta, Signori di Rimini, Cesena e Pesaro. -

Ramberto Malatesta
Zurich Open Repository and Archive University of Zurich Main Library Strickhofstrasse 39 CH-8057 Zurich www.zora.uzh.ch Year: 2014 Appendice documentaria su Ramberto Malatesta Castagnola, Raffaella Posted at the Zurich Open Repository and Archive, University of Zurich ZORA URL: https://doi.org/10.5167/uzh-101199 Book Section Originally published at: Castagnola, Raffaella (2014). Appendice documentaria su Ramberto Malatesta. In: Antonioli, Andrea. Ramberto Malatesta, Monografia e catalogo della mostra su Ramberto Malatesta, principe e astrologo,. Cesena: Biblioteca Malatestiana, 277-321. Andrea Antonioli RAMBERTO MALATESTA MENTE SUBLIME & ANIMA OSCURA con appendice di testi e documenti a cura di Andrea Antonioli, Raffaella Castagnola, Alessandra Peroni Casa Editrice 1 2 <<…considerando che el sommo Opifice ci ha constituito uno elegante libro nel cielo dove, oculata fide, noi possiamo gli nostri futuri atti continuo prospettare, cosa con- grua è … in quello come in uno proprio spe- chio ricerchare gli nostri proprii atti accorte; acciocché, conosciute le sua carattere, pos- siamo con somma verità conoscere tutte, o buona parte, di nostre future actione…>>. Rambertus de Malatestis Sogliani Comes Oroscopo di Francesco Guicciardini. cc. 1v-2r 3 COORDINAMENTO GENERALE Andrea Antonioli COMITATO SCIENTIFICO Andrea Antonioli – Direttore Ente Morale Museo e Biblioteca Renzi Raffaella Castagnola – Università di Zurigo Fiamma Lenzi – IBC Servizio Musei e Beni Culturali – Coordinamento Musei Alessandra Peroni – Università di Bologna COMITATO TECNICO-ORGANIZZATIVO -

DELLA PROVINCIA RIMINESE Luoghi E Itinerari Di Visita
DELLA PROVINCIA RIMINESE Luoghi e itinerari di visita Bellaria Igea Marina Santarcangelo di Romagna Rimini Poggio Berni Torriana Montebello Verucchio Riccione Coriano Talamello Repubblica Novafeltria di San Marino Misano Adriatico Sant’Agata Feltria San Leo Montescudo Maiolo Montecolombo Cattolica San Clemente fiume Conca Gemmano Morciano San Giovanni Pennabilli di Romagna in Marignano Casteldelci AR Montefiore Conca Saludecio Montegridolfo Mondaino fiume Marecchia Dove siamo Trento Milano Venezia Torino Bologna Oslo Helsinki Genova Ravenna Rimini Stoccolma Mosca Firenze Ancona Dublino Perugia Londra Amsterdam Varsavia Bruxelles Kijev Roma Berlino Praga Vienna Bari Parigi Monaco Napoli Budapest Milano Bucarest Rimini Madrid Cagliari Roma Catanzaro Ankara Palermo Algeri Atene Tunisi Riviera di Rimini Provincia di Rimini Travel Notes Servizio Turismo LEGGENDE, MISTERI E CURIOSITÀ della provincia riminese Riviera di Rimini Travel Notes collana di editoria turistica a cura di Provincia di Rimini Servizio Turismo Testi Progetto grafico Rita Giannini Relè - Tassinari/Vetta (Leonardo Sonnoli) Redazione Rita Giannini Foto Licia Romani in copertina, Montebello, Castello di Azzurrina a lato, Mondaino, Celletta votiva in penultima pagina, Sant’Agata Feltria, Rocca Fregoso Impaginazione Litoincisa87, Rimini (Licia Romani) Prima edizione 2016 LEGGENDE, MISTERI E CURIOSITÀ della provincia riminese è una pubblicazione turistico-culturale a diffusione gratuita Un ringraziamento speciale al Maestro Tonino Guerra per avere concesso l’utilizzo dei disegni -

Ezra Pound in Rimini
Linguistics and Literature Studies 1(1): 43-45, 2013 http://www.hrpub.org DOI: 10.13189/lls.2013.010107 Ezra Pound in Rimini Leonardo Paganelli State University of Genoa, Italy – Via Balbi 4, Genova 16126, Italy *Corresponding Author: [email protected] Copyright © 2013 Horizon Research Publishing All rights reserved. Abstract In 1922 Ezra Pound went to Rimini, Italy, in he was already famous as a poet and a philologist; he had order to study the story of Malatestas. He carried out precise read Dante and appreciated the Divine Comedy very much. research about Sigismondo Pandolfo Malatesta and his The stories of Malatesta Da Verucchio (1212-1312), attempt to create an independent Seignory all over Central nicknamed «the Old Mastiff»; 4 Paolo Malatesta’s Italy in the XV century A.D., forerunning Cesare Borgia’s unfortunate love for Francesca Da Rimini (his brother projects. At last, Pound wrote his four Malatesta Cantos Gianciotto’s bride); 5 the glory of Sigismondo Pandolfo (VIII-XI). In 1944, when Rimini was bombed, he expressed (1417-1468), the man who dared to build in Rimini a pagan his deepest sympathy for that martyr town. Some of these Temple in honour of his family and of his lover Isotta Degli data have been analysed by a recent critical edition of Atti too – all those things impressed deeply on Pound’s Pound’s Draft of XXX Cantos, published by Prof. imagination. In Rimini, he found the real scenery of Bacigalupo. Malatesta’s literary saga. That’s why he decided to wrote the four Malatesta Cantos (VIII-XI in this volume), published Keywords Ezra Pound, Sigismondo Pandolfo Malatesta, by Thomas Stearns Eliot in 1923. -

Francesca Da Rimini
Gabriele D’Annunzio Francesca da Rimini www.liberliber.it Questo e-book è stato realizzato anche grazie al so- stegno di: E-text Web design, Editoria, Multimedia (pubblica il tuo libro, o crea il tuo sito con E-text!) https://www.e-text.it/ QUESTO E-BOOK: TITOLO: Francesca da Rimini AUTORE: D'Annunzio, Gabriele TRADUTTORE: CURATORE: NOTE: CODICE ISBN E-BOOK: n. d. DIRITTI D'AUTORE: no LICENZA: questo testo è distribuito con la licenza specificata al seguente indirizzo Internet: http://www.liberliber.it/online/opere/libri/licenze/ COPERTINA: n. d. TRATTO DA: I Malatesti : Francesca da Rimini / Ga- briele D'Annunzio. - Milano : Fratelli Treves, 1903. - 279 p. ; 20 cm. - (Titolo uniforme: Francesca da Rimini). CODICE ISBN FONTE: n. d. 1a EDIZIONE ELETTRONICA DEL: 9 gennaio 2019 INDICE DI AFFIDABILITÀ: 1 2 0: affidabilità bassa 1: affidabilità standard 2: affidabilità buona 3: affidabilità ottima SOGGETTO: PER011030 ARTI RAPPRESENTATIVE / Teatro / Drammatur- gia DIGITALIZZAZIONE: Catia Righi, [email protected] REVISIONE: Maria Grazia Hall, [email protected] IMPAGINAZIONE: Catia Righi, [email protected] PUBBLICAZIONE: Catia Righi, [email protected] 3 Liber Liber Se questo libro ti è piaciuto, aiutaci a realizzarne altri. Fai una donazione: www.liberliber.it/online/aiuta/. Scopri sul sito Internet di Liber Liber ciò che stiamo realizzando: migliaia di ebook gratuiti in edizione inte- grale, audiolibri, brani musicali con licenza libera, video e tanto altro: www.liberliber.it/. 4 Indice generale Liber Liber......................................................................4 -

Francesca Da Rimini
Francesca da Rimini Tragedia in quattro atti di Gabriele d’Annunzio Riduzione di Tito Ricordi Musica di Riccardo Zandonai DRAmATIS pERSONÆ I figli di Guido Minore da Polenta Francesca soprano Samaritana mezzosoprano Ostasio basso I figli di Malatesta da Verucchio Giovanni lo Sciancato baritono Paolo il Bello tenore Malatestino dall’Occhio tenore Le donne di Francesca Biancofiore mezzosoprano Garsenda soprano Altichiara contralto Adonella soprano Smaragdi, la schiava mezzosoprano Ser Toldo Berardengo tenore Il giullare basso Il balestriere tenore Il torrigiano baritono I balestrieri e gli arcieri. I musici. A Ravenna nelle case dei Polentani. A Rimini nelle case dei Malatesti. Prima rappresentazione assoluta: Torino, Teatro Regio, 19 febbraio 1914 Nuova produzione Teatro alla Scala (Editore Casa Ricordi, milano) 5 ATTO pRImO Biancofiore ma tu chi sei? quel Gianni… Appare una corte, nelle case dei Polentani, con - Altichiara tigua a un giardino che brilla di là da una chiu - O Biancofiore, guardalo in che panni! sura di marmi traforati in guisa di transenne. Ri - Il farsetto s’azzuffa co’ calzari. corre per l’alto una loggia che a destra corri - (ride) sponde con le camere gentilesche e di fronte, Ah, ah, ah! aerata su le sue colonnette, mostra avere una duplice veduta. Ne discende, a manca, una sca - Garsenda la leggera. Una grande porta è a destra e una Oh, Adonella, guardalo: è scampato bassa finestra ferrata, pe’ cui vani si scopre una solo in panni di gamba. fuga di arcate che circondano un’altra corte più vasta. Presso la scala è un’arca bisantina, senza Biancofiore coperchio, riempiuta di terra come un testo, Guarda, guarda Altichiara dove fiorisce un rosaio vermiglio. -
ROCCHE CASTELLI IT.Pdf
Luoghi e itinerari di visita Dove siamo Bellaria Trento Igea Marina Milano Venezia Torino Bologna Oslo Helsinki Genova Ravenna Rimini Stoccolma Mosca Firenze Dublino Ancona Santarcangelo Perugia di Romagna Londra Amsterdam Varsavia Rimini Bruxelles Kijev Poggio Berni Roma Berlino Praga Vienna Bari Parigi Monaco Napoli Torriana Budapest Verucchio Milano Montebello Bucarest Rimini Riccione Madrid Cagliari Roma Catanzaro Ankara Coriano Talamello Repubblica Atene Palermo Novafeltria di San Marino Misano Adriatico Algeri Castelleale Tunisi Sant’Agata Feltria Maioletto San Leo Montescudo Agello Maiolo Montecolombo Cattolica Petrella Guidi Sassofeltrio San Clemente Gradara Maciano Gemmano Morciano San Giovanni fiume Conca di Romagna in Marignano Ponte Messa Pennabilli Casteldelci Monte AR Cerignone Montefiore Conca Saludecio Piacenza Molino Pietrarubbia Tavoleto Montegridolfo di Bascio Carpegna Macerata Mondaino Feltria Ferrara fiume Marecchia Sassocorvaro Parma Reggio Emilia Modena Rimini Mondaino Castel Sismondo Castello con Museo Paleontologico Bologna Santarcangelo di Romagna Montegridolfo Ravenna Rocca Malatestiana Borgo Torriana/Montebello Montefiore Conca Forlì Rocca dei Guidi di Bagno Rocca Malatestiana Cesena Verucchio Montescudo Rimini Rocca Malatestiana Borgo Castello di Albereto San Marino San Leo Fortezza Montecolombo Borgo Petrella Guidi Borgo e rovine del castello Monte Cerignone Rocca Sant’Agata Feltria Rocca Fregoso - Museo Sassocorvaro Rocca Ubaldinesca Principali distanze Pennabilli Torre di Molino di Bascio Macerata Feltria -
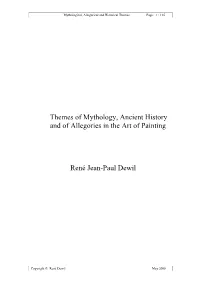
Mythological and Historical Themes
Mythological, Allegorical and Historical Themes Page: 1 / 125 Themes of Mythology, Ancient History and of Allegories in the Art of Painting René Jean-Paul Dewil Copyright © René Dewil May 2008 Mythological, Allegorical and Historical Themes Page: 2 / 125 Copyright Clause Copyright © René Jean-Paul Dewil 2008 René Jean-Paul Dewil is identified as the sole author of this work. All rights reserved. No part of this publication may be altered without the written permission of the author. The ebook may be copied in electronic or other forms for personal use only. It may not be printed, introduced in any retrieval system, electronic or otherwise, photocopied or otherwise recorded without the prior written permission of the author. The only system where the ebook may be retrieved from is the Internet website www.theartofpainting.be, which holds the only and original text acknowledged by the author. This publication remains under copyright. Copyright © René Dewil May 2008 Mythological, Allegorical and Historical Themes Page: 3 / 125 Introduction Painters have used many mythological themes as well as themes of history. The aim of the following is to classify the paintings according to those themes and sub-themes. The paintings are classified according to main themes, called macro themes, and then they are further classified within each macro theme to micro themes. The themes have been discovered by the classification of tens of thousands of paintings presented in the main museum of the world. A list of these paintings, plus their classification in macro themes and micro themes is available in Microsoft Excel © spreadsheet format (see the Internet site www.theartofpainting.be ). -

Critica Del Testo
Critica del testo XIV / 1, 2011 Dante, oggi / 1 a cura di Roberto Antonelli Annalisa Landolfi Arianna Punzi viella © Dipartimento di Studi Europei, Americani e Interculturali, “Sapienza” Università di Roma ISSN 1127-1140 ISBN 978-88-8334-637-8 Rivista quadrimestrale, anno XIV, n. 1, 2011 Registrazione presso il Tribunale di Roma n. 125/2000 del 10/03/2000 Sito internet: http://w3.uniroma1.it/studieuropei/critica [email protected] Direzione: R. Antonelli, F. Beggiato, P. Boitani, C. Bologna, N. von Prellwitz Direttore responsabile: Roberto Antonelli Questa rivista è finanziata da “Sapienza” Università di Roma Viella libreria editrice via delle Alpi, 32 – I-00198 ROMA tel. 06 84 17 758 – fax 06 85 35 39 60 www.viella.it – [email protected] Premessa di Roberto Antonelli vii Problematiche Roberto Antonelli Come (e perché) Dante ha scritto la Divina Commedia? 3 Andreas Kablitz Die Ethik der Göttlichen Komödie 25 Zygmunt G. Baranski Dante poeta e lector: «poesia» e «riflessione tecnica» (con divagazioni sulla Vita nova) 81 Roberto Mercuri Il metodo intertestuale nella lettura della Commedia 111 Albert Russell Ascoli Tradurre l’allegoria: Convivio II, i 153 Teodolinda Barolini Dante’s Sympathy for the Other, or the Non-Stereotyping Imagination: Sexual and Racialized Others in the Commedia 177 Le opere e la ricezione Natascia Tonelli Le rime 207 Roberto Rea La Vita nova: questioni di ecdotica 233 Raffaella Zanni Il De vulgari eloquentia fra linguistica, filosofia e politica 279 Giorgio Stabile Dante oggi: il Convivio tra poesia e ragione 345 Antonio Montefusco Le Epistole di Dante: un approccio al corpus 401 Riccardo Viel Sulla tradizione manoscritta della Commedia: metodo e prassi in centocinquant’anni di ricerca 459 Paolo Canettieri Il Fiore e il Detto d’Amore 519 Saverio Bellomo «La natura delle cose aromatiche» e il sapore della Commedia: quel che ci dicono gli antichi commenti a Dante 531 Alessia Ronchetti Da Beatrice a Fiammetta.