Studia Erudita *
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
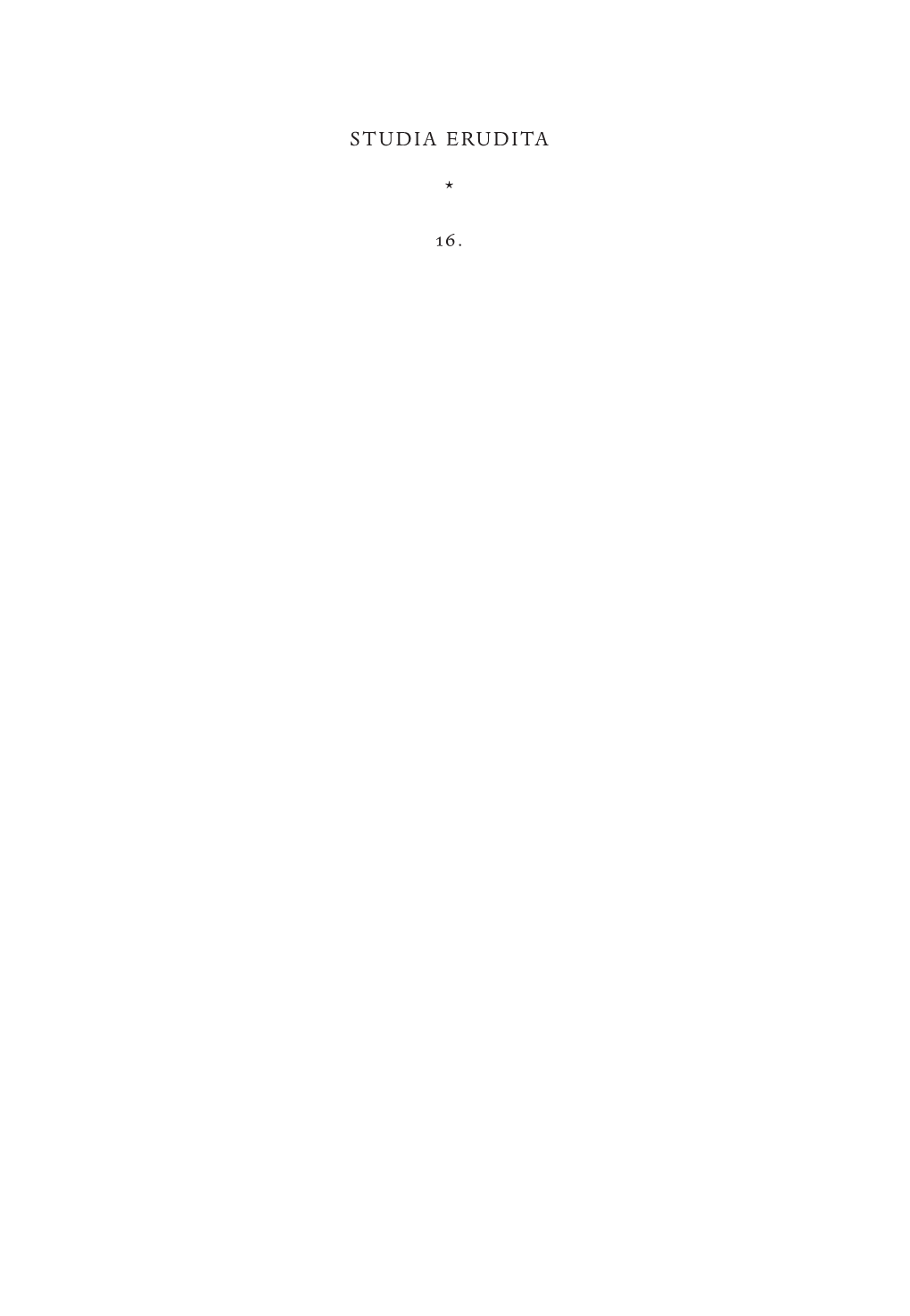
Load more
Recommended publications
-
Manifesto 6X3 Mt Volponi 2011
Comuni di Altidona Fermo PROVINCIA DI COMUNE DI REGIONE Monte urano FERMO URBINO MARCHE Monte Vidon Corrado Porto San Giorgio Porto Sant’Elpidio Sant’Elpidio a Mare Premio Letterario Nazionale Paolo Volponi Letteratura ed impegno civile 2012IX edizione 15novembre 1dicembre PROVINCIA DI COMUNE DI REGIONE FERMO URBINO MARCHE Comuni di Altidona Fermo Monte Urano Monte Vidon Corrado Porto San Giorgio Porto Sant’Elpidio Sant’Elpidio a Mare IX edizione 2012 15novembre 1dicembre Camera di Commercio Fermo Fondazione Progetto “Città e Cultura” Porto Sant’Elpidio Centro Studi “Osvaldo Licini” Monte Vidon Corrado Il Circolo di Confusione Fermo e Porto San Giorgio Fototeca Provinciale di Fermo Altidona Belvedere L’Altritalia Periferie La Luna Unione Europea / Regione Marche PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2007-2013 MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARE E FORESTALE UNIONE EUROPEA PSR Marche 2007-2013 - Asse IV - Misura 4.2.1 - Progetto di Cooperazione Interterritoriale PRESENTAZI ONE Coordinamento progettuale: Angelo Ferracuti Giuria Tecnica: Enrico Capodaglio Angelo Ferracuti Massimo Gezzi Massimo Raffaeli Emanuele Zinato 3i libri vincitori Franco Arminio Terracarne Mondadori Alessandro Leogrande Il naufragio Feltrinelli Davide Orecchio Città distrutte Gaffi L’esperienza del premio Volponi, che giunge alla sua IX edizione, è tra le più prestigiose in ambito regionale e non solo. Il concorso delle istituzioni locali, del mondo dell’istruzione, di soggetti pubblici, privati e cooperativi, delle associazioni, insieme al legame “ideale” tra le città di Urbino e Fermo, la ricchezza del programma e il serio lavoro preparatorio, lo rendono un appuntamento annuale atteso e capace di proporre ogni anno interessanti novità nel segno di un intellettuale e scrittore originale, come pochi, qual era Paolo Volponi. -
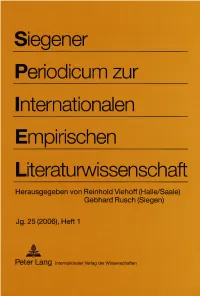
On the Monitor, Darkly. from Mediation to Media by Way of Reality 73
Siegener Periodicum zur Internationalen____ Empirischen______ Literaturwissenschaft Herausgegeben von Reinhold Viehoff (Halle/Saale) Gebhard Rusch (Siegen) Jg. 25 (2006), Heft 1 Peter Lang Internationaler Verlag der Wissenschaften SPIEL Siegener Periodicum zur Internationalen Empirischen Literaturwissenschaft SPIEL: Siegener Periodicum zur Internationalen Empirischen Literaturwissenschaft Jg. 25 (2006), Heft 1 Peter Lang Frankfurt am Main • Berlin • Bern • Bruxelles • New York • Oxford • Wien Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über <http://www.d-nb.de> abrufbar. ISSNISSN 2199-80780722-7833 © Peter Lang GmbH Internationaler Verlag der Wissenschaften Frankfurt am Main 2009 Alle Rechte Vorbehalten. Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlages unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen. www.peterlang.de Siegener Periodicum zur Internationalen Empirischen Literaturwissenschaft SPIEL 25 (2006), H. 1 Mediale Wende - Ansprüche, Konzepte und Diskurse / Mediatic turn - Claims, Concepts, and Discourses hrsg. von / ed. by Theo Hug (Innsbruck) Die Heftbezeichnung SPIEL 25 (2006), H. 1 ist produktionstechnischen Gründen geschuldet und bezieht sich nicht auf das tatsächliche Erscheinungsjahr dieses Bandes, 2008. Dafür bittet die Redaktion um Verständnis. Das Heft wird zitiert: Theo Hug (Hg.), 2008: Mediale Wende - Ansprüche, Konzepte und Diskurse. Frankfurt/Main: Peter Lang. (= special issue SPIEL, 25 (2006), H. 1). Owing to technical reasons of production, the title SPIEL 25 (2006), H. 1 does not refer to the actual year of publication of this issue. The editorial team asks for the readers’ indulgence. -

Postmodern Narration in Umberto Eco's the Name of The
Shanlax International Journal of English 1 Umberto Eco, Italy‟s most celebrated philosopher, semiotician, literary critic, linguist and novelist, is widely acclaimed for many of his influential scholarly works. His novels The Name of the Rose, Foucault’s Pendulum, Baudolino, An Island of the Day Before, Mysterious Flame of Queen Loana, The Prague Cemetery have gained much adulation from his readers. His recent novel Numero Zero has also earned greater Dr. B. Kathiresan popularity. An exceptional narrative style imposed in these Associate Professor of English novels identifies them predominantly with postmodern Thiruvalluvar University literature. The Name of the Rose is a postmodern novel where Eco recites a fictious tale of Adso of Melk who inturn narrates S.Pushpanjali his past to the readers. Adso‟s story deals with William along Research Scholar, Thiruvalluvar University with his novice Adso, solving the mystery of seven bizarre deaths that occurs in the Benadictine Monastery where they come o n a mission to partake in a theological disputation. The postmodern narration in the novel harnesses temporal distortion and unreliable narration. Temporal distortion refers to a technique that the postmodern authors implement in their novels to convey the story. It includes employing features like fragmentation and non- linear narration. Fragmentation is the disarray of events whereas non-linear narration is the usage of distorted timeline in the portrayal of events. A novel, in general, usually incorporates a structure that assembles the compendium of information belonging to the story in an organized fashion. When this fabrication breaks, there is an interruption in the disposal of the events of the story, affecting the totality of meaning. -

Normality Fantasy Fantastic Storytelling, Rhymes, Songs; Exploring Italian Through Literature, Poetry and Music
Normality Fantasy Fantastic Storytelling, rhymes, songs; exploring Italian through literature, poetry and music. By Andrea Francesco Manno • Introduction to Dino Buzzati • Dino Buzzati is an Italian writer, painter, artist and journalist who lived in northern Italy during the 1900s. He is one of the most important Italian authors of the 20th century • His worldwide fame is mostly due to his novel ”The Tartar Step”, although he is also known for his collections of short stories. • His ”Sessanta racconti”, a short-story collection that won the Strega Prize in 1958, features elements of science fiction, fantasy and horror. • Buzzati’s words about normality, style and fantastic: • […] It seems to me that fantasy should be as close as possible to journalism.[…] • The effectiveness of a fantastic story will depend on its being told in the most simple and practical terms.[…] • Una goccia d’acqua sale per i gradini della scala. La senti? Disteso in letto nel buio , ascolto il suo arcano cammino” […]. Dino Buzzati. Una goccia. “ Sessanta Racconti”. • https://www.dariopalma.com/images/Buzzati_Le_S Story telling and torie_Dipinte_3.JPG?378 painting: • https://www.dariopalma.com/images/Buzzati_Le_S torie_Dipinte_4.JPG?378 “Le storie dipinte”. • https://www.exibart.com/repository/media/eventi /2005/05/dino-buzzati-8211-storie-disegnate-e- An art graphic dipinte.jpg novel in which ordinary life meets the fantastic. Introduction to Gianni Rodari. • Rodari is considered Italy's most important 20th- The grammar of century children's author and his books have been translated into many languages. His approach to fantasy in “ Il libro writing and story telling is playful and aims to stimulate the imagination and fantasy. -

Pubblicazioni N.58
PUBBLICAZIONI Vengono segnalate, in ordine alfabetico per autore (o curatore o parola- chiave), quelle contenenti materiali conservati nell’AP della BCLu e strettamente collegate a Prezzolini, Flaiano, Ceronetti, Chiesa, ecc. Le pubblicazioni seguite dalle sigle dei vari Fondi includono documenti presi dai Fondi stessi. Cinque secoli di aforismi , a cura di Antonio Castronuovo, “Il lettore di provincia”, a. XLVIII, fasc. 149, luglio-dicembre 2017 [ANTONIO CASTRONUOVO , Premessa ; ANDREA PAGANI , La dissimulazione onesta nell’aforisma di Tasso ; GIULIA CANTARUTTI , I clandestini ; SILVIA RUZZENENTI , Tradurre aforismi. Spunti di riflessione e Fragmente di un’autrice tedesca dell’Illuminismo ; MATTEO VERONESI , Leopardi e l’universo della ghnome; NEIL NOVELLO , Una «meta» terrestre a Zürau. Kafka alla prova dell’aforisma ; SANDRO MONTALTO , Aforisti italiani (giustamente?) dimenticati ; GILBERTO MORDENTI , Montherlant: carnets e aforismi ; MASSIMO SANNELLI , Lasciate divertire Joë Bousquet ; ANNA ANTOLISEI , Pitigrilli, un aforista nell’oblio ; SILVANA BARONI , «Ripassa domani realtà!». Pessoa aforista ; ANNA MONACO , Un nemico dell’aforisma: Albert Camus ; SILVIA ALBERTAZZI , Fotorismi: aforismi e fotografia ; MARIA PANETTA , Apologia del lettore indiscreto: Bobi Bazlen e l’aforisma «involontario» ; SIMONA ABIS , Gli aforismi di Gómez Dávila: la dignità come perversione ; FULVIO SENARDI , Francesco Burdin, aforista in servizio permanente ; ANTONIO CASTRONUOVO , L’aforista Maria Luisa Spaziani ; PAOLO ALBANI , L’aforisma tra gesto involontario -

Between the Local and the National: the Free Territory of Trieste, "Italianita," and the Politics of Identity from the Second World War to the Osimo Treaty
Graduate Theses, Dissertations, and Problem Reports 2014 Between the Local and the National: The Free Territory of Trieste, "Italianita," and the Politics of Identity from the Second World War to the Osimo Treaty Fabio Capano Follow this and additional works at: https://researchrepository.wvu.edu/etd Recommended Citation Capano, Fabio, "Between the Local and the National: The Free Territory of Trieste, "Italianita," and the Politics of Identity from the Second World War to the Osimo Treaty" (2014). Graduate Theses, Dissertations, and Problem Reports. 5312. https://researchrepository.wvu.edu/etd/5312 This Dissertation is protected by copyright and/or related rights. It has been brought to you by the The Research Repository @ WVU with permission from the rights-holder(s). You are free to use this Dissertation in any way that is permitted by the copyright and related rights legislation that applies to your use. For other uses you must obtain permission from the rights-holder(s) directly, unless additional rights are indicated by a Creative Commons license in the record and/ or on the work itself. This Dissertation has been accepted for inclusion in WVU Graduate Theses, Dissertations, and Problem Reports collection by an authorized administrator of The Research Repository @ WVU. For more information, please contact [email protected]. Between the Local and the National: the Free Territory of Trieste, "Italianità," and the Politics of Identity from the Second World War to the Osimo Treaty Fabio Capano Dissertation submitted to the Eberly College of Arts and Sciences at West Virginia University in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy in Modern Europe Joshua Arthurs, Ph.D., Co-Chair Robert Blobaum, Ph.D., Co-Chair Katherine Aaslestad, Ph.D. -

T's Ot Ace, T's E In
® ISSN 2283-835X Free Copy - Map inside SeptemberF - October o2015t's www.flot orenceisyou.com ace,nce info@flt's orenceisyou.com ein... s 20.000 copies Y Your Newspaperu! in English and Italian By Anna Balzani By Cosimo Ceccuti Editor in chief Chairman of the @AnnaBalzani Fondazione Spadolini After the summer vacations, for- Fu l’avvento della capitale del re- tunate those who have managed gno a Firenze, nel 1865, a far sentire to fi nd a few days to relax, it is du- la necessità nel nostro paese di un ring the month of September when periodico di cultura politica che projects and activities, previously consentisse un dibattito aperto e undertaken, seem to fl ourish and qualifi cato – al di sopra delle po- move forward with a new boost. lemiche parlamentari e della fret- I wish that while you are fl ipping tolosità dei quotidiani – sui grandi each page of Florence is You! you Elisa Tozzi Piccini temi e problemi dell’Italia, unita will fi nd new ideas and interesting politicamente (mancavano Venezia By Anna Balzani e Roma) ma ancora da unifi care in Continued on page 16 Continued on page 4 tante altre questioni. La tradizione, a Firenze, era prestigiosa. Fra 1821 e 1832 la “Antologia” di Gian Pietro Vieusseux, Gino Capponi e Niccolò Tommaseo, aveva contribuito - fi no David Gilmour Adi Da Samraj alla soppressione ordinata dalla censura - alla formazione della co- scienza nazionale, imponendosi a livello europeo nella battaglia per il progresso della società civile, per l’emancipazione delle clas- si più deboli, l’educazione delle donne, l’istruzione dei contadini, il miglioramento delle condizioni economiche attraverso il rispar- mio. -

History and Emotions Is Elsa Morante, Goliarda Sapienza and Elena
NARRATING INTENSITY: HISTORY AND EMOTIONS IN ELSA MORANTE, GOLIARDA SAPIENZA AND ELENA FERRANTE by STEFANIA PORCELLI A dissertation submitted to the Graduate Faculty in Comparative Literature in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy, The City University of New York 2020 © 2020 STEFANIA PORCELLI All Rights Reserved ii Narrating Intensity: History and Emotions in Elsa Morante, Goliarda Sapienza and Elena Ferrante by Stefania Porcell i This manuscript has been read and accepted for the Graduate Faculty in Comparative Literature in satisfaction of the dissertation requirement for the degree of Doctor of Philosophy. ________ ______________________________ Date [Giancarlo Lombardi] Chair of Examining Committee ________ ______________________________ Date [Giancarlo Lombardi] Executive Officer Supervisory Committee: Monica Calabritto Hermann Haller Nancy Miller THE CITY UNIVERSITY OF NEW YORK iii ABSTRACT Narrating Intensity: History and Emotions in Elsa Morante, Goliarda Sapienza and Elena Ferrante By Stefania Porcelli Advisor: Giancarlo Lombardi L’amica geniale (My Brilliant Friend) by Elena Ferrante (published in Italy in four volumes between 2011 and 2014 and translated into English between 2012 and 2015) has galvanized critics and readers worldwide to the extent that it is has been adapted for television by RAI and HBO. It has been deemed “ferocious,” “a death-defying linguistic tightrope act,” and a combination of “dark and spiky emotions” in reviews appearing in popular newspapers. Taking the considerable critical investment in the affective dimension of Ferrante’s work as a point of departure, my dissertation examines the representation of emotions in My Brilliant Friend and in two Italian novels written between the 1960s and the 1970s – La Storia (1974, History: A Novel) by Elsa Morante (1912-1985) and L’arte della gioia (The Art of Joy, 1998/2008) by Goliarda Sapienza (1924-1996). -

Milan Celtic in Origin, Milan Was Acquired by Rome in 197 B.C. an Important Center During the Roman Era (Mediolânum Or Mediola
1 Milan Celtic in origin, Milan was acquired by Rome in 197 B.C. An important center during the Roman era (Mediolânum or Mediolanium), and after having declined as a medieval village, it began to prosper as an archiepiscopal and consular town between the tenth and eleventh centuries. It led the struggle of the Italian cities against the Emperor Frederick I (Barbarossa) at Legnano (1176), securing Italian independence in the Peace of Constance (1183), but the commune was undermined by social unrest. During the thirteenth century, the Visconti and Della Torre families fought to impose their lordship or signoria. The Viscontis prevailed, and under their dominion Milan then became the Renaissance ducal power that served as a concrete reference for the fairy-like atmosphere of Shakespeare’s The Tempest. Meanwhile, Milan’s archbishopric was influential, and Carlo Borromeo (1538-1584) became a leading figure during the counter-Reformation. Having passed through the rule of the Sforzas (Francesco Sforza ruled until the city was captured by Louis XII of France in 1498) and the domination of the Hapsburgs, which ended in 1713 with the war of the Spanish Succession, Milan saw the establishment of Austrian rule. The enlightened rule of both Hapsburg emperors (Maria Theresa and Joseph II) encouraged the flowering of enlightenment culture, which Lombard reformers such as the Verri brothers, Cesare Beccaria, and the entire group of intellectuals active around the journal Il caffè bequeathed to Milan during the Jacobin and romantic periods. In fact, the city which fascinated Stendhal when he visited it in 1800 as a second lieutenant in the Napoleonic army became, between the end of the eighteenth century and the beginning of the nineteenth century, a reference point in the cultural and social field. -

Brochure Lignano Eng
Seaside holidays with a difference A melting pot for Latin, Germanic and Slav civilizations. Beaches of fine sand and a sea gently sloping away in Lignano and Grado, inlets embedded between white rocks in Trieste. Enchanting places, all year round. espite its limited extension, the And the allure of this area lasts well D coastline of Friuli Venezia Giulia beyond the summer months. offers many different facets of typical The fascination of Friuli Venezia Giulia Mediterranean appeal: surroundings and coast is just as intense in the spring, landscapes that astonish visitors because autumn and even winter. Mediterranean of the incredible contrasts in the space This is when the beaches are ideal for of a few miles. long romantic strolls. Grado is animated This is right where the Adriatic laps at by its centuries-old fishing tradition, with the shores of central Europe, offering delicious freshly caught fish skilfully a meeting between Latin, Germanic prepared by the local restaurants. and Slavic Mediterranean cultures. Northwards, the Trieste gulf, swept beaches From Lignano Sabbiadoro to Grado, the frequently by the impetuous north-easterly Friuli Venezia Giulia coast welcomes you Bora wind, offers a more introspective with its inviting and relaxing appeal. relationship with the sea. Here you’ll find broad sandy beaches From Duino to Sistiana and through to with their characteristic soft golden-brown Trieste itself, the coastline features a coloured sand and dunes. succession of sheer white cliffs interspersed in the heart And the sea is absolutely irresistible, with areas of dense Mediterranean vegetation. with its shallow waters and relaxing waves It’s also an ideal destination for summer that break gently on the beach. -
Descrizione Centro Manoscritti
Il Fondo Ferrieri presso il Centro Manoscritti dell’Università di Pavia Nicoletta Trotta Il Fondo Ferrieri è stato acquisito dal Centro di ricerca sulla tradizione manoscrit- ta di autori moderni e contemporanei dell’Università di Pavia nel 1991 per volontà dei figli di Enzo Ferrieri: in una lettera del 12 settembre 1991Anna Ferrieri Castelli e Giuliano Ferrieri scrivevano al Magnifico Rettore dell’ateneo pavese per confer- mare la donazione di «tutto il materiale autografo inedito conservato da Enzo Fer- rieri, che testimonia l’intenso scambio di corrispondenza, di idee e di iniziative culturali» che il loro «padre ebbe con i protagonisti della vita intellettuale italiana ed europea durante il ventennio tra le due guerre» e promettevano di consegnare,a completamento del materiale già affidato, i numeri disponibili della rivista «Il Convegno». Qualche mese prima il Centro Manoscritti aveva dedicato a questa importante acquisizione una mostra documentaria dal titolo “Il Convegno”di Enzo Ferrieri e la cultura europea dal 1920 al 1940, tenutasi a Pavia, presso la Sala dell’Annunciata, dall’11 al 25 maggio.Il ricco catalogo,1 curatodaAngeloStella,siapreconlacorpo- sa sezione Le sale della letteratura italiana diAnna Modena,seguono i contributi di Guido Lopez, Eugenio Levi, la“coscienza inquieta” del“Convegno”, di Maria Fancel- li,2 Oltre Chiasso e diAndrea Mancini, I segni della regia: la voce,l’albero,la bottiglia rovesciata;chiude il volume lo spoglio della rivista, “Il Convegno”: indice degli auto- ri e delle opere recensite,perlecuredichiscrive. -

Italian Studies Comp Exam Reading Lists 1&2
1 University of Texas at Austin Graduate Program in Italian Studies Reading Lists 1 and 2 for the Comprehensive Examination In addition to careful study of the required works listed below, students are expected to acquire general knowledge of all periods, genres, and major movements in Italian literature and cinema. List 1 (1200-1750) Read as widely as possible in the two-volume Poeti del Duecento, ed. G. Contini (Milan: Ricciardi, 1960). Francis of Assisi, "Cantico delle creature" Jacopone da Todi, "Que farai, fra Iacovone" (Contini #2), "Donna de Paradiso (Contini #16) Giacomo da Lentini, "Madonna, dir vo voglio" (Contini #1), "Meravigliosamente" (Contini #2), "Io m'aggio posto in core a Dio servire" (Contini #12) Guittone d'Arezzo, "Gente noiosa e villana" (Contini #3), "Tuttor ch'eo dirò 'gioi', gioiva cosa" (Contini #16) Compiuta Donzella, "A la stagion che 'l mondo foglia e fiora," "Lasciar vorria lo mondo a Dio servire" (both poems in Contini and in Natalia Costa-Zalessow, ed., Scrittrici italiane dal XII al XX secolo [Ravanna: Longo, 1982]). Cecco Angiolieri, "S'i' fosse fuoco, arderei il mondo," "Tre cose solamente m'ènno in grado" Guido Guinizzelli, "Al cor gentil rempaira sempre amore," "Vedut' ho la lucente stella Diana" Guido Cavalcanti, "Chi è questa che vèn, ch'ogn'om la mira," "Donna me prega" Dante Alighieri, Vita nuova, Divina Commedia, De vulgari eloquentia (Italian or English translation) Giovanni Boccaccio, all of Il Decameron, with emphasis on the following novelle in addition to the frame narrative: 1.1-3, 2.4-5, 3.1-2, 4.5, 4.7, 4.9, 5.8-9, 6.7-10, 7.1-2, 8.3-6, 9.2-3, 10.4-5, 10.10.