ALLEGATO: Caratteristiche Salienti Dell'area Protetta
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
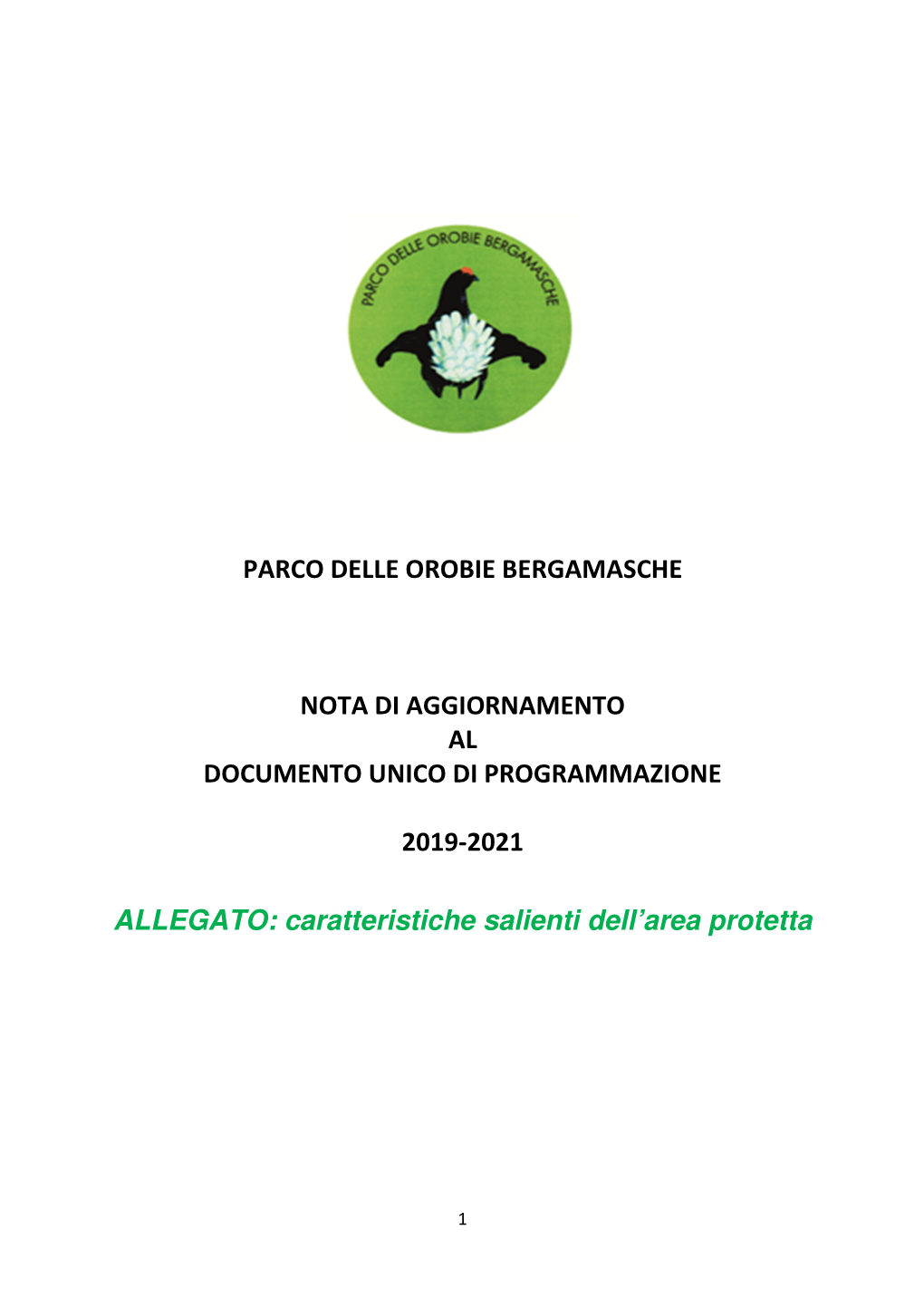
Load more
Recommended publications
-

A Registro Ufficiale.U.0053836.17-06-2020
REGISTRO UFFICIALE.U.0053836.17-06-2020.h.10:58 DIREZIONE SOCIOSANITARIA Spett.li Sindaci dei Comuni della provincia di Bergamo Consiglio di Rappresentanza dei Sindaci Presidenti delle Assemblee dei Sindaci dei Distretti Presidenti delle Assemblee dei Sindaci degli Ambiti distrettuali Responsabili Uffici di Piano Responsabili UTES Oggetto: Ordinanza n. 566 del 12.06.2020 - Servizi per l’infanzia e l’adolescenza (attività estive). Gentilissimi, anche a seguito del confronto tenutosi il 15 giugno c.a. con la Direzione Politiche per la famiglia, genitorialità e pari opportunità di Regione Lombardia in merito all’Ordinanza n. 566 del 12 giugno u.s. e ai servizi estivi per l’infanzia e l’adolescenza si specifica quanto segue: − L’Ente gestore deve predisporre il Progetto Organizzativo che contiene una descrizione generale dell’attività ed è articolato in relazione agli aspetti disciplinati dall’allegato 8 al DPCM 11 giugno 2020 e dall’Ordinanza n. 566 del 12 giugno 2020. L’Ente gestore provvede altresì ad inviare il progetto al Comune e alla scrivente ATS agli indirizzi: [email protected] [email protected] tel. 035.385.306-7 − Le attività estive potranno essere realizzate come opportunità organizzate di socialità e gioco per i bambini e adolescenti 0-17 anni (Ordinanza regionale n. 566/2020) o come Centri Ricreativi Diurni (per i quali resta in vigore la relativa normativa - L.R. 3/2008, D.g.r. 11496/2010, D.d.g. 1254/2010 e Ordinanza regionale n. 566/2020). In entrambi i casi l’Ente Gestore dovrà predisporre il Progetto Organizzativo e trasmetterlo al Comune di riferimento e all’ATS di Bergamo. -

ALLEGATO 4: CARTOGRAFIA DI INQUADRAMENTO (Fonte: Sistema Informativo Territoriale – SITER - Della Provincia Di Bergamo)
ALLEGATO 4: CARTOGRAFIA DI INQUADRAMENTO (fonte: Sistema Informativo TERritoriale – SITER - della Provincia di Bergamo) VILMINORE DI SCALVE VALGOGLIO GROMO COLERE ´ OLTRESSENDA ALTA ARDESIO ANGOLO TERME CASTIONE DELLA PRESOLANA FINO DEL MONTE VILLA D`OGNA PARRE PIARIO ONORE CLUSONE ROGNO SONGAVAZZO CERETE ROVETTA COSTA VOLPINO BOSSICO SOVERE GANDINO LOVERE 1:50.000 Confine comunale Industriale Raffreddamento Scarico di emergenza privato Scarico depurato pubblico Terminale pubblica fognatura bianche Scarico di emergenza (Staz. sol. / bypass) Sfioratore Sfioratore/scarico staz. sollevamento Reticolo idrografico Carta degli scarichi autorizzati in corpo d'acqua superficiale VILMINORE DI SCALVE VALGOGLIO GROMO COLERE ´ OLTRESSENDA ALTA ARDESIO ANGOLO TERME CASTIONE DELLA PRESOLANA FINO DEL MONTE VILLA D`OGNA PARRE PIARIO ONORE CLUSONE ROGNO SONGAVAZZO CERETE ROVETTA COSTA VOLPINO BOSSICO SOVERE GANDINO LOVERE 1:50.000 Confine comunale Sorgenti / Fontanili Derivazioni superficiali Pozzi Potabile Potabile Potabile Antincendio Antincendio Antincendio Igienico Igienico Igienico Industriale Industriale Industriale Produzione Energia Produzione Energia Produzione Energia Piscicoltura Piscicoltura Piscicoltura Zootecnico Zootecnico Irriguo Zootecnico Irriguo Uso Domestico Irriguo Uso Domestico Altro uso Uso Domestico Altro uso Altro uso Carta delle piccole derivazioni di acqua VILMINORE DI SCALVE VALGOGLIO GROMO COLERE ´ OLTRESSENDA ALTA ARDESIO ANGOLO TERME CASTIONE DELLA PRESOLANA FINO DEL MONTE VILLA D`OGNA PARRE PIARIO ONORE CLUSONE ROGNO SONGAVAZZO -

(Ha) Palude Brabbia VA Casale Litta, Cazzago Brabbia, Inarzo, Ternat
BIOSFERA ZPS - ZONE DI PROTEZIONE SPECIALE ZONE PROTETTE SUPERFICIE ZONA DI PROTEZIONE SPECIALE PROVINCIA COMUNI (ha) Palude Brabbia VA Casale Litta, Cazzago Brabbia, Inarzo, Ternate, Varano Borghi 459,79 Parco Regionale Campo dei Fiori VA Barasso, Bedero, Valcuvia, Brinzio, Castello Cabiaglio, Cocquio-Trevisago, Comerio, Cuvio, Gavirate, Induno Olona, Luvinate, Orino, Valganna, Varese 1.298,40 Lago di Varese VA Azzate, Bardello, Biandronno, Bodio Lomnago, Bubuggiate, Cazzago Brabbia, Galliate Lombardo, Gavirate, Varese 1.738,03 Canneti del Lago Maggiore VA Angera, Besozzo, Brebbia, Ispra, Monvalle, Ranco, Sesto Calende 227,27 Triangolo Lariano CO, LC Canzo, Valbrona, Valmadrera 592,78 Monte Generoso CO Lanzo d'Intelvi, Pellio d'Intelvi 236,88 Valsolda CO Valsolda 327,45 Monte Barro LC Galbiate, Malgrate, Pescate, Valmadrera 411,24 Grigne LC Abbadia, Lariana, Ballabio, Cortenova, Esino, Lario, Mandello del Lario, Pasturo 7.161,48 Lago di Mezzola e Pian di Spagna SO, CO Dubino, Gera Lario, Novate Mezzola, Sorico, Verceia 1.610,55 Parco Nazionale dello Stelvio SO, BS Bormio, Livigno, Ponte di Legno, Sondalo, Temù, Valdidentro,Valdisotto,Valfurva, Vezza d'Oglio, Vione 59.744,33 Monte di scerscen - Ghiacciaio di Scerscen - Monte Motta SO Lanzada 9.666,25 Disgrazia - Sissone SO Chiesa in Valmalenco 3.010,48 Val Codera SO Novate Mezzola 818,00 Parco Regionale Orobie Valtellinesi SO Albaredo per San Marco, Albosaggia, Andalo Valtellino, Aprica, Bema, Caioplo, Cedrasco, Colorina, Cosio Valtellino, Delebio, Faedo Valtellino, Forcola, Gerola Alta, -

International Orobie Skyraid - Ardesio/Valbondione - 24/07/2021 06:00
INTERNATIONAL OROBIE SKYRAID - ARDESIO/VALBONDIONE - 24/07/2021 06:00 Pos Bib Name Cat #Cat Team Var Time 1 284 ARRIGONI LUCA O40M 1 ASD AUTOCOGLIATI 07:11:18.246 RUN 2 533 LORENZI FRANCESCO AM 1 TEAM BOSCAINI 00:35:06.754 07:46:25.000 RUNNERS 3 597 CARRARA LUCA O40M 2 TEAM SALOMON 00:47:47.767 07:59:06.013 4 9 BELINGHIERI CLEMENTE O40M 3 AUTOCOGLIATI 00:49:20.268 08:00:38.514 5 210 ZANCHI MARCO O40M 4 TEAM VIBRAM / 00:55:36.267 08:06:54.513 MARINELLI COMENDUNO 6 207 BARONI ANDREA O40M 5 G.S. MARINELLI 01:03:07.286 08:14:25.532 7 520 MILESI IVAN AM 2 GS OROBIE 01:04:30.779 08:15:49.025 8 229 MAZZOCCHI DAVIDE AM 3 TEAM POOL 01:05:51.007 08:17:09.253 9 588 SORTENI ANDREA AM 4 SKYRUNNING 01:06:35.781 08:17:54.027 ADVENTURE 10007 10 406 NORIS ANDREA AM 5 SPORT EVOLUTION 01:08:13.512 08:19:31.758 11 465 BOLIS MATTEO O40M 6 ALTITUDE RACE 01:16:11.046 08:27:29.292 12 25 ZANCHI NICOLO AM 6 TEAM GAAREN 01:16:49.556 08:28:07.802 #BEaHERO 13 288 CURNIS CARLO AM 7 ELLE ERRE ASD 01:19:03.054 08:30:21.300 14 534 TURINI GIUDITTA AF 1 HOKA ONE ONE- 01:24:53.540 08:36:11.786 KARPOS 15 258 MORETTINI LORENZO AM 8 GAV VERTOVA 01:24:56.051 08:36:14.297 16 444 PICCINELLI ENRICO AM 9 01:27:59.535 08:39:17.781 17 527 MICHELI GIAMBATTISTA AM 10 CARVICO 01:28:52.521 08:40:10.767 SKYRUNNING 18 499 BONZI LORIS AM 11 G.S.OROBIE 01:29:51.513 08:41:09.759 19 172 MERLINI MAURIZIO AM 12 ALTITUDE RACE 01:30:49.525 08:42:07.771 20 17 SALMASO MATTEO AM 13 TEAM GAAREN 01:31:37.513 08:42:55.759 #BEaHERO 21 399 MARCHESI MARCO AM 14 01:35:49.797 08:47:08.043 22 70 CAPELLI MAICHOL AM 15 TEAM GAAREN 01:36:22.802 08:47:41.048 #BEaHERO 23 611 BRUMANA ANDREA AM 16 A.S. -

[email protected] COMUNE DI
Regione Lombardia - Giunta DIREZIONE GENERALE INFRASTRUTTURE, TRASPORTI E MOBILITA' SOSTENIBILE INFRASTRUTTURE VIARIE E AEROPORTUALI VIABILITA' E MOBILITA' CICLISTICA Piazza Città di Lombardia n.1 www.regione.lombardia.it 20124 Milano [email protected] Tel 02 6765.1 Protocollo S1.2019.0010104 del 20/03/2019 PROVINCIA DI BERGAMO Email: [email protected] COMUNE DI ADRARA SAN MARTINO Email: [email protected] mbardia.it COMUNE DI ADRARA SAN ROCCO Email: [email protected] COMUNE DI ALBANO SANT'ALESSANDRO Email: [email protected] COMUNE DI ALBINO Email: [email protected] COMUNE DI ALGUA Email: [email protected] COMUNE DI ALME Email: [email protected] COMUNE DI ALMENNO SAN BARTOLOMEO Email: [email protected] mo.it COMUNE DI ALMENNO SAN SALVATORE Email: [email protected] COMUNE DI ALZANO LOMBARDO Email: [email protected] COMUNE DI AMBIVERE Email: [email protected] Referente per l'istruttoria della pratica: PAOLA VIGO Tel. 02/6765.5137 GABRIELE CASILLO Tel. 02/6765.8377 COMUNE DI ANTEGNATE Email: [email protected] COMUNE DI ARCENE Email: [email protected] COMUNE DI ARDESIO Email: [email protected] COMUNE DI ARZAGO D'ADDA Email: [email protected] COMUNE DI AVERARA Email: [email protected] COMUNE DI AVIATICO Email: [email protected] -

Scarica Il Documento
REGIONE LOMBARDIA PROVINCIA DI BERGAMO C.M. VALLE BREMBANA COMUNE DI OLTRE IL COLLE E N E R G I A M I N E R A L S I T A L I A S . R . L . P E R M E S S O D I R I C E R C A M I N E R A R I O I N C O N C E S S I O N E D E N O M I N A T O “ P A R I N A ” P R O G R A M M A D E I L A V O R I 2 0 1 8 C O M U N E D I O L T R E I L C O L L E ( B G ) - M I N I E R E D E L C O M P L E S S O M I N E R A R I O R I S O / P A R I N A - S T U D I O P E R L A V A L U T A Z I O N E D I I N C I D E N Z A ( A R T . 6 D I R E T T I V A 9 2 / 4 3 / C E E “ H A B I T A T ” , D P R 3 5 7 / 1 9 9 7 E D G R V I I / 1 4 1 0 6 / 2 0 0 3 ) Grassobbio, giugno 2018 a cura di: Hattusas S.r.L. -

CV Per. Ind. Graziano Guerini
Studio Elettrotecnico Guerini p.i. Graziano Uffici: Piazza San Giorgio, 15/E – 24020 Fiorano al Serio - BG – Tel/fax 035721651 – Cell. 3357205362 e-mail: [email protected] - c.f. GRN GZN 77D15 D952R - P.I. 02931130161 – Iscrizione all’Albo n°1305 Curriculum Professionale INFORMAZIONI GENERALI Nome e Cognome Guerini Graziano Nato a Gazzaniga il 15/04/1977 Residente in Via Tironega, 46 24060 Endine Gaiano (BG) Ufficio in Piazza San Giorgio, 15/E 24020 Fiorano al Serio (BG) Recapiti Telefonici: Tel/fax 035721651 Cell.335/7205362 E-mail: [email protected] Professione: Libero Professionista Iscritto al Collegio dei periti Industriali della Provincia di Bergamo nell’anno 2002 al n°1305 ISTRUZIONE Diploma di Perito Industriale conseguito presso l’ITIS di Gazzaniga (BG) nell’anno scolastico 1995/96 specializzazione Elettrotecnica, Votazione 56/60. Diploma di abilitazione all’esercizio della libera professione conseguito presso l’ITIS Paleocapa (BG) nell’anno 2001, votazione 66/100 Attestato di partecipazione al corso di “classificazione delle aree a rischio di esplosione” svoltosi presso la sede del Collegio dei Periti Industriali di Bergamo nell’anno 2002 secondo le nuove Norme CEI 31-30, 31-35 ecc. Attestato di partecipazione al corso di “Protezione dalle sovratensioni, scelta ed applicazione di scaricatori di sovratensioni”” svoltosi presso la sede del Collegio dei Periti Industriali di Bergamo nell’anno 2002 secondo le Norme CEI 81-1, 81-4 e Guida CEI 81-8. Master di illuminotecnica applicata per esterni secondo la legge regionale 17/2000 e 38/2004 svoltosi nell’anno 2005 Attestato di partecipazione al corso di “classificazione delle aree a rischio di esplosione per la presenza di Polveri”” svoltosi presso la sede del CEI con relatore prof. -

Mapping Riflessivo Sul Contagio Covid-19
MAPPING RIFLESSIVO SUL CONTAGIO COVID-19 Dalla localizzazione del fenomeno all’importanza della sua dimensione territoriale 1° RAPPORTO DI RICERCA Perché proprio a Bergamo? (marzo 2020 – aprile 2020) Gruppo di ricerca: Responsabili: Emanuela Casti, direttore del Centro Studi sul Territorio e responsabile del DiathesisLab Fulvio Adobati, membro del Centro Studi sul Territorio Ricercatori e studenti implicati: Andrea Azzini, Andrea Brambilla, Francesca Cristina Cappennani, Emanuele Comi, Elisa Consolandi, Emanuele Garda, Marta Rodeschini, Maria Rosa Ronzoni, Anna Maria Variato Sommario SINTESI ORIENTATIVA p. 3 INTRODUZIONE p. 5 Capitolo I – DALLA LOCALIZZAZIONE ALL’IMPORTANZA DELLA DIMENSIONE TERRITORIALE DEL CONTAGIO 1.1 Implicazioni geografiche e ancoraggi teorici p. 6 1.2 Dati territoriali del Covid-19 p. 9 Capitolo II – MAPPING RIFLESSIVO: PRIMI RISULTATI 2.1 Territorio nazionale p. 11 2.2 Regione Lombardia p. 14 2.3 Provincia di Bergamo p. 16 Lista delle figure p. 19 Riferimenti bibliografici p. 20 2 SINTESI ORIENTATIVA Per contribuire a dare una risposta sul perché la diffusione del contagio ha assunto le attuali proporzioni nel territorio bergamasco alcuni ricercatori del CST dell’Università di Bergamo hanno intrapreso una ricerca che, utilizzando le banche dati prodotte negli anni sugli aspetti socio- territoriali e gli innovativi sistemi cartografici web in esso utilizzati, stanno indagando la diffusione del contagio del Covid-19. a scala nazionale, della Lombardia e della provincia di Bergamo. Mettendo in rapporto gli aspetti territoriali (distribuzione della popolazione, composizione per fasce di età, varie forme di mobilità, organizzazione del lavoro, inquinamento-clima) con quelli resi pubblici dal Ministero della Salute e dall’Istituto Superiore di Sanità. -

SCUOLE DELL'obbligo PER GRADUATORIE PERMANENTI E D'istituto FLC CGIL BERGAMO Servizi Per Gli Iscritti
SCUOLE DELL'OBBLIGO PER GRADUATORIE PERMANENTI E D'ISTITUTO FLC CGIL BERGAMO Servizi per gli iscritti DISTRETTO 025 IST.COMPR.CLUSONE COD. BGIC80600Q VIALE ROMA 11 TEL. 034621023 SC.DELL'INFANZIA PIARIO n. classi n. alunni SC.PRIMARIA CLUSONE n. classi n. alunni SC.PRIMARIA PIARIO n. classi n. alunni SC.PRIMARIA VILLA D'OGNA n. classi n. alunni SC.SEC.I GR.CLUSONE n. classi n. alunni IST.COMPR.GROMO COD. BGIC85100N VIA DE MARCHI 12 TEL. 034641111 SC.DELL'INFANZIA ARDESIO VALCANALE n. classi n. alunni SC.DELL'INFANZIA GANDELLINO n. classi n. alunni SC.DELL'INFANZIA VALGOGLIO n. classi n. alunni SC.PRIMARIA ARDESIO n. classi n. alunni SC.PRIMARIA ARDESIO VALCANALE n. classi n. alunni SC.PRIMARIA GANDELLINO n. classi n. alunni SC.PRIMARIA GROMO n. classi n. alunni SC.PRIMARIA VALBONDIONE n. classi n. alunni SC.PRIMARIA VALGOGLIO n. classi n. alunni SC.SEC.I GR.ARDESIO n. classi n. alunni SC.SEC.I GR.GROMO n. classi n. alunni SC.SEC.I GR.VALBONDIONE n. classi n. alunni IST.COMPR.PONTE NOSSA COD. BGIC86400Q VIA RIMEMBRANZE 5 TEL. 035701102 SC.DELL'INFANZIA GORNO VILLASIO n. classi n. alunni SC.DELL'INFANZIA ONETA n. classi n. alunni SC.PRIMARIA GORNO n. classi n. alunni SC.PRIMARIA ONETA n. classi n. alunni SC.PRIMARIA PARRE n. classi n. alunni SC.PRIMARIA PONTE NOSSA n. classi n. alunni SC.PRIMARIA PREMOLO n. classi n. alunni SC.SEC.I GR.GORNO n. classi n. alunni SC.SEC.I GR.PONTE NOSSA n. classi n. alunni IST.COMPR.ROVETTA COD. -

Bergamo-Ski-Tour-2020Low.Pdf
“Il Bergamo Ski Tour è una manifestazione che mette in evidenza l’importanza della collaborazione fra club per l’organizzazione di gare di alto livello. In questa occasione, lo Sci Club Gromo unitamente agli Sci Club Roncobello e Schilpario ne sono la dimostrazione pratica. L’evento torna a Bergamo impreziosito da gare che assegnano titoli importanti, che vanno dal Campionato Italiano Assoluto IL BERGAMO ai Campionati U23 U20 e U18, e questo ci inorgoglisce dato che vedremo sfidarsi sulle nostre piste campioni di livello mondiale. SKI TOUR È UNA Tutto ciò incrementerà l’entusiasmo e l’amore per questo sport dei tanti ragazzi che già lo praticano, incuriosendo anche a quelli MANIFESTAZIONE CHE che, ancora giovanissimi, vorrebbero indossare gli sci “stretti”. METTE IN EVIDENZA La buona riuscita dell’evento sarà possibile solo grazie all’impegno L’IMPORTANZA DELLA di tante persone, che metteranno a disposizione il loro tempo libero per aiutare la macchina organizzativa a rendere la manifestazione COLLABORAZIONE indimenticabile, come spesso accade nella nostra provincia. FRA CLUB PER Agli organizzatori vanno i complimenti per aver saputo riproporre L’ORGANIZZAZIONE DI un evento sicuramente gradito ai tantissimi appassionati, mentre GARE DI ALTO LIVELLO agli atleti auguriamo un in bocca al lupo per le gare.” - Fausto Denti - SALUTO DEL SALUTO BG FISI PRESIDENTE COMITATO ORGANIZZATORE Presidente del co: Fausto Denti Membri: Emiliano Milesi, Paolo Morstabilini, Andrea Giudici, Laura Quarteroni, Cristina Bonacorsi, Ilario Morandi DELEGATI, ORGANI -

Concentrazioni Radon Nei Comuni Della Provincia Di Bergamo
CONCENTRAZIONI RADON NEI COMUNI DELLA PROVINCIA DI BERGAMO durata rilievo valore medio Provincia Comune anno competenza (giorni) (Bq/m3) BERGAMO ADRARA SAN MARTINO 365 47 2003 campagna ASL ARPA 365 51 2003 campagna ASL ARPA 365 67 2003 campagna ASL ARPA 365 121 2003 campagna ASL ARPA 365 160 2003 campagna ASL ARPA BERGAMO ALBINO 365 66 2003 campagna ASL ARPA 365 99 2003 campagna ASL ARPA 365 120 2003 campagna ASL ARPA 365 626 2003 campagna ASL ARPA 365 69 2003 campagna ASL ARPA BERGAMO ALGUA 365 140 2003/2009 campagna ASL ARPA 365 250 2003 campagna ASL ARPA 365 120 2003 campagna ASL ARPA 365 56 2003 campagna ASL ARPA 365 385 2003 campagna ASL ARPA BERGAMO ALMENNO SAN BARTOLOMEO 365 27 2003 campagna ASL ARPA 365 31 2003 campagna ASL ARPA 365 43 2003 campagna ASL ARPA 365 58 2003 campagna ASL ARPA BERGAMO ALMENNO SAN SALVATORE 365 16 2003 campagna ASL ARPA 365 45 2003 campagna ASL ARPA 365 60 2003 campagna ASL ARPA 365 70 2003 campagna ASL ARPA 365 82 2003 campagna ASL ARPA 365 158 2003 campagna ASL ARPA BERGAMO ALZANO LOMBARDO 6 595 2013 ICO Sas di ing Fornai 5 165 2013 ICO Sas di ing Fornai 121 255 2013 ICO Sas di ing Fornai BERGAMO AMBIVERE 365 63 2003 campagna ASL ARPA 365 79 2003 campagna ASL ARPA 365 114 2003 campagna ASL ARPA BERGAMO ARDESIO 365 54 2003/2009 campagna ASL ARPA 365 82 2003/2009 campagna ASL ARPA 365 122 2003/2009 campagna ASL ARPA 365 70 2003/2009 campagna ASL ARPA 365 112 2003/2009 campagna ASL ARPA 365 144 2003/2009 campagna ASL ARPA 365 156 2003/2009 campagna ASL ARPA 365 47 2003/2009 campagna ASL ARPA 365 240 2003/2009 -

Parte 2: Settori B2 E B3
AGENZIAAGENZIA per per il ilTRASPORTO TRASPORTO PUBBLICO PUBBLICO LOCALE LOCALE deldel BACINO BACINO di di BERGAMO BERGAMO Via T.Tasso 8, 24121 Bergamo – CF e PIVA 04083130163 Via T.Tasso 8, 24121 Bergamo – CF e PIVA 04083130163 PEC: [email protected] Tel. 035/387706 mail: [email protected] Web: www.agenziatplbergamo.it PEC: [email protected] Tel. 035/387706 mail: [email protected] Web: www.agenziatplbergamo.it Programma di Bacino del Trasporto Pubblico Locale Allegato 2 - Percorsi delle linee Parte 2: settori B2 e B3 versione data Redatto da Descrizione 0 01/03/2018 Emilio Grassi Emissione per consultazione 1 15/05/2018 Emilio Grassi Emissione per iter approvativo 2 30/06/2018 Emilio Grassi Recepimento osservazioni Regione Lombardia Indice Percorsi delle Linee in Area Urbana – settore B1 – Linee di forza in Area Urbana Parte 1 – Linee di supporto in Area Urbana – Possibili varianti in Area Urbana Percorsi delle Linee interurbane Parte 2 ° Settore B2 ° Settore B3 Percorsi delle Linee interurbane ° Settore B4 Parte 3 ° Settore B5 ° Settore B6 Percorsi delle Linee interurbane ° Settore B7 Parte 4 ° Settore B8 ° Settore B9 Parte 5 Gli interscambi 30 giugno 2018 pag. 2 Linee del settore B2xx: elenco e gerarchia Nome classificazione Linea RL01 R-Link Bergamo – Grumello – Sarnico RL02 R-Link Bergamo – Casazza – Lovere B210 Portante interurbana Grumello-Telgate-Bergamo B211 Adduzione liv.1 Credaro-Grumello B212 Adduzione liv.1 Adrara S.Rocco-Villongo B213 Adduzione liv.1 Foresto Sparso-Credaro B221 Adduzione