Dott. Roberto Rattu Coordinatore Dottorato Prof.Ssa Cristina Lavi
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Journal of European Integration History
Journal of European Integration History Revue d’Histoire de l’Intégration Européenne Zeitschrift für Geschichte der europäischen Integration JOURNAL OF EUROPEAN INTEGRATION HISTORY Edited by Contents The purpose of The Journal of European Integration History is to encourage the analysis and The European Union Liaison Elena CALANDRI, Simone PAOLI understanding of different aspects of European integration, especially since 1945, in as wide a Commitee of Historians Europe and the Mediterranean in the long 1980s perspective as possible. The Journal publishes the conclusions of research on diplomatic, military, Evanthis HATZIVASSILIOU economic, technological, social and cultural aspects of integration. Numbers devoted to single Number 1 n The Cold War as a Frontier: The Mediterranean themes as well as to diverse subjects are published in English, French or German. Each number Cleavages and the View from NATO, 1967-1982 includes reviews of important, relevant publications. Karin LIEBHART Images of the Mediterranean in Late 20th Century REVUE D’HISTOIRE DE L’INTÉGRATION EUROPÉENNE German Quality Press Volume 21 L’objectif de la Revue d’histoire de l’intégration européenne est de promouvoir l’analyse et la n Sofia PAPASTAMKOU compréhension des différents aspects de l’intégration européenne particulièrement depuis 1945, Greece between Europe and the Mediterranean, mais sans exclusive. La Revue publie les résultats des recherches sur les aspects diplomatiques, 1981-1986.The Israeli-Palestinian Conflict and the 2015 militaires, économiques, technologiques, sociaux et culturels de l’intégration. Les numéros à thème n Greek-Libyan Relations as Case Studies ou ceux ouverts à diverses perspectives sont publiés dans l’une des langues suivantes: anglais, Claudia CASTIGLIONI français, allemand. -

Sociology in Italy Today. INSTITUTION Delaware Univ., Newark.; Institute of International Studies (DHEW/OE), Washington, D.C
DOCUMENT RESUME ED 057 263 AA 000 756 AUTHOR DiPenzo, Gordon J. TITLE Sociology in Italy Today. INSTITUTION Delaware Univ., Newark.; Institute of International Studies (DHEW/OE), Washington, D.C. PUB DATE 71 NOTE 58p. EDRS PRICE MF-$0.65 HC-$3.29 DESCRIPTORS College Faculty; College Students; *Data Collection; Employment Opportunities; Graduate Study; *Interviews; Libraries; Organizational Change; Professional Occupations; *Research Methodology; *Sociology; *Surveys; Universities IDENTIFIERS *Italy ABSTRACT The purpose of this assessment is to update earlier surveys of Italian sociology, particularly in terms of developments within the past 10 to 15 years--and again, to offer primarily an American perspective on such an overview. The present assessment differs in that many of the data upon which it is based are derived from informal study conducted during a two-year period. This study involved on-the-spot visits to universities, research agencies, publishing houses, library inspections, and a number of personal interviews, throughout Italy, with sociologists, university professors, research people, students, and other personnel associated with Italian soci3logy. Formal research was also conducted. It was found that Italian sociology during the past 25 years has emerged into one of the strongest positions among the countries of Europe. Further progress, however, depends to a great extent upon reorganization of the Italian university and the creation of emplLyment opportunities for sociologists throughout Italian society. Reportedly only a very small percentage, less than 10%, of gradual- from Trento and the post-graduate programs are successful in employment commensurate with their professional training and interests. (Author/CK) SOCIOLOGY IN ITALY TODAY GORDONcJ. DiRENZO PROFESSOR OF SOCIOLOGY University of Delaware and University of Rome* 1971 SOCIOLOGY IN ITALY TODAY Assessments of the post-World War II development of sociology in Italy have been made periodically (Rapport, 1957; Rose, 1958; Treves, 1959,1960; Evangelisti, 1961; Moss) 1964). -

Language & Identity
Bouzidi, Hassan (1989) Language attitudes and their implications for education: Morocco as a case study. PhD thesis. http://theses.gla.ac.uk/5371/ Copyright and moral rights for this thesis are retained by the author A copy can be downloaded for personal non-commercial research or study, without prior permission or charge This thesis cannot be reproduced or quoted extensively from without first obtaining permission in writing from the Author The content must not be changed in any way or sold commercially in any format or medium without the formal permission of the Author When referring to this work, full bibliographic details including the author, title, awarding institution and date of the thesis must be given Glasgow Theses Service http://theses.gla.ac.uk/ [email protected] LANGUAGE ATTITUDES AND THEIR IMPLICATIONS FOR EDUCATION: MOROCCO AS A CASE STUDY Thesis submitted to the University of GLASGOW by HASSAN BOUZIDI in fulfilment of the requirements of the degree of Doctor of Philosophy. © H. BOUZIDI Glasgow University October, 1989 FOR MY MOTHER AND FATHER ACKNOWLEDGMENTS I would especially like to express my gratitude to my supervisors Professor John Mattock and Mr. J.M.Y. Simpson for their indefatigable help and assistance throughout the period of my research. Thanks are also due to Miss A.M. McGregor and Professor LB. Thomson for their invaluable support and patience, to Dr. M.K.C. MacMahon for his suggestions and advice, and to Mr J.Stephen, of the Computing Science Department, for his generous help with the preparation of the statistical figures. I am deeply indebted to several institutions: the Moroccan Ministry of Higher Education for providing me with a grant and Glasgow University for providing financial help for a number of years; their assistance ensured the continuity of my research. -

2/9/2010 1 STANLEY LIEBERSON Curriculum Vitae Personal Birthdate
2/9/2010 STANLEY LIEBERSON Curriculum Vitae Personal Birthdate: April 20, 1933 Birthplace: Montreal, Canada Citizenship: U.S.A. Education B.A. None M.A. University of Chicago Sociology 1958 Ph.D. University of Chicago Sociology 1960 Positions Harvard University, Professor of Sociology 1988- (Abbott Lawrence Lowell Research Professor 2007-) (Abbott Lawrence Lowell Professor 1991-2006) University of California, Berkeley, Professor of Sociology 1983-1988 University of Arizona, Professor of Sociology 1974-1983 University of Chicago, Professor of Sociology 1971-1974 University of Washington, Professor of Sociology 1967-1971 University of Wisconsin, Assistant Professor to Professor of Sociology 1961-1967 University of Iowa, Instructor to Assistant Professor of Sociology 1959-196l University of Toronto, Claude Bissell Distinguished Visiting Professor 1979-1980 Stanford University, Visiting Professor Summer 1970 Professional Activities Editorial Activities Social Problems (1965-1967); Sociological Inquiry (1965-1967); American Journal of Sociology (1969-1974); Language in Society (1972-1974); Sociological Methods and Research (1971-1996); Sociological Abstracts 1972-1973); International Journal of the Sociology of Language (1974- ); Canadian Journal of Sociology/Revue canadienne de sociologie (1975- 2000); Language Problems and Language Planning (1977-1999); Social Forces (1980-1983); Research in Social Stratification and Mobility, (1984-1986). 1 2/9/2010 Other Professional Activities University of Chicago Colver-Rosenberger Educational Prize -

Work Package Descriptions
Grant agreement for: CIP-Best Practice Network Annex I - "Description of Work" Project acronym: AthenaPlus Project full title: " Access to cultural heritage networks for Europeana " Grant agreement no: 325098 Version date: 2013-03-06 Table of Contents Part A A.1 Project summary ......................................................................................................................................3 A.2 List of beneficiaries ..................................................................................................................................4 A.3 Overall budget breakdown for the project ............................................................................................... 6 Workplan Tables WT1 List of work packages ............................................................................................................................1 WT2 List of deliverables .................................................................................................................................2 WT3 Work package descriptions ................................................................................................................... 6 Work package 1......................................................................................................................................6 Work package 2....................................................................................................................................11 Work package 3....................................................................................................................................15 -

CES Factbook 2012
European Factbook 2012 The European People’s Party and Centre-Right Politics C E S EUROPEAN FACTBOOK 2012 The European People’s Party and Centre-Right Politics “The European Factbook, now in its fifth year, is the consolidated annual publication with all relevant data and documentation about the European People’s Party (EPP), the largest EU-level party which represents the political family of the centre-right. The 2012 edition includes the latest updates and information from both European level and national level politics. The EPP is currently the leading Europarty in the three main EU institutions: the Euro- pean Council with 16 out of 27 heads of state and government, the European Commission with 13 out of 27 members, and the European Parliament with 271 out of 754 MEPs. Apart from the structure of the EPP and its role in the EU institutions, the European Factbook includes information about EPP member- parties in EU and non-EU countries, EPP parliamentary groups in the Council of Europe, the OSCE and NATO, EPP member associations, as well as information about EPP’s think-tank the Centre for European Studies (CES) and its member foundations. Finally, the European Factbook provides readers with a set of important supplementary documents including the EU Regulation that governs political parties at European level and the ‘Giannakou Report’.” Kostas Sasmatzoglou, Editor-in-Chief ISSN 2031-0196 www.thinkingeurope.eu C E S EUROPEAN FACTBOOK 2012 The European People’s Party and Centre-Right Politics Editor-in-Chief: Kostas Sasmatzoglou Assistant Editors: Bernada Cunj, Pavlína Heymans-Špačková, Óscar Sánchez Benítez Additional Research and Editing: Lisa Dutton, Brenda Furniere, Sara Pini, Panos Tasiopoulos Cover, Type & Design: Andreas Neuhaus Printed in Germany by Druckhaus Süd Brussels, April 2012 Centre for European Studies Rue du Commerce 20 Brussels, B-1000 The Centre for European Studies (CES) is the political foundation of the European People’s Party (EPP), dedicated to the promotion of Christian democrat, conservative and like-minded political values. -

Stuart Blume, Joske Bunders, Loet Leydesdorff, Richard Whitley (Eds.), the Social Direction of the Public Sciences
P 86 - 6 Social Sciences and Political Projects: The Emergence and Demise of Reform Coalitions between Social Scientists and Policy-Makers in France, Italy, and West Germany by Peter Wagner For publication in: Stuart Blume, Joske Bunders, Loet Leydesdorff, Richard Whitley (eds.), The Social Direction of the Public Sciences. Sociology of the Sciences Yearbook XI, Dordrecht, Reidel, 1987. Earlier versions of this paper were presented at the conference on "The Social D ire c tio n o f the P ublic Sciences", Amsterdam, Novermber 1985, and at two workshops o f the Theory and Methodology Group o f the Swedish Collegium fo r Advanced Study in the Social Sciences, Amsterdam, December 1985, and Uppsala, April 1986. I would like to thank the participants in the discussions for valuable comments and criticism s. Final Version, May 1986 Zusammenfassung In diesem Beitrag wird die Entstehung einer Policy-Orientierung - einer Konzentration der Forschung auf Politikfelder oder auf politisch administrative Prozesse im Hinblick darauf, Voraussetzungen für "bes sere P olitik" zu schaffen - in den Sozial Wissenschaften in Frankreich, Italien und der Bundesrepublik Deutschland als Interaktionsprozeß von Wissenschaftlern und Nicht-Wissenschaftlern untersucht. In einem be stimmten gesellschaftlichen Kontext gingen Sozialwissenschaftler Koali tionen mit den Teilen der politischen und wirtschaftlichen Eliten ein, die die Notwendigkeit eines umfassenden g e se lls c h a ftlic h e n Modernisie rungsprozesses sahen, und definierten ihre eigene Aufgabe als die der Vorbereitung der erforderlichen politischen Innovationen auf der Grund lage sozial wissenschaftlicher Expertise. Nachfolgende soziale Entwick lungen führen zu einer Desillusionierung und zur Suche nach anderen gesellschaftlichen Akteuren zum Engagement in auf Forschung gegründeter politischer Aktion. -

Journal of European Integration History 1/2010
Journal of European Integration History /2010 Revue d’Histoire de l’Intégration Européenne 1Volume 16 Zeitschrift für Geschichte der europäischen Integration Pages 1-153 Editors: Published twice a year by the Groupe de liaison des professeurs d’histoire contemporaine auprès de la Commission européenne. This publication is part of the Network EU-History based at the Kulturwissenschaftliches Institut Essen. It is financed by the Ministère d’Etat, Présidence du gouvernement of the Grand Duchy of Luxembourg. Editorial Board: Wilfried LOTH (chairman), Universität Essen (Jean Monnet Chair) | Gérard BOSSUAT, Université de Cergy-Pontoise (Jean Monnet Chair) | Elena CALANDRI, Università degli Studi di Firenze | Anne DEIGHTON, Wolfson College, Oxford (Jean Monnet Chair) | Michel DUMOULIN, Université catholique de Louvain (Jean Monnet Chair) | Michael GEHLER, Universität Hildesheim (Jean Monnet Chair) | Fernando GUIRAO, Universitat Pompeu Fabra, Barcelona (Jean Monnet Chair) | Johnny LAURSEN, University of Aarhus | N. Piers LUDLOW, London School of Economics | Alan S. MILWARD, European University Institute, Florence | Kiran Klaus PATEL, European University Institute, Florence | Nicolae PĂUN, University of Cluj-Napoca | Sylvain SCHIRMANN, Institut d'études politiques, Strasbourg | Klaus SCHWABE, Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen (Jean Monnet Chair) | Gilbert TRAUSCH, Centre Robert Schuman, Université de Liège | Jan VAN der HARST, University of Groningen (Jean Monnet Chair) | Antonio VARSORI, Università di Padova (Jean Monnet Chair) www.eu-historians.eu Editorial Secretariat: Charles Barthel, director, Centre d’études et de recherches européennes, Robert Schuman, 4 Rue Jules Wilhelm, L-2728 Luxembourg, Tel.: (3 52) 24 78 22 90, Fax.: (3 52) 42 27 97 Contents / Table des matières / Inhalt Anne DEIGHTON Preface ............................................................................................. 5 Ilaria POGGIOLINI/Alex PRAVDA Britain in Europe in the 1980s: East & West. -
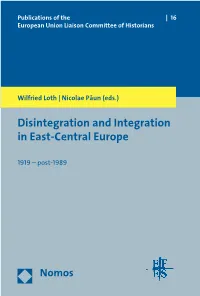
Disintegration and Integration in East-Central Europe
Publications of the | 16 European Union Liaison Committee of Historians Wilfried Loth | Nicolae Păun (eds.) Disintegration and Integration in East-Central Europe 1919 – post-1989 Nomos BUT_Loth_1330-1.indd 1 06.05.14 08:27 Veröffentlichungen der Historiker-Verbindungsgruppe bei der Kommission der Europäischen Gemeinschaften Publications of the European Union Liaison Committee of Historians Volume 16 BUT_Loth_1330-1.indd 2 06.05.14 08:27 Wilfried Loth | Nicolae Păun (eds.) Disintegration and Integration in East-Central Europe 1919 – post-1989 Nomos BUT_Loth_1330-1.indd 3 06.05.14 08:27 Die Deutsche Nationalbibliothek lists this publication in the Deutsche Nationalbibliografie; detailed bibliographic data is available in the Internet at http://dnb.d-nb.de. ISBN 978-3-8487-1330-1 (Nomos Verlagsgesellschaft, Baden-Baden) 978-606-526-178-5 (Editura Fundaţiei pentru Studii Europene) 1st edition 2014 © Nomos Verlagsgesellschaft, Baden-Baden 2014. Printed in Germany. This work is subject to copyright. All rights are reserved, whether the whole or part of the material is concerned, specifically those of translation, reprinting, re-use of illustrations, broadcasting, reproduction by photocopying machine or similar means, and storage in data banks. Under § 54 of the German Copyright Law where copies are made for other than private use a fee is payable to »Verwertungsgesellschaft Wort«, Munich. BUT_Loth_1330-1.indd 4 06.05.14 08:27 Table of contents INTRODUCTION 9 Wilfried LOTH The European Union as a Pan-European Project 13 Ioan-Aurel POP Preliminaries to European Integration in the Transylvanian Area (Case Study on Unity and Diversity) 22 THE END OF EMPIRES AND THE ATTEMPTS AT CREATING A NEW BALANCE (1919-1945) Lucian LEUŞTEAN The Late Start of the Little Entente.