Il Turco in Italia
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
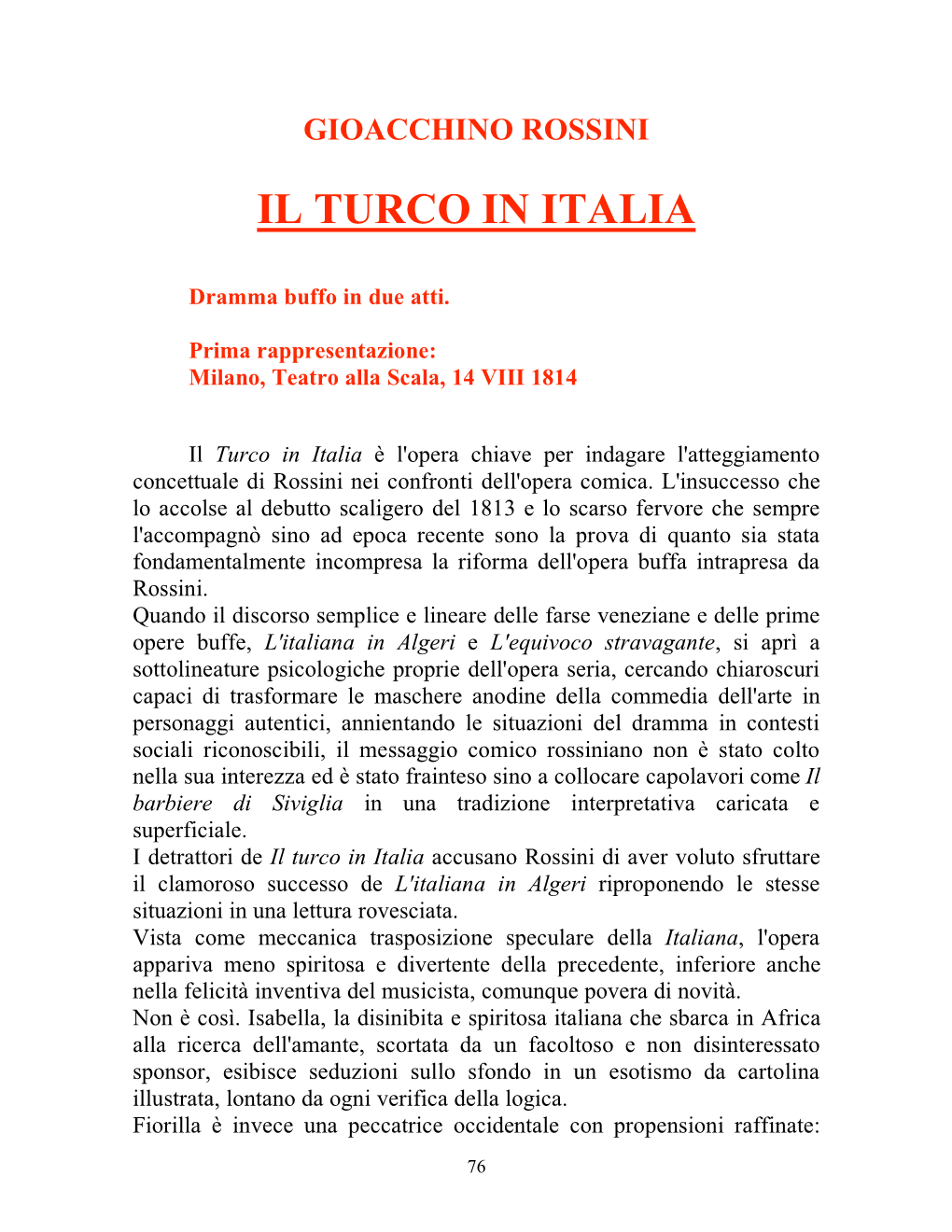
Load more
Recommended publications
-

The Italian Girl in Algiers
Opera Box Teacher’s Guide table of contents Welcome Letter . .1 Lesson Plan Unit Overview and Academic Standards . .2 Opera Box Content Checklist . .8 Reference/Tracking Guide . .9 Lesson Plans . .11 Synopsis and Musical Excerpts . .32 Flow Charts . .38 Gioachino Rossini – a biography .............................45 Catalogue of Rossini’s Operas . .47 2 0 0 7 – 2 0 0 8 S E A S O N Background Notes . .50 World Events in 1813 ....................................55 History of Opera ........................................56 History of Minnesota Opera, Repertoire . .67 GIUSEPPE VERDI SEPTEMBER 22 – 30, 2007 The Standard Repertory ...................................71 Elements of Opera .......................................72 Glossary of Opera Terms ..................................76 GIOACHINO ROSSINI Glossary of Musical Terms .................................82 NOVEMBER 10 – 18, 2007 Bibliography, Discography, Videography . .85 Word Search, Crossword Puzzle . .88 Evaluation . .91 Acknowledgements . .92 CHARLES GOUNOD JANUARY 26 –FEBRUARY 2, 2008 REINHARD KEISER MARCH 1 – 9, 2008 mnopera.org ANTONÍN DVOˇRÁK APRIL 12 – 20, 2008 FOR SEASON TICKETS, CALL 612.333.6669 The Italian Girl in Algiers Opera Box Lesson Plan Title Page with Related Academic Standards lesson title minnesota academic national standards standards: arts k–12 for music education 1 – Rossini – “I was born for opera buffa.” Music 9.1.1.3.1 8, 9 Music 9.1.1.3.2 Theater 9.1.1.4.2 Music 9.4.1.3.1 Music 9.4.1.3.2 Theater 9.4.1.4.1 Theater 9.4.1.4.2 2 – Rossini Opera Terms Music -

572032 Bk Penderecki
ROSSINI Complete Overtures • 4 Il barbiere di Siviglia Il Turco in Italia • Armida Prague Sinfonia Orchestra • Christian Benda Complete Overtures • 4 Gioachino Rossini (1792-1868): matrimonio, for which it was adapted, to be used again, poem. Coming to his senses, he leaves Armida, who is Gioachino Antonio Rossini, one of the most successful Useless Precaution), to avoid confusion with Paisiello’s after further revision, as an overture for Adelaide di now torn between love and desire for revenge. The and popular operatic composers of his time, was born in work, Rossini’s opera deals with the plan by Count Borgogna in 1817. opening Sinfonia contrasts two elements, the steady Pesaro in 1792. His father, a brass-player, had a modest Almaviva to woo Rosina and win her hand in marriage. Ricciardo e Zoraide was first staged at the Teatro march of the crusaders and a rapid Vivace, the march career, disturbed by the political changes of the period as With the help of the barber and general factotum Figaro, San Carlo in Naples in 1818. Agorante, angry at the unexpectedly returning to interrupt the livelier section. the French replaced the Austrians in Northern Italy. he carries out his plan to outwit her guardian, Dr Bartolo, refusal of Ircano to give him his daughter Zoraide in Le Comte Ory, Rossini’s fourth opera for Paris, was Rossini’s mother was a singer and as a boy Rossini who has his eye on his ward’s fortune. The overture was marriage, ousts Ircano from his kingdom of Nubia and first staged at the Paris Opéra in August 1828. -

03-10-2018 Semiramide Mat.Indd
GIOACHINO ROSSINI semiramide conductor Opera in two acts Maurizio Benini Libretto by Gaetano Rossi, based on production John Copley the play Sémiramis by Voltaire set designer Saturday, March 10, 2018 John Conklin 1:00–4:40 PM costume designer Michael Stennett lighting designer John Froelich revival stage director The production of Semiramide was Roy Rallo made possible by a generous gift from the Lila Acheson and DeWitt Wallace Fund for Lincoln Center, established by the founders of The Reader’s Digest Association, Inc. The revival of this production is made possible by a gift from Ekkehart Hassels-Weiler general manager Peter Gelb music director designate Yannick Nézet-Séguin 2017–18 SEASON The 34th Metropolitan Opera performance of GIOACHINO ROSSINI’S This performance semiramide is being broadcast live over The Toll Brothers– Metropolitan Opera conductor International Radio Maurizio Benini Network, sponsored in order of vocal appearance by Toll Brothers, America’s luxury oroe, high priest of the magi ® homebuilder , with Ryan Speedo Green* generous long-term support from idreno, an indian prince The Annenberg Javier Camarena Foundation, The Neubauer Family assur, a prince Foundation, the Ildar Abdrazakov Vincent A. Stabile Endowment for semir amide, queen of babylon Broadcast Media, Angela Meade and contributions from listeners arsace, commander of the assyrian army worldwide. Elizabeth DeShong There is no Toll Brothers– a zema, a princess Metropolitan Sarah Shafer Opera Quiz in List Hall today. mitr ane, captain of the guard Kang Wang** This performance is also being broadcast ghost of king nino live on Metropolitan Jeremy Galyon Opera Radio on SiriusXM channel 75. -

GREAT OPERATIC ARIAS GREAT OPERATIC ARIAS CHAN 3112 CHANDOS O PERA in ENGLISH BARRY BANKS Tenor Sings BEL CANTO ARIAS
CHAN 3112 Book Cover.qxd 20/9/06 11:02 am Page 1 GREAT OPERATIC ARIAS GREAT OPERATIC ARIAS CHAN 3112 CHANDOS O PERA IN ENGLISH BARRY BANKS BANKS BARRY tenor sings BEL CANTO ARIAS sings BEL CANTO PETER MOORES FOUNDATION CHAN 3112 BOOK.qxd 20/9/06 11:08 am Page 2 Christian Steiner Barry Banks sings Bel canto Arias 3 CHAN 3112 BOOK.qxd 20/9/06 11:08 am Page 4 Time Page Time Page Gioachino Rossini (1792–1868) Igor Stravinsky (1882–1971) from The Italian Girl in Algiers from The Rake’s Progress Lindoro’s Cavatina (Languir per una bella) Tom Rakewell’s Recitative and Aria 1 ‘In dreams of endless pleasure’ 7:16 [p. 46] 6 ‘Here I stand’ – ‘Since it is not by merit’ 2:40 [p. 48] London Philharmonic Orchestra London Philharmonic Orchestra from Stabat Mater (Cujus animam) Gaetano Donizetti (1797–1848) 2 ‘Through her soul in endless grieving’ 6:25 [p. 46] London Philharmonic Orchestra from Don Pasquale Ernesto’s Prelude and Aria (Cercherò lontana terra) from Count Ory 7 ‘Poor lost Ernesto’ – Count’s Cavatina (Que le destin prospère) 3 ‘I shall go, no more returning’ 9:47 [p. 48] ‘May destiny befriend you’ 4:38 [p. 46] London Philharmonic Orchestra London Philharmonic Orchestra from CHAN 3011(2) Don Pasquale from Moses in Egypt from The Elixir of Love Amenophis’ and Pharaoh’s Duet (Parla, spiegar non posso) Nemorino’s Romance (Una furtiva lagrima) 4 ‘The blow at last has fallen’ 7:10 [p. 46] 8 ‘Only one teardrop’ 5:14 [p. -

David Parry Conductor
David Parry Conductor David Parry is acknowledged as an Much in demand from ensembles both in the inspirational champion of operatic, concert and UK and further afield, David Parry is regularly symphonic repertoire across a vast range. He is at the helm of orchestras including the London known both for the re-appraisal of important Philharmonic, Philharmonia, Royal lesser-known compositions and for a Philharmonic, City of Birmingham, Halle, consistently fresh approach to established Academy of St Martin in the Fields and English repertoire. Chamber Orchestra. Significant credits include the world premiere He has an extensive discography for Chandos of Jonathan Dove’s The Adventures of and Opera Rara. His recording of Rossini Pinocchio (in separate productions for Opera Ermione won a Gramophone Award for best North and Staatstheater Stuttgart), Der opera recording 2011. Fliegende Holländer (for Portland Opera), Madama Butterfly (in Anthony Minghella’s In recent seasons David conducted The Pirates production for ENO which earned him an of Penzance for ENO, Carmen and La scala di “the musical performance Olivier Award), Cosí fan tutte and the premiere seta for Scottish Opera, Maometto Secondo (of of Dove’s Flight (both for Glyndebourne Festival which his live recording with Garsington was under David Parry sweeps more Opera) and Maria Stuarda (for Stockholm released on Avie) and the German stage Royal Opera). premiere of Ermione in Rostock, L’italiana in or less everything before it” Algeri and Il turco in Italia for Garsington, David Parry made his operatic debut with La L’oca del Caïro with the London Mozart Players, Tim Ashley, The Guardian Cenerentola for English Music Theatre and a new production of Tales of Hoffman in subsequently joined the conducting staff first at Wuppertal, and concerts with the English Dortmund then at Opera North. -

New on Naxos | FEBRUARY 2014 the Complete Rossini Overtures by Christian Benda and the Prague Sinfonia Orchestra
NEWThe World’s O LeadingN ClassicalNAXO Music LabelS FEBRUARY 2014 This Month’s Other Highlights © 2014 Naxos Rights US, Inc. • Contact Us: [email protected] www.naxos.com • www.classicsonline.com • www.naxosmusiclibrary.com • blog.naxos.com NEW ON NAXOS | FEBRUARY 2014 The Complete Rossini Overtures by Christian Benda and the Prague Sinfonia Orchestra Rossini’s ceaseless wit and invention are best exemplified in his series of operas. His colourful orchestration and command of both comic and tragic elements can be savoured in Naxos’s complete series of symphonic overtures, either in four standard CD volumes or the spectacular sonics of the two Blu-ray Audio discs. Complete Overtures, Volume 1 La gazza ladra • Semiramide • Elisabetta, Regina d’Inghilterra (Il barbiere di Siviglia) Otello • Le siège de Corinthe • Sinfonia in D ‘al Conventello’ • Ermione 7 47313 09337 3 La gazza ladra (The Thieving Magpie) is perhaps one of the world’s most popular concert openers. The overture for Elisabetta, Regina d’Inghilterra was used again a year later by Rossini for Il barbiere di Siviglia. “an admirable start to what looks like being a very desirable series” – MusicWeb International 8.570933 Complete Overtures, Volume 2 Guillaume Tell • Eduardo e Cristina • L’inganno felice • La scala di seta Demetrio e Polibio • Il Signor Bruschino • Sinfonia di Bologna • Sigismondo 7 47313 09347 2 8.572735 Playing Time: 55:31 Guillaume Tell, with its overture in four movements, includes a scene for five solo cellos. La scala di seta (The Silken Ladder), one of his most popular pieces, opens with an overture of charm and élan. -

Gioachino Rossini: IL TURCO in ITALIA Naxos 2.110259 IL TURCO
Gioachino Rossini: IL TURCO IN ITALIA Naxos 2.110259 IL TURCO IN ITALIA Dramma buffo in due atti di Gioachino Rossini Libretto: Felice Romani Selim, principe turco che viaggia Donna Fiorilla, donna capricciosa ma onesta Don Geronio, uomo debole e pauroso Don Narciso, cavaliere servente di Donna Fiorilla Prosdocimo, poeta e conoscente di Don Geronio Zaida, un tempo schiava e promessa sposa di Selim, poi zingara Albazar, prima confidente di Selim, poi zingaro seguace e confidente di Zaida Chapter 1 Chapter 3 Sinfonia POETA Ah! se di questi Zingari l'arrivo ACT I Potesse preparar qualche accidente, Scene I Che intrigo sufficiente Luogo solitario fuori di Napoli. Spiaggia di mare. Colle da un lato Mi presentasse per un dramma intero! sparso di casini di campagna che si vedono in lontananza, e di Un bel quadro farei tratto dal vero. tende custodite da Zingari. Abbandonar bisogna Una truppa di Zingari è sul colle, un'altra al piano,tutti occupati a Il pensier sovra i capricci differenti uffici. Della bella Fiorilla: Zaida, Albazar, indi il Poeta Hanno già messo in scena Dei Poeti d'ogni razza Chapter 2 Sciocco marito, ed una moglie pazza. ZINGARI Ecco appunto Geronio Nostra patria è il mondo intero Che ha la pazzia di farsi astrologare: Ed in sen dell'abbondanza Corro i Zingari presto ad avvisare. L'altrui credula ignoranza (il poeta sale il colle e si vede accennare ai Zingari Ci fa vivere e sguazzar. Geronio il quali esce dalla parte opposta meditando.) ZAIDA SCENA III Hanno tutti il cor contento, Don Geronio, indi Zingari e Zingare Sol la misera son io! Ho perduto l'amor mio, Chapter 4 E nol posso più trovar. -

Cenerentola Was Born in Pesaro, Italy, on February 29, 1792 (A Leap Year)
ABOUT THE COMPOSER GIOACHINO ROSSINI (FEBRUARY 29, 1792 – NOVEMBER 13, 1868) EARLY YEARS The composer of La Cenerentola was born in Pesaro, Italy, on February 29, 1792 (a leap year). For a time, his parents earned a living traveling from one small opera house to another-his mother as a singer and his father as a horn player in the orchestra. Gioachino was occasionally left behind with his grandmother and his aunt in Pesaro. He had only a little education in reading, writing, grammar and arithmetic. Much of the time he ran wild. When Gioachino was 12, his parents ended their travels and settled in Bologna. As a boy he studied music with a talented priest. He also began to play the violin and viola and to compose sonatas and other pieces. Because of his beautiful singing voice, he was often invited to sing in churches in Bologna, and he was soon able to earn extra money playing harpsichord for opera companies in and around Bologna. At 14, he began more formal music studies at the Conservatory. At the end of his first year, he was chosen to write a cantata that was performed in public. Unfortunately, he had to leave the Conservatory after four years in order to earn money for his family. All his life he was to regret the fact that he did not receive more musical training. SUCCESS Rossini's first paid composition was a one-act comic opera for a theatre in Venice. La cambiale di matrimonio (The Marriage Contract), written in less than a week, earned him one hundred dollars-an enormous sum for the 19-year-old Gioachino! The opera was a success, and he kept writing. -

For Immediate Release April 17, 2009
PITTBURGHOPERA page 1 For Immediate Release April 17, 2009 Contact: Kesha M. Pate, Public Relations Manager [email protected] or (412) 281-0912 ext 248 Photos: Allison M. Ruppert, Marketing and Community Relations Manager [email protected] or (412) 281-0912 ext 262 Pittsburgh Opera presents The Italian Girl in Algiers May 2-10 What: Gioachino Rossini’s opera The Italian Girl in Algiers (L'italiana in Algeri) Where: Benedum Center for the Performing Arts Experience is Everything 7th Street and Penn Avenue, Downtown Pittsburgh 2008-2009 Season When: Saturday, May 2, 8:00 PM Tuesday, May 5, 7:00 PM Friday, May 8, 8:00 PM Sunday, May 10, 2:00 PM Run Time: Two hours, 45 minutes, including one intermission Language: Sung in Italian with English titles projected above the stage Tickets: Start at $16. Call 412-456-6666 for more information or visit www.pittsburghopera.org Pittsburgh, PA… Pittsburgh Opera presents Gioachino Rossini’s opera The Italian Girl in Algiers (L’italiana in Algeri) at the Benedum Center May 2 – 10. This effervescent comedy gets a 1930s-style makeover and takes us behind the beaded curtain of a sultan’s harem. Hilarity ensues when the Amelia Earhart-style heroine Isabella crash-lands on the Algerian coast while attempting to rescue her beloved Lindoro from the Bey of Algiers, Mustafà. Pittsburgh Opera’s updated production includes an elaborate storybook set, bold costumes and a hot air balloon that provides the heroine’s dramatic departure in the finale. Music Director Antony Walker conducts. Vivica Genaux returns to Pittsburgh Opera in one of her signature roles as the feisty heroine Isabella. -

Presentazione Di Powerpoint
La Magia dell’Opera Biografia di Gioachino Rossini Gioachino Rossini era nato a Pesaro il 29 Febbraio 1792 in una famiglia di semplici origini. Il padre Giuseppe suonava nella banda comunale ed era chiamato “trombetta” perché con la sua tromba convocava le adunanze pubbliche del comune. La mamma, Anna Guidarini, figlia di un fornaio locale, era una cantante d’opera. Con una famiglia così era naturale che il piccolo Gioachino si dedicasse alla musica sin da bambino. Cominciò a studiare con il padre diversi strumenti e canto e si appassionò talmente alle musiche di due grandi compositori tedeschi, Mozart e Haydn, da guadagnarsi il soprannome di “tedeschino”. Il padre era un fervente sostenitore della rivoluzione francese e per le sue idee politiche si fece parecchi nemici, così fu costretto a cambiare spesso città. Il giovane Gioachino trascorse quindi gli anni della sua prima giovinezza in parte con la nonna e in parte in viaggio tra una città e l’altra. Ma questo non gli impedì di farsi notare per il suo talento musicale. A soli 8 anni fu iscritto al Conservatorio di Bologna ed a 14 aveva già scritto la sua prima opera, Demetria e Polibio , che però rimase per molti anni in un cassetto. Ancora giovanissimo era spesso chiamato a cantare e suonare nelle chiese e nei teatri; così guadagnava i suoi primi soldini con cui aiutava la famiglia. A 18 anni Gioachino ebbe l’onore e la soddisfazione di vedere rappresentata una sua opera, La cambiale di matrimonio, al teatro San Moisè di Venezia. Iniziava così la sua carriera fulminante nel melodramma ! Negli anni successivi compose molte altre opere buffe facendo sempre entusiasmare e divertire il pubblico. -

Gioachino Rossini (1792–1868) Italian, Ingenious, Inspired
Gioachino Rossini (1792–1868) Italian, ingenious, inspired. Gioachino Rossini occupied an unrivalled position in the Italian musical world of his time, winning considerable success relatively early in his career. He was the first of the great 19th century Italian opera composers and brought opera into the public consciousness and even today his music still rings true. Rossini had already written ten operas before he was 21, and eventually composed 39 major stage works, though in his last thirty years he wrotcve nothing new. He did try to become a composer of serious operas, but it will always be his comic operas, The Barber of Seville (8.553436) and Cinderella (8.660191-92) that his fame will rest. Label Cat. No. Composer Title Feartured Artists UPC Ekaterina Sadovnikova, Miriam Zubieta, Soprano / Margarita Gritskova, Mezzo-soprano / Gheorghe Vlad, Yasushi Watanabe, Tenor / ROSSINI, Gioachino 1 Naxos 8.660401-02 Adelaide di Borgogna [2 CDs] Cornelius Lewenberg, Baritone / 0730099040174 (1792–1868) Baurzhan Anderzhanov, Bass-baritone / Camerata Bach Choir, Poznań / Virtuosi Brunensis / Luciano Acocella Digital Exclusive Arias for Contralto Ewa Podles, Contralto / ROSSINI, Gioachino The Barber of Seville • The Lady of the Lake • Hungarian State Opera Chorus / 2 Naxos 8.553543 0730099454322 (1792–1868) Tancredi • Semiramide • The Italian Girl in Algiers Hungarian State Opera Orchestra / • Cinderella • Maometto II Pier Giorgio Marandi Silvia Dalla Benetta, Soprano / Ana Victória Pitts, Marina Viotti, Mezzo-soprano / ROSSINI, Gioachino 3 Naxos -

Gioachino Rossini Sigismondo Rossini Opera Festival
UNITEL and CLASSICA present Gioachino Rossini Sigismondo Rossini Opera Festival Conductor Michele Mariotti Staged by Damiano Michieletto SigismondoGioachino Rossini Early Rossini has something buoyant, vibrant, youthful about it – even when it is a “dramma Aper musica” such as “Sigismondo”, a dark swirl of an opera revolving around a mad king and his delusions, his wife who is allegedly dead but very much alive, the fate of Poland and much more. Premiered in 1814 but rarely played thereafter, the work deserves to be resur- rected, if only for its many beautiful and original arias and ensembles, some of which were such brilliant little masterpieces that he reused them in his later successes such as “Il turco in Italia”, “La Cenerentola” and “Il bar- biere di Siviglia”. The work was given its first performance from the critical new edition at the 2010 Rossini Opera Fes- Conductor Michele Mariotti tival in Pesaro, “a small Italian variant of Bayreuth and Orchestra Orchestra del Teatro Salzburg” (Süddeutsche Zeitung). The press hailed the Comunale di Bologna production as a “perfect symbiosis of music and stage Chorus Coro del Teatro Comunale work” that yields “truly brilliant theater” (Quotidiano di Bologna Nazionale). Director Damiano Michieletto sets the first Chorus Master Paolo Vero act in a startlingly realistic “insane asylum” of around Sigismondo Daniela Barcellona 1900, where King Sigismondo has been placed after los- Ulderico / Zenovito Andrea Concetti ing his mind over his wife’s death, which he, convinced of Aldimira Olga Peretyatko her infidelity, had ordered. The second act takes place in Ladislao Antonino Siragusa an elegantly appointed royal palace, where Sigismondo, Anagilda Manuela Bisceglie who has now recovered, must confront an assault by the Radoski Enea Scala Bohemian army and decide upon Poland’s fate.