Title of My Book
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
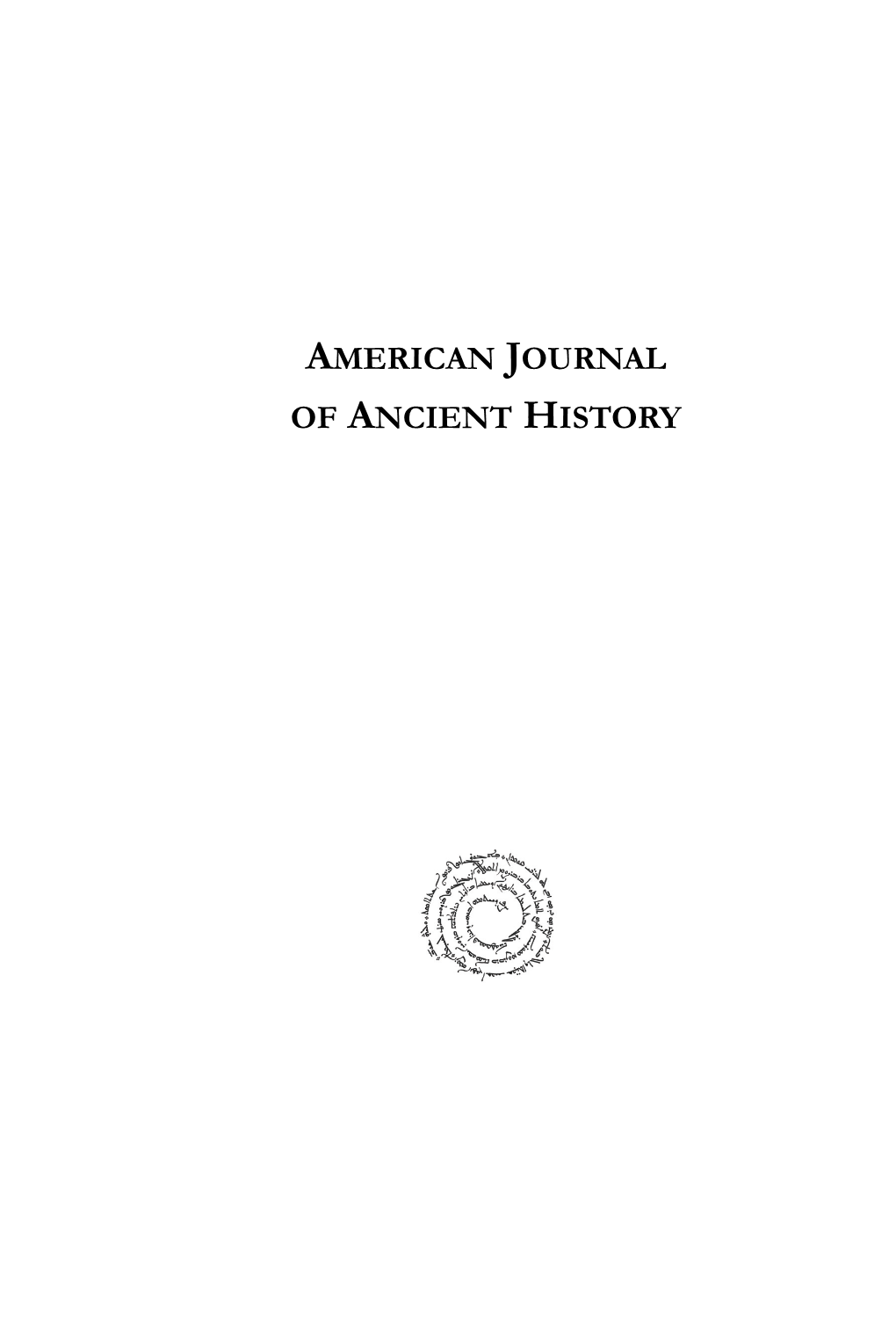
Load more
Recommended publications
-

S. Croce Camerina (Rg) Saggi Di Scavo Nel Casale
S. CROCE CAMERINA (RG) Rasacambra citata nella conferma dei beni del 1158 da par- SAGGI DI SCAVO NEL CASALE MEDIEVALE te di Papa Adriano IV all’abbazia S. Maria Latina di Geru- RELAZIONE PRELIMINARE salemme. Il casale è attestato poco più tardi nel 1173 nella conferma dei beni del conte Guglielmo all’abbazia di S. di Filippo d’Agira come casale et ecclesia Sanctae Crucis de Rasacambri (WHITE 1938, pp. 351). Ancora nel 1194 il ca- GIOVANNI DI STEFANO, SALVINA FIORILLA sale e la chiesa sono tra i beni confermati da Enrico VI di Hoenstaufen a S. Filippo d’Agira e cinque anni dopo com- paiono nel documento con il quale Costanza e il figlio Fe- INTRODUZIONE derico confermano i beni all’abbazia (PIRRI 1733, II, p. 1250). Nel 1303 in una bolla di Benedetto XII in cui sono Le ricerche archeologiche finora condotte nella pro- enumerati i beni di S. Maria Latina di Gerusalemme il casale e vincia di Ragusa hanno evidenziato una diffusa presenza di la chiesa Sanctae Crucis de Rosacambra sono menzionati abitati d’età bizantina tuttora in corso di studio (DI STEFANO come dipendenti dal Convento dei Santi Lorenzo e Filippo OLARINO 1975; MESSINA-DI STEFANO 1997; PELLAGATTI-DI STEFANO di Scicli a sua volta suffraganeo di S. Filippo d’Agira (S 1999). In particolare alla periferia di S. Croce Camerina, in 1901, p. 215). Il casale e la chiesa Sanctae Crucis de contrada Mirio, a quattro Km dalla costa, nell’area che gra- Rosacambra sono attestati ancora da una serie di altri docu- vita intorno al “Vallone Fontana” ed alla sorgente Paradiso, menti fino al 1450 quando il complesso venne concesso a Pie- tra il 1989 ed il 1992 con successive campagne di scavo tro Celestri nobile messinese (PIRRI 1733, I, p. -

Archivio Storico Ii
Società Santacrocese di Storia Patria ARCHIVIO STORICO II ANNO II 2015 Ringraziamenti Rivolgiamo un sentito ringraziamento a tutti i soci e a quanti, con la loro collabora- zione, hanno contribuito alla realizzazione di questo secondo volume dell’Archivio Stori- co edito dalla Società Santacrocese di Storia Patria. Al Sindaco Signora Franca Iurato ed all’Amministrazione Comunale di Santa Croce Camerina va la nostra gratitudine per aver costantemente sostenuto l’Associazione e per- messo, mettendo a disposizione strutture e risorse, la pubblicazione del presente volume. ll Presidente e il Consiglio Direttivo Santa Croce Camerina - Piazza Marittima nel 1900 (G. Aquila) 2 PRESENTAZIONE Il secondo volume dell’Archivio Storico accoglie la raccolta di alcuni articoli, scaturenti da ricer- che d’archivio o da campagne effettuate nei siti archeologici locali, che analizzano momenti della nostra storia. I soci hanno potuto usufruire, nel corso del presente anno, di diverse iniziative ed attività culturali organizzate dalla “Società Santacrocese di Storia Patria”. Il dottor Giovanni Di Stefano, direttore del Museo Regionale di Kamarina, ha aperto la serie di conferenze, trattando sulle recenti scoperte archeologiche effettuate nel sito di Kaukana, ed in particola- re sul “quartiere Vandalo” e sulle tombe che coronano l’abside della chiesetta Bizantina. Il dottor Saverio Scerra, archeologo presso la Soprintendenza ai Beni Culturali ed Ambientali di Ragusa, ha effettuato una conferenza sugli approdi nella costa meridionale della Sicilia, nel tratto com- preso tra Gela e Pachino, soffermandosi dettagliatamente sulle ipotesi relative all’approdo di Kaukana - Punta Secca. I relatori Di Stefano e Scerra, hanno trasmesso alla redazione dell’Archivio Storico, gli articoli inerenti i temi trattati nelle conferenze, che vengono pubblicati nel presente volume. -

UBC Excavations of the Roman Villa at Gerace, Sicily: Results of the 2013 Season
8%&([FDYDWLRQVRIWKH5RPDQ9LOODDW*HUDFH6LFLO\ 5HVXOWVRIWKH6HDVRQ 5-$:LOVRQ Mouseion: Journal of the Classical Association of Canada, Volume 12, Number 2, 2012, LVI -- Series III, pp. 175-230 (Article) 3XEOLVKHGE\8QLYHUVLW\RI7RURQWR3UHVV For additional information about this article http://muse.jhu.edu/journals/mou/summary/v1012/1012.2.wilson.html Access provided by University of British Columbia Library (17 Sep 2015 21:18 GMT) Mouseion, Series III, Vol. 12 (2012) 175–230 © 2015 Mouseion (published in 2015) UBC Excavations of the Roman Villa at Gerace, Sicily: Results of the 2013 Season R.J.A. Wilson Abstract/Résumé The paper describes results from UBC excavations at the Roman villa of Gerace, Sicily, in 2013. Geophysical survey in 2012 demonstrated that some half a dozen further structures once existed here, in addition to the small villa-like building partially inves- tigated by others in 1994 and 2007. In 2013 excavation concentrated on rooms 1 and 2 of the latter residence. The former, provided with a bench, a work-top and an earth floor, may have been a kitchen. Room 2 had a white mortar floor and plastered walls. A small portion of mosaic-paved corridor outside these rooms was also investigated. The building was erected not before ca. ad 370 and perished in a fire in the second half of the fifth century. Immediately to the east a building suggested by geophysics to have been some 50 m long was trial-trenched. The part excavated was paved with an intact floor of stone flags. The paving extended up to 2.20 m beyond the structure’s east and west exterior walls, possibly to ensure it was kept dry. -

Explanatory Or More Detailed References (Where There Are Many), Or References to Places Where an Artist’S Work Is Best Represented, Are Given in Bold
550 Index Explanatory or more detailed references (where there are many), or references to places where an artist’s work is best represented, are given in bold. Numbers in italics are picture references. Dates are given for all artists, architects and sculptors with works referenced in this guide. Ancient names are rendered in italics, as are works of art. Abakainon, ancient city 474 Agrigento contd Acate 326 Grotta Fragapane 201 Accommodation 515 Hellenistic and Roman district 212 Aci Castello 426 Kolymbethra Garden 208 Acireale 424 Living Museum of the Almond Tree 213 Acitrezza 426 Lower agora 206 Acquaviva Platani 254 Museo Civico 215 Acquedolci 482 Museo Diocesano 216 Addaura Caves 73; (finds from) 64 Oratory of Phalaris 211 Adelaide, wife of Roger I 300, 481, 482 Pezzino Necropolis 214 (tomb of) 477 Pinacoteca Palazzo dei Filippini 215 Adrano 419; (finds from) 360 S. Biagio 212 Adranon, ancient city 223 S. Maria dei Greci 215 Aegadian Islands 180ff S. Nicola 211 Aeneas, legends concerning 136, 143, 144, Sanctuary of Asklepios 213 147 Sanctuary of Demeter 212 Aeolian Islands 484 Sanctuary of the Chthonic Divinities 207 Aeschylus 256, 257, 344, 364, 400, 415 Temple of Castor and Pollux 207 Agatha, St 409, 410, 411 (reliquaries of) Temple of Concord 198, 201, 204 404 Temple of Hephaistos 214 Agathocles, tyrant of Syracuse 11, 95, 100, Temple of Hera 200 147, 173, 259, 344, 448 Temple of Herakles 205 Agira 294 Temple of Zeus 205, 207, 209 Agrigento 199ff; (finds from) 208, 360 Tomb of Theron 213 Aqueduct of Phaiax 208, 215 Upper agora -

UC Davis UC Davis Previously Published Works
UC Davis UC Davis Previously Published Works Title Celebrating the Severans: Commemorative Politics and the Urban Landscape in High Imperial Sicily Permalink https://escholarship.org/uc/item/9z0063xd Journal Latomus, 75(2) Author Pfuntner, Laura Publication Date 2016-07-01 Peer reviewed eScholarship.org Powered by the California Digital Library University of California Celebrating the Severans: Commemorative Politics and the Urban Landscape in High Imperial Sicily 1. Introduction Sicily is often characterized as resistant or immune to the dramatic processes of social and cultural change that affected the Mediterranean basin during Rome’s most intensive period of imperial expansion in the late Republic and the early Principate, and then as socially, politically, and culturally isolated from the wider Mediterranean world for the rest of the imperial period. 1 The usual evi- dence cited of Sicilian communities’ resistance or apathy to the cultural and material trappings of Roman imperial power is the limited use of Latin in pub- lic and private inscriptions, 2 as well as the lack of explosive urban growth and monumentalization on the island. For example, relatively few imperial-era, purpose-built administrative buildings (curiae, basilicae), leisure structures (bath houses, theaters, amphitheaters) or cult buildings have been identified in Sicily, even within the island’s six Augustan colonies. 3 1 Scholarship on the processes of cultural change in Rome and its empire that were described as “Romanization” for much of the twentieth century is extensive. A. WALLACE- HADRILL, Rome’s Cultural Revolution, Cambridge, 2008, p. 7-32, and D.J. MATTINGLY, Imperialism, Power, and Identity: Experiencing the Roman Empire, Princeton, 2010, p. -

CURRICULUM VITAE Davide Tanasi, Ph.D. Office Address
ORCID ID: https://orcid.org/0000-0001-9531-427X CURRICULUM VITAE Davide Tanasi, Ph.D. Office address: Department of History, University of South Florida, 4202 E Fowler Ave - Tampa, Florida 33620, USA [email protected] Research interests: Archaeology of Sicily and Malta; Archaeological Science; Digital Archaeology; Mortuary Archaeology; Ceramic Studies; Digital Communication of Cultural Heritage. EDUCATION 2007 - Ph.D. in ‘Archaeology, Historical Development and Cultural Interrelations in Antiquity and Middle Ages’ (concentration in Classical Archaeology), University of Torino, Italy. 2003 - Three-year post-graduate program in Classical Archaeology (Diploma di Specializzazione), University of Torino, Italy 1999 - B.A. and M.A. in Classical Studies (concentration in Mediterranean archaeology), University of Catania, Italy ACADEMIC APPOINTMENTS 2019 (August 7th) – Associate Professor of Digital Humanities, Department of History, University of South Florida 2019 (January 7th) – Director of the Department of History’s Institute for Digital Exploration – IDEx (www.usfidex.com), University of South Florida 2016 – 2019 Assistant Professor of Digital Humanities, Department of History, University of South Florida Affiliate Assistant Professor, University of Washington, Department of Classics (2016-2019) 2018 – 2019 - Program Director of the University of South Florida spring break study abroad program in Greece USF Athens – History and Culture 2017 – 2019 - Program Director of the University of South Florida summer study abroad program in Sicily USF -

Carrie L. Sulosky Weaver
CARRIE L. SULOSKY WEAVER Henry Clay Frick Department of History of Art and Architecture 104 Frick Fine Arts Building University of Pittsburgh Pittsburgh, Pennsylvania 15260 Mobile: 814.242.4769 [email protected] EDUCATION 2013 PhD, History of Art and Architecture (Classical Art and Archaeology) University of Virginia Dissertation: “Depositing the Dead: Human Remains, Material Culture and Funerary Practices in Kamarina, Sicily, ca. 5th to 3rd Century BC” Committee: Tyler Jo Smith (advisor), John J. Dobbins, Anastasia Dakoui-Hild, John R. Shepherd 2009 MA, History of Art and Architecture (Classical Art and Archaeology) University of Virginia Thesis: “The Eternal Feast: The Significance of Banquet Scenes on Roman Marble Cineraria” 2006 MSc with Distinction, Human Osteology and Funerary Archaeology University of Sheffield Thesis: “Regional Variations in Romano-British Cremation Rites” 2005 BA summa cum laude, Major in Anthropology and Classics, Minor in Italian University of Pittsburgh Honor’s Thesis: “The Role of Agriculture in Preceramic Peru” 2004 Archaeological Field School: The Anglo-American Project in Pompeii ACADEMIC APPOINTMENTS 2015–2016 Instructor, History of Art and Architecture, University of Pittsburgh 2013–2015 Kenneth P. Dietrich School of Arts and Sciences Postdoctoral Fellow, History of Art and Architecture, University of Pittsburgh 2013 Instructor, Religious Studies, Washington and Jefferson College 2011–2012 Instructor, Humanities, Pennsylvania Highlands Community College 2008–2010 Teaching Assistant, History of Art and Architecture, University of Virginia PUBLICATIONS In Preparation Book Marginalized Populations in the Ancient Greek World: The Bioarchaeology of the Other. University of Edinburgh Press. Monograph. Proposal under consideration. 1 Catalogue Sulosky Weaver, C.L., ed. From the Shores of the Great Sea: The Etruscan, Greek and Roman Objects in the Collections of the Carnegie Museum of Natural History. -

Carrie L. Sulosky Weaver
CARRIE L. SULOSKY WEAVER Department of Classics 1501 Cathedral of Learning University of Pittsburgh Pittsburgh, Pennsylvania 15260 Mobile: 814.242.4769 [email protected] EDUCATION 2013 PhD, History of Art and Architecture (Classical Art and Archaeology) University of Virginia Dissertation: “Depositing the Dead: Human Remains, Material Culture and Funerary Practices in Kamarina, Sicily, ca. 5th to 3rd Century BC” Committee: Tyler Jo Smith (advisor), John J. Dobbins, Anastasia Dakouri-Hild, John R. Shepherd 2009 MA, History of Art and Architecture (Classical Art and Archaeology) University of Virginia Thesis: “The Eternal Feast: The Significance of Banquet Scenes on Roman Marble Cineraria” 2006 MSc with Distinction, Human Osteology and Funerary Archaeology University of Sheffield Thesis: “Regional Variations in Romano-British Cremation Rites” 2005 BA summa cum laude, Major in Anthropology and Classics, Minor in Italian University of Pittsburgh Honor’s Thesis: “The Role of Agriculture in Preceramic Peru” 2004 Archaeological Field School: The Anglo-American Project in Pompeii ACADEMIC APPOINTMENTS 2016–2017 Visiting Assistant Professor, Classics, University of Pittsburgh 2015–2016 Instructor, History of Art and Architecture, University of Pittsburgh 2013–2015 Kenneth P. Dietrich School of Arts and Sciences Postdoctoral Fellow, History of Art and Architecture, University of Pittsburgh 2013 Instructor, Religious Studies, Washington and Jefferson College 2011–2012 Instructor, Humanities, Pennsylvania Highlands Community College 2008–2010 Teaching Assistant, History of Art and Architecture, University of Virginia 1 PUBLICATIONS Book 2015 The Bioarchaeology of Classical Kamarina: Life and Death in Greek Sicily. Gainesville: University Press of Florida. Peer-reviewed monograph. Articles and Book Chapters 2016 “Encounters with Death: Was there Dark Tourism in Classical Greece?” Journal of Greek Archaeology 1: 211–32. -

Serie a Maschile
FEDERAZIONE ITALIANA PALLA TAMBURELLO ALBO D’ORO CAMPIONATI ITALIANI - SPECIALITA’ OPEN SERIE A MASCHILE 1967 - Salvi San Massimo (Verona) 1896 - Udinese 1968 - Salvi San Massimo (Verona) 1897 - Non disputato 1969 - Murisengo (Alessandria) 1898 - Niccolò Barabino (Genova) 1970 - SVAB Castell'Alfero (Asti) 1899 - Niccolò Barabino (Genova) 1971 - Ongari Marmirolo (Mantova) 1900 - Non disputato 1972 - SVAB Castell'Alfero (Asti) 1901 - Petrarca Arezzo 1973 - Murisengo (Alessandria) 1902 - Niccolò Barabino (Genova) 1974 - Viarigi (Asti) 1903 - Non disputato 1975 - Lonardi S. Floriano (Verona) 1904 - Niccolò Barabino (Genova) 1976 - Lonardi S. Floriano (Verona) 1905 - Rivarolese (Genova) 1977 - Lonardi S. Floriano (Verona) 1906 - Niccolò Barabino (Genova) 1978 - Lonardi San Floriano (Verona) 1907 - Niccolò Barabino (Genova) 1979 - C.R. Ovada (Alessandria) 1908 - Sampierdarenese (Genova) 1980 - Maria Pia Bussolengo (Verona) 1909 - Sampierdarenese (Genova) 1981 - Ongari Marmirolo (Mantova) 1910 - Sampierdarenese (Genova) 1982 - Maria Pia Bussolengo (Verona) 1911 - Sampierdarenese (Genova) 1983 - Maria Pia Bussolengo (Verona) 1912 - Sampierdarenese (Genova) 1984 - Minotti Valgatara (Verona) 1913 - Non disputato 1985 - Bussolengo CCV (Verona) 1914 - Torino 1986 - Bussolengo CCV (Verona) 1915/1918 - non disputati (I° guerra mondiale) 1987 - Medole Can.-Martini (Mantova) 1919 - Torino 1988 - Medole Can.-Martini (Mantova) 1920 - Sampierdarenese (Genova) 1989 - Medole Can.-Martini (Mantova) 1921 - Torino 1990 - S.S. Aldeno C. Rur. (Trento) 1922 - Pisa 1991 - S.S. Aldeno La Trentina (Trento) 1923 - Pisa 1992 - Castelferro Graf. (Alessandria) 1924 - Firenze SERIE A1 1925 - Verona 1993 - Castelferro (Alessandria) 1926 – Verona 1994 - Castelferro (Alessandria) 1927 - Sestrese (Genova) 1995 - Castelferro (Alessandria) 1928 - Sestrese (Genova) 1996 - Castelferro (Alessandria) 1929 - Non disputato 1997 - Castelferro (Alessandria) 1930 - Verona 1998 - E. G. Castellaro (Mantova) 1931 - Empolese (Firenze) 1999 - U.S.T. -
Carrie L. Sulosky Weaver
CARRIE L. SULOSKY WEAVER Henry Clay Frick Department of History of Art and Architecture 104 Frick Fine Arts Building University of Pittsburgh Pittsburgh, Pennsylvania 15260 Mobile: 814.242.4769 [email protected] EDUCATION 2013 PhD, History of Art and Architecture (Classical Art and Archaeology) University of Virginia Dissertation: “Depositing the Dead: Human Remains, Material Culture and Funerary Practices in Kamarina, Sicily, ca. 5th to 3rd Century BC” 2009 MA, History of Art and Architecture (Classical Art and Archaeology) University of Virginia Thesis: “The Eternal Feast: The Significance of Banquet Scenes on Roman Marble Cineraria” 2006 MSc with Distinction, Human Osteology and Funerary Archaeology University of Sheffield Thesis: “Regional Variations in Romano-British Cremation Rites” 2005 BA summa cum laude, Major in Anthropology and Classics, Minor in Italian University of Pittsburgh Honor’s Thesis: “The Role of Agriculture in Preceramic Peru” 2004 Archaeological Field School: The Anglo-American Project in Pompeii ACADEMIC APPOINTMENTS 2013–2015 Kenneth P. Dietrich School of Arts and Sciences Postdoctoral Fellow, History of Art and Architecture, University of Pittsburgh 2013 Adjunct Instructor, Religious Studies, Washington and Jefferson College 2011–2012 Adjunct Instructor, Humanities, Pennsylvania Highlands Community College 2008–2010 Teaching Assistantship, History of Art and Architecture, University of Virginia 1 PUBLICATIONS Book In press The Bioarchaeology of Classical Kamarina: Life and Death in Greek Sicily. Gainesville: University Press of Florida, forthcoming 2015. Peer-reviewed book. Articles and Book Chapters In press Wilson, R.J.A. with J.W. Hayes, C.L. Sulosky Weaver and G. Di Stefano. “Il banchetto funerario nella Sicilia della prima età bizantina: nuove attestazioni da Kaukana.” Sicilia Antiqua 11: 515–63. -

Carrie L. Sulosky Weaver
CARRIE L. SULOSKY WEAVER Department of Classics 1501 Cathedral of Learning University of Pittsburgh Pittsburgh, Pennsylvania 15260 Mobile: 814.242.4769 [email protected] EDUCATION 2013 PhD, History of Art and Architecture (Classical Art and Archaeology) University of Virginia Dissertation: “Depositing the Dead: Human Remains, Material Culture and Funerary Practices in Kamarina, Sicily, ca. 5th to 3rd Century BC” Committee: Tyler Jo Smith (advisor), John J. Dobbins, Anastasia Dakouri-Hild, John R. Shepherd 2009 MA, History of Art and Architecture (Classical Art and Archaeology) University of Virginia Thesis: “The Eternal Feast: The Significance of Banquet Scenes on Roman Marble Cineraria” 2006 MSc with Distinction, Human Osteology and Funerary Archaeology University of Sheffield Thesis: “Regional Variations in Romano-British Cremation Rites” 2005 BA summa cum laude, Major in Anthropology and Classics, Minor in Italian University of Pittsburgh Honor’s Thesis: “The Role of Agriculture in Preceramic Peru” 2004 Archaeological Field School: The Anglo-American Project in Pompeii ACADEMIC APPOINTMENTS 2016–2019 Visiting Assistant Professor, Classics, University of Pittsburgh 2015–2016 Instructor, History of Art and Architecture, University of Pittsburgh 2013–2015 Kenneth P. Dietrich School of Arts and Sciences Postdoctoral Fellow, History of Art and Architecture, University of Pittsburgh 2013 Instructor, Religious Studies, Washington and Jefferson College 2011–2012 Instructor, Humanities, Pennsylvania Highlands Community College 2008–2010 Teaching Assistant, History of Art and Architecture, University of Virginia 1 PUBLICATIONS Refereed Monograph 2015 The Bioarchaeology of Classical Kamarina: Life and Death in Greek Sicily. Gainesville: University Press of Florida. ‡ Choice Magazine’s Outstanding Academic Title Award (2017) ‡ Choice Magazine’s Top 75 Community College Titles (December 2016) ‡ Archaeological Institute of America Publication Subvention Grant (2015) Refereed Edited Volume Forthcoming Gondek, R.M. -

Map 47 Sicilia Compiled by R.J.A
Map 47 Sicilia Compiled by R.J.A. Wilson, 1997 Introduction The island of Sicily has a long tradition of antiquarian interest, and books and articles have been written on its topography since the sixteenth century. Some of the older works, such as Fazello (1558), Cluverius (1619), D’Orville (1764), and especially Houel (1782), still repay study. In more recent times, Sicily is fortunate to have had published, in Manni (1981), a systematic listing of all place names and other toponyms which occur in the ancient sources, although his identification with modern sites on the ground is not always reliable (cf. Wilson 1985). Another invaluable tool of research is Nenci and Vallet’s BTCGI (1977- ). In the last fifty years especially, there has been an explosion of archaeological research, the results of which can be followed in the quadrennial reports to the Palermo conferences appearing in Kokalos, as well as in other important conference volumes such as those on the area of the Elymi in western Sicily (Nenci 1992; 1997), or through the periodic reviews of Sicilian archaeological work published in ArchRep (most recently Wilson 1987; 1995). Also very useful are two volumes reporting on recent work by the Palermo Soprintendenza (Di Stefano 1993b; 1997). Yet despite all this scholarly interest and activity, many topographical questions remain unanswered. With regard to physical geography, coastline changes since antiquity are believed to have been minor, but little geomorphological work has been undertaken, with the exception of a pioneering survey of the south-east coastline (Basile 1988; Lena 1988). This has demonstrated a rise in sea level since antiquity affecting, among other places, the coastal topography of Syracuse itself.