Archivio Storico Ii
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

MICROZONAZIONE SISMICA Relazione Illustrativa MS Livello 1 Regione Sicilia Comune Di Giarratana
Regione Siciliana - Presidenza Dipartimento della Protezione Civile Attuazione dell'Articolo 11 della Legge 24 giugno 2009, n.77 MICROZONAZIONE SISMICA Relazione Illustrativa MS Livello 1 Regione Sicilia Comune di Giarratana Convenzione in data 20/12/2011 tra il Dipartimento Regionale della Protezione Civile e l’Università degli Studi di Palermo: Indagini di Microzonazione sismica di Livello I in diversi Comuni della Regione Sicilia ai sensi dell’OPCM 3907/2010 Contraente: Soggetto realizzatore: Data: Regione Siciliana - Presidenza Università degli Studi di Palermo Novembre 2012 Dipartimento della Protezione Civile 2 INDICE Premessa Pag. 4 1. Introduzione 5 1.1 Finalità degli studi 5 1.2 Descrizione generale dell’area 6 1.3 Definizione della cartografia di base 7 1.4 Elenco archivi consultati 8 1.5 Definizione dell’area da sottoporre a microzonazione 8 2. Definizione della pericolosità di base e degli eventi di riferimento 10 2.1 Sismicità storica della Sicilia sud – orientale 10 2.2 Sismicità storica e pericolosità sismica nel comune di Giarratana 14 2.3 Faglie attive 20 2.4 Pericolosità geo-idrologica 21 3. Assetto geologico e geomorfologico 21 3.1 Inquadramento geologico 21 3.2 Assetto Tettonico 23 3.3 Caratteri morfologici, stratigrafici e tettonici del territorio di Giarratana 23 3.3.1 Caratteri morfologici 23 3.3.2 Litostratigrafia 28 3.3.2.1 Formazione Ragusa 29 3.3.2.2 Formazione Tellaro 29 3.3.2.3 Coperture 29 3.3.3 Lineamenti tettonici di Giarratana 31 4. Dati geotecnici e geofisici 31 4.1 Il database 31 4.2 Unità geologico – litotecniche 33 4.3 Indagini geofisiche precedenti 34 4.4 Il metodo HVSR 34 4.5 Indagini HVSR 37 5. -

1 Il Paesaggio Culturale Della Contea Di Modica
Il paesaggio culturale della Contea di Modica Elena DI BLASI Dipartimento di Economia e Territorio, Facoltà di Economia, Università degli Studi di Catania, c.so Italia, 55 –95129- Catania, tel.095/375344 int.336, fax 095/377174, e-mail: [email protected] Riassunto. La ricerca vuole offrire spunti di riflessione su un’ area della Sicilia dalla storia antica: la Contea di Modica. Una storia, quella della Contea, che affonda le proprie radici indietro nel tempo, scandita da diverse dominazioni che hanno lasciato i “segni” impressi sul territorio, interessato da nefasti eventi naturali che hanno determinato via via l’assetto urbanistico, politico, economico e sociale. Per meglio comprendere le caratteristiche dei centri, che un tempo fecero parte della gloriosa Contea, si è cercato di cogliere gli aspetti percettivi anche attraverso la cartografia storica, che contribuisce a dare il “senso dei luoghi” e la loro “immagine”. Obiettivo del lavoro è quello di evidenziare le forti potenzialità turistiche di questo territorio, non soltanto per la presenza di un patrimonio artistico di valore inestimabile, eredità delle variegate ed alterne vicende umane espresse nelle diverse forme di cultura materiale ed immateriale, ma anche per i grandi giacimenti naturali. Sono stati, inoltre, indagati i punti di forza di Ragusa, Modica e Scicli, città che appartennero all’antica Contea. Questi tre centri fanno parte con Caltagirone, Catania, Militello in Val di Catania e Noto di un ampio progetto denominato il “Piano di Gestione del Val di Noto” che ha come obiettivo l’analisi di tutte le risorse comprese in questa vasta area avente come unico comune denominatore il Barocco, già riconosciuto dall’Unesco patrimonio dell’umanità, e coglierne nel contempo le differenze. -

Società Santacrocese Di Storia Patria Le Contrade Di Santa Croce
Società Santacrocese di Storia Patria Monografie Le Contrade di Santa Croce Camerina PAGINA NON CONSULTABILE Presentazione Come recita l’art. 1 dello statuto della “Società Santacrocese di Storia Patria”, lo scopo primario dell’associazione è quello di favorire studi storici riguardanti Santa Croce Camerina e di pubblicare opere, memorie e documenti che vi si riferiscono. Nell’ambito della ricerca di ciò che costituisce il nostro passato, tra quanto già emerso e pubbli- cato nei precedenti volumi dell’Archivio Storico, trova un posto considerevole e degno di nota il lavo- ro monografico riguardante le contrade di Santa Croce Camerina. Il gruppo di lavoro che per la realizzazione di tale opera ha messo a disposizione competenze, tempo, fatiche di ricerca e di verifica, consultando documenti d’archivio, raccogliendo notizie verifica- bili e verificate nei siti descritti, assemblando il tutto con competenza e scrupolosità, oltre ad essere animato da un profondo amore per la propria terra, ha ritenuto importante porre dei puntelli, lasciando delle tracce che possono servire alle generazioni che verranno dopo di noi. Leggere queste pagine è entrare in un tempo che, forse, a parecchi di noi non appartiene, è supe- rare i confini degli anni, tuffarsi nelle epoche precedenti che ci hanno dato le origini, renderci orgo- gliosi per quanto i nostri avi, con fatiche, sono riusciti a definire e conservare, in un viaggio storico, culturale, umano e sociale. Affascinanti le notizie che, da una attenta lettura emergono, circa la derivazione dei toponimi, la storia che contraddistingue particolari contrade, le appartenenze delle stesse a notabili del tempo, con le relative controversie, nonché, soprattutto riguardo alle contrade Pirrera e Mezzagnone con la loro carica di storia. -

Baroque Sicily
Baroque Sicily Travel Baggage Allowance Passports We advise you to check the baggage allowances Please ensure your 10-year British Passport is not carefully as you are likely to be charged the excess out of date and is valid for a full six months beyond if you exceed the weight limit. Maximum weights the duration of your visit. EU, Andorra, for single bags apply. Liechtenstein, Monaco, San Marino or Switzerland valid national identification cards are also With Easyjet your ticket includes one hold bag of up acceptable for travel to Italy. to 23kg plus one cabin bag no bigger than 56 x 45 x 25 cm. Overhead locker space is limited on board the aircraft and on busy flights your cabin bag may Visas have to go in the hold. Visas are not required for British and EU nationals. For all other passport holders please check the visa Please contact the airline for further information requirements with the appropriate embassy. http://www.easyjet.com/en/planning/baggage Italian Consulate-General: “Harp House”, 83/86 Farringdon Street, London EC4A 4BL. Tel: (0)20 7936 5900. Fax: (0)20 7583 9425. Labels Email: [email protected] Please use the luggage labels provided. It is useful Website: to have your home address located inside your http://www.conslondra.esteri.it/Consolato_Londra suitcase should the label go astray. Open Mon-Fri 0900-1200 Transfers On arrival in Catania, transfer to Modica and to Tickets Hotel Principe d’Aragona. Included with this documentation is an e-ticket, which shows the reference number for your flight. -

COMUNE DI ISPICA PROVINCIA DI RAGUSA COMMITTENTE: ISPICA 1 SRL Via Del Salice N°105 97100 Ragusa P.Iva: 01741230880
COMUNE DI ISPICA PROVINCIA DI RAGUSA COMMITTENTE: ISPICA 1 SRL Via Del Salice n°105 97100 Ragusa p.iva: 01741230880 N.C. 02_08_19 R.C. Ing. Alessandro Cappello Relazione Geologica (Revisione 0 - del 16.03.2021) Ing. Giovanni Cassarino P2 07 Ing. Giancarlo Dimartino Ing. Juan Francisco Baglieri Studio di geologia del dott. Donato Causapruno Via Serenella, 1 - 97100 Ragusa p.iva:01039610884 [email protected] - [email protected] cell: 3355264357 COMUNE DI ISPICA PROVINCIA DI RAGUSA OGGETTO: Studio geologico a supporto del Progetto di realizzazione di realizzazione di un campo fotovoltaico della potenza di 7,645 MW in c.da Pantano Secco nel Comune di Ispica, Provincia di Ragusa. COMMITTENTE: RE.GR.AN. SRL INTESTATARIO DEL PROGETTO: ISPICA 1 SRL ELABORATO: RELAZIONE GEOLOGICA N° 26FN20 IL Geologo Geol. Donato Causapruno REDATTO VERIFICATO APPROVATO COMMESSA FASE REV. DATA Donato Causapruno 00 Febbraio 2021 Studio di geologia del dott. Donato Causapruno - Via Serenella, 1 - 97100 Ragusa - p.iva:01039610884 1 - [email protected] - [email protected] - cell:3355264357 PREMESSA La Società “ISPICA 1 SRL” con sede in Ragusa in via del Salice 105, P. Iva: 01716320880 rappresentata dal sig. Causapruno Salvatore in qualità di Legale Rappresentante, intende realizzare un campo fotovoltaico della potenza di 7,645 MW in c.da Pantano Secco nel Comune di Ispica, Provincia di Ragusa, in adempimento alle disposizioni di legge dell’art. 6 del D. Lgs. n. 28 del 03/03/2011, come recepito dal D.P. Regionale Sicilia n. 48 del 18/07/2012, concernente la Procedura Abilitativa Semplificata (PAS) e delle Delibere AEEG n°90/07 e n°99/08 (TICA) e s.m.i. -

SICILY: CROSSROADS of MEDITERRANEAN CIVILIZATIONS Including Malta Aboard the 48-Guest Yacht Elysium May 13 – 23, 2022
JOURNEYS Beyond the ordinary SICILY: CROSSROADS OF MEDITERRANEAN CIVILIZATIONS Including Malta Aboard the 48-Guest Yacht Elysium May 13 – 23, 2022 Temple of Segesta SCHEDULE OUTLINE ITALY May 13 Depart the US Ionian May 14 Arrive in Palermo. Transfer to the Grand Hotel et des Palmes. Sea May 15 Morning tour of Palermo. Afternoon excursion to Monreale. Elysium May 16 Morning excursion to Cefalu. Board the in the afternoon and sail. May 17 Marsala. Excursion to Segesta and the hill village of Erice. May 18 Porto Empedocle. Excursion to Agrigento and Piazza Armerina. May 19 Pozzallo. Explore the Baroque towns of Modica, Palazzolo Acreide, Noto, and Ispica. May 20 Valletta, Malta. Tour Valletta and Malta’s prehistoric monuments. May 21 Syracuse. Visit the city’s ancient monuments. Motor route May 22 Giardini Naxos. Excursion to Taormina. Ship route Mediterranean Air route Sea May 23 Palermo. Disembark and transfer to the airport. PROGRAM NARRATIVE Many places in the Mediterranean can lay claim to being a “crossroads of cultures and civilizations,” but none with better justification than Sicily. For, 3,000 years, wave after wave of new cultures, ideas and artistic techniques have swept over the island, leaving in their wake temples, theaters, castles villages, and extraordinary works of art that together have earned Sicily the reputation of an “open-air museum.” Our itinerary demonstrates the importance of Sicily to Greek civilization in the great theaters at Syracuse and Taormina and in the Doric temples at Agrigento and Segesta. Roman remains mingle with the Greek in Syracuse, and the wealth of Imperial Rome is evident in the 3rd-century villa near Piazza Armerina. -

Elenco Ditte
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Struttura di Vigilanza sulle Concessionarie Autostradali $002'(51$0(172$1&256,('(//$66 ³',&+,$5$0217(´('(//$665$*86$1$ DALLO SVINCOLO CON LA S.S. 115 ALLO SVINCOLO CON LA S.S. 114. (C.U.P. F12C03000000001) PROGETTO DEFINITIVO PARTE GENERALE ESPROPRI (OHQFRGLWWHHLQGHQQLWjG HVSURSULR Lotto 2 Comune di CHIARAMONTE GULFI (RG) Il Progettista Supporto specialistico Responsabile di progetto ed incaricato delle integrazioni tra Ottimizzazione della cantierizzazione le varie prestazioni: delle opere arm engineering & consulting Ing. Santa Monaco - Ordine Ing. Torino 5760H Ing. Gianmaria De Stavola - Ordine Ing. Venezia 2074 Consulenze specialistiche Geologo: Geotecnica e opere d'arte minori: Dott. Geologo Fabio Melchiorri Ordine Geologi del Lazio A.P. n 663 Ing. Antonio Alparone Opere d'arte principali: Opere di mitigazione dell'impatto ambientale: Viadotti Gallerie Rumore, Ing. G. Mondello Ing. G. Guiducci Ecosistemi e paesaggio vibrazioni GP ingegneria ed atmosfera RIFERIMENTO ELABORATO DATA FASE TR\LT DISCIPLINA\OPERA DOC PROGR. ST.\REV. FOGLIO GENNAIO '17 _ _ _ _ _ _ SCALA D 0 1 T 1 L 2 E S 0 1 1 1 R G 0 0 1 0 A 0 1 DI 0 1 - REV. DATA DESCRIZIONE VERIFICATO APPROVATO A GENNAIO '17 Emissione Novastudio Zoi Monaco IL CONCESSIONARIO L'ENTITA' COSTRUTTRICE IL RESPONSABILE DEL SARC SRL VISTO PER ACCETTAZIONE PROCEDIMENTO LOTTO 2 - CHIARAMOTE GULFI DATI INTESTAZIONE CATASTALE DATI CATASTO TERRENI CORRISPONDENZA CATASTO URBANO Nominativo o denominazione HA CA Sub ARE Sub. Quota Foglio Partic. Classe -

RELAZIONE PAESAGGISTICA Codifica Terna ITMARI11002 Rev
Progetto / Project: Collegamento ITALIA-MALTA MALTA-ITALY link Titolo / title: Enemalta code: ITMARI11002 Rev. 0 RELAZIONE PAESAGGISTICA Codifica Terna ITMARI11002 Rev. 0 INDICE 1 PREMESSA ......................................................................................................................................................... 3 1.1 FINALITÀ DELLA RELAZIONE .......................................................................................................................................... 3 1.2 LOCALIZZAZIONE DELL’AREA DI INTERVENTO .................................................................................................................... 4 2 I VINCOLI E I LIVELLI DI TUTELA PAESAGGISTICA ................................................................................................ 6 2.1 PREMESSA ............................................................................................................................................................... 6 2.2 LA PIANIFICAZIONE PAESAGGISTICA ............................................................................................................................... 7 2.2.1 Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR) – Linee Guida ..................................................................... 7 2.2.2 Piano Territoriale Paesaggistico della Provincia di Ragusa (PTPR) ............................................................. 9 2.2.3 Pianificazione locale (PRG) ....................................................................................................................... -

S. Croce Camerina (Rg) Saggi Di Scavo Nel Casale
S. CROCE CAMERINA (RG) Rasacambra citata nella conferma dei beni del 1158 da par- SAGGI DI SCAVO NEL CASALE MEDIEVALE te di Papa Adriano IV all’abbazia S. Maria Latina di Geru- RELAZIONE PRELIMINARE salemme. Il casale è attestato poco più tardi nel 1173 nella conferma dei beni del conte Guglielmo all’abbazia di S. di Filippo d’Agira come casale et ecclesia Sanctae Crucis de Rasacambri (WHITE 1938, pp. 351). Ancora nel 1194 il ca- GIOVANNI DI STEFANO, SALVINA FIORILLA sale e la chiesa sono tra i beni confermati da Enrico VI di Hoenstaufen a S. Filippo d’Agira e cinque anni dopo com- paiono nel documento con il quale Costanza e il figlio Fe- INTRODUZIONE derico confermano i beni all’abbazia (PIRRI 1733, II, p. 1250). Nel 1303 in una bolla di Benedetto XII in cui sono Le ricerche archeologiche finora condotte nella pro- enumerati i beni di S. Maria Latina di Gerusalemme il casale e vincia di Ragusa hanno evidenziato una diffusa presenza di la chiesa Sanctae Crucis de Rosacambra sono menzionati abitati d’età bizantina tuttora in corso di studio (DI STEFANO come dipendenti dal Convento dei Santi Lorenzo e Filippo OLARINO 1975; MESSINA-DI STEFANO 1997; PELLAGATTI-DI STEFANO di Scicli a sua volta suffraganeo di S. Filippo d’Agira (S 1999). In particolare alla periferia di S. Croce Camerina, in 1901, p. 215). Il casale e la chiesa Sanctae Crucis de contrada Mirio, a quattro Km dalla costa, nell’area che gra- Rosacambra sono attestati ancora da una serie di altri docu- vita intorno al “Vallone Fontana” ed alla sorgente Paradiso, menti fino al 1450 quando il complesso venne concesso a Pie- tra il 1989 ed il 1992 con successive campagne di scavo tro Celestri nobile messinese (PIRRI 1733, I, p. -

Comune Di Santa Croce Camerina (Rg)
Comune di Santa Croce Camerina (Rg) PIANO DI UTILIZZO DEL DEMANIO MARITTIMO Adeguamento alla L.R. n.3 del 17/03/2016 e D.A. 319/GAB del 05/08/2016 IL DIRIGENTE DEL III DIPARTIMENTO ASSETTO DEL TERRITORIO Arch. Maria Angela Mormina RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Arch. Maurizio Arestia Elaborato 1 Relazione Tecnica Illustrativa PROGETTISTA Arch. Pianif. Costanza Dipasquale Giugno 2018 INDICE Indice ............................................................................................................................................. 1 1. INTRODUZIONE.......................................................................................................................... 2 2. Il Piano di Utilizzo del Demanio marittimo (PUDM).................................................................. 5 2.1 Definizione ed ambito di applicazione................................................................................5 2.2 Iter di approvazione ............................................................................................................6 2.3 Finalità del piano.................................................................................................................8 2.4 Elaborati di piano ................................................................................................................9 3. Lo stato di fatto ....................................................................................................................... 11 3.1 Inquadramento territoriale...............................................................................................11 -
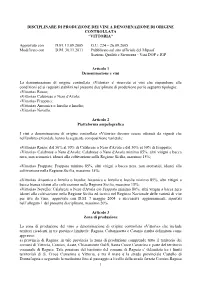
DOC Vittoria
DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA “VITTORIA” Approvato con D.M. 13.09.2005 G.U. 224 – 26.09.2005 Modificato con D.M. 30.11.2011 Pubblicato sul sito ufficiale del Mipaaf Sezione Qualità e Sicurezza - Vini DOP e IGP Articolo 1 Denominazione e vini La denominazione di origine controllata «Vittoria» e' riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie: «Vittoria» Rosso; «Vittoria» Calabrese o Nero d'Avola; «Vittoria» Frappato; «Vittoria» Ansonica o Inzolia o Insolia; «Vittoria» Novello. Articolo 2 Piattaforma ampelografica I vini a denominazione di origine controllata «Vittoria» devono essere ottenuti da vigneti che nell'ambito aziendale hanno la seguente composizione varietale: «Vittoria» Rosso: dal 50% al 70% di Calabrese o Nero d'Avola e dal 30% al 50% di Frappato; «Vittoria» Calabrese o Nero d'Avola: Calabrese o Nero d'Avola minimo 85%, altri vitigni a bacca nera, non aromatici, idonei alla coltivazione nella Regione Sicilia, massimo 15%; «Vittoria» Frappato: Frappato minimo 85%, altri vitigni a bacca nera, non aromatici, idonei alla coltivazione nella Regione Sicilia, massimo 15%; «Vittoria» Ansonica o Inzolia o Insolia: Ansonica o Inzolia o Insolia minimo 85%, altri vitigni a bacca bianca idonei alla coltivazione nella Regione Sicilia, massimo 15%; «Vittoria» Novello: Calabrese o Nero d'Avola e/o Frappato minimo 80%, altri vitigni a bacca nera idonei alla coltivazione nella Regione Sicilia ed iscritti nel Registro Nazionale delle varietà di vite per uve da vino, approvato con D.M. 7 maggio 2004 e successivi aggiornamenti, riportati nell’allegato 1 del presente disciplinare, massimo 20%. -

“No Ai Missili a Comiso, No Ai Missili in Europa!”
“NO AI MISSILI A COMISO, NO AI MISSILI IN EUROPA!” A case study of transnational contacts between Comiso (Sicily, Italy), Greenham Common (England) and the Dutch peace movement H.E. Wink MA Thesis | MA History, Specialisation Politics, Culture and National Identities Leiden University | 20 ECTS Supervisor: Dr. B.S. van der Steen | Second reader: Dr. D. Fazzi 29-06-2020 Contents Introduction ................................................................................................................................ 2 Chapter 1: The emergence of the peace movement at Comiso ................................................ 14 Chapter 2: International involvement ...................................................................................... 19 Chapter 3: Local involvement .................................................................................................. 31 Chapter 4: Peace camps ........................................................................................................... 41 Conclusion ............................................................................................................................... 49 Bibliography ............................................................................................................................ 53 Translation of the title: “No to the missiles at Comiso, no to the missiles in Europe!” Image: International Institute of Social History: [Poster.] made by Opland, (call number IISG BG E9/598), via https://hdl.handle.net/10622/903B422B-BBE6-48B7-8FB4-733CB4BB406E.