CHIOMONTE Valutazione Del Rischio Archeologico
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more
Recommended publications
-

Orari E Percorsi Della Linea Treno SFM3
Orari e mappe della linea treno SFM3 Torino - Bardonecchia/Susa Visualizza In Una Pagina Web La linea treno SFM3 (Torino - Bardonecchia/Susa) ha 5 percorsi. Durante la settimana è operativa: (1) Bardonecchia: 05:15 - 22:29 (2) Bussoleno: 05:45 - 22:59 (3) Collegno: 21:19 - 22:21 (4) Modane: 07:45 - 15:45 (5) Torino P.Nuova: 06:01 - 20:21 Usa Moovit per trovare le fermate della linea treno SFM3 più vicine a te e scoprire quando passerà il prossimo mezzo della linea treno SFM3 Direzione: Bardonecchia Orari della linea treno SFM3 14 fermate Orari di partenza verso Bardonecchia: VISUALIZZA GLI ORARI DELLA LINEA lunedì 05:15 - 22:29 martedì 05:15 - 22:29 Torino Porta Nuova 2a Via Nizza, Torino mercoledì 05:15 - 22:29 Grugliasco giovedì 05:15 - 22:29 Collegno venerdì 05:15 - 22:29 2 /A Via Giacinto Collegno, Grugliasco sabato 05:15 - 21:15 Alpignano domenica 05:45 - 21:45 1 Viale Vittoria, Alpignano Rosta 24 Piazza Stazione, Rosta Informazioni sulla linea treno SFM3 Avigliana Direzione: Bardonecchia 7 Corso Laghi, Avigliana Fermate: 14 Durata del tragitto: 86 min S.Antonino-Vaie La linea in sintesi: Torino Porta Nuova, Grugliasco, 35 Via Roma, Sant'Antonino di Susa Collegno, Alpignano, Rosta, Avigliana, S.Antonino- Vaie, Bussoleno, Meana, Chiomonte, Salbertrand, Bussoleno Oulx-Cesana-Clavaiere-Sestriere, Beaulard, Via Traforo, Bussoleno Bardonecchia Meana Via Pian Barale, Meana di Susa Chiomonte 1 Via Stazione, Chiomonte Salbertrand 14 Viale Stazione, Salbertrand Oulx-Cesana-Clavaiere-Sestriere 65 Corso Montenero, Oulx Beaulard Bardonecchia -

Presentazione Standard Di Powerpoint
L'Ente di gestione delle aree protette delle Alpi Cozie, istituito dalla Regione Piemonte nel 2012, tutela e gestisce Comune di Vaie CHIANOCCO e VAIE un vasto patrimonio naturale, paesaggistico e culturale Via I Maggio 40 che comprende ben 4 parchi naturali, 2 riserve naturali 10050 Vaie (TO) speciali e un ecomuseo. Domenica 25 Settembre 2016 www.comune.vaie.to.it Propone numerosi progetti didattici con escursioni VII GIORNATA guidate per diffondere la conoscenza naturalistica e PATRIMONIO ARCHEOLOGICO stimolare la consapevolezza ambientale. Comune di Chianocco Fr. Roccaforte 1 DELLA VALLE DI SUSA Partecipa al progetto mettendo a disposizione 10050 Chianocco (TO) competenze storico - naturalistiche del proprio personale www.comune.chianocco.to.it dipendente e collabora con accompagnatori naturalistici “IL FUOCO“ professionisti attraverso la Società 3Valli E LE CULTURE PREISTORICHE: Ambiente &Sviluppo. Sede legale: Via Fransuà Fontan 1 VITA QUOTIDIANA, PRODUZIONE 10050 Salbertrand (TO) DELLA CERAMICA E DEI PRIMI www.parchialpicozie.it METALLI, ATTIVITÀ AGRICOLE Via Mazzini 1 Il Museo Laboratorio della 10059 Susa (TO) Preistoria di Vaie è attivo dal 2001 www.vallesusa-tesori.it nel campo delle tecnologie antiche. Presenta collezioni sperimentali e diorami sui periodi pre – protostorici. Offre laboratori Via San Pancrazio 4 di base e specialistici, visite 10050 Vaie (TO) guidate al Museo e al Percorso www.museopreistoriavaie.it Archeologico (sito del IV millennio). CENTRO Associazione Basta Poco ARCHEOLOGIA Via San Pancrazio 4 Vaie SPERIMENTALE TORINO Il Centro di Archeologia Pieghevole stampato con il Sperimentale Torino dal 1986 contributo della Percorsi alla scoperta delle origini conduce studi e ricerche sulle Fondazione Magnetto. tecnologie antiche. Dal 2015 fa della Valle di Susa parte della Direzione del Museo. -

Comune Informa
2017 dicembre anno 12 - n°23 informaCOMUNE PeriodicoPeriodi dell’amministrazione di Sant’Antonino di Susa in questo numero: num AMMINISTRAZIONE Bilancio di previsione all’insegna della continuità pag. 4 LAVORI PUBBLICI Con le opere alla scuola si risparmia energia pag. 6 AMBIENTE Si promuove il compostaggio domestico pag. 7 SCUOLA ‘Cento passi’, la scuola custode di legalità pag.12 POLITICHE SOCIALI Cibo dall’azienda alle famiglie bisognose pag. 20 CULTURA Rosso contro la violenza sulle donne Visite al rifugio antiaereo pag. 21 L’amministrazione comunale augura Buone feste a tutti i concittadini di Susanna Preacco EDITORIALE dicembre 2017 sindaco di Sant’Antonino IL NOSTRO IMPEGNO PER LE FAMIGLIE E LA SCUOLA Cari concittadini, con il termine del mio terzo anno di mandato in L’altra considerazione è relativa al progetto “Aggiungi un pasto qualità di sindaco e porgendovi i migliori auguri per un buon 2018, a tavola”, fortemente voluto e perseguito con tenacia e determi- vorrei proporvi alcune rifl essioni. nazione dal Comune e dai servizi sociali ma che, senza l’apporto Ho scelto in particolare due argomenti, che ritengo particolarmen- determinante ed indispensabile delle associazioni e delle rappre- te interessanti per la nostra comunità. sentanze sindacali, in particolare del signor Ilario, non sarebbe mai Il primo riguarda la scuola che, come spesso ho avuto modo di af- partito. fermare, rappresenta un investimento e non un costo; in questo Ma non posso non citare la ditta Sogefi , in particolare l’ex direttore settore la nostra amministrazione si impegna molto, non solo in Michele Bergese e la ditta All Foods che si sono prodigate ed han- termini economici ma di attenzione, di ascolto, di interesse. -
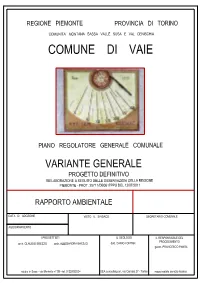
Elab. Rapporto Ambientale.Pdf
RAPPORTO AMBIENTALE QUADRO NORMATIVO IN MATERIA DI COMPATIBILITÀ AMBIENTALE IN CUI SI INSERISCE LA VARIANTE AL PIANO REGOLATORE DI VAIE ITER DI APPROVAZIONE DEL PIANO: • Adozione Progetto Preliminare – D.C.C. n. 6 del 23-01-2008 • Approvazione Progetto Definitivo – D.C.C. n. 27 del 30-06-2008 • Integrazione alla documentazione - D.C.C. n. 46 del 19-12-2008 • Integrazione alla documentazione - D.C.C. n. 57 del 30-11-2009 QUADRO NORMATIVO • Direttiva 2001/42/CE – 27-06-2001 – introduzione della Valutazione Ambientale Strategica nella normativa europea. Termine di adeguamento 21/07/2004 ( Italia inadempiente) • Parte seconda del D.Lgs. 152/2006 – procedure per la predisposizione della VAS, della VIA e della Autorizzazione Integrata Ambientale ( i processi avviati posteriormente al 31/07/2007 entrano nella diretta applicazione del Decreto) • D.Lgs. 4/2006 del 16/01/2008 – correzione al D.Lgs. 152/2006 con la sostituzione della parte seconda e modifica del regime transitorio ( in cui rientra il piano di Vaie) • D.G.R. n. 12-8931 del 19/06/2008 - indirizzi operativi per l’applicazione delle procedure VAS nei piani e nei programmi Il D.Lgs. 152/2006, così come integrato dal D.Lgs. 4/2008, è lo strumento legislativo su cui si basa la programmazione in materia ambientale, in ottemperanza a quanto richiesto dalla normativa comunitaria; in esso sono contenuti i criteri e le procedure per il procedimento di Valutazione Ambientale Strategica (VAS). Con D.G.R. n. 12-8931 del 19/06/2008. La Regione Piemonte conferma gli indirizzi per l’elaborazione del Rapporto Ambientale, identificandoli con i punti dell’allegato f all’art. -

Elenco Dei Comuni Inseriti Nelle Zone Omogenee Della Citta
ELENCO DEI COMUNI INSERITI NELLE ZONE OMOGENEE DELLA CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO (hp://www.ciametropolitana.torino.it/cms/territorio-urbanistica/ pianificazione-strategica/zone-omogenee) Zona 1 “TORINO” (N. Comuni 1: Torino) Zona 2 “AMT OVEST” (N. Comuni 14: Alpignano, Buigliera Alta, Collegno, Druento, Grugliasco, Piane a, Reano, Rivoli, Rosta, San Gillio, Sangano, Trana, Venaria, Villarbasse) Zona 3 “AMT SUD” (N. Comuni 18: Beinasco, Bruino, Candiolo, Carignano, Castagnole P.te, La Loggia, Moncalieri, Nichelino, None, Orbassano, Pancalieri, Piossasco, Piobesi Torinese, Rivalta di Torino, Trofarello, Vinovo, Virle Piemonte,Volvera) Zona 4 “AMT NORD” (N. Comuni 7: Borgaro Torinese, Caselle Torinese, Lein., San Benigno C.se, San Mauro Torinese, Seimo Torinese, Volpiano) Zona 5 “PINEROLESE” (N. Comuni 45: Airasca, Angrogna, Bibiana, Bobbio Pellice, Bricherasio, Buriasco, Campiglione 0enile, Cantalupa, Cavour, Cercenasco, Cumiana, 0enestrelle, 0rossasco, Gar igliana, 1nverso Pinasca, Luserna S. Giovanni, Lusernea, Macello, Massello, Osasco, Perosa Argentina, Perrero, Pinasca, Pinerolo, Piscina, Pomareo, Porte, Pragelato, Prali, Pramollo, Prarostino, Roleo, Ror2, Roure, Sal a di Pinerolo, San Germano C.se, San Pietro Val Lemina, San Secondo di P., Scalenghe, Torre Pellice, 3sseau4, Vigone, Villafranca Piemonte, Villar Pellice, Villar Perosa) Zona 6 “VALLI SUSA E SANGONE” (N. Comuni 40: Almese, Avigliana, Bardonecchia, Borgone Susa, Bru olo, Bussoleno, Caprie, Caselee, Cesana T.se, Chianocco, Chiomonte, Chiusa di San Michele, Claviere, Coa e, Condove, E4illes, Giaglione, Giaveno, Gravere, Maie, Meana di Susa, Mompantero, Moncenisio, Novalesa, Oul4, Rubiana, Salbertrand, San Didero, San Giorio di Susa, Sant7Ambrogio di Torino, Sant7Antonino di Susa, Sau e di Cesana, Sau e d7Oul4, Sestriere, Susa, Vaie, Valgioie, Venaus, Villar Dora, Villarfocchiardo) Zona 7 “CIRIACESE - VALLI DI LANZO” (N. -

Minero-Petrographic Characterization of Chianocco Marble
1 Type of the Paper (Article, Review, Communication, etc.) 2 Minero-petrographic characterization of Chianocco 3 Marble employed for Palazzo Madama façade in 4 Turin (NW Italy) 5 Francesca Gambino 1*, Alessandro Borghi 1, Anna d’Atri 1, Luca Martire 1, Martina Cavallo1, 6 Lorenzo Appolonia2,3, Paola Croveri2 7 1 Department of Earth Sciences, University of Turin, Via Valperga Caluso, 35, Turin, 10125, Italy; 8 [email protected] 9 2 Centro Conservazione e Restauro “La Venaria Reale”, Via XX Settembre 18, 10078 Venaria Reale (TO), Italy 10 3 Soprintendenza per i beni e le attività culturali della Regione Autonoma Valle d’Aosta, Piazza Narbonne, n. 11 3 - 11100 Aosta, Italy 12 * Correspondence: [email protected] 13 Received: date; Accepted: date; Published: date 14 15 Abstract: The study of ancient marbles plays an important role in the interpretation of an historical 16 and archaeological site and gives interesting information about building materials used in ancient 17 times and their trade routes. The present work focuses on Chianocco Marble that represents one of 18 the most important ancient white marbles for Cultural Heritage exploited in Piedmont region (NW 19 Italy) and employed for Palazzo Madama façade. A multi-analytical study based on petrographic 20 (optical and scanning electron microscopy), electron microprobe and stable isotope analyses was 21 carried out on these marbles in order to perform an archaeometric study. 22 Chianocco Marble was used in Turin during the baroque era by the Savoy architect Filippo Juvarra 23 (1678 - 1736) in historical buildings, as the façade of Palazzo Madama, the plinth of the façade of the 24 town Cathedral and the columns (now plastered) of the portico of Piazza San Carlo. -
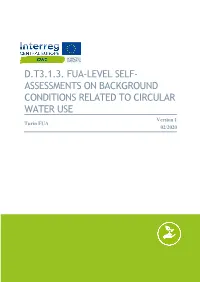
D.T3.1.3. Fua-Level Self- Assessments on Background Conditions Related To
D.T3.1.3. FUA-LEVEL SELF- ASSESSMENTS ON BACKGROUND CONDITIONS RELATED TO CIRCULAR WATER USE Version 1 Turin FUA 02/2020 Sommario A.CLIMATE,ENVIRONMENT AND POPULATION ............................................... 3 A1) POPULATION ........................................................................................ 3 A2) CLIMATE ............................................................................................. 4 A3) SEALING SOIL ...................................................................................... 6 A4) GREEN SPACES IN URBANIZED AREAS ...................................................... 9 B. WATER RESOURCES ............................................................................ 11 B1) ANNUAL PRECIPITATION ...................................................................... 11 B2) RIVER, CHANNELS AND LAKES ............................................................... 13 B3) GROUND WATER .................................................................................. 15 C. INFRASTRUCTURES ............................................................................. 17 C1) WATER DISTRIBUTION SYSTEM - POPULATION WITH ACCESS TO FRESH WATER .................................................................................................... 17 C2) WATER DISTRIBUTION SYSTEM LOSS ..................................................... 18 C3) DUAL WATER DISTRIBUTION SYSTEM ..................................................... 18 C4) FIRST FLUSH RAINWATER COLLECTION ................................................ -

SERIES Basement and Mesozoic Cover, Are Known by Different Local Names (E.G
GEOSCIENCE CANADA Volume 43 2016 13 SERIES basement and Mesozoic cover, are known by different local names (e.g. Luserna Stone, Borgone and Vaie Stone, Perosa Stone, Bargiolina Quartzite, Foresto and Chianocco Marble). These stones were largely employed during the 17th and 18th centuries for some of the most famous and important monuments in Turin (capital of Piedmont region, northwestern Italy), as well as in the countryside, since Roman times. Some of the materials exploited in the Dora-Maira Unit were also exported to foreign countries: Borgone and Vaie Stone were used for the paving of the Louvre Museum, and Perosa Stone was employed for the construction of the monument of Independence in Lagos, Nigeria. Consequently, the Dora-Maira Unit can be designated as a Global Heritage Stone Province. RÉSUMÉ L’Unité Dora-Maira est une unité géologique affleurant dans la Heritage Stone 2. partie interne des Alpes Cottiennes; elle appartient au Domai- ne Penninique des Alpes occidentales (Italie du Nord-Ouest). The Dora-Maira Unit (Italian Cottian Alps): A Elle se compose d’une croûte continentale d’âge Paléozoïque Reservoir of Ornamental Stones Since supérieur et de sa couverture carbonatique Mésozoïque, méta- morphosées en faciès éclogite pendant le Cénozoïque. En rai- Roman Times* son de la complexité des associations lithologiques et des transformations métamorphiques et structurelles, l’Unité + Alessandro Borghi , Paola Cadoppi and Giovanna Dora-Maira a été une source de pierres ornementales au cours Antonella Dino des siècles, et encore il représente un réservoir de matériau employé localement pour des bâtiments contemporains et his- Department of Earth Sciences, University of Turin toriques. -

Citta' Metropolitana Di Torino
CITTA' METROPOLITANA DI TORINO - SU00125 Torna all'elenco Sito Web http://www.cittametropolitana.torino.it/ Telefono 0118616601 Email [email protected] Tipo Ente Enti Locali Sezione SCU - Sezione Piemonte Codice Ente Nome Ente Tipo Relazione SU00125A00 Comune di Avigliana Contratto SU00125A01 Comune di Caravino Contratto SU00125A15 Agenzia Piemonte Lavoro Contratto SU00125A18 Associazione AMISCOUT di Cassine Contratto SU00125A19 Associazione culturale Macapà Contratto SU00125A20 Associazione LA PIAZZETTA ONLUS Contratto SU00125A17 C.I.S.S. 38 - Consorzio Intercomunale dei Servizi Socio Assistenziali Contratto SU00125A02 Comune di Buriasco Contratto SU00125A22 FONDAZIONE CASA DELL'ANZIANO "MADONNA DELLA Contratto MISERICORDIA" ONLUS SU00125A23 Fondazione Fransoua Casa Amica Onlus Contratto SU00125A21 GINEPRODUE COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' ONLUS Contratto SU00125A16 Opera Pia Paravidini Contratto SU00125A24 Scuola dell'Infanzia paritaria "•Duchessa di Genova" Contratto SU00125A09 Comune di Ponderano Contratto SU00125A10 Comune di Pray Contratto SU00125A11 Comune di Rueglio Contratto SU00125A12 Comune di San Giusto Canavese Contratto SU00125A13 Comune di San Salvatore Monferrato Contratto SU00125A14 Comune di San Sebastiano da Po Contratto SU00125A03 Comune di Coazze Contratto SU00125A04 Comune di Cumiana Contratto SU00125A05 Comune di Mathi Contratto SU00125A06 Comune di Pecetto Torinese Contratto SU00125A07 Comune di Pinasca Contratto SU00125A08 Comune di Pomaretto Contratto SU00125A25 APS RONDO' BIMBI -

Dipartimenti Di Prevenzione Delle ASL Della Regione Piemonte Ambito Territoriale (Comuni)
Dipartimenti di prevenzione delle ASL della Regione Piemonte Ambito territoriale (comuni) 1 ASL Ambito territoriale ASL Città di Torino Torino Almese, Avigliana, Bardonecchia, Beinasco, Borgone Susa, Bruino, Bruzolo, Bussoleno, Buttigliera Alta, Caprie, Caselette, Cesana Torinese, Chianocco, Chiomonte, Chiusa di San Michele, Claviere, Coazze, Collegno, Condove, Exilles, Giaglione, Giaveno, Gravere, Grugliasco, Mattie, Meana di Susa, Mompantero, Moncenisio, Novalesa, Orbassano, Oulx, Piossasco, Reano, Rivalta di Torino, Rivoli, Rosta, Rubiana, Salbertrand, San Didero, San Giorio di Susa, Sangano, Sant’ambrogio di Torino, Sant’Antonino di Susa, Sauze di Cesana, Sauze d’Oulx, Susa, Trana, Vaie, Valgioie, Venaus, Villar Dora, Villar Focchiardo, Villarbasse, Volvera, Alpignano, Druento, ASL TO3 Givoletto, La Cassa, Pianezza, San Gillio, Val della Torre, Venaria Reale, Airasca, Angrogna, Bibiana, Bobbio Pellice, Bricherasio, Buriasco, Campiglione Fenile, Cantalupa, Cavour, Cercenasco, Cumiana, Fenestrelle, Frossasco, Garzigliana, Inverso Pinasca, Luserna San Giovanni, Lusernetta, Macello, Massello, Osasco, Perosa Argentina, Perrero, Pinasca, Pinerolo, Piscina, Pomaretto, Porte, Pragelato, Prali, Pramollo, Prarostino, Roletto, Rorà, Roure, Salza di Pinerolo, San Germano Chisone, San Pietro Val Lemina, San Secondo di Pinerolo, Scalenghe, Sestriere, Torre Pellice, Usseaux, Vigone, Villafranca Piemonte, Villar Pellice, Villar Perosa, Virle Piemonte. Ala di Stura, Balangero, Balme, Barbania, Borgaro Torinese, Cafasse, Cantoira, Caselle Torinese, -

Turin-Lyon Re-Establishing the Relations with the Susa Valley.Pdf
Mario Virano Commissioner of the Government NETLIPSE Network Meeting Turin-Lyon: Re-establishing the relations with the Susa Valley Warsaw, 16 October 2012 SUSA VALLEY, SINCE EVER CROSSROADS BETWEEN EUROPE AND MEDITERRANEAN ROYAL ROAD SUSA VALLEY NAPOLEONIC ROAD (1803-1813) The New Railway Line Turin-Lyon NLTL THE PROJECT OF 2004 CONTESTED BY LOCAL PEOPLE THE PROJECT OF 2004 MASS DEMONSTRATION IN VENAUS IN DECEMBER 2005 LY TO The New Railway Line Turin-Lyon NLTL HOW WAS THE NEW PROJECT ATTAINED THE RESUMPTION OF THE DEBATE AFTER VENAUS - FROM 2006 TO PRESENT A CONSTANT DEBATE ESTABLISHMENT OF THE POLITICAL BOARD AT PALAZZO CHIGI WHICH HAS MET 7 TIMES UNTIL PRESENT AND WHICH INCLUDES ALL CONCERNED MINISTRIES, THE REGION, THE PROVINCE, THE CITY OF TURIN, RAILWAY COMPANIES AND LOCAL COMMUNITIES. ESTABLISHMENT OF THE TECHNICAL OBSERVATORY, GATHERING EXPERTS OF ALL CONCERNED INSTITUTIONS, WITH THE AIM TO DEFINE THE NEW PROJECT: 199 MEETINGS FROM 12 DECEMBER 2006 UNTIL TODAY 300 HEARINGS OF EXPERTS, INCLUDING 65 INTERNATIONAL ONES 10 WORKING GROUPS 9 PAPERS SUMMARIZING ALL STUDIES CURRENT STRUCTURE OF THE OBSERVATORY 50 MUNICIPALITIES REPRESENTED BY 16 DELEGATES N. DELEGATES OF THE MUNICIPALITIES CONCERNED IN THE NLTL DELEGATES MUNICIPALITIES AMT CENTRAL NODE – PASSENGERS - TURIN 1 1 LINKS WITH RAILWAY ORBASSANO FREIGHT YARD 1 1 SUSA INTERNATIONAL STATION 1 1 CHIOMONTE WINZE EXIT 1 1 SANT’ANTONINO DI SUSA INTERCHANGE WITH HISTORICAL LINE 1 1 AVIGLIANA INTERCHANGE WITH HISTORICAL LINE 1 1 NORTHERN SETTIMO, BORGARO 2 1 CIRCUMVALLATION WESTERN VENARIA, COLLEGNO, GRUGLIASCO 3 1 CIRCUMVALLATION ALPIGNANO, VILLARBASSE, RIVOLI, ROSTA, BUTTIGLIERA, WESTERN ADDUCTION 7 2 BRUINO, RIVALTA VAL SANGONE REANO, SANGANO, TRANA, GIAVENO, VALGIOIE, COAZZE 6 1 SANT’AMBROGIO, CHIUSA SAN MICHELE,VAIE, VILLAR FOCCHIARDO, SAN GIORIO, BUSSOLENO, MEANA, MATTIE, LOWER SUSA VALLEY 14 3 CONDOVE, CHIANOCCO, BRUZOLO, S. -

Consegna a Domicilio Dal Venerdì Al Martedì Da Stuzzicare
BRASSERIA PROTAGONISTA LA BIRRA MENU DELIVERY CONSEGNA A DOMICILIO DAL VENERDÌ AL MARTEDÌ DA STUZZICARE Patatine* fritte 4 Anelli di cipolla* 5 Alette di pollo 5 GOFRI singolo / doppio Pulled pork 5 / 9 Chili con carne con fagioli 5 / 9 Il condimento viene spedito caldo in vaschetta separata e serve aggiungerlo alla cialda del gofri HAMBURGER SORALAMA’ BURGER Carne di vitella Fassone 150g, provola 8 dolce, cipolla alla piastra, speck, pomodoro, salsa piccante HAMBURGER Carne di vitella Fassone 150g, insalata, 7 pomodoro, ketchup, maionese TANTAROBABURGER Carne di vitella Fassone 150g, tometta, 10 speck, uovo, insalata, pomodoro, ketchup, maionese TOMABURGER Carne di vitella Fassone 150g, toma, insalata, 8 ketchup, maionese VEGANBURGER Burger vegano, insalata, pomodoro, 9 maionese vegana SECONDI Stinco alla birra 11 Ribs costine di maiale in salsa BBQ 11 DOLCI Birramisù 4 BIBITE Bibite Molecola / Fanta / Sprite / Coca Cola / Coca Cola Zero 3 Chinotto / Tonica / Estathè al limone e alla pesca Bottiglia di birra 33cl 4,50 Cartone misto da 4 bottiglie da 33cl 11,50 Cartone misto da 12 bottiglie da 33cl 29,50 Cartone misto da 24 bottiglie da 33cl 54,50 MENU Hamburger Tomaburger o Hamburger + birra 33cl 9,90 Hamburger Veganburger, Soralama’ burger o Tantarobaburger 10,90 + birra 33cl Gofri singolo Pulled pork o Chili + birra 33cl 8,90 Gofri doppio Pulled pork o Chili + birra 33cl 11,90 Stinco o Ribs + birra 33cl 13,90 Aggiungi al menu le patatine fritte o anelli di cipolla. 2,90 (i prodotti si possono aggiungere 1 volta per menu) I menu possono