Città Metropolitana Di Roma
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Strutture Ospedaliere E Studi Di MG Presso I Quali Svolgere L'attività Di
Strutture ospedaliere e studi di MG presso i quali svolgere l’attività di tirocinio pratico valutativo per l’abilitazione all’esercizio della professione di medico-chirurgo Seconda sessione - 2017 CLINICA CHIRURGICA AZIENDA OSPEDALIERA INDIRIZZO CITTA' CAP CONVENZIONE Az. Ospedaliera “Fatebenefratelli” ISOLA TIBERINA, 39 ROMA 00186 In attivazione Az. Ospedaliera “S. Camillo – Forlanini” CIRCONVAL. GIANICOLENSE, 87 ROMA 00152 In scadenza Az. Ospedaliera “San Giovanni Addolorata” VIA DELL’AMBA ARADAM, 9 ROMA 00184 In attivazione Istituto Nazionale Tumori “Regina Elena” VIA ELIO CHIANESI, 53 ROMA 00128 Attiva Ospedale “Cristo Re” VIA DELLE CALASANZIANE, 25 ROMA 00167 In attivazione Presidio Ospedaliero “G.B. Grassi” VIA PASSERONI, 30 OSTIA LIDO 00122 In scadenza CLINICA MEDICA AZIENDA OSPEDALIERA INDIRIZZO CITTA' CAP CONVENZIONE Az. Ospedaliera “Fatebenefratelli” ISOLA TIBERINA, 39 ROMA 00186 In attivazione Az. Ospedaliera “S. Camillo – Forlanini” CIRCONVAL. GIANICOLENSE, 87 ROMA 00152 In scadenza Az. Ospedaliera “San Giovanni Addolorata” VIA DELL’AMBA ARADAM, 9 ROMA 00184 In attivazione Istituto Nazionale Tumori “Regina Elena” VIA ELIO CHIANESI, 53 ROMA 00128 Attiva Ospedale “M. G. Vannini” VIA DELL’ACQUA BULICANTE, 4 ROMA 00177 In scadenza Presidio Ospedaliero “Santo Spirito in Sassia” LUNGOTEVERE IN SASSIA, 1 ROMA 00193 In scadenza STUDI DI MEDICINA GENERALE TITOLO COGNOME NOME INDIRIZZO CITTA' CAP Dott. BARBARO NATALE VIA SAN GODENZO 94 ROMA 00189 Dott. BASTIANELLI MAURIZIO VIA UNGHERIA PALESTRINA 00036 Dott.ssa BATTISTA TERESA VIA P. MATTEUCCI 104 ROMA 00154 Dott. BERRE` GIUSEPPE VIA RENDE 6 ROMA 00178 Dott. BIAGIOLI GRAZIANO VIA LATA 36 VELLETRI 00049 Dott. BRUNO VITO FRANCESCO VIA ROVIANO 67 ROMA 00176 Dott. CARACCIOLO FRANCESCO VIA DI VIGNA CONSORTI 6 ROMA 00148 Dott. -

Anno Scolastico 2018-19 LAZIO AMBITO 0013
Anno Scolastico 2018-19 LAZIO AMBITO 0013 - ROMA PROVINCIA Elenco Scuole I Grado Ordinato sulla base della prossimità tra le sedi definita dall’ufficio territoriale competente SEDE DI ORGANICO ESPRIMIBILE DAL Altri Plessi Denominazione altri Indirizzo altri Comune altri PERSONALE Scuole stesso plessi-scuole stesso plessi-scuole stesso plessi-scuole Codice Istituto Denominazione Istituto DOCENTE Denominazione Sede Caratteristica Indirizzo Sede Comune Sede Istituto Istituto Istituto stesso Istituto RMIC89000B IC V TIVOLI BAGNI RMMM89001C ORAZIO - TIVOLI NORMALE PIAZZA B. DELLA QUEVA TIVOLI RMIC8G0006 IC TIVOLI III - VILLA RMMM8G0017 SMS I.C. TIVOLI III NORMALE VIA LIBERTUCCI TIVOLI ADRIANA RMIC892003 I.C TIVOLI IV-VINCENZO RMMM892014 VINCENZO PACIFICI NORMALE VIA DELLA LEONINA TIVOLI RMMM892025 S. GREGORIO DA VIA BORGO PIO SNC SAN PACIFICI SASSOLA GREGORIO DA SASSOLA RMIC89300V IC TIVOLI II - TIVOLI RMMM89301X BACCELLI - TIVOLI NORMALE VIA DEI PINI 19 TIVOLI RMMM893021 SAN POLO DEI VIA I MAGGIO SNC SAN POLO CENTRO CAVALIERI DEI CAVALIERI RMIC8F600E TIVOLI I - TIVOLI CENTRO RMMM8F601G TIVOLI "EMILIO SEGRE'" NORMALE VIA DEL PARCO DI VILLA TIVOLI BRASCHI, 23 RMVC02000V CONVITTO NAZ."A.DI RMMM41900D S.M.S.ANNESSA C.N."A.DI NORMALE PIAZZA GARIBALDI N.1 TIVOLI SAVOIA,DUCA D'AOSTA" SAVOIA" RMIC8BF004 I.C.C.B. CONTE DI RMMM8BF015 C. B. CONTE DI CAVOUR NORMALE VIA PIO LA TORRE, SNC CASTEL CAVOUR MADAMA RMIC897006 DON LORENZO MILANI RMMM897017 DON LORENZO MILANI NORMALE VIA MARCO AURELIO GUIDONIA 02 MONTECELIO RMIC898002 LEONARDO DA VINCI RMMM898013 LEONARDO DA VINCI NORMALE VIA DOUHET GUIDONIA GUIDONIA 6 MONTECELIO RMIC89900T IC ALBERTO RMMM89901V T. MINNITI GUIDONIA NORMALE VIA TRENTO S.N.C. -

Roma, 17 Novembre 2017 Comuni
Roma, 17 novembre 2017 Ufficio Provinciale di Roma - Territorio ______________ Il Direttore Comuni di: - BELLEGRA - CAPENA - CAPRANICA PRENESTINA - CARPINETO ROMANO - CASTELNUOVO DI PORTO - CASTEL SAN PIETRO ROMANO - CAVE - CIVITELLA SAN PAOLO - COLLEFERRO - FIANO ROMANO - FILACCIANO - GALLICANO NEL LAZIO - GAVIGNANO - GENAZZANO - GORGA - LABICO - MONTELANICO - MORLUPO - NAZZANO - OLEVANO ROMANO - PALESTRINA - PISONIANO - POLI - PONZANO ROMANO - RIANO - RIGNANO FLAMINIO - ROCCA DI CAVE - SACROFANO - SANT’ORESTE L’originale del documento è conservato presso l’Ufficio emittente Agenzia delle Entrate – Ufficio Provinciale di Roma - Territorio – Via Raffaele Costi 58/60 – 00155 Roma Tel. 06.7240.2530-2557 - Fax 06.7240.2534 – e-mail: [email protected] pec: [email protected] - SAN VITO ROMANO - SEGNI - TORRITA TIBERINA - ZAGAROLO e.p.c. - Restanti Comuni della Provincia di Roma - Ordini e Collegi Professionali della Provincia di Roma - Associazioni Agricole della Provincia di Roma - Agenzia delle Entrate Direzioni Provinciali - Agenzia delle Entrate Direzione Regionale del Lazio Ufficio Attività Immobiliari Prot. All. 1 OGGETTO: Conservazione del Catasto Terreni - verificazioni quinquennali gratuite artt.118 e 119 del Regolamento n.2153/1938. II DPR 917/1986 consente, con cadenza quinquennale, ai possessori di richiedere la variazione del reddito dominicale per sostituzione della qualità di coltura o per diminuzione della capacità produttiva ascrivibile a specifiche cause; l'Agenzia dell'Entrate verifica gratuitamente tali segnalazioni. Per godere del beneficio della verificazione quinquennale gratuita i possessori interessati, i cui beni ricadono nei Comuni oggetto di verifica periodica, devono presentare, entro il 31 gennaio 2018, la denuncia dei cambiamenti al competente Ufficio provinciale dell'Agenzia del Territorio utilizzando gli stampati disponibili in Ufficio o sul sito http://www.agenziaentrate.gov.it, seguendo il percorso: Cosa devi fare – Aggiornare dati catastali e ipotecari - Variazioni colturali. -

Bellegra Roiate
I PCA SI NES ULLE BEG, ROE CA N TE Stefano Rocca Santo Bellegra Roiate Quando la passione degli insegnanti incontra dei siti di incantevole armonia, delle storie di lunga tradizione, degli alunni dall'animo sensibile, nasce la SCUOLA… Il luogo in cui il passato indica la strada del futuro e i grandi aprono ai piccoli le porte della bellezza... Il Dirigente Scolastico Prof.ssa Donatella Antonellis Bellegra, Roiate e Rocca Santo Stefano sono tre piccoli comuni della provincia di Roma, caratterizzati da luoghi interessanti dal punto di vista storico, artistico e paesaggistico. Con questo nostro lavoro vogliamo farvi conoscere i principali siti di interesse culturale dei nostri paesi, come ad esempio le chiese di San Sisto o San Nicola a Bellegra, quelle di San Tommaso o San Benedetto a Roiate e quelle di San Sebastiano o Santa Maria Assunta a Rocca Santo Stefano. Portarvi a fare una passeggiata tra i boschi di castagno o tra gli antichi uliveti, farvi conoscere i frutti delle piante di nocciolo o dei rinomati fallacciani. Conoscere e valorizzare il patrimonio culturale, partendo dal territorio in cui viviamo, è fondamentale per la nostra formazione, per questo ringraziamo la Prof.ssa Valentina Ferrante per l’idea e il coordinamento del lavoro e tutti i docenti che hanno collaborato. Gli Alunni della II^E, II^F e I^F A. S. 2020-2021 Bellegra IL CONVENTO DI SAN FRANCESCO Il Convento di San Francesco d’Assisi nacque nel 1223 dalla visita di San Francesco in questo posto, Francesco restò colpito dal luogo che era circondato dal verde dei castagni e dei faggi. -

Unione Comuni VALLE GIOVENZANO- Orari Corse Servizio Sperimentale TPL
Unione Comuni VALLE GIOVENZANO- Orari corse servizio sperimentale TPL CORSE CAPOLINEA 1 SOSTA 2 SOSTA 3 SOSTA 4 SOSTA 5 SOSTA MANDELA SAMBUCI LINEA 1 CORSA N° 1 - GERANO/MANDELA (FS) GERANO CERRETO CICILIANO SAMBUCI (FS) ORARIO PARTENZA 04:35 04:45 04:55 05:00 05:05 MANDELA SAMBUCI LINEA 1 CORSA N°2- MANDELA (FS)/PISONIANO SAMBUCI PISONIANO (FS) ORARIO PARTENZA 06:00 06:05 06:25 GERANO BIVIO CERRETO BIVIO CICILIANO BIVIO (SP MANDELA LINEA 1 CORSA N°3 - PISONIANO/MANDELA (FS) PISONIANO SAMBUCI (PONTE TERENZIO) (PONTE TERENZIO) 33A) SAMBUCI (FS) ORARIO PARTENZA 06:30 06:40 06:45 06:50 06:55 07:00 MANDELA SAMBUCI LINEA 1 CORSA N°4- MANDELA (FS)/GERANO SAMBUCI GERANO (FS) ORARIO PARTENZA 07:05 07:10 07:20 MANDELA SAMBUCI LINEA 2 CORSA N°1 - PISONIANO/MANDELA (FS) PISONIANO CICILIANO SAMBUCI (FS) CORSE MATTINA CORSE ORARIO PARTENZA 07:15 07:25 07:35 07:40 MANDELA SAMBUCI LINEA 1 CORSA N°5 - GERANO/MANDELA (FS) GERANO CERRETO (FS) ORARIO PARTENZA 07:25 07:35 07:45 CORSA N°6 ANDATA-RITORNO MANDELA MANDELA SAMBUCI MANDELA SAMBUCI LINEA 1 SARACINESCO (FS) /SARACINESCO (FS) (FS) ORARIO PARTENZA 09:00 09:15 09:30 MANDELA SAMBUCI LINEA 2 CORSA N°2 - MANDELA (FS)/PISONIANO SAMBUCI PISONIANO (FS) ORARIO PARTENZA 10:35 10:40 11:00 CORSA N°7- ANDATA-RITORNO MANDELA MANDELA SAMBUCI MANDELA SAMBUCI LINEA 1 SARACINESCO (FS) /SARACINESCO (FS) (FS) ORARIO PARTENZA 12:20 12:30 12:40 MANDELA SAMBUCI LINEA 1 CORSA N°8 - MANDELA (FS)/PISONIANO SAMBUCI PISONIANO (FS) ORARIO PARTENZA 15:50 16:00 16:10 MANDELA SAMBUCI LINEA 2 CORSA N°3 - PISONIANO/MANDELA (FS) PISONIANO -

Anno Scolastico 2018-19 LAZIO AMBITO 0013
Anno Scolastico 2018-19 LAZIO AMBITO 0013 - ROMA PROVINCIA Elenco Scuole Primaria Ordinato sulla base della prossimità tra le sedi definita dall’ufficio territoriale competente SEDE DI ORGANICO ESPRIMIBILE DAL Altri Plessi Denominazione altri Indirizzo altri Comune altri PERSONALE Scuole stesso plessi-scuole stesso plessi-scuole stesso plessi-scuole Codice Istituto Denominazione Istituto DOCENTE Denominazione Sede Caratteristica Indirizzo Sede Comune Sede Istituto Istituto Istituto stesso Istituto RMIC89000B IC V TIVOLI BAGNI RMEE89001D TIVOLI - BAGNI NORMALE VIA NERI, 11 TIVOLI RMEE89002E TIVOLI B.GO VIA DELL'AERONAUTICA TIVOLI NUOVO-COLONNELLE RMEE89003G TIVOLI - G. RODARI VIA COLLODI TIVOLI RMIC8G0006 IC TIVOLI III - VILLA RMEE8G0018 M. TERESA DI CALC. - V. NORMALE VIA LEONINA, 6 TIVOLI RMEE8G0029 ISTITUTO COMPRENSIVO VIA G. A. CROCE TIVOLI ADRIANA LEONINA TIVOLI III RMIC892003 I.C TIVOLI IV-VINCENZO RMEE892037 MARIA NORMALE VIA PATERNO,28 TIVOLI RMEE89206A CASAPE VIA PIETRO TESTI CASAPE PACIFICI MONTESSORI - VIA PATERNO RMEE892048 IQBAL MASIH - VIA VIA ROSOLINA,136-138 TIVOLI ROSOLINA RMEE892059 S.GREGORIO DA VIA BORGO PIO SNC SAN SASSOLA GREGORIO DA SASSOLA RMIC89300V IC TIVOLI II - TIVOLI RMEE893033 TIVOLI II GIORDANI NORMALE VIALE PICCHIONI TIVOLI RMEE893011 TIVOLI - S. POLO SCALO VIA DEI PLATANI SNC TIVOLI CENTRO RMEE893022 MANLIO BATTISTINI VIA I MAGGIO SNC SAN POLO DEI CAVALIERI RMIC8F600E TIVOLI I - TIVOLI CENTRO RMEE8F601L TIVOLI I - SANDRO NORMALE VIA COLLEGIO 2 TIVOLI RMEE8F602N TIVOLI I - DON NELLO VIA F. BULGARINI 36 TIVOLI PERTINI DEL RASO RMVC02000V CONVITTO NAZ."A.DI RMEE27801N SC.EL.ANNESSA NORMALE PIAZZA GARIBALDI N.1 TIVOLI SAVOIA,DUCA D'AOSTA" C.N."A.DI SAVOIA" RMIC8BF004 I.C.C.B. -

Valori Agricoli Medi Della Provincia Annualità 2019
Ufficio del territorio di ROMA Data: 29/10/2020 Ora: 11.00.29 Valori Agricoli Medi della provincia Annualità 2019 Dati Pronunciamento Commissione Provinciale Pubblicazione sul BUR n. del n. del REGIONE AGRARIA N°: 1 REGIONE AGRARIA N°: 2 ALTO ANIENE MONTAGNA NORD OCCIDENTALE DEI LEPINI Comuni di: AFFILE, AGOSTA, ANTICOLI CORRADO, ARCINAZZO Comuni di: CARPINETO ROMANO, GAVIGNANO, GORGA, ROMANO, ARSOLI, CAMERATA NUOVA, MANDELA, CANTERANO, MONTELANICO, SEGNI CAPRANICA PRENESTINA, CERRETO LAZIALE, CERVARA DI ROMA, CICILIANO, CINETO ROMANO, GERANO, JENNE, LICENZA, MARANO EQUO, MONTEFLAVIO, PERCILE, RIOFREDDO, ROCCA CANTERANO, ROCCAGIOVINE, ROCCA SANTO STEFANO, ROIATE, ROVIANO, SAMBUCI, SAN POLO DEI CAVALIERI, SARACINESCO, SUBIACO, VALLEPIETRA, VALLINFREDA, VICOVARO, VIVARO ROMANO COLTURA Valore Sup. > Coltura più Informazioni aggiuntive Valore Sup. > Coltura più Informazioni aggiuntive Agricolo 5% redditizia Agricolo 5% redditizia (Euro/Ha) (Euro/Ha) BOSCO CEDUO 5000,00 5000,00 BOSCO D`ALTO FUSTO 5000,00 5000,00 BOSCO MISTO 4500,00 4500,00 CANNETO 5000,00 CASTAGNETO 17000,00 18000,00 FRUTTETO 27500,00 INCOLTO PRODUTTIVO 1500,00 ORTO 31000,00 29000,00 ORTO IRRIGUO 34000,00 31000,00 PASCOLO 5000,00 4000,00 PASCOLO ARBORATO 5000,00 4000,00 Pagina: 1 di 15 Ufficio del territorio di ROMA Data: 29/10/2020 Ora: 11.00.29 Valori Agricoli Medi della provincia Annualità 2019 Dati Pronunciamento Commissione Provinciale Pubblicazione sul BUR n. del n. del REGIONE AGRARIA N°: 1 REGIONE AGRARIA N°: 2 ALTO ANIENE MONTAGNA NORD OCCIDENTALE DEI LEPINI Comuni di: AFFILE, AGOSTA, ANTICOLI CORRADO, ARCINAZZO Comuni di: CARPINETO ROMANO, GAVIGNANO, GORGA, ROMANO, ARSOLI, CAMERATA NUOVA, MANDELA, CANTERANO, MONTELANICO, SEGNI CAPRANICA PRENESTINA, CERRETO LAZIALE, CERVARA DI ROMA, CICILIANO, CINETO ROMANO, GERANO, JENNE, LICENZA, MARANO EQUO, MONTEFLAVIO, PERCILE, RIOFREDDO, ROCCA CANTERANO, ROCCAGIOVINE, ROCCA SANTO STEFANO, ROIATE, ROVIANO, SAMBUCI, SAN POLO DEI CAVALIERI, SARACINESCO, SUBIACO, VALLEPIETRA, VALLINFREDA, VICOVARO, VIVARO ROMANO COLTURA Valore Sup. -

The Long-Term Influence of Pre-Unification Borders in Italy
A Service of Leibniz-Informationszentrum econstor Wirtschaft Leibniz Information Centre Make Your Publications Visible. zbw for Economics de Blasio, Guido; D'Adda, Giovanna Conference Paper Historical Legacy and Policy Effectiveness: the Long- Term Influence of pre-Unification Borders in Italy 54th Congress of the European Regional Science Association: "Regional development & globalisation: Best practices", 26-29 August 2014, St. Petersburg, Russia Provided in Cooperation with: European Regional Science Association (ERSA) Suggested Citation: de Blasio, Guido; D'Adda, Giovanna (2014) : Historical Legacy and Policy Effectiveness: the Long-Term Influence of pre-Unification Borders in Italy, 54th Congress of the European Regional Science Association: "Regional development & globalisation: Best practices", 26-29 August 2014, St. Petersburg, Russia, European Regional Science Association (ERSA), Louvain-la-Neuve This Version is available at: http://hdl.handle.net/10419/124400 Standard-Nutzungsbedingungen: Terms of use: Die Dokumente auf EconStor dürfen zu eigenen wissenschaftlichen Documents in EconStor may be saved and copied for your Zwecken und zum Privatgebrauch gespeichert und kopiert werden. personal and scholarly purposes. Sie dürfen die Dokumente nicht für öffentliche oder kommerzielle You are not to copy documents for public or commercial Zwecke vervielfältigen, öffentlich ausstellen, öffentlich zugänglich purposes, to exhibit the documents publicly, to make them machen, vertreiben oder anderweitig nutzen. publicly available on the internet, or to distribute or otherwise use the documents in public. Sofern die Verfasser die Dokumente unter Open-Content-Lizenzen (insbesondere CC-Lizenzen) zur Verfügung gestellt haben sollten, If the documents have been made available under an Open gelten abweichend von diesen Nutzungsbedingungen die in der dort Content Licence (especially Creative Commons Licences), you genannten Lizenz gewährten Nutzungsrechte. -

La Stipe Votiva in Località Pantanacci (Genzano Di Roma-Lanuvio, Roma)
La stipe votiva in località Pantanacci (Genzano di Roma-Lanuvio, Roma) Luca Attenni – Giuseppina Ghini 1. Premessa Inoltre, il contesto topografico circostante è partico- larmente ricco di vestigia archeologiche poste a di- Nel luglio del 2012 l’intervento del Gruppo Tutela stanza ravvicinata: oltre al già citato complesso sacra- Patrimonio Archeologico della Guardia di Finanza le di Giunone Sospita, che si erge a circa m 800 a sud, ha consentito di interrompere uno scavo clandestino a m 60 a est c’erano una cava in peperino di età e di recuperare, in località Pantanacci (attualmente repubblicana e l’antico acquedotto che alimentava la ricadente tra il Comune di Lanuvio e quello di Gen- città di Lanuvium, a m 200 a sud una necropoli di età zano di Roma), una gran mole di materiale votivo de- imperiale5. stinato al mercato antiquario internazionale. Stante Il luogo ha suscitato grande interesse scientifico e la situazione di emergenza legata ai ritrovamenti, uni- notevole riscontro turistico sin dal 2012, anno della tamente all’indubbio interesse archeologico del sito, prima campagna d’indagine archeologica, cui sono è stata tempestivamente avviata una prima campagna immediatamente seguite attività di manutenzione e di scavo1. messa in sicurezza del territorio, pubblicazione dei Il sito, che si identifica come una stipe votiva col- dati, musealizzazione delle migliaia di reperti (sia locata in un antro naturale interessato già in antico all’interno del Museo Nazionale delle Navi Romane da interventi antropici, si colloca nei rigogliosi boschi di Nemi, sia in una nuova sala espositiva all’interno dell’ager Lanuvinus, non lontano dal celebre Santua- del Borgo Medioevale di Lanuvio), attività divulga- rio di Giunone Sospita, di cui potrebbe, il condizio- tive in sedi prestigiose (tra cui la conferenza presso nale è d’obbligo, essere parte integrante2. -

This Regulation Shall Be Binding in Its Entirety and Directly Applicable in All Member States
12. 8 . 91 Official Journal of the European Communities No L 223/ 1 I (Acts whose publication is obligatory) COMMISSION REGULATION (EEC) No 2396/91 of 29 July 1991 fixing for the 1990/91 marketing year the yields of olives and olive oil THE COMMISSION OF THE EUROPEAN COMMUNITIES, Whereas the measures provided for in this Regulation are in accordance with the opinion of the Management Having regard to the Treaty establishing the European Committee for Oils and Fats, Economic Community, Having regard to Council Regulation No 136/66/EEC of 22 September 1966 on the establishment of a common HAS ADOPTED THIS REGULATION : organization of the market in oils and fats ('), as last amended by Regulation (EEC) No 1720/91 (2) ; Article 1 Having regard to Council Regulation (EEC) No 2261 /84 of 17 July 1984 laying down general rules on the granting 1 . For the 1990/91 marketing year, yields of olives and of aid for the production of olive oil and of aid to olive oil olive oil and the relevant production zones shall be as producer organizations (3), as last amended by Regulation specified in Annex I hereto . (EEC) No 3500/90 (4), and in particular Article 19 thereof, 2. The production zones are defined in Annex II . Whereas Article 18 of Regulation (EEC) No 2261 /84 provides that yields of olives and olive oil should be fixed for each homogeneous production zone on the basis of Article 2 information supplied by the producer Member States ; This Regulation shall enter into force on the third day Whereas, in view of the information received, it is appro following its publication in the Official Journal of the priate to fix these yields as specified in Annex I hereto ; European Communities. -

Disciplinare Caccia Al Cinghiale
PROVINCIA DI ROMA DISCIPLINA DELLA CACCIA AL CINGHIALE STAGIONE VENATORIA 2014/2015 Adottato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 223 del 13./09/2013 Aggiornato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 303 del 14/11/2013 Aggiornato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 295 del 25/09/2014 STAGIONE VENATORIA 2014/2015 Il presente “Disciplinare ” individua il periodo e le modalità di caccia alla specie cinghiale, nonché le zone ove è possibile effettuare la caccia in battuta e prescrive le modalità per la costituzione delle squadre e lo svolgimento della battuta, cosi come previsto all’art. 5 del “Regolamento della caccia al cinghiale nella Provincia di Roma” approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 41 del 13/09/2010. Art. 1 1. La caccia alla specie cinghiale (Sus scrofa) nella Provincia di Roma è consentita esclusivamente nei giorni: - 12, 18, 19, 25, 26 del mese di ottobre 2014; - 1, 2, 6, 9, 13, 16, 20, 23, 27, 30 del mese di novembre 2014; - 3, 6, 7, 10, 13, 14, 17, 20, 21, 24, 27, 28, 31 del mese dicembre 2014; - 3, 4, 7, 10,11, 14, 17, 18, 21, 24, 25, 28, 31 del mese di gennaio 2015. Art. 2 CACCIA AL CINGHIALE IN BATTUTA 1. La caccia al cinghiale in battuta negli A.T.C. RM 1 e RM 2 può essere esercitata esclusivamente nelle zone indicate nell’allegato A: a) per la caccia al cinghiale in battuta, all’interno delle zone di cui all’allegato A e nelle A.F.V., è consentito l’ausilio del cane da seguita anche nei giorni del mese di gennaio sopra individuati. -
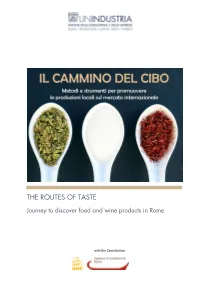
The Routes of Taste
THE ROUTES OF TASTE Journey to discover food and wine products in Rome with the Contribution THE ROUTES OF TASTE Journey to discover food and wine products in Rome with the Contribution The routes of taste ______________________________________ The project “Il Camino del Cibo” was realized with the contribution of the Rome Chamber of Commerce A special thanks for the collaboration to: Hotel Eden Hotel Rome Cavalieri, a Waldorf Astoria Hotel Hotel St. Regis Rome Hotel Hassler This guide was completed in December 2020 The routes of taste Index Introduction 7 Typical traditional food products and quality marks 9 A. Fruit and vegetables, legumes and cereals 10 B. Fish, seafood and derivatives 18 C. Meat and cold cuts 19 D. Dairy products and cheeses 27 E. Fresh pasta, pastry and bakery products 32 F. Olive oil 46 G. Animal products 48 H. Soft drinks, spirits and liqueurs 48 I. Wine 49 Selection of the best traditional food producers 59 Food itineraries and recipes 71 Food itineraries 72 Recipes 78 Glossary 84 Sources 86 with the Contribution The routes of taste The routes of taste - Introduction Introduction Strengthening the ability to promote local production abroad from a system and network point of view can constitute the backbone of a territorial marketing plan that starts from its production potential, involving all the players in the supply chain. It is therefore a question of developing an "ecosystem" made up of hospitality, services, products, experiences, a “unicum” in which the global market can express great interest, increasingly adding to the paradigms of the past the new ones made possible by digitization.