Sommario Lettera Ai Soci
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
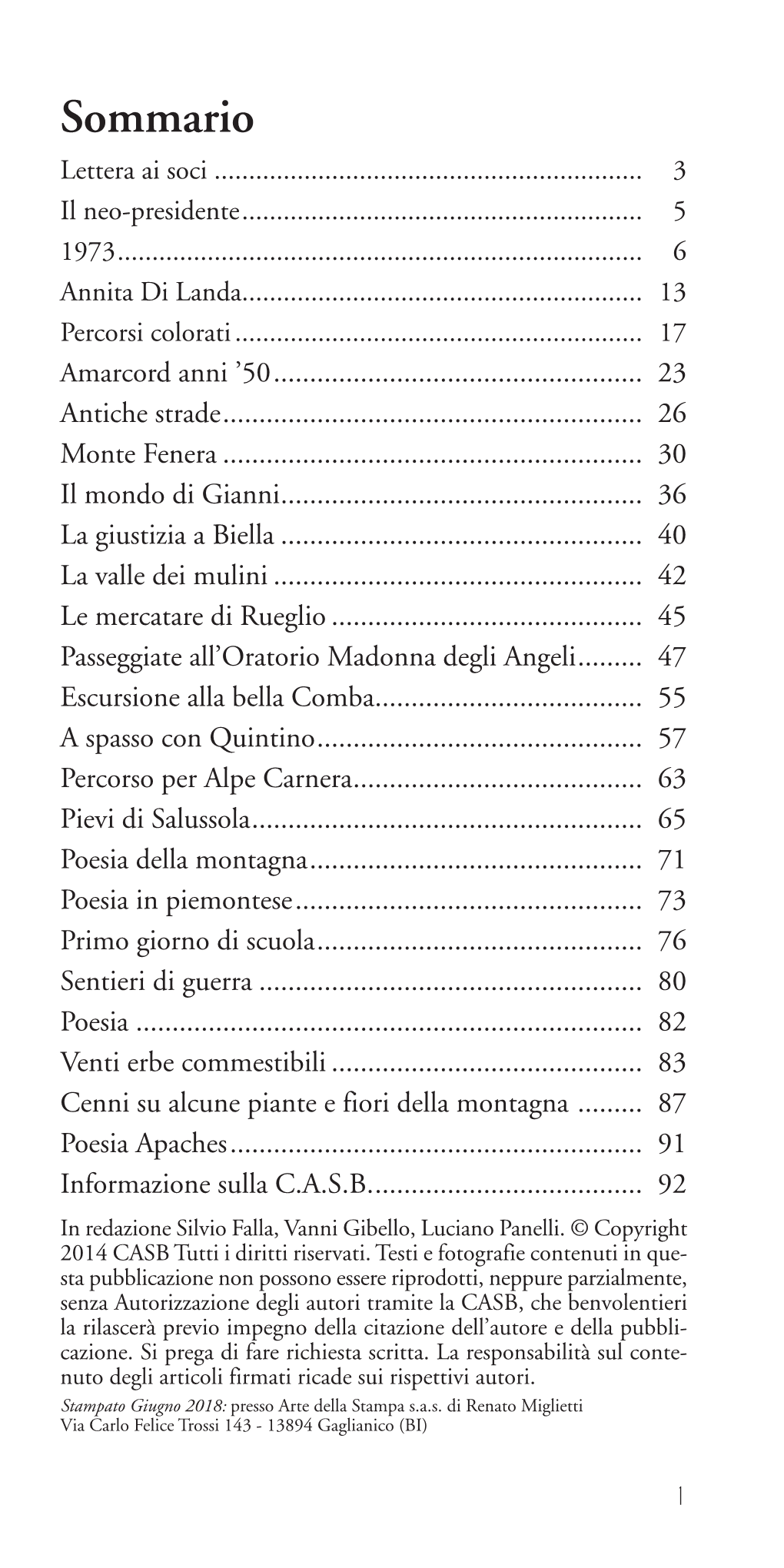
Load more
Recommended publications
-

Voti Lista Regionale Per Comune
ELEZIONI REGIONALI 2019 VOTI LISTA REGIONALE PER COMUNE COMUNE CIRCOSCRIZIONE REGIONE LISTA REGIONALE VOTI % SEZ TOTALI AILOCHE BIELLA PIEMONTE MOVIMENTO 5 20 12,6582 1 STELLE AILOCHE BIELLA PIEMONTE CIRIO PRESIDENTE 109 68,9873 1 AILOCHE BIELLA PIEMONTE CIRIO PRESIDENTE 109 68,9873 1 AILOCHE BIELLA PIEMONTE CIRIO PRESIDENTE 109 68,9873 1 AILOCHE BIELLA PIEMONTE CIRIO PRESIDENTE 109 68,9873 1 AILOCHE BIELLA PIEMONTE CIRIO PRESIDENTE 109 68,9873 1 AILOCHE BIELLA PIEMONTE SÌ CHIAMPARINO 28 17,7215 1 PRESIDENTE AILOCHE BIELLA PIEMONTE SÌ CHIAMPARINO 28 17,7215 1 PRESIDENTE AILOCHE BIELLA PIEMONTE SÌ CHIAMPARINO 28 17,7215 1 PRESIDENTE AILOCHE BIELLA PIEMONTE SÌ CHIAMPARINO 28 17,7215 1 PRESIDENTE AILOCHE BIELLA PIEMONTE SÌ CHIAMPARINO 28 17,7215 1 PRESIDENTE AILOCHE BIELLA PIEMONTE SÌ CHIAMPARINO 28 17,7215 1 PRESIDENTE AILOCHE BIELLA PIEMONTE SÌ CHIAMPARINO 28 17,7215 1 PRESIDENTE AILOCHE BIELLA PIEMONTE IL POPOLO DELLA 1 0,6329 1 FAMIGLIA ANDORNO MICCA BIELLA PIEMONTE MOVIMENTO 5 230 13,2641 4 STELLE ANDORNO MICCA BIELLA PIEMONTE CIRIO PRESIDENTE 1033 59,5732 4 ANDORNO MICCA BIELLA PIEMONTE CIRIO PRESIDENTE 1033 59,5732 4 ANDORNO MICCA BIELLA PIEMONTE CIRIO PRESIDENTE 1033 59,5732 4 ANDORNO MICCA BIELLA PIEMONTE CIRIO PRESIDENTE 1033 59,5732 4 ANDORNO MICCA BIELLA PIEMONTE CIRIO PRESIDENTE 1033 59,5732 4 ANDORNO MICCA BIELLA PIEMONTE SÌ CHIAMPARINO 464 26,7589 4 PRESIDENTE ANDORNO MICCA BIELLA PIEMONTE SÌ CHIAMPARINO 464 26,7589 4 PRESIDENTE ANDORNO MICCA BIELLA PIEMONTE SÌ CHIAMPARINO 464 26,7589 4 PRESIDENTE ANDORNO MICCA BIELLA PIEMONTE -

SP 413 Zimone - San Sudario U B Ie N a ) Ioppino Belvedere C.Ale Montano
SP 413 Zimone - San Sudario u b ie n a ) ioppino Belvedere C.ale Montano Crosa R o g g i a Vermogno M o Comune di li n R a ia r Parogno ia le Zubiena Milano - Vermogno d i P ar ogno C.na Gianetto Ò 4 1 C.na Lucento 1 lla ne To o e p l lo ia o R c S io R Bessa C.na Tamagno C.na Carrera Á C.na Molino Valle Rio ì Piletta V a San Sudario Valle l S R o io San Grato rda P i le tta 3 1 Fornace C.na Ranco Ò4 7 Ò C.na Carbonera 4 10 San Sudario ere y C io R Magnano C.na Pradaronco 4 Reg. Fontanazze Bose Reg. Pianezza C.na Cerej 5 0 0 2 4 Ò Zimone Piverone Ò 4 14 Reg. Olive Comune di Piverone Reg. Tizzone a' Mos Roggia di Reg. Ponente lug 29, 2014 SP 413 Zimone - San Sudario Lunghezza8350 m F - Strada locale (extraurbana ed urbana) dalla SP 400 in comune di Zimone alla SP 411 località La Bessa in comune di Cerrione Note: deriva dalla fusione della 50 e della 72 dell'allegato 3 Delib. del Commissario n. 8 del 27/04/1995) Tratto intermedio tra i Comuni di Zimone e Magnano: metà carreggiata (lato sx) ricade in comune di Piverone, Provincia di Torino; la gestione del tratto indicato rimane di competenza della Provincia di Biella INIZIO in Comune di: Zimone altri riferimenti: Via Circonvallazione Note: Caposaldo al centro dell'incrocio tra la S.P. -

Computo Zona 2- Serra
zona 2 serra COMPUTO PROGETTO: SGOMBERO NEVE - TAGLIO ERBA E INTERVENTI VARI DESCRIZIONE STRADALI VOCI DI COMPUTO A) SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTO ANTIGELO TIPOLOGIA N. prezzo IMPORTI km IMPORTI TOTALI DELLA STRADA INTERVENTI unitario PARZIALI A) INTERVENTI PER SGOMBERO NEVE n. SP nome sintetico descrizione Km. da Cerrione incocio SP 305 a confine 400 S.P. Biella Zimone 7,450 7,450 134 4.991,50 provinciale E 5 da S.P. 409 in comune di Sala al confine 408 S.P. Sala Andrate 2,938 2,938 134 1.968,46 Prov. di Torino E 5 S.P. Zubiena Sala da SS 338 in Zubiena per Sala Torrazzo 409 6,950 6,950 134 4.656,50 Torrazzo alla S.S. 338 E 5 da S.P. 413 in comune di Magnano alla 410 S.P. di Magnano 2,034 2,034 134 1.362,78 S.S. 338 E 5 da Cerrione, fine centro abitato , a S.S. 338 in Loc. Filippi di Zubiena ( verbale di 411 S.P. Cerrione Chalet 7,606 7,606 134 5.096,02 dismissione centro abitato di Cerrione in E 5 data 13/11/02) S.P. Bornasco Sala da S.S. 338 in comune di Zubiena per 412 3,936 3,936 134 2.637,12 B.se Bornasco alla S.P. 409 in Sala B.se E 5 S.P. Zimone Magnano da SP 400 a SP 411 in Loc. Bessa di 413 8,427 8,427 134 5.646,09 S. Sudario Cerrione per Magnano S. Sudario E 5 da S.P. -

Città Di Biella Medaglia D’Oro Al V.M
Città di Biella Medaglia d’oro al V.M. BANDO per l’attribuzione di contributi del Fondo per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione 2019 e 2020 Ambito n. 12 – Capofila BIELLA ANDORNO MICCA, BIELLA, BORRIANA, CALLABIANA, CAMANDONA, CAMBURZANO, CAMPIGLIA CERVO, CAVAGLIA', CERRIONE, DONATO, DORZANO, GAGLIANICO, GRAGLIA, MAGNANO, MIAGLIANO, MONGRANDO, MUZZANO, NETRO, OCCHIEPPO INFERIORE, OCCHIEPPO SUPERIORE, PETTINENGO, PIEDICAVALLO, POLLONE, PONDERANO, PRALUNGO, RONCO BIELLESE, ROPPOLO, ROSAZZA, SAGLIANO MICCA, SALA BIELLESE, SALUSSOLA, SANDIGLIANO, SORDEVOLO, TAVIGLIANO, TERNENGO, TOLLEGNO, TORRAZZO, VALDILANA, VEGLIO, VERRONE, VIGLIANO BIELLESE, VILLA DEL BOSCO, VIVERONE, ZIMONE, ZUBIENA, ZUMAGLIA Visti: la L.R. 9 dicembre 1998 n. 431 concernente la disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili ad uso abitativo ed in particolare l’art. 11 che istituisce, presso il Ministero dei Lavori Pubblici, il Fondo Nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione; il Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 7 giugno 1999 concernente i requisiti minimi dei conduttori per beneficiare di tali contributi; la D.G.R. n. 6-1164 del 27 marzo 2020 concernente criteri e procedure per la ripartizione ed erogazione delle risorse del Fondo per l’accesso all’abitazione in locazione 2019; la D.G.R. n. 5-1531 del 19 giugno 2020 concernente criteri e procedure per la ripartizione ed erogazione delle risorse del Fondo per l’accesso all’abitazione in locazione 2020; SI RENDE NOTO che dal 1° SETTEMPRE 2020 AL 30 SETTEMBRE 2020 sono aperti i termini per la partecipazione al Bando per l’assegnazione di contributi ad integrazione dei canoni di locazione sia per l’anno 2019 che per il 2020. -

Relazione 2018
Slowland Piemonte Relazione anno 2018 1 L’anno 2018 è stato l’anno in cui la Lo statuto dell’Associazione nostra Associazione ha finalmente evidenzia come gli obiettivi non Introduzione concretizzato in modo operativo il siano limitati ad un ambito specifico, lavoro fatto nei tre anni precedenti, quale ad esempio quello turistico, ma del Presidente anni in cui vi è stato un lungo lavoro cerchino invece di interpretare tutte di coordinamento, tra i comuni, e di le forze e le debolezze per girarle in definizione delle linee comuni sui opportunità, a partire dal bellissimo Presidente a.i. principi e sugli obiettivi. territorio che abbiamo e la sua Pancrazio Bertaccini vocazione turistica, per passare dallo Sono stati raggiunti risultati sviluppo tecnologico e di servizi che importanti perché hanno permesso è alla base della crescita di ogni di affrontare diverse problematiche, comunità. Crescita che nella nostra sfruttare opportunità in modo visione deve restare nell’ambito della congiunto e sperimentare nuovi tipi sostenibilità e per questo fare tesoro di progettazione, collaborando tra di tutto il lavoro che è già stato fatto amministrazioni e ragionando su nelle esperienze che sono maturate ricadute non vincolate dai limiti in questi anni e negli anni passati, amministrativi e dagli effetti a breve quali il Contratto di Lago di Viverone, periodo. e nei progetti, che sono stati spesso realizzati con intelligenza e Per questi risultati vorrei ringraziare attenzione alla comunità, ai quali subito gli amministratori che hanno però mancava -

Provincia Di Biella
Provincia di Biella DATA COMUNE TIPO ATTO SOTTOTIPO ATTO ATTO DECRETO ASSEGNAZIONE A AILOCHE 14/05/1941 COMMISSARIALE CATEGORIA DECRETO ASSEGNAZIONE A ANDORNO MICCA 07/10/1936 COMMISSARIALE CATEGORIA SITUAZIONE DA BENNA 02/11/1994 SITUAZIONE DA DEFINIRE DEFINIRE DECRETO DICH. INESISTENZA USI BIELLA 16/05/1935 COMMISSARIALE CIVICI DECRETO ASSEGNAZIONE A BIELLA 20/10/1936 COMMISSARIALE CATEGORIA DECRETO ASSEGNAZIONE A BIELLA 21/10/1936 COMMISSARIALE CATEGORIA DECRETO DICH. INESISTENZA USI BIELLA 12/05/1939 COMMISSARIALE CIVICI DECRETO ASSEGNAZIONE A BIELLA 15/05/1939 COMMISSARIALE CATEGORIA DECRETO ASSEGNAZIONE A BIELLA 16/05/1939 COMMISSARIALE CATEGORIA DECRETO ASSEGNAZIONE A BIOGLIO 20/10/1936 COMMISSARIALE CATEGORIA DECRETO ASSEGNAZIONE A BIOGLIO 28/05/1939 COMMISSARIALE CATEGORIA DECRETO DICH. INESISTENZA USI BORRIANA 10/11/1936 COMMISSARIALE CIVICI DECRETO DICH. INESISTENZA USI BORRIANA 02/04/1940 COMMISSARIALE CIVICI SITUAZIONE DA BRUSNENGO 24/02/1994 SITUAZIONE DA DEFINIRE DEFINIRE DECRETO ASSEGNAZIONE A CALLABIANA 20/10/1936 COMMISSARIALE CATEGORIA DECRETO ASSEGNAZIONE A CAMANDONA 05/02/1940 COMMISSARIALE CATEGORIA DECRETO ASSEGNAZIONE A CAMBURZANO 30/03/1940 COMMISSARIALE CATEGORIA DECRETO ASSEGNAZIONE A CAMPIGLIA CERVO 08/04/1940 COMMISSARIALE CATEGORIA DETERMINAZIONE DICHIARAZIONE DI CANDELO 08/09/1999 DIRIGENZIALE INESISTENZA USI CIVICI DATA COMUNE TIPO ATTO SOTTOTIPO ATTO ATTO DECRETO ASSEGNAZIONE A CAPRILE 22/03/1940 COMMISSARIALE CATEGORIA DECRETO DICH. INESISTENZA USI CASAPINTA 10/06/1939 COMMISSARIALE CIVICI CASTELLETTO DECRETO DICH. INESISTENZA USI 24/03/1937 CERVO COMMISSARIALE CIVICI CASTELLETTO DECRETO DICH. INESISTENZA USI 02/04/1940 CERVO COMMISSARIALE CIVICI DECRETO DICH. INESISTENZA USI CAVAGLIA' 27/03/1940 COMMISSARIALE CIVICI CERRETO DECRETO DICH. INESISTENZA USI 10/06/1939 CASTELLO COMMISSARIALE CIVICI ATTI VARI SENZA CERRIONE - - DECRETO DECRETO ASSEGNAZIONE A COGGIOLA 21/03/1940 COMMISSARIALE CATEGORIA DECRETO DICH. -

Farmers' Opinions
ISSN 2039-2117 (online) Mediterranean Journal of Social Sciences Vol 7 No 1 ISSN 2039-9340 (print) MCSER Publishing, Rome-Italy January 2016 What Does the Optional Quality Term “Mountain Product” Involve? The Biellese Mountain (North-West Italy) Farmers’ Opinions Alessandro Bonadonna Assistant Professor, Department of Management University of Turin [email protected] Doi:10.5901/mjss.2016.v7n1p18 Abstract The latest European Regulation on quality schemes for agricultural products and foodstuffs, in addition to underlining the importance of consolidated voluntary certification schemes (PDO, PGI, TSG), confirms the importance of origin specifically for rural areas. The European Parliament drew attention to the need for the enhancement of mountain and insular areas and introduced the “Optional quality terms”. The Delegated Regulation, EU n. 665/2014, defined the conditions of use of the term “Mountain Product”. According to the current orientation, this optional term provides for a labelling scheme that allows to promote qualified mountain production. This paper aimed at the evaluation of when this term can be used i.e. the goods must meet set criteria as well as reporting the farmers’ points of view. The data were collected with the scope of defining a certification scheme dedicated to this optional quality term. A model mountain area (Montagne Biellesi, North-West Italy) was taken into consideration with semi-structured interviews on 33 farms collecting information from the producers as to their opinions on the use of this optional quality term. The resulting data, not only emphasizes the need for more extended and detailed communication as to which initiatives the European Union is taking, but also poses some doubts about the implementation of a certification scheme. -

La Popolazione Dei Comuni Biellesi: Andamento Per Aggregazioni Territoriali
.1. Dati demografici e statistici di sfondo 1.2 La popolazione dei comuni biellesi: andamento per aggregazioni territoriali. Sommario 1. Andamento demografico per aggregazioni territoriali 2. Popolazione per fasce d'etá e aggregazioni territoriali 3. Mappa della distribuzione della popolazione 4. Principali indicatori demografici dei comuni biellesi 1. Andamento demografico per aggregazioni territoriali La popolazione nella provincia si distribuisce in modo disomogeneo sul territorio, concentrandosi maggiormente nei comuni della prima periferia del capoluogo e nella zona di pianura del triangolo Biella-Cossato-Cavagliá. Nel presente articolo esaminiamo la popolazione per aggregazioni territoriali, suddividendola per fasce di età e proponendo una visualizzazione su mappa per apprezzare meglio la distribuzione della popolazione sul territorio biellese. Le aggregazioni territoriali che utilizziamo traggono spunto dalla suddivisione proposta da Economia Biellese, e sono le seguenti: • Bassa Valle del Cervo: Andorno, Miagliano, Sagliano, Tavigliano, Tollegno • Alta Valle Cervo : Campiglia, Piedicavallo, Quittengo, Rosazza, San Paolo Cervo • Pipanura Elvo - Cervo : Benna, Borriana, Candelo, Castelletto, Gaglianico, Gifflenga, Massazza, Mottalciata, Ponderano, Sandigliano, Verrone, Villanova • La Serra : Cavaglià, Cerrione, Dorzano, Magnano, Roppolo, Sala, Salussola, Torrazzo, Viverone, Zimone, Zubiena • Alta Valle Elvo : Camburzano, Donato, Graglia, Mongrando, Muzzano, Netro, Occhieppo Inferiore, Occhieppo Superiore, Pollone, Sordevolo • Colline -

Dipvvf.COM-BI.REGISTRO UFFICIALE.U.0002110.11-03-2020
dipvvf.COM-BI.REGISTRO UFFICIALE.U.0002110.11-03-2020 DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE COMANDO PROVINCIALE DI BIELLA UFFICIO PREVENZIONE [email protected] Ordine degli Ingegneri della Provincia di Biella Via Novara 1, 13900 Biella [email protected] Ordine degli Architetti della Provincia di Biella Via Novara 1, 13900 Biella [email protected] Collegio Geometri della Provincia di Biella Via Eugenio Bona, 7, 13900 Biella [email protected] Collegio dei Periti Industriali della Provincia di Biella Via Sabadell, 6a - 13900 Biella [email protected] Comunità Montana Valle del Cervo "LA BURSCH" Via B. Galliari, 50 - 13811 - Andorno Micca [email protected] Suap Biellese Orientale Via Mazzini, 3 - 13825 - Crocemosso (Vallemosso) [email protected] Comunità Collinare tra Baraggia e Bramaterra Via Martiri della Libertà 15 - 13874 Mottalciata [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] Via Santa Barbara, 3/a - 13900 BIELLA - (Tel. 0158555660/1/2 - Fax 0158555659) [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] e, p.c. -

U N a H O T El C a V Ag Lia'
Da Cavaglià a Magnano Partenza: UNA HOTEL, Cavaglià Arrivo: UNA HOTEL, Cavaglià Lunghezza Totale (km): 42,3 Percorribilità: In mountain bike o ibrida Tempo di percorrenza in bicicletta (ore.min): 4.00 Dislivello in salita (m): 505 Dislivello in discesa (m): 505 Quota massima (m): 557 Difficoltà: Media Strade pavimentate: 54% Strade sterrate e carrarecce: 46% Mulattiere e sentieri: 0% Ciclabilità: 100% Come arrivare al punto di partenza: Treno (stazione Santhià), bus ATAP Note sul percorso: L'itinerario inizia su un terreno pianeggiante per poi salire gradualmente attraverso i boschi della Serra Morenica di Ivrea. Si costeggia il Lago di Bertignano e si prosegue fino ai villaggi di Zimone e Magnano. Una breve deviazione ci porta al Monastero di Bose e alla vicina Chiesa di San Secondo. Si rientra quindi verso il Lago di Viverone, percorrendo un tratto della ciclovia Francigena. Punti di ristoro a Zimone, Magnano e Cavaglià. Quota (m) Profilo altimetrico 800 700 600 500 400 300 200 100 0 0 5 10 15 20 25 30 35 40 Distanza (km) Rilievi, fotografie e materiale descrittivo a cura di UNA HOTEL CAVAGLIA' HOTEL UNA Ludovico Bizzocchi e Emanuele Belletti - itinerAria - www.itineraria.eu Nelle fotografie, dall'alto in basso: due ciclisti alle prese con le e- bike, si pedala tra i prati, le risaie. UNA HOTEL - Da Cavaglià a Magnano Rif. km km Dir. Descrizione Alt. tot. parz. (m) 1 0,0 0,0 PORTA LATERALE DELL'HOTEL SUL CANALE DELLA MANDRIA Imbocca la carrareccia e 220 ! verso la vicina strada provinciale 2 0,1 0,1 GIRA A SINISTRA sulla Strada Provinciale, -

Codice A1706A D.D. 1 Agosto 2017, N. 783 D.M. 30 Dicembre 2015. Autorizzazione Per Il Territorio Regionale Della Concessione Di
REGIONE PIEMONTE BU40 05/10/2017 Codice A1706A D.D. 1 agosto 2017, n. 783 D.M. 30 dicembre 2015. Autorizzazione per il territorio regionale della concessione di assegnazione supplementare di prodotti petroliferi ammessi ad agevolazione fiscale in agricoltura per siccita'. Integrazione e correzione per mero errore materiale della DD n. 748/A1706A del 21 luglio 2017. Con determinazione dirigenziale n. 748/A1706A del 21 luglio 2017 è stata autorizzata per il territorio regionale la concessione di assegnazione supplementare di prodotti petroliferi ammessi ad agevolazione fiscale in agricoltura per siccità, individuando tre aree differenti interessate con gravità decrescente. Con propria comunicazione (mail del 26 luglio 2017) il settore territoriale dell’agricoltura di Vercelli-Biella ha segnalato l'opportunità di integrare l'elenco dei Comuni di Biella e Vercelli individuati nell'ambito dell'Area 2 inserendo Gaglianico per coerenza con gli altri Comuni indicati e eliminando Vergnasco, in quanto frazione di Cerrione, e di correggere Iozzolo in Lozzolo Preso atto di quanto comunicato dal settore territoriale dell’agricoltura di Vercelli-Biella e ritenuto di procedere all’integrazione e correzione richieste. Preso atto che rimane confermato il restante testo della Determinazione n. 748/A1706A del 21 luglio 2017 e che per i Comuni inseriti, per la concessione dell’assegnazione supplementare, valgono le disposizioni già indicate per i Comuni dell’Area 2 nella determinazione sopra riportata. Vista la determinazione dirigenziale n. 1322/A1706A del 30 dicembre 2016 che ha approvato il manuale delle procedure per la gestione degli utenti motori agricoli (UMA) Visto il D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, come modificato dal D.lgs 25 maggio 2016 n. -

Commission Implementing Decision (Eu) 2017
22.11.2017 EN Official Journal of the European Union L 306/31 COMMISSION IMPLEMENTING DECISION (EU) 2017/2175 of 21 November 2017 amending the Annex to Implementing Decision (EU) 2017/247 on protective measures in relation to outbreaks of the highly pathogenic avian influenza in certain Member States (notified under document C(2017) 7835) (Text with EEA relevance) THE EUROPEAN COMMISSION, Having regard to the Treaty on the Functioning of the European Union, Having regard to Council Directive 89/662/EEC of 11 December 1989 concerning veterinary checks in intra- Community trade with a view to the completion of the internal market (1), and in particular Article 9(4) thereof, Having regard to Council Directive 90/425/EEC of 26 June 1990 concerning veterinary and zootechnical checks applicable in intra-Community trade in certain live animals and products with a view to the completion of the internal market (2), and in particular Article 10(4) thereof, Whereas: (1) Commission Implementing Decision (EU) 2017/247 (3) was adopted following outbreaks of highly pathogenic avian influenza of subtype H5 in a number of Member States (‘the concerned Member States’), and the establishment of protection and surveillance zones by the competent authority of the concerned Member States in accordance with Article 16(1) of Council Directive 2005/94/EC (4). (2) Implementing Decision (EU) 2017/247 provides that the protection and surveillance zones established by the competent authorities of the concerned Member States in accordance with Directive 2005/94/EC are to comprise at least the areas listed as protection and surveillance zones in the Annex to that Implementing Decision.