Biblioteca Essenziale Laterza 96
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Understanding Calvinism: B
Introduction A. Special Terminology I. The Persons Understanding Calvinism: B. Distinctive Traits A. John Calvin 1. Governance Formative Years in France: 1509-1533 An Overview Study 2. Doctrine Ministry Years in Switzerland: 1533-1564 by 3. Worship and Sacraments Calvin’s Legacy III. Psycology and Sociology of the Movement Lorin L Cranford IV. Biblical Assessment B. Influencial Interpreters of Calvin Publication of C&L Publications. II. The Ideology All rights reserved. © Conclusion INTRODUCTION1 Understanding the movement and the ideology la- belled Calvinism is a rather challenging topic. But none- theless it is an important topic to tackle. As important as any part of such an endeavour is deciding on a “plan of attack” in getting into the topic. The movement covered by this label “Calvinism” has spread out its tentacles all over the place and in many different, sometimes in conflicting directions. The logical starting place is with the person whose name has been attached to the label, although I’m quite sure he would be most uncomfortable with most of the content bearing his name.2 After exploring the history of John Calvin, we will take a look at a few of the more influential interpreters of Calvin over the subsequent centuries into the present day. This will open the door to attempt to explain the ideology of Calvinism with some of the distinctive terms and concepts associated exclusively with it. I. The Persons From the digging into the history of Calvinism, I have discovered one clear fact: Calvinism is a religious thinking in the 1500s of Switzerland when he lived and movement that goes well beyond John Calvin, in some worked. -

Girolamo Zanchi on Union with Christ and the Final Judgment
Perichoresis Volume 18.1 (2020): 41–56 DOI: 10.2478/perc-2020-0003 GIROLAMO ZANCHI ON UNION WITH CHRIST AND THE FINAL JUDGMENT J.V. FESKO* Reformed Theological Seminary ABSTRACT. Union with Christ was a key doctrine for second-generation Reformed theologian Girolamo Zanchi. As a Thomist, Zanchi shared similar elements with Thomas Aquinas in his understanding of salvation as participatio, but his understanding of union with Christ differed with regard to the difference between infused and imputed righteousness. Unlike Aquinas’s doctrine of infused righteousness, Zanchi argued for imputed righteousness, which was both the foundation for one’s justification in this life as well as appearing before the divine bar at the final judgment. Zanchi’s doctrine of union with Christ has the utmost significance for personal eschatology and the judgment believers undergo at the great assize, insights that are worth retrieving for a clear understanding of the relationship between justification and the final judgement. KEYWORDS: Union with Christ, participation (participatio), insitio Christi, imputed righteous- ness, infused righteousness, Aquinas, Zanchi, final judgment Introduction The doctrine of participatio or union with Christ has been a prominent theme in historical and doctrinal literature. Some have claimed that union with Christ is a panacea for healing the doctrinal rift between the Western and Eastern churches (Braaten and Jenson 1998: vii-ix). Others have claimed that union is the great insight of John Calvin (1509-64) and that later Reformed theologians ignored or abandoned his doctrine (Partee 2008: 13-35). Calvin’s successors traded their doctrinal inheritance for a bowl of scholastic lentils when they supposedly moved away from union and embraced the ordo salutis (Evans 2008: 40, 264-67). -

Jerome Zanchi (1516–90) and the Analysis of Reformed Scholastic Christology
Stefan Lindholm, Jerome Zanchi (1516–90) and the Analysis of Reformed Scholastic Christology © 2016, Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co. KG, Göttingen ISBN Print: 9783525551042 — ISBN E-Book: 9783647551043 Stefan Lindholm, Jerome Zanchi (1516–90) and the Analysis of Reformed Scholastic Christology Reformed Historical Theology Edited by Herman J. Selderhuis in Co-operation with Emidio Campi, Irene Dingel, Elsie Anne McKee, RichardMuller,Risto Saarinen, and Carl Trueman Volume 37 © 2016, Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co. KG, Göttingen ISBN Print: 9783525551042 — ISBN E-Book: 9783647551043 Stefan Lindholm, Jerome Zanchi (1516–90) and the Analysis of Reformed Scholastic Christology Stefan Lindholm Jerome Zanchi (1516–90) and the Analysis of Reformed Scholastic Christology Vandenhoeck & Ruprecht © 2016, Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co. KG, Göttingen ISBN Print: 9783525551042 — ISBN E-Book: 9783647551043 Stefan Lindholm, Jerome Zanchi (1516–90) and the Analysis of Reformed Scholastic Christology Bibliographic informationpublishedbythe Deutsche Nationalbibliothek The Deutsche Nationalbibliotheklists this publication in the Deutsche Nationalbibliografie; detailed bibliographic data available online:http://dnb.d-nb.de. ISSN 2198-8226 ISBN 978-3-525-55104-2 Yo ucan find alternative editions of this book and additionalmaterial on ourWebsite:www.v-r.de 2016, Vandenhoeck & RuprechtGmbH & Co.KG, Theaterstraße13, D-37073 Göttingen/ Vandenhoeck & RuprechtLLC,Bristol, CT,U.S.A. www.v-r.de All rightsreserved. No partofthis work maybereproduced or utilized in anyform or by anymeans, electronicormechanical, including photocopying, recording,orany information storage and retrieval system, withoutprior written permissionfrom the publisher. Printed in Germany. Typesetting by Konrad Triltsch GmbH, Ochsenfurt Printed and bound by Hubert & Co GmbH & Co.KG, Robert-Bosch-Breite 6, D-37079 Göttingen Printed on aging-resistantpaper. -

Immortality and Method in Ursinus' Theological Ambiance John Donnelly Marquette University, [email protected]
Marquette University e-Publications@Marquette History Faculty Research and Publications History, Department of 1-1-1986 Immortality and Method in Ursinus' Theological Ambiance John Donnelly Marquette University, [email protected] Post-print. "Immortality and Method in Ursinus's Theological Ambiance," in Controversy and Conciliation: The Reformation and the Palatinate 1559-1583. Ed. Derk Visser. Allison Park, PA: Pickwick Publications, 1986: 183-195. © 1986 Wipf and Stock Publisher. Used with permission. Immortality and Method in Ursinus's Theological Ambiance John Patrick Donnelly, S. J. The main theological and religious positions of mainstream Pro testantism in Europe and America were staked out by the first genera tion of Martin Luther and the second generation of John Calvin. Most reformation research has rightly concentrated on the first two genera tions, but recently American scholarship has started to examine the role of the third generation represented by Zacharias Ursinus and his con temporaries, the Shapers of Religious Traditions. This conference brings together many of the scholars who have contributed to that thrust-I was tempted to say younger scholars, but as I look around I n()te that most of us have acquired gray hair in the decade since we started publishing in this area. It has always seemed to me that a major contribution of the third generation of reformers was their shift of theological method away from the strongly biblical theologies of Luther and Calvin toward the neoscholasticism of the Age of Protestant Orthodoxy, a period which stretched from the late sixteenth century well into the eighteenth cen tury, and in places remained important even in the nineteenth century, for instance the Calvinism of the American Princeton School. -

Peter Martyr Vermigli and Thomas Aquinas on Predestination
CONFLUENCE AND INFLUENCE: PETER MARTYR VERMIGLI AND THOMAS AQUINAS ON PREDESTINATION Frank A. James III Introduction In his Paradiso, Dante Alighieri describes predestination as a mystery whose “root lies hidden from the intellect.”1 By its very inscrutability, the idea of predestination has fascinated theologians from Augustine to Pannenberg.2 It also has been a central dogma, as it were, for Richard A. Muller’s ground-breaking research. When he published his doctoral dis- sertation over twenty-five years ago, Christ and the Decree, few could have anticipated that his approach to the development of post-Reformational theology would have lasting value. His was after all a rather obscure area of research, which hitherto had been largely the domain of dead-white- European-males with hard to pronounce names. From the outset of his career, Muller recognized the historiographical significance of Peter Martyr Vermigli and the doctrine of predestination. In Christ and the Decree, Muller made what many considered a rather star- tling academic judgment: We must divide the laurels between Calvin and Vermigli in judging the influence of their respective doctrines of predestination. Whereas Calvin’s basic structure and definition, which designates election and reprobation as almost coordinate halves of the decree, had more impact…[it was Vermigli’s conception of predestination that] would eventually be enunciated as the confessional norm of Reformed theology.3 1 Divine Comedy, Paradisio, Canto XX: “O Predestination! How remote and dim, Thy root lies hidden from the intellect which only glimpses the First Cause Supreme! And you, ye mortals, keep your judgment checked, since we, who see God, have not therefore skill To know yet all the number of the elect, And such defective sight is sweet for us, Because our good is refined by this good, That which God wills we also will.” 2 Wolfhart Pannenberg’s dissertation: Die prädestinationslehre des Duns Skotus in Zusammenhang der scholastischen Lehrntwicklung (Göttingen: V&R, 1954). -

Jerome Zanchi, the Application of Theology, PATRICK J
Jerome Zanchi, the Application of Theology, PATRICK J. and the Rise of the English O’BANION Practical Divinity Tradition* Cet article s’inscrit dans le débat récemment relancé sur la relation entre les théologiens scolastiques de la Réforme et les premiers réformateurs, mais propose également de l’amener dans une nouvelle direction. On y ana- lyse d’abord la doctrine de Dieu, telle que développée par Jerome Zanchi (1516–1590), en mettant en relief comment il passe de conclusions de théo- logie systématique à des implications de théologie pratique, en particulier, à travers son usage de la convention dite de l’usus doctrinae. L’article cherche ensuite à estimer l’impact de cette convention en dehors des milieux érudits en explorant la relation entre le discours de Zanchi et la tradition anglaise pratique de la divinité. On y met donc en lumière comment les pasteurs et les théologiens populaires ont emprunté à Zanchi dans le cadre de leur charge d’âmes et de réforme de la nation anglaise. wo early modern likenesses of the Italian exile and Reformed theolo- Tgian Jerome Zanchi (1516–1590) exist.1 The first, the work of Hendrik Hondius, was published in his Icones virorum nostra patrumque memoria illustrium (1599). The second, probably engraved by Theodore de Bry, was included in Jean-Jacques Boissard’s Bibliotheca chalcographica (1669). Beneath each engraving, the artists added a few lines of Latin verse celebrat- ing Zanchi’s life. Although there are differences between the verses in the two works, both agree that Zanchi was nulli pietate secundus: second to none in piety. -

Zanchi Nel Quinto Centenario Della Nascita
«Sono venuto alla luce nel 1516, l’anno prima che tornasse a splendere la luce del Vangelo» Commemorazione del Quinto Centenario della nascita del teologo riformato bergamasco Girolamo Zanchi (1516-1590) Bergamo, Tempio della Chiesa Valdese, 2 febbraio 2016 Occorre incorporare la teologia nella storia e, per una strada contraria, la storia nella teologia, smettere di vedere in questa solo una collezione di concetti e di ragionamenti, riavvicinandola invece a cento altre manifestazioni del pensiero e dei sentimenti contemporanei…in una parola cercare di afferrare le realtà psicologiche che si nascondono sotto le formule scolastiche (LUCIEN FEBVRE , Studi su Riforma e Rinascimento , Einaudi 1966, p. 59) La commemorazione del Quinto Centenario della nascita di Girolamo Zanchi, teologo di dimensione europea, si svolse, cinque anni fa, con la lettura di brani autobiografici che trassi dalla sua corrispondenza, lettura alternata con musiche di Johann Sebastian Bach, eseguite all’organo dal maestro Fabio Piazzalunga. Si preferì, in quell’occasione, non parlare tanto di Zanchi teologo quanto piuttosto dell’uomo; anche se vita e teologia furono in lui così intimamente unite che l’individualità del soggetto si fuse sempre più saldamente con la sua opera teologica. Zanchi fu assai parco nel parlare di sé. Solo una lettera può dirsi integralmente autobiografica, quella del 2 aprile 1565 al parente Lelio Zanchi di Verona; e, in misura minore, la lettera dedicatoria a Filippo I d’Assia dell’opera Miscellanea Theologica del 1566. Le altre lettere, tutte di stretto argomento teologico, ecclesiale, pastorale, contengono solo sporadici passi autobiografici. Scelsi quei passi che mi parvero meglio adeguati ad abbozzare per accenni l’immagine della sua personalità, gli affetti famigliari, le amicizie, i sentimenti, lo stile, i gusti. -
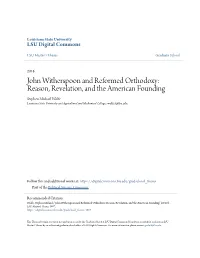
John Witherspoon and Reformed Orthodoxy
Louisiana State University LSU Digital Commons LSU Master's Theses Graduate School 2016 John Witherspoon and Reformed Orthodoxy: Reason, Revelation, and the American Founding Stephen Michael Wolfe Louisiana State University and Agricultural and Mechanical College, [email protected] Follow this and additional works at: https://digitalcommons.lsu.edu/gradschool_theses Part of the Political Science Commons Recommended Citation Wolfe, Stephen Michael, "John Witherspoon and Reformed Orthodoxy: Reason, Revelation, and the American Founding" (2016). LSU Master's Theses. 1807. https://digitalcommons.lsu.edu/gradschool_theses/1807 This Thesis is brought to you for free and open access by the Graduate School at LSU Digital Commons. It has been accepted for inclusion in LSU Master's Theses by an authorized graduate school editor of LSU Digital Commons. For more information, please contact [email protected]. JOHN WITHERSPOON AND REFORMED ORTHODOXY: REASON, REVELATION, AND THE AMERICAN FOUNDING A Thesis Submitted to the Graduate Faculty of the Louisiana State University and Agricultural and Mechanical College in partial fulfillment of the requirements for the degree of Masters of Arts in The Department of Political Science by Stephen Michael Wolfe B.S., United States Military Academy, 2008 August 2016 TABLE OF CONTENTS ABSTRACT...................................................................................................................................iii CHAPTER 1. INTRODUCTION AND LITERATURE REVIEW..........................................................1 -

Philosophical Works
Vol4.Prelims Page i Friday, June 25, 2010 9:43 AM The Peter Martyr Library Volume Four Philosophical Works i Vol4.Prelims Page ii Friday, June 25, 2010 9:43 AM The Peter Martyr Library Series One General Editors JOHN PATRICK DONNELLY, S. J., and JOSEPH C. McLelland Managing Editor ROBERT V. SCHNUCKER Editorial Committee Marvin W. Anderson Rita Belladonna Edward J. Furcha Frank A. James III William J. Klempa Editorial Board Irena Backus Alister E. McGrath Institut d’histoire de la Réformation Wycliffe Hall Université de Genève Oxford University Peter S. Bietenholz John McIntyre University of Saskatchewan University of Edinburgh Rita Belladonna H. Wayne Pipkin York University Associated Mennonite Biblical Downsview, Ontario Seminaries, Elkhart, Indiana Fritz Büsser Jill Raitt Institut für Schweizer University of Missouri Reformationsgeschichte, Zurich Columbia, Missouri Antonio D’Andrea Donna R. Runnalls McGill University, Montreal McGill University, Montreal Richard C. Gamble Luigi Santini Calvin College and Seminary Chiesa Evangelica Valdese Grand Rapids, Michigan Firenze Robert M. Kingdon Pamela D. Stewart Institute for Research in the Humanities McGill University University of Wisconsin-Madison Montreal William Klempa John Tedeschi The Presbyterian College, Montreal University of Wisconsin-Madison John H. Leith Thomas F. Torrance Union Theological Seminary of Virginia University of Edinburgh Michael Percival-Maxwell Cesare Vasoli McGill University, Montreal Università di Firenze Vol4.Prelims Page iv Friday, June 25, 2010 9:43 AM This book has been brought to publication with the generous support of Truman State University, Kirksville, Missouri and is published jointly by The Thomas Jefferson University Press and Sixteenth Century Journal Publishers, Inc. Kirksville, Missouri, U.S.A. -

Reformed Confessions and Scholasticism. Diversity and Harmony
Perichoresis Volume 14. Issue 3 (2016): 17-43 DOI: 10.1515/perc-2016-0014 REFORMED CONFESSIONS AND SCHOLASTICISM. DIVERSITY AND HARMONY ANDREAS J. BECK * Evangelical Theological Faculty, Leuven ABSTRACT. This paper discusses the complex relationship of Reformed confessions and Re- formed orthodox scholasticism. It is argued that Reformed confessions differ in genre and method from Reformed scholastic works, although such differences between confessional and scholastic language should not be mistaken for representing different doctrines that are no longer in harmony with each other. What is more, it is precisely the scholastic background and training of the authors of such confessions that enabled them to place their confessional writings in the broader catholic tradition of the Christian church and to include patristic and medieval theological insights. Thus proper attention to their scholastic background helps to see that at least in some confessions the doctrine of predestination, for instance, is not as ‘rigid’ as one might think at first sight. In order to demonstrate that the doctrine of the Reformed confessions was much in line with the scholastic theology of Reformed orthodoxy, this paper discusses, after having explained the terms ‘Reformed orthodoxy’ and ‘sch olasticism ’, the early Reformed scho- lastic theologians Beza, Zanchi, and Ursinus, who also have written confessional texts. The paper also includes a more detailed discussion of the Belgic Confession and the scholastic background of the Canons of Dordt and the Westminster Confession , thereby focusing on the doctrines of God, providence, and predestination. KEY WORDS: Reformed confessions, scholasticism, Belgic Confession , Synod of Dordt, predesti- nation Introduction Around 1565, we observe not only the rise of most national Reformed con- fessions, but also the beginning of Reformed orthodoxy and scholasticism. -

The Grammar of Justification: the Doctrines of Peter Martyr Vermigli and John Henry Newman and Their Ecumenical Implications
Middlesex University Research Repository An open access repository of Middlesex University research http://eprints.mdx.ac.uk Castaldo, Christopher A. (2015) The grammar of justification: the doctrines of Peter Martyr Vermigli and John Henry Newman and their ecumenical implications. PhD thesis, Middlesex University / London School of Theology. [Thesis] Final accepted version (with author’s formatting) This version is available at: https://eprints.mdx.ac.uk/15772/ Copyright: Middlesex University Research Repository makes the University’s research available electronically. Copyright and moral rights to this work are retained by the author and/or other copyright owners unless otherwise stated. The work is supplied on the understanding that any use for commercial gain is strictly forbidden. A copy may be downloaded for personal, non-commercial, research or study without prior permission and without charge. Works, including theses and research projects, may not be reproduced in any format or medium, or extensive quotations taken from them, or their content changed in any way, without first obtaining permission in writing from the copyright holder(s). They may not be sold or exploited commercially in any format or medium without the prior written permission of the copyright holder(s). Full bibliographic details must be given when referring to, or quoting from full items including the author’s name, the title of the work, publication details where relevant (place, publisher, date), pag- ination, and for theses or dissertations the awarding institution, the degree type awarded, and the date of the award. If you believe that any material held in the repository infringes copyright law, please contact the Repository Team at Middlesex University via the following email address: [email protected] The item will be removed from the repository while any claim is being investigated. -

Calvin Reformed Tradition
CALVIN and the REFORMED TRADITION On the Work of Christ and the Order of Salvation Richard A. Muller K Richard A. Muller, Calvin and the Reformed Tradition Baker Academic, a division of Baker Publishing Group, © 2012. Used by permission. (Unpublished manuscript—copyright protected Baker Publishing Group) MMuller_CalvinRefTradit_BKB_djm.indduller_CalvinRefTradit_BKB_djm.indd 1 88/27/12/27/12 33:43:43 PMPM © 2012 by Richard A. Muller Published by Baker Academic a division of Baker Publishing Group P.O. Box 6287, Grand Rapids, MI 49516–6287 www.bakeracademic.com Printed in the United States of America All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means—for example, electronic, photocopy, recording—without the prior written permission of the publisher. The only exception is brief quotations in printed reviews. Library of Congress Cataloging-in-Publication Data Muller, Richard A. (Richard Alfred), 1948– Calvin and the Reformed Tradition : on the work of Christ and the order of salvation / Richard A. Muller p. cm. Includes bibliographical references and index. ISBN 978-0-8010-4870-8 (pbk.) 1. Reformed Church—Doctrines—History. 2. Jesus Christ—History of doctrines. 3. Jesus Christ—Person and offices. 4. Salvation—Christianity—History of doctrines. 5. Calvin, Jean, 1509–1564. 6. Calvinism. 7. Protestant Scholasticism. I. Title. BX9422.3.M845 2012 232—dc23 2012028060 The internet addresses, email addresses, and phone numbers in this book are accurate at the time of publication. They are provided as a resource. Baker Publishing Group does not endorse them or vouch for their content or permanence.